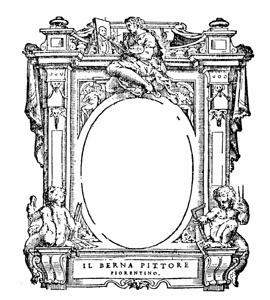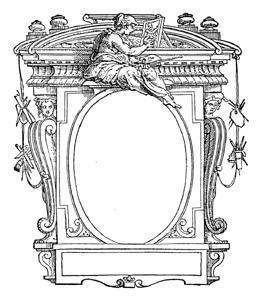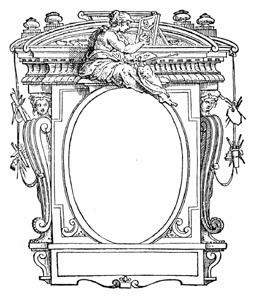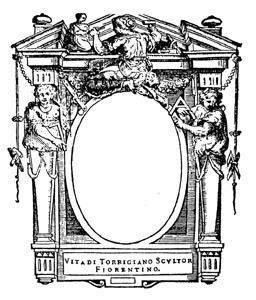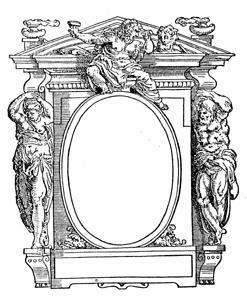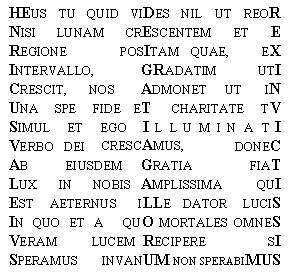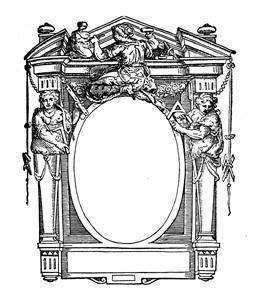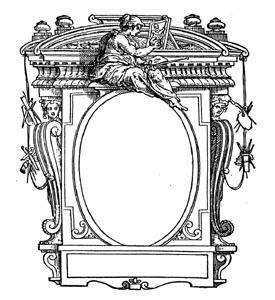SCRITTE DA MESSER
GIORGIO VASARI
PITTORE ARETINO PARTE TERZA
PROEMIO
Veramente grande augumento fecero alle arti della architettura, pittura e scultura quelli eccellenti Maestri che noi abbiamo descritti sin qui, nella Seconda Parte di queste Vite; aggiugnendo alle cose de' primi regola, ordine, misura, disegno e maniera se non in tutto perfettamente, tanto almanco vicino al vero, che i terzi, di chi noi ragioneremo da qui avanti, poterono mediante quel lume sollevarsi e condursi alla somma perfezzione, dove abbiamo le cose moderne di maggior pregio e più celebrate. Ma perché più chiaro ancor si conosca la qualità del miglioramento che ci hanno fatto i predetti artefici, non sarà certo fuori di proposito dichiarare, in poche parole, i cinque aggiunti che io nominai, e discorrer succintamente donde sia nato quel vero buono, che superato il secolo antico, fa il moderno sì glorioso. Fu adunque la regola nella architettura il modo del misurare delle anticaglie, osservando le piante degli edificii antichi nelle opere moderne; l'ordine fu il dividere l'un genere dall'altro, sì che toccasse ad ogni corpo le membra sue, e non si cambiasse più tra loro il dorico, lo ionico, il corinzio et il toscano; e la misura fu universale, sì nella architettura, come nella scultura, fare i corpi delle figure retti, dritti e con le membra organizzate parimente; et il simile nella pittura. Il disegno fu lo imitare il più bello della natura in tutte le figure, così scolpite come dipinte, la qual parte viene dallo aver la mano e l'ingegno che raporti tutto quello che vede l'occhio in sul piano, o disegni o in su fogli o tavola o altro piano, giustissimo et a punto; e così di rilievo nella scultura; la maniera venne poi la più bella, dall'avere messo in uso il frequente ritrarre le cose più belle; e da quel più bello, o mani o teste o corpi o gambe aggiugnerle insieme e fare una figura di tutte quelle bellezze che più si poteva; e metterla in uso in ogni opera per tutte le figure, che per questo si dice esser bella maniera.
Queste cose non l'aveva fatte Giotto, né que' primi artefici, se bene eglino avevano scoperto i principii di tutte queste difficoltà, e toccatele in superficie, come nel disegno, più vero che non era prima e più simile alla natura, e così l'u-nione de' colori et i componimenti delle figure nelle storie e molte altre cose, da le quali a bastanza s'è ragionato. Ma se bene i secondi agomentarono grandemente a queste arti tutte le cose dette di sopra, elle non erano però tanto perfette, che elle finissino di aggiugnere all'intero della perfezzione. Mancandoci ancora nella regola, una licenzia, che non essendo di regola, fosse ordinata nella regola e potesse stare senza fare confusione o guastare l'ordine, il quale aveva bisogno d'una invenzione copiosa di tutte le cose e d'una certa bellezza continuata in ogni minima cosa, che mostrasse tutto quell'ordine con più ornamento. Nelle misure mancava uno retto giudizio, che senza che le figure fussino misurate avessero in quelle grandezze, ch'elle eran fatte, una grazia che eccedesse la misura. Nel disegno non v'erano gli estremi del fine suo, perché se bene e' facevano un braccio tondo et una gamba diritta, non era ricerca con muscoli con quella facilità graziosa e dolce che apparisce fra 'l vedi e non vedi, come fanno la carne e le cose vive: ma elle erano crude, e scorticate, che faceva difficoltà agli occhi e durezza nella maniera, alla quale mancava una leggiadria di fare svelte e graziose tutte le figure e massimamente le femmine et i putti con le membra naturali come agli uomini, ma ricoperte di quelle grassezze e carnosità, che non siano goffe, come li naturali, ma arteficiate dal disegno e dal giudizio.
Vi mancavano ancora la copia de' belli abiti, la varietà di tante bizzarrie, la vaghezza de' colori, la università ne' casamenti e la lontananza e varietà ne' paesi. Et avegna che molti di loro cominciassino come Andrea Verrocchio, Antonio del Pollaiuolo e molti altri più moderni, a cercare di fare le loro figure più studiate, e che ci apparisse dentro maggior disegno, con quella imitazione più simile e più a punto alle cose naturali, nondimeno e' non v'era il tutto ancora, che ci fusse l'una sicurtà più certa, che eglino andavano inverso il buono e ch'elle fussino però approvate secondo l'ope-re degli antichi, come si vide quando il Verrocchio rifece le gambe e le braccia di marmo al Marsia di casa Medici in Fiorenza, mancando loro pure una fine et una estrema perfezzione ne' piedi, mani, capegli, barbe, ancora che il tutto delle membra, sia accordato con l'antico et abbia una certa corrispondenza giusta nelle misure. Ché s'eglino avessino avuto quelle minuzie dei fini, che sono la perfezzione et il fiore dell'arte, arebbono avuto ancora una gagliardezza risoluta nell'opere loro e ne sarebbe conseguito la leggiadria et una pulitezza e somma grazia, che non ebbono, ancora che vi sia lo stento della diligenzia, che son quelli che dànno gli stremi dell'arte nelle belle figure, o di rilievo o dipinte. Quella fine e quel certo che ci mancava, non lo potevano mettere così presto in atto, avvenga che lo studio insecchisce la maniera, quando egli è preso per terminare i fini in quel modo. Bene lo trovaron poi dopo loro gli altri, nel veder cavar fuora di terra certe anticaglie, citate da Plinio delle più famose: il Lacoonte, l'Ercole et il Torso grosso di Bel Vede-re, così la Venere, la Cleopatra, lo Apollo et infine altre: le quali nella lor dolcezza e nelle lor asprezze con termini carnosi e cavati dalle maggior bellezze del vivo, con certi atti che non in tutto si storcono, ma si vanno in certe parti movendo e si mostrano con una graziosissima grazia. E furono cagione di levar via una certa maniera secca e cruda e tagliente, che per lo soverchio studio avevano lasciata in questa arte Pietro della Francesca, Lazaro Vasari, Alesso Baldovinetti, Andrea dal Castagno, Pesello, Ercole Ferrarese, Giovan Bellini, Cosimo Rosselli, l'Abate di San Clemente, Domenico del Ghirlandaio, Sandro Botticello, Andrea Mantegna, Filippo e Luca Signorello; i quali, per sforzarsi, cercavano fare l'impossibile dell'arte con le fatiche e massime negli scorti e nelle vedute spiacevoli che, sì come erano a loro dure a condurle, così erano aspre a vederle. Et ancora che la maggior parte fussino ben disegnate e senza errori, vi mancava pure uno spirito di prontezza che non ci si vide mai, et una dolcezza ne' colori unita, che la cominciò ad usare nelle cose sue il Francia Bolognese e Pietro Perugino. Et i popoli nel vederla corsero come matti a questa bellezza nuova e più viva, parendo loro assolutamente che e' non si potesse già mai far meglio.
Ma lo errore di costoro dimostrarono poi chiaramente le opere di Lionardo da Vinci, il quale, dando principio a quella terza maniera, che noi vogliamo chiamare la moderna, oltra la gagliardezza e bravezza del disegno, et oltra il contraffare sottilissimamente tutte le minuzie della natura così apunto, come elle sono, con buona regola, miglior ordine, retta misura, disegno perfetto e grazia divina, abbondantissimo di copie e profondissimo di arte, dette veramente alle sue figure il moto et il fiato. Seguitò dopo lui, ancora che alquanto lontano, Giorgione da Castel Franco, il quale sfumò le sue pitture e dette una terribil movenzia alle sue cose, per una certa oscurità di ombre bene intese; né meno di costui diede alle sue pitture forza, rilievo, dolcezza e grazia ne' colori fra' Bartolomeo di San Marco. Ma più di tutti il graziosissimo Raffaello da Urbino, il quale studiando le fatiche de' maestri vecchi e quelle de' moderni, prese da tutti il meglio, e fattone raccolta, arricchì l'arte della pittura di quella intera perfezzione, che ebbero anticamente le figure d'A-pelle e di Zeusi e più, se si potesse dire o mostrare l'opere di quelli a questo paragone. Laonde la natura restò vinta dai suoi colori, e l'invenzione era in lui sì facile e propria quanto può giudicare chi vede le storie sue, le quali sono simili alli scritti, mostrandoci in quelle i siti simili e gli edificii, così come nelle genti nostrali e strane, le cere e gli abiti, secondo che egli ha voluto: oltra il dono della grazia delle teste, giovani, vecchi e femmine, riservando alle modeste la modestia, alle lascive la lascivia et ai putti ora i vizii negli occhi et ora i giuochi nelle attitudini. E così i suoi panni piegati, né troppo semplici, né intrigati, ma con una guisa che paiono veri. Seguì in questa maniera, ma più dolce di colorito e non tanta gagliarda Andrea del Sarto, il qual si può dire che fusse raro, perché l'opere sue sono senza errori. Né si può esprimere le leggiadrissime vivacità, che fece nelle opere sue Antonio da Correggio, sfilando i suoi capelli con un modo, non di quella maniera fine che facevano gli innanzi a lui, ch'era difficile, tagliente e secca, ma d'una piumosità morbidi, che si scorgevano le fila nella facilità del farli, che parevano d'oro e più belli che i vivi, i quali restano vinti dai suoi coloriti.
Il simile fece Francesco Mazzola Parmigiano, il quale in molte parti di grazia e di ornamenti e di bella maniera lo avanzò, come si vede in molte pitture sue, le quali ridano nel viso e sì come gli occhi veggono vivacissimamente, così si scorge il batter de' polsi, come più piacque al suo pennello. Ma chi considererà l'opere delle facciate di Polidoro e di Maturino, vedrà le figure far que' gesti che l'impossibile non può fare, e stupirà come e' si possa non ragionare con la lingua ch'è facile, ma esprimere col pennello le terribilissime invenzioni messe da loro in opera con tanta pratica e destrezza, rappresentando i fatti de' Romani, come e' furono propriamente. E quanti ce ne sono stati, che hanno dato vita alle loro figure coi colori ne' morti? Come il Rosso, fra' Sebastiano, Giulio Romano, Perin del Vaga, perché de' vivi, che per se medesimi son notissimi, non accade qui ragionare. Ma quello che importa il tutto di questa arte è che l'hanno ridotta oggi talmente perfetta e facile per chi possiede il disegno, l'invenzione et il colorito, che dove prima da que' nostri maestri si faceva una tavola in sei anni, oggi in un anno questi maestri ne fanno sei: et io ne fo indubitatamente fede e di vista e d'opera; e molto più si veggono finite e perfette, che non facevano prima gli altri maestri di conto. Ma quello che fra i morti e' vivi porta la palma e trascende e ricuopre tutti è il divino Michelagnolo Buonarroti il qual non solo tien il principato di una di queste arti, ma di tutte tre insieme. Costui supera e vince non solamente tutti costoro, ch'han-no quasi che vinto già la natura, ma quelli stessi famosissimi antichi, che sì lodatamente fuor d'ogni dubbio la superarono: et unico si trionfa di quegli, di questi e di lei, non imaginandosi appena quella cosa alcuna sì strana e tanto difficile, ch'egli con la virtù del divinissimo ingegno suo, mediante l'industria, il disegno, l'arte, il giudizio e la grazia, di gran lunga non la trapassi. E non solo nella pittura e ne' colori, sotto il qual genere si comprendono tutte le forme e tutti i corpi retti e non retti, palpabili et impalpabili, visibili e non visibili, ma nell'estrema rotondità ancora de' corpi; e con la punta del suo scarpello e delle fatiche di così bella e fruttifera pianta, son distesi già tanti rami e sì onorati, che oltre l'a-ver pieno il mondo in sì disusata foggia de' più saporiti frutti che siano, hanno ancora dato l'ultimo termine a queste tre nobilissime arti con tanta e sì maravigliosa perfezzione, che ben si può dire e sicuramente, le sue statue in qual si voglia parte di quelle, esser più belle assai che l'antiche. Conoscendosi nel mettere a paragone teste, mani, braccia e piedi formati dall'uno e dall'altro, rimane in quelle di costui un certo fondamento più saldo, una grazia più interamente graziosa et una molto più assoluta perfezione, condotta con una certa difficultà sì facile nella sua maniera, che egli è impossibile mai veder meglio. Il che medesimamente si può credere delle sue pitture; le quali, se per avventura ci fussero di quelle famosissime greche o romane da poterle a fronte a fronte paragonare, tanto resterebbono in maggior pregio e più onorate, quanto più appariscono le sue sculture superiori a tutte le antiche. Ma se tanto sono da noi ammirati que' famosissimi che provocati con sì eccessivi premii e con tanta felicità diedero vita alle opere loro, quanto doviamo noi maggiormente celebrare e mettere in cielo questi rarissimi ingegni che non solo senza premii, ma in una povertà miserabile fanno frutti sì preziosi? Credasi et affermisi adunque che se in questo nostro secolo fusse la giusta remunerazione, si farebbono senza dubbio cose più grandi e molto migliori che non fecero mai gli antichi. Ma lo avere a combattere più con la fame, che con la Fama, tien sotterrati i miseri ingegni, né gli lascia (colpa e vergogna di chi sollevare gli potrebbe e non se ne cura) farsi conoscere. E tanto basti a questo proposito, essendo tempo di oramai tornare a le Vite: trattando distintamente di tutti quegli che hanno fatto opere celebrate, in questa terza maniera: il principio della quale fu Lionardo da Vinci, dal quale appresso cominceremo.
IL FINE DEL PROEMIO
VITA DI LIONARDO DA VINCI
PITTORE E SCULTORE FIORENTINO

Grandissimi doni si veggono piovere dagli influssi celesti ne' corpi umani molte volte naturalmente, e sopra naturali, talvolta, strabocchevolmente accozzarsi in un corpo solo bellezza, grazia e virtù, in una maniera, che dovunque si volge quel tale, ciascuna sua azzione è tanto divina, che lasciandosi dietro tutti gl'altri uomini, manifestamente si fa conoscere per cosa (come ella è) largita da Dio e non acquistata per arte umana.
Questo lo videro gli uomini in Lionardo da Vinci, nel quale oltra la bellezza del corpo, non lodata mai a bastanza, era la grazia più che infinita in qualunque sua azzione; e tanta e sì fatta poi la virtù, che dovunque l'animo volse nelle cose difficili, con facilità le rendeva assolute. La forza in lui fu molta e congiunta con la destrezza, l'animo e 'l valore, sempre regio e magnanimo. E la fama del suo nome tanto s'allargò, che non solo nel suo tempo fu tenuto in pregio, ma pervenne ancora molto più ne' posteri dopo la morte sua.
Veramente mirabile e celeste fu Lionardo, figliuolo di ser Piero da Vinci, e nella erudizione e principii delle lettere arebbe fatto profitto grande, se egli non fusse stato tanto vario et instabile. Perciò che egli si mise a imparare molte cose e, cominciate, poi l'abbandonava. Ecco nell'abbaco egli in pochi mesi ch'e' v'attese, fece tanto acquisto, che movendo di continuo dubbi e difficultà al maestro che gl'insegnava, bene spesso lo confondeva. Dette alquanto d'opera alla musica, ma tosto si risolvé a imparare a sonare la lira, come quello che da la natura aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiadria; onde sopra quella cantò divinamente all'improvviso. Nondimeno, benché egli a sì varie cose attendesse, non lasciò mai il disegnare et il fare di rilievo, come cose che gl'andavano a fantasia più d'alcun'altra. Veduto questo, ser Piero, e considerato la elevazione di quello ingegno, preso un giorno alcuni de' suoi disegni gli portò ad Andrea del Verrochio, ch'era molto amico suo, e lo pregò strettamente che gli dovesse dire se Lionardo, attendendo al disegno, farebbe alcun profitto. Stupì Andrea nel veder il grandissimo principio di Lionardo, e confortò ser Piero che lo facesse attendere, onde egli ordinò con Lionardo ch'e' dovesse andare a bottega di Andrea; il che Lionardo fece volentieri oltre a modo. E non solo esercitò una professione, ma tutte quelle ove il disegno si interveniva. Et avendo uno intelletto tanto divino e maraviglioso che, essendo bonissimo geometra, non solo operò nella scultura, facendo, nella sua giovanezza, di terra alcune teste di femine che ridono, che vanno, formate per l'arte di gesso, e parimente teste di putti, che parevano usciti di mano d'un maestro, ma nell'architettura ancora fé molti disegni così di piante come d'altri edifizii e fu il primo ancora che, giovanetto, discoresse sopra il fiume d'Arno per metterlo in canale da Pisa a Fiorenza. Fece disegni di mulini, gualchiere et ordigni, che potessino andare per forza d'acqua; e perché la professione sua volle che fusse la pittura, studiò assai in ritrar di naturale, e qualche volta in far medaglie, di figure di terra, et adosso a quelle metteva cenci molli interrati, e poi con pazienza si metteva a ritrargli sopra a certe tele sottilissime di rensa o di pannilini adoperati, e gli lavorava di nero e bianco con la punta del pennello, che era cosa miracolosa, come ancora ne fa fede alcuni, che ne ho di sua mano, in sul nostro libro de' disegni; oltre che disegnò in carta, con tanta diligenza e sì bene, che in quelle finezze non è chi vi abbia aggiunto mai, che n'ho io una testa di stile e chiaro scuro, che è divina, et era in quello ingegno infuso tanta grazia da Dio, et una demostrazione sì terribile accordata con l'intelletto e memoria che lo serviva, e col disegno delle mani sapeva sì bene esprimere il suo concetto, che con i ragionamenti vinceva e con le ragioni confondeva ogni gagliardo ingegno. Et ogni giorno faceva modegli e disegni da potere scaricare con facilità monti e forargli per passare da un piano a un altro, e per via di lieve e di argani e di vite mostrava potersi alzare, e tirare pesi grandi, e modi da votar porti e trombe da cavare de' luoghi bassi acque; ché quel cervello mai restava di ghiribizzare, de' quali pensieri e fatiche se ne vede sparsi per l'arte nostra molti disegni, et io n'ho visti assai. Oltre che perse tempo fino a disegnare gruppi di corde fatti con ordine, e che da un capo seguissi tutto il resto fino a l'altro, tanto che s'empiessi un tondo, che se ne vede in istampa uno difficilissimo e molto bello, e nel mezzo vi sono queste parole: Leonardus Vinci Accademia; e fra questi modegli e disegni ve n'era uno, col quale più volte a molti cittadini ingegnosi, che allora governavano Fiorenza, mostrava volere alzare il tempio di San Giovanni di Fiorenza, e sottomettervi le scalee, senza ruinarlo, e con sì forti ragioni lo persuadeva, che pareva possibile, quantunque ciascuno, poi che e' si era partito, conoscesse per se medesimo l'impossibilità di cotanta impresa. Era tanto piacevole nella conversazione che tirava a sé gl'animi delle genti. E non avendo egli, si può dir, nulla, e poco lavorando, del continuo tenne servitori e cavalli, de' quali si dilettò molto, e particularmente di tutti gl'altri animali, i quali con grandissimo amore e pacienza governava. E mostrollo ché spesso passando dai luoghi dove si vendevano uccelli, di sua mano cavandoli di gabbia e pagatogli a chi li vendeva il prezzo che n'era chiesto, li lasciava in aria a volo, restituendoli la perduta libertà. Laonde volle la natura tanto favorirlo, che dovunque e' rivolse il pensiero, il cervello e l'animo, mostrò tanta divinità nelle cose sue, che nel dare la perfezzione, di prontezza, vivacità, bontade, vaghezza e grazia, nessuno altro mai gli fu pari.
Vedesi bene che Lionardo per l'intelligenza de l'arte cominciò molte cose e nessuna mai ne finì, parendoli che la mano aggiugnere non potesse alla perfezzione dell'arte ne le cose, che egli si imaginava, conciò sia che si formava nel-l'idea alcune difficultà sottili e tanto maravigliose, che con le mani, ancora ch'elle fussero eccellentissime, non si sarebbono espresse mai. E tanti furono i suoi capricci, che, filosofando de le cose naturali, attese a intendere la proprietà del-le erbe, continuando et osservando il moto del cielo, il corso de la Luna e gl'andamenti del Sole.
Acconciossi dunque, come è detto, per via di ser Piero, nella sua fanciullezza a l'arte con Andrea del Verrocchio, il quale, faccendo una tavola dove San Giovanni battezzava Cristo, Lionardo lavorò un Angelo, che teneva alcune vesti; e benché fosse giovanetto, lo condusse di tal maniera che molto meglio de le figure d'Andrea stava l'Angelo di Lionardo. Il che fu cagione ch'Andrea mai più non volle toccar colori, sdegnatosi che un fanciullo ne sapesse più di lui. Li fu allogato per una portiera, che si avea a fare in Fiandra d'oro e di seta tessuta, per mandare al re di Portogallo, un cartone d'Adamo e d'Eva, quando nel Paradiso terrestre peccano: dove col pennello fece Lionardo di chiaro e scuro lumeggiato di biacca un prato di erbe infinite con alcuni animali, che invero può dirsi che in diligenza e naturalità al mondo divino ingegno far non la possa sì simile.
Quivi è il fico oltra lo scortar de le foglie e le vedute de' rami, condotto con tanto amore, che l'ingegno si smarrisce solo a pensare, come un uomo possa avere tanta pacienza; èvvi ancora un palmizio, che ha la rotondità de le ruote de la palma lavorate con sì grande arte e maravigliosa, che altro che la pazienzia e l'ingegno di Lionardo non lo poteva fare. La quale opera altrimenti non si fece: onde il cartone è oggi in Fiorenza nella felice casa del Magnifico Ottaviano de' Medici donatogli non ha molto dal zio di Lionardo. Dicesi che ser Piero da Vinci, essendo alla villa, fu ricercato domesticamente da un suo contadino, il quale, d'un fico da lui tagliato in sul podere, aveva di sua mano fatto una rotella, che a Fiorenza gnene facesse dipignere; il che egli contentissimo fece, sendo molto pratico il villano nel pigliare uccelli e ne le pescagioni, e servendosi grandemente di lui ser Piero a questi esercizii. Laonde, fattala condurre a Firenze, senza altrimenti dire a Lionardo di chi ella si fosse, lo ricercò che egli vi dipignesse suso qualche cosa. Lionardo, arrecatosi un giorno tra le mani questa rotella, veggendola torta, mal lavorata e goffa la dirizzò col fuoco, e datala a un torniatore, di roza e goffa che ella era, la fece ridurre delicata e pari. Et appresso ingessatala et acconciatala a modo suo, cominciò a pensare quello che vi si potesse dipignere su, che avesse a spaventare chi le venisse contra, rappresentando lo effetto stesso che la testa già di Medusa. Portò dunque Lionardo per questo effetto ad una sua stanza, dove non entrava se non egli solo, lucertole, ramarri, grilli, serpe, farfalle, locuste, nottole et altre strane spezie di simili animali: da la moltitudine de' quali, variamente adattata insieme, cavò uno animalaccio molto orribile e spaventoso, il quale avvelenava con l'alito e faceva l'aria di fuoco. E quello fece uscire d'una pietra scura e spezzata, buffando veleno da la gola aperta, fuoco dagl'occhi e fumo dal naso sì stranamente, che pareva monstruosa et orribile cosa affatto. E penò tanto a farla, che in quella stanza era il morbo degli animali morti troppo crudele, ma non sentito da Lionardo, per il grande amore che portava nell'arte. Finita questa opera, che più non era ricerca, né dal villano né dal padre, Lionardo gli disse, che ad ogni sua comodità mandasse per la rotella, che quanto a lui era finita. Andato dunque ser Piero una mattina a la stanza per la rotella e picchiato alla porta, Lionardo gli aperse, dicendo che aspettasse un poco; e ritornatosi nella stanza acconciò la rotella al lume in sul leggio et assettò la finestra, che facesse lume abbacinato, poi lo fece passar dentro a vederla. Ser Piero nel primo aspetto, non pensando alla cosa, subitamente si scosse, non credendo che quella fosse rotella, né manco dipinto quel figurato che e' vi vedeva. E tornando col passo a dietro, Lionardo lo tenne, dicendo: “Questa opera serve per quel che ella è fatta. Pigliatela, dunque, e portatela, ché questo è il fine, che dell'opere s'aspetta”. Parse questa cosa più che miracolosa a ser Piero, e lodò grandissimamente il capriccioso discorso di Lionardo; poi, comperata tacitamente da un merciaio un'altra rotella dipinta d'un cuore trapassato da uno strale, la donò al villano che ne li restò obligato sempre mentre che e' visse. Appresso vendé ser Piero quella di Lionardo secretamente in Fiorenza a certi mercatanti, cento ducati. Et in breve ella pervenne a le mani del duca di Milano, vendutagli 300 ducati da detti mercatanti.
Fece poi Lionardo una Nostra Donna in un quadro, ch'era appresso papa Clemente VII, molto eccellente. E fra l'al-tre cose che v'erano fatte, contrafece una caraffa piena d'acqua con alcuni fiori dentro, dove oltra la maraviglia della vivezza, aveva imitato la rugiada dell'acqua sopra, sì che ella pareva più viva che la vivezza. Ad Antonio Segni, suo amicissimo, fece in su un foglio un Nettuno condotto così di disegno con tanta diligenzia, che e' pareva del tutto vivo.
Vedevasi il mare turbato et il carro suo tirato da' cavalli marini con le fantasime, l'orche, et i noti et alcune teste di dèi marini, bellissime. Il quale disegno fu donato da Fabio suo figliuolo a Messer Giovanni Gaddi, con questo epigramma:
Pinxit Virgilius Neptunum, pinxit Homerus
dum maris undisoni per vada flectit equos.
Mente quidem vates illum conspexit uterque
Vincius ast oculis, iureque vincit eos.
Vennegli fantasia di dipignere in un quadro a olio una testa d'una Medusa con una acconciatura in capo con uno agrupamento di serpe la più strana e stravagante invenzione che si possa immaginare mai; ma come opera, che portava tempo, e come quasi interviene in tutte le cose sue, rimase imperfetta. Questa è fra le cose eccellenti nel palazzo del duca Cosimo insieme con una testa d'uno Angelo che alza un braccio in aria, che scorta dalla spalla al gomito venendo inanzi, e l'altro ne va al petto con una mano. È cosa mirabile, che quello ingegno, che avendo desiderio di dare sommo rilievo alle cose che egli faceva, andava tanto con l'ombre scure a trovare i fondi de' più scuri, che cercava neri che ombrassino e fussino più scuri degl'altri neri per fare del chiaro, mediante quegli, fussi più lucido; et infine riusciva questo modo tanto tinto, che non vi rimanendo chiaro avevon più forma di cose fatte per contrafare una notte, che una finezza del lume del dì: ma tutto era per cercare di dare maggiore rilievo, di trovar il fine e la perfezzione dell'arte.
Piacevagli tanto quando egli vedeva certe teste bizzarre, o con barbe o con capegli degli uomini naturali, che arebbe seguitato uno, che gli fussi piaciuto, un giorno intero e se lo metteva talmente nella idea, che poi arrivato a casa lo disegnava come se l'avesse avuto presente. Di questa sorte se ne vede molte teste e di femine e di maschi, e n'ho io disegnato parechie di sua mano con la penna, nel nostro libro de' disegni tante volte citato, come fu quella di Amerigo Vespucci, ch'è una testa di vecchio bellissima disegnata di carbone e parimenti quella di Scaramuccia, capitano de' Zingani, che poi ebbe Messer Donato Valdanbrini d'Arezzo canonico di S. Lorenzo lassatagli dal Giambullari. Cominciò una tavola della adorazione da Magi, che v'è su molte cose belle massime di teste. La quale era in casa d'Amerigo Benci dirimpetto alla loggia dei Peruzzi, la quale anche ella rimase imperfetta come l'altre cose sua.
Avvenne che morto Giovan Galeazzo duca di Milano e creato Lodovico Sforza nel grado medesimo l'anno 1494, fu condotto a Milano con gran riputazione Lionardo al Duca, il quale molto si dilettava del suono de la lira, perché sonasse: e Lionardo portò quello strumento, ch'egli aveva di sua mano fabricato d'argento gran parte in forma d'un teschio di cavallo, cosa bizzarra e nuova, acciò ché l'armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce, laonde superò tutti i musici, che quivi erano concorsi a sonare. Oltra ciò fu il migliore dicitore di rime a l'improviso del tempo suo. Sentendo il Duca i ragionamenti tanto mirabili di Lionardo, talmente s'innamorò de le sue virtù, che era cosa incredibile. E pregatolo, gli fece fare in pittura una tavola d'altare, dentrovi una Natività che fu mandata dal Duca a l'imperatore. Fece ancora in Milano ne' frati di S. Domenico a S. Maria de le Grazie un Cenacolo, cosa bellissima e maravigliosa, et alle teste degli Apostoli diede tanta maestà e bellezza, che quella del Cristo lasciò imperfetta, non pensando poterle dare quella divinità celeste, che a l'imagine di Cristo si richiede. La quale opera, rimanendo così per finita, è stata dai milanesi tenuta del continuo in grandissima venerazione, e dagli altri forestieri ancora, atteso che Lionardo si imaginò e riuscigli di esprimere quel sospetto che era entrato negl'Apostoli, di voler sapere chi tradiva il loro maestro. Per il che si vede nel viso di tutti loro l'amore, la paura e lo sdegno, o vero il dolore, di non potere intendere lo animo di Cristo. La qual cosa non arreca minor maraviglia, che il conoscersi allo incontro l'ostinazione, l'odio e 'l tradimento in Giuda, senza che ogni minima parte dell'opera mostra una incredibile diligenzia. Avvenga che insino nella tovaglia è contraffatto l'opera del tessuto, d'una maniera che la rensa stessa non mostra il vero meglio.
Dicesi che il priore di quel luogo sollecitava molto importunamente Lionardo che finissi l'opera, parendogli strano veder talora Lionardo starsi un mezzo giorno per volta astratto in considerazione, et arebbe voluto, come faceva dell'o-pere che zappavano ne l'orto, che egli non avesse mai fermo il pennello. E non gli bastando questo, se ne dolse col Duca e tanto lo rinfocolò, che fu costretto a mandar per Lionardo e destramente sollecitarli l'opera, mostrando con buon modo, che tutto faceva per l'importunità del priore. Lionardo, conoscendo l'ingegno di quel principe esser acuto e discreto, volse (quel che non avea mai fatto con quel priore) discorrere col Duca largamente sopra di questo; gli ragionò assai de l'arte, e lo fece capace che gl'ingegni elevati, talor che manco lavorano, più adoperano, cercando con la mente l'invenzioni, e formandosi quelle perfette idee, che poi esprimono e ritraggono le mani da quelle già concepute ne l'in-telletto. E gli soggiunse che ancor gli mancava due teste da fare, quella di Cristo, della quale non voleva cercare in terra e non poteva tanto pensare, che nella imaginazione gli paresse poter concipere quella bellezza e celeste grazia, che dovette essere quella de la divinità incarnata. Gli mancava poi quella di Giuda, che anco gli metteva pensiero, non credendo potersi imaginare una forma, da esprimere il volto di colui, che dopo tanti benefizii ricevuti, avessi avuto l'animo sì fiero, che si fussi risoluto di tradir il suo Signore e creator del mondo, purché di questa seconda ne cercherebbe, ma che alla fine non trovando meglio, non gli mancherebbe quella di quel priore, tanto importuno et indiscreto. La qual cosa mosse il Duca maravigliosamente a riso e disse che egli avea mille ragioni. E così il povero priore confuso attese a sollecitar l'opera de l'orto e lasciò star Lionardo. Il quale finì bene la testa del Giuda, che pare il vero ritratto del tradimento et inumanità. Quella di Cristo rimase, come si è detto, imperfetta.
La nobiltà di questa pittura, sì per il componimento, sì per essere finita con una incomparabile diligenza, fece venir voglia al re di Francia, di condurla nel regno: onde tentò per ogni via, se ci fussi stato architetti, che con travate di legnami e di ferri, l'avessino potuta armar di maniera, che ella si fosse condotta salva, senza considerare a spesa, che vi si fusse potuta fare, tanto la desiderava. Ma l'esser fatta nel muro, fece che Sua Maestà se ne portò la voglia, et ella si rimase a' milanesi. Nel medesimo refettorio, mentre che lavorava il Cenacolo, nella testa dove è una Passione di maniera vecchia, ritrasse il detto Lodovico, con Massimiliano suo primogenito, e dall'altra parte la duchessa Beatrice, con Francesco altro suo figliuolo, che poi furono amendue duchi di Milano, che sono ritratti divinamente. Mentre che egli attendeva a questa opera, propose al Duca fare un cavallo di bronzo di maravigliosa grandezza, per mettervi in memoria l'i-magine del Duca. E tanto grande lo cominciò e riuscì, che condur non si poté mai. Ècci chi ha avuto opinione (come son varii e molte volte per invidia maligni, i giudizii umani) che Lionardo (come dell'altre sue cose) lo cominciasse perché non si finisse; perché, essendo di tanta grandezza in volerlo gettar d'un pezzo, vi si vedeva difficultà incredibile, e si potrebbe anco credere, che dall'effetto, molti abbin fatto questo giudizio, poiché delle cose sue ne son molte rimase imperfette. Ma per il vero si può credere che l'animo suo grandissimo et eccellentissimo per esser troppo volontaroso fusse impedito, e che il voler cercare sempre eccellenza sopra eccellenza, e perfezzione sopra perfezzione ne fusse cagione, talché l'opra fusse ritardata dal desio, come disse il nostro Petrarca; e nel vero quelli che veddono il modello, che Lionardo fece di terra grande, giudicano non aver mai visto più bella cosa, né più superba, il quale durò fino che i francesi vennono a Milano con Lodovico re di Francia, che lo spezzarono tutto. Ènne anche smarrito un modello piccolo di cera, ch'era tenuto perfetto, insieme con un libro di notomia di cavagli fatta da lui per suo studio. Attese di poi, ma con maggior cura, alla notomia degli uomini, aiutato e scambievolmente aiutando in questo Messer Marc'Antonio della Torre, eccellente filosofo, che allora leggeva in Pavia e scriveva di questa materia e fu de' primi (come odo dire) che cominciò a illustrare con la dottrina di Galeno le cose di medicina, et a dar vera luce alla notomia, fino a quel tempo involta in molte e grandissime tenebre d'ignoranza. Et in questo si servì maravigliosamente dell'ingegno, opera e mano di Lionardo, che ne fece un libro disegnato di matita rossa e tratteggiato di penna [dove disegnò cadaveri] che egli di sua mano scorticò e ritrasse con grandissima diligenza, dove egli fece tutte le ossature et a quelle congiunse poi con ordine tutti i nervi, e coperse di muscoli i primi appiccati all'osso, et i secondi che tengono il fermo, et i terzi che muovano, et in quegli a parte per parte di brutti caratteri scrisse lettere, che sono fatte con la mano mancina a rovescio, e chi non ha pratica a leggere non l'intende, perché non si leggono se non con lo specchio.
Di queste carte della notomia degl'uomini n'è gran parte nelle mani di Messer Francesco da Melzo, gentiluomo milanese, che nel tempo di Lionardo era bellissimo fanciullo e molto amato da lui, così come oggi è bello e gentile vecchio, che le ha care e tiene come per reliquie tal carte insieme con il ritratto della felice memoria di Lionardo. E chi legge quegli scritti, par impossibile che quel divino spirito abbi così ben ragionato dell'arte e de' muscoli e nervi e vene, e con tanta diligenza d'ogni cosa. Come anche sono nelle mani di... pittor milanese alcuni scritti di Lionardo, pur di caratteri scritti con la mancina a rovescio, che trattano della pittura e de' modi del disegno e colorire. Costui non è molto, che venne a Fiorenza a vedermi, desiderando stampar questa opera, e la condusse a Roma per dargli esito, né so poi che di ciò sia seguito.
E per tornare alle opere di Lionardo, venne al suo tempo in Milano il re di Francia, onde pregato Lionardo di far qualche cosa bizzarra, fece un lione, che caminò parecchi passi, poi s'aperse il petto e mostrò tutto pien di gigli. Prese in Milano Salaì milanese per suo creato, il qual era vaghissimo di grazia e di bellezza, avendo begli capegli, ricci et inanellati, de' quali Lionardo si dilettò molto et a lui insegnò molte cose dell'arte; e certi lavori, che in Milano si dicono essere di Salaì, furono ritocchi da Lionardo.
Ritornò a Fiorenza, dove trovò che i frati de' Servi avevano alloggato a Filippino l'opere della tavola dell'altar maggiore della Nunziata; per il che fu detto da Lionardo che volentieri avrebbe fatta una simil cosa. Onde Filippino inteso ciò, come gentil persona ch'egli era, se ne tolse giù: et i frati, perché Lionardo la dipignesse, se lo tolsero in casa, facendo le spese a lui et a tutta la sua famiglia. E così li tenne in pratica lungo tempo, né mai cominciò nulla. Finalmente fece un cartone dentrovi una Nostra Donna et una S. Anna, con un Cristo, la quale non pure fece maravigliare tutti gl'artefici, ma finita ch'ella fu, nella stanza durarono due giorni d'andare a vederla gl'uomini e le donne, i giovani et i vecchi, come si va a le feste solenni, per veder le maraviglie di Lionardo, che fecero stupire tutto quel popolo. Perché si vedeva nel viso di quella Nostra Donna, tutto quello che di semplice e di bello, può con semplicità e bellezza dare grazia a una madre di Cristo; volendo mostrare quella modestia e quella umiltà, che in una vergine contentissima d'alle-grezza del vedere la bellezza del suo figliuolo, che con tenerezza sosteneva in grembo; e mentre che ella con onestissima guardatura a basso scorgeva un S. Giovanni piccol fanciullo, che si andava trastullando con un pecorino, non senza un ghigno d'una S. Anna, che colma di letizia, vedeva la sua progenie terrena esser divenuta celeste. Considerazioni veramente dallo intelletto et ingegno di Lionardo. Questo cartone, come di sotto si dirà, andò poi in Francia. Ritrasse la Ginevra d'Amerigo Benci cosa bellissima; et abbandonò il lavoro a' frati, i quali lo ritornarono a Filippino, il quale sopravenuto egli ancora dalla morte non lo poté finire. Prese Lionardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di Monna Lisa sua moglie, e quattro anni penatovi lo lasciò imperfetto, la quale opera oggi è appresso il re Francesco di Francia in Fontanableò; nella qual testa chi voleva veder quanto l'arte potesse imitar la natura, agevolmente si poteva comprendere, perché quivi erano contrafatte tutte le minuzie che si possono con sottigliezza dipignere. Avvenga che gli occhi avevano que' lustri e quelle acquitrine, che di continuo si veggono nel vivo; et intorno a essi erano tutti que' rossigni lividi et i peli, che non senza grandissima sottigliezza si possono fare. Le ciglia per avervi fatto il modo del nascere i peli nella carne, dove più folti e dove più radi, e girare secondo i pori della carne, non potevano essere più naturali. Il naso, con tutte quelle belle aperture rossette e tenere, si vedeva essere vivo. La bocca, con quella sua sfenditura con le sue fini unite dal rosso della bocca con l'incarnazione del viso, che non colori, ma carne pareva veramente. Nella fontanella della gola, chi intentissimamente la guardava, vedeva battere i polsi: e nel vero si può dire che questa fussi di-pinta d'una maniera da far tremare e temere ogni gagliardo artefice e sia qual si vuole. Usovvi ancora questa arte, che essendo Monna Lisa bellissima, teneva mentre che la ritraeva, chi sonasse o cantasse, e di continuo buffoni che la facessino stare allegra, per levar via quel malinconico, che suol dar spesso la pittura a' ritratti che si fanno. Et in questo di Lionardo vi era un ghigno tanto piacevole che era cosa più divina che umana a vederlo, et era tenuta cosa maravigliosa, per non essere il vivo altrimenti.
Per la eccellenzia dunque delle opere di questo divinissimo artefice, era tanto cresciuta la fama sua, che tutte le persone che si dilettavano de l'arte, anzi la stessa città intera disiderava ch'egli le lasciasse qualche memoria; e ragionavasi per tutto di fargli fare qualche opera notabile e grande, donde il pubblico fusse ornato et onorato di tanto ingegno, grazia e giudizio, quanto nelle cose di Lionardo si conosceva. E tra il gonfalonieri et i cittadini grandi si praticò che essendosi fatta di nuovo la gran sala del consiglio, l'architettura della quale fu ordinata col giudizio e consiglio suo, di Giuliano S. Gallo e di Simone Pollaiuoli detto Cronaca e di Michelagnolo Buonarroti e Baccio d'Agnolo (come a' suoi luoghi più distintamente si raggionerà). La quale finita, con grande prestezza fu per decreto publico ordinato, che a Lionardo fussi dato a dipignere qualche opera bella; e così da Piero Soderini, gonfaloniere allora di giustizia, gli fu allogata la detta sala. Per il che volendola condurre Lionardo, cominciò un cartone alla sala del papa, luogo in S. Maria Novella, dentrovi la storia di Niccolò Piccinino, capitano del duca Filippo di Milano, nel quale disegnò un groppo di cavalli che combattevano una bandiera, cosa che eccellentissima e di gran magisterio fu tenuta per le mirabilissime considerazioni che egli ebbe nel far quella fuga. Perciò che in essa non si conosce meno la rabbia, lo sdegno e la vendetta negli uomini che ne' cavalli; tra quali due intrecciatisi con le gambe dinanzi non fanno men guerra coi denti, che si faccia chi gli cavalca nel combattere detta bandiera, dove apiccato le mani un soldato, con la forza delle spalle, mentre mette il cavallo in fuga, rivolto egli con la persona, aggrappato l'aste dello stendardo, per sgusciarlo per forza delle mani di quattro, che due lo difendono con una mano per uno, e l'altra in aria con le spade tentano di tagliar l'aste; mentre che un soldato vecchio con un berretton rosso, gridando, tiene una mano nell'asta e con l'altra inalberato una storta, mena con stizza un colpo, per tagliar tutte a due le mani a coloro, che con forza digrignando i denti, tentano con fierissima attitudine di difendere la loro bandiera; oltra che in terra fra le gambe de' cavagli v'è due figure in iscorto, che combattendo insieme, mentre uno in terra ha sopra uno soldato, che alzato il braccio quanto può, con quella forza maggiore gli mette alla gola il pugnale, per finirgli la vita: e quello altro con le gambe e con le braccia sbattuto, fa ciò che egli può per non volere la morte. Né si può esprimere il disegno che Lionardo fece negli abiti de' soldati, variatamente variati da lui; simile i cimieri e gli altri ornamenti, senza la maestria incredibile che egli mostrò nelle forme e lineamenti de' cavagli: i quali Lionardo meglio ch'altro maestro fece, di bravura, di muscoli e di garbata bellezza. Dicesi che per disegnare il detto cartone fece uno edifizio artificiosissimo che, stringendolo, s'alzava, et allargandolo, s'abbassava. Et imaginandosi di volere a olio colorire in muro, fece una composizione d'una mistura sì grossa, per lo incollato del muro, che continuando a dipignere in detta sala, cominciò a colare, di maniera che in breve tempo abbandonò quella, vedendola guastare. Aveva Lionardo grandissimo animo et in ogni sua azzione era generosissimo. Dicesi che andando al banco per la provisione, ch'ogni mese da Piero Soderini soleva pigliare, il cassiere gli volse dare certi cartocci di quattrini; et egli non li volse pigliare, rispondendogli: “Io non sono dipintore da quattrini”. Essendo incolpato d'aver giuntato da Piero Soderini fu mormorato contra di lui; per che Lionardo fece tanto con gli amici suoi, che ragunò i danari e portolli per ristituire, ma Piero non li volle accettare.
Andò a Roma col duca Giuliano de' Medici nella creazione di papa Leone, che attendeva molto a cose filosofiche e massimamente alla alchimia, dove formando una pasta di una cera, mentre che caminava faceva animali sottilissimi pieni di vento, ne i quali soffiando, gli faceva volare per l'aria; ma cessando il vento, cadevano in terra. Fermò in un ramarro, trovato dal vignaruolo di Belvedere, il quale era bizzarrissimo, di scaglie di altri ramarri scorticate, ali a dosso con mistura d'argenti vivi, che nel moversi quando caminava tremavano; e fattogli gl'occhi, corna e barba, domesticatolo e tenendolo in una scatola, tutti gli amici ai quali lo mostrava, per paura faceva fuggire. Usava spesso far minuta-mente digrassare e purgare le budella d'un castrato, e talmente venir sottili, che si sarebbono tenuto in palma di mano. Et aveva messo in un'altra stanza un paio di mantici da fabbro, ai quali metteva un capo delle dette budella, e gonfiandole ne riempieva la stanza, la quale era grandissima, dove bisognava che si recasse in un canto chi v'era, mostrando quelle trasparenti e piene di vento, dal tenere poco luogo in principio, esser venute a occuparne molto, aguagliandole alla virtù. Fece infinite di queste pazzie, et attese alli specchi; e tentò modi stranissimi nel cercare olii per dipignere e vernice per mantenere l'opere fatte. Fece in questo tempo per Messer Baldassarri Turini da Pescia che era datario di Leone, un quadretto di una Nostra Donna col Figliuolo in braccio con infinita diligenzia et arte. Ma, o sia per colpa di chi lo ingessò o pur per quelle sue tante e capricciose misture delle mestiche e de' colori, è oggi molto guasto. Et in un altro quadretto ritrasse un fanciulletto, che è bello e grazioso a maraviglia, che oggi sono tutti e due in Pescia appresso a Messer Giulio Turini. Dicesi, che essendogli allogato una opera dal Papa, subito cominciò a stillare olii et erbe per far la vernice; perché fu detto da papa Leone: “Oimè costui non è per far nulla, da che comincia a pensare alla fine innanzi il principio dell'opera”. Era sdegno grandissimo fra Michele Agnolo Buonaroti e lui; per il che partì di Fiorenza Michelagnolo per la concorrenza, con la scusa del duca Giuliano, essendo chiamato dal Papa per la facciata di S. Lorenzo. Lionardo intendendo ciò partì, et andò in Francia, dove il re avendo avuto opere sue, gli era molto affezzionato; e desiderava ch'e' colorisse il cartone della S. Anna; ma egli, secondo il suo costume, lo tenne gran tempo in parole. Finalmente venuto vecchio, stette molti mesi ammalato; e vedendosi vicino alla morte, si volse diligentemente informare de le cose catoliche e della via buona e santa religione cristiana, e poi con molti pianti, confesso e contrito, se bene e' non poteva reggersi in piedi, sostenendosi nelle braccia di suoi amici e servi, volse divotamente pigliare il santissimo Sacramento fuor del letto. Sopragiunseli il re che spesso et amorevolmente lo soleva visitare; per il che egli per riverenza rizzatosi a sedere sul letto, contando il mal suo e gli accidenti di quello mostrava tuttavia quanto avea offeso Dio e gli uomini del mondo, non avendo operato nell'arte come si conveniva. Onde gli venne un parossismo messaggero della morte. Per la qual cosa rizzatosi il re e presoli la testa per aiutarlo e porgerli favore, acciò che il male lo allegerisse, lo spirito suo, che divinissimo era, conoscendo non potere avere maggiore onore, spirò in braccio a quel re nella età sua d'anni 75. Dolse la perdita di Lionardo fuor di modo a tutti quegli che l'avevano conosciuto, perché mai non fu persona, che tanto facesse onore alla pittura. Egli con lo splendor dell'aria sua, che bellissima era, rasserenava ogni animo mesto, e con le parole volgeva al sì et al no ogni indurata intenzione. Egli con le forze sue riteneva ogni violenta furia; e con la destra torceva un ferro d'una campanella di muraglia et un ferro di cavallo, come se fusse piombo. Con la liberalità sua raccoglieva e pasceva ogni amico povero e ricco, pur che egli avesse ingegno e virtù.
Ornava et onorava con ogni azzione qualsivoglia disonorata e spogliata stanza; per il che ebbe veramente Fiorenza grandissimo dono nel nascere di Lionardo, e perdita più che infinita nella sua morte. Nell'arte della pittura aggiunse costui alla maniera del colorire ad olio una certa oscurità; donde hanno dato i moderni, gran forza e rilievo alle loro figure. E nella statuaria fece pruove nelle tre figure di bronzo che sono sopra la porta di S. Giovanni da la parte di tramontana fatte da Giovan Francesco Rustici, ma ordinate co 'l consiglio di Lionardo, le quali sono il più bel getto e di disegno e di perfezzione, che modernamente si sia ancor visto. Da Lionardo abbiamo la notomia de' cavalli e quella degli uomini assai più perfetta. Laonde per tante parti sue sì divine, ancora che molto più operasse con le parole che co' fatti, il nome e la fama sua non si spegneranno già mai. Per il che fu detto in lode sua da Messer Giovanbatista Strozzi così:
Vince costui pur solo
tutti altri; e vince Fidia e vince Apelle;
e tutto il lor vittorioso stuolo.
Fu discepolo di Lionardo Giovanantonio Boltraffio milanese, persona molto pratica et intendente, che l'anno 1500 dipinse in nella chiesa della Misericordia fuor di Bologna, in una tavola a olio, con gran diligenzia la Nostra Donna col Figliuolo in braccio, S. Giovanni Batista e S. Bastiano ignudo, et il padrone che la fé fare ritratto di naturale ginocchioni, opera veramente bella et in quella scrisse il nome suo e l'esser discepolo di Lionardo. Costui ha fatto altre opere et a Milano et altrove; ma basti aver qui nominata questa che è la migliore. E così Marco Uggioni, che in S. Maria della Pace fece il transito di Nostra Donna e le nozze di Cana Galilee.
VITA DI GIORGIONE DA CASTEL FRANCO
PITTOR VINIZIANO

Ne' medesimi tempi che Fiorenza acquistava tanta fama, per l'opere di Lionardo, arrecò non piccolo ornamento a Vinezia la virtù et eccellenza [di] un suo cittadino, il quale di gran lunga passò i Bellini, da loro tenuti in tanto pregio, e qualunque altro fino a quel tempo avesse in quella città dipinto. Questi fu Giorgio che in Castel Franco, in sul trevisano, nacque l'anno 1478, essendo doge Giovan Mozenigo, fratel del doge Piero: dalle fattezze della persona e da la grandezza de l'animo, chiamato poi col tempo Giorgione. Il quale, quantunque egli fusse nato d'umilissima stirpe, non fu però se non gentile e di buoni costumi in tutta sua vita. Fu allevato in Vinegia e dilettossi continovamente de le cose d'amore e piacqueli il suono del liuto mirabilmente e tanto, che egli sonava e cantava nel suo tempo tanto divinamente, che egli era spesso per quello adoperato a diverse musiche e ragunate di persone nobili.
Attese al disegno e lo gustò grandemente; et in quello la natura lo favorì sì forte, che egli, innamoratosi delle cose belle, di lei non voleva mettere in opera cosa, che egli dal vivo non ritraesse. E tanto le fu suggetto e tanto andò imitandola, che non solo egli acquistò nome d'aver passato Gentile e Giovanni Bellini, ma di competere con coloro che lavoravano in Toscana et erano autori della maniera moderna. Aveva veduto Giorgione alcune cose di mano di Lionardo, molto fumeggiate e cacciate, come si è detto, terribilmente di scuro. E questa maniera gli piacque tanto che mentre vis-se sempre andò dietro a quella, e nel colorito a olio la imitò grandemente. Costui gustando il buono de l'operare, andava scegliendo di mettere in opera sempre del più bello e del più vario che e' trovava. Diedegli la natura tanto benigno spirito che egli nel colorito a olio et a fresco fece alcune vivezze et altre cose morbide et unite e sfumate talmente negli scuri, che fu cagione che molti di quegli, che erano allora eccellenti, confessassino lui esser nato per metter lo spirito ne le figure e per contraffar la freschezza de la carne viva, più che nessuno che dipignesse, non solo in Venezia, ma per tutto.
Lavorò in Venezia nel suo principio molti quadri di Nostre Donne et altri ritratti di naturale, che sono e vivissimi e belli, come se ne vede ancora tre bellissime teste a olio di sua mano nello studio del reverendissimo Grimani, patriarca d'Aquileia: una fatta per Davit (e per quel che si dice, è il suo ritratto) con una zazzera, come si costumava in que' tempi in fino alle spalle, vivace e colorita, che par di carne: ha un braccio et il petto armato, col quale tiene la testa mozza di Golia. L'altra è una testona maggiore, ritratta di naturale, che tiene in mano una beretta rossa da comandatore, con un bavero di pelle, e sotto uno di que' saioni a l'antica: questo si pensa, che fusse fatto per un generale di esserciti. La terza è d'un putto, bella quanto si può fare con certi capelli a uso di velli, che fan conoscere l'eccellenza di Giorgione e non meno l'affezzione del grandissimo patriarca, che gli ha portato sempre a la virtù sua, tenendole carissime e meritamente. In Fiorenza è di man sua in casa de' figliuoli di Giovan Borgherini, il ritratto d'esso Giovanni quando era giovane in Venezia, e nel medesimo quadro il maestro che lo guidava, che non si può veder in due teste né miglior macchie di color di carne, né più bella tinta di ombre. In casa Anton de' Nobili è un'altra testa d'un capitano armato, molto vivace e pronta, di qual dicano esser un de' capitani, che Consalvo Ferrante menò seco a Venezia, quando visitò il doge Agostino Barberigo, nel qual tempo si dice, che ritrasse il gran Consalvo armato, che fu cosa rarissima e non si poteva vedere pittura più bella che quella, e che esso Consalvo se ne la portò seco. Fece Giorgione molti altri ritratti, che sono sparsi in molti luoghi per Italia bellissimi, come ne può far fede quello di Lionardo Loredano, fatto da Giorgione quando era doge, da me visto in mostra per un'Assensa, che mi parve veder vivo quel serenissimo principe, oltra che ne è uno in Faenza, in casa Giovanni da Castel Bolognese, intagliatore di camei e cristalli, ecc., che è fatto per il suocero suo, lavo-ro veramente divino, perché vi è una unione sfumata ne' colori, che pare di rilievo più che dipinto.
Dilettossi molto del dipignere in fresco, e fra molte cose che fece, egli condusse tutta una facciata di Ca' Soranzo in su la piazza di San Polo. Ne la quale, oltra molti quadri e storie et altre sue fantasie, si vede un quadro lavorato a olio in su la calcina, cosa che ha retto all'acqua, al sole et al vento, e conservatasi fino a oggi. Ècci ancora una primavera, che a me pare delle belle cose che e' dipignesse in fresco, ed è gran peccato, che il tempo l'abbia consumata sì crudelmente. Et io per me non trovo cosa che nuoca più al lavoro in fresco, che gli scirocchi, e massimamente vicino a la marina, do-ve portono sempre salsedine con esso loro. Seguì in Venezia, l'anno 1504, al ponte del Rialto un fuoco terribilissimo nel Fondaco de' tedeschi, il quale lo consumò tutto, con le mercanzie e con grandissimo danno de' mercatanti: dove la Signoria di Venezia ordinò di rifarlo di nuovo, e con maggior commodità di abituri e di magnificenza e d'ornamento e bellezza fu speditamente finito, dove, essendo cresciuto la fama di Giorgione, fu consultato et ordinato da chi ne aveva la cura, che Giorgione lo dipingesse in fresco di colori, secondo la sua fantasia, purché e' mostrasse la virtù sua e che e' facesse un'opera eccellente, essendo ella nel più bel luogo e ne la maggior vista di quella città. Per il che, messovi mano, Giorgione non pensò se non a farvi figure a sua fantasia, per mostrar l'arte; che nel vero non si ritrova storia, che abbino ordine o che rappresentino i fatti di nessuna persona segnalata, o antica o moderna, et io per me non l'ho mai intese, né anche per dimanda, che si sia fatta, ho trovato chi l'intenda, perché dove è una donna, dove è un uomo in varie attitudini, chi ha una testa di lione appresso, altra con un Angelo, a guisa di Cupido, né si giudica quel che si sia. V'è bene sopra la porta principale, che riesce in merzeria, una femina a sedere, ch'ha sotto una testa d'un gigante morta, quasi in forma d'una Iuditta, ch'alza la testa con la spada e parla con un todesco, quale è a basso, né ho potuto interpretare per quel che se l'abbi fatta, se già non l'avesse voluta fare per una Germania. In somma e' si vede ben le figure sue esser molto insieme, e che andò sempre acquistando nel meglio: e vi sono teste e pezzi di figure molto ben fatte e colorite vivacissimamente. Et attese in tutto quello che egli vi fece, che traesse al segno de le cose vive e non a imitazione nessuna de la maniera. La quale opera è celebrata in Venezia e famosa non meno per quello che e' vi fece, che per il commodo delle mercanzie et utilità del pubblico. Lavorò un quadro d'un Cristo che porta la croce et un giudeo lo tira, il quale col tempo fu posto nella chiesa di San Rocco, et oggi per la devozione che vi hanno molti, fa miracoli, come si vede. Lavorò in diversi luoghi, come a Castelfranco e nel trivisano, e fece molti ritratti a vari principi italiani; e fuor d'Italia furono mandate molte de l'opere sue, come cose degne veramente, per far testimonio che se la Toscana soprabbondava di artefici in ogni tempo, la parte ancora di là vicino a' monti non era abbandonata e dimenticata sempre dal cielo.
Dicesi che Giorgione, ragionando con alcuni scultori nel tempo che Andrea Verrocchio faceva il cavallo di bronzo, che volevano perché la scultura mostrava in una figura sola diverse positure e vedute girandogli a torno, che per questo avanzasse la pittura, che non mostrava in una figura se non una parte sola, Giorgione che era d'oppinione che in una storia di pittura si mostrasse senza avere a caminare a torno, ma in una sola occhiata tutte le sorti delle vedute che può fare in più gesti un uomo, (cosa che la scultura non può fare, se non mutando il sito e la veduta, talché non sono una ma più vedute), propose di più che da una figura sola di pittura voleva mostrare il dinanzi et il didietro et i due profili dai lati: cosa che e' fece mettere loro il cervello a partito. E la fece in questo modo: dipinse uno ignudo, che voltava le spalle et aveva in terra una fonte d'acqua limpidissima, nella quale fece dentro per riverberazione la parte dinanzi; da un de' lati era un corsaletto brunito, che s'era spogliato, nel quale era il profilo manco, perché nel lucido di quell'arme si scorgeva ogni cosa; da l'altra parte era uno specchio, che drento vi era l'altro lato di quello ignudo; cosa di bellissimo ghiribizzo e capriccio, volendo mostrare in effetto che la pittura conduce con più virtù e fatica, e mostra in una vista sola del naturale, più che non fa la scultura. La qual opera fu sommamente lodata et ammirata, per ingegnosa e bella. Ritrasse ancora di naturale Caterina regina di Cipro, qual vidi io già nelle mani del clarissimo Messer Giovan Cornaro: e nel nostro libro una testa colorita a olio, ritratta da un todesco di casa Fucheri, che allora era de' maggiori mercanti nel Fondaco de' tedeschi, la quale è cosa mirabile, insieme con altri schizzi e disegni di penna fatti da lui. Mentre Giorgione attendeva ad onorare e sé e la patria sua, nel molto conversar, che e' faceva per trattenere con la musica molti suoi amici, si innamorò d'una madonna, e molto goderono l'uno e l'altra de' loro amori. Avvenne che l'anno 1511 ella infettò di peste, non ne sapendo però altro, e praticandovi Giorgione al solito, se li appiccò la peste di maniera, che in breve tempo nella età sua di 34 anni, se ne passò a l'altra vita, non senza dolore infinito di molti suoi amici, che lo amavano per le sue virtù, e danno del mondo, che perse. Pure tollerarono il danno e la perdita con lo esser restati loro due eccellenti suoi creati Sebastiano Viniziano, che fu poi frate del Piombo a Roma, e Tiziano da Cadore, che non solo lo paragonò, ma lo ha superato grandemente, de' quali a suo luogo si dirà pienamente l'onore e l'utile che hanno fatto a questa arte.
VITA DI ANTONIO DA CORREGGIO
PITTORE

Io non voglio uscire del medesimo paese, dove la gran madre natura per non essere tenuta parziale, dette al mondo di rarissimi uomini della sorte che avea già molti e molti anni adornata la Toscana, infra e' quali fu di eccellente e bellissimo ingegno dotato Antonio da Correggio pittore singularissimo. Il quale attese alla maniera moderna tanto perfettamente, che in pochi anni dotato dalla natura et esercitato dall'arte divenne raro e maraviglioso artefice. Fu molto d'a-nimo timido, e con incommodità di se stesso in continove fatiche esercitò l'arte, per la famiglia che lo aggravava: et ancora che e' fusse tirato da una bontà naturale, si affliggeva niente di manco più del dovere, nel portare i pesi di quelle passioni, che ordinariamente opprimono gli uomini. Era nell'arte molto maninconico e suggetto alle fatiche di quella e grandissimo ritrovatore di qualsivoglia difficultà delle cose, come ne fanno fede nel Duomo di Parma una moltitudine grandissima di figure, lavorate in fresco, e ben finite, che sono locate nella tribuna grande di detta chiesa: nelle quali scorta le vedute al di sotto in su con stupendissima maraviglia. Et egli fu il primo, che in Lombardia cominciasse cose della maniera moderna, per che si giudica, che se l'ingegno di Antonio fosse uscito di Lombardia e stato a Roma, avrebbe fatto miracoli e dato delle fatiche a molti che nel suo tempo furono tenuti grandi. Conciò sia che, essendo tali le cose sue senza aver egli visto de le cose antiche o de le buone moderne, necessariamente ne seguita che se le avesse vedute, arebbe infinitamente migliorato l'opere sue, e crescendo di bene in meglio sarebbe venuto al sommo de' grandi.
Tengasi pur per certo che nessuno meglio di lui toccò colori, né con maggior vaghezza o con più rilievo alcun artefice dipinse meglio di lui, tanta era la morbidezza delle carni ch'egli faceva, e la grazia con che e' finiva i suoi lavori. Egli fece ancora in detto luogo due quadri grandi lavorati a olio, nei quali, fra gli altri, in uno si vede un Cristo morto, che fu lodatissimo. Et in S. Giovanni in quella città fece una tribuna in fresco, nella quale figurò una Nostra Donna, che ascende in cielo, fra moltitudine di Angeli et altri Santi intorno; la quale pare impossibile ch'egli potesse non esprimere con la mano, ma imaginare con la fantasia per i belli andari de' panni e delle arie che e' diede a quelle figure, delle quali ne sono nel nostro libro alcune dissegnate di lapis rosso di sua mano, con certi fregi di putti bellissimi et altri fregi fatti in quella opera per ornamento, con diverse fantasie di sacrifizii alla antica; e nel vero, se Antonio non avesse condotte l'opere sue a quella perfezzione che le si veggono, i disegni suoi (se bene hanno in loro una buona maniera e vaghezza, e pratica di maestro) non gli arebbano arecato fra gli artefici quel nome, che hanno l'eccellentissime opere sue. È que-st'arte tanto dificile et ha tanti capi, che uno artefice bene spesso non li può tutti fare perfettamente; perché molti sono che hanno disegnato divinamente, e nel colorire hanno avuto qualche imperfezzione, altri hanno colorito maravigliosamente, e non hanno disegnato alla metà; questo nasce tutto dal giudizio e da una pratica che si piglia da giovane chi nel disegno e chi sopra i colori. Ma perché tutto s'impara per condurre l'opere perfette nella fine, il quale è il colorire con disegno tutto quel che si fa, per questo il Coreggio merita gran lode avendo conseguito il fine della perfezione ne l'ope-re, che egli a olio et a fresco colorì; come nella medesima città nella chiesa de' frati de' Zoccoli di S. Francesco, che vi dipinse una Nunziata in fresco tanto bene, che accadendo per aconcime di quel luogo, rovinarla, feciono que' frati ricingere il muro atorno con legnami armati di ferramenti, e tagliandolo a poco a poco la salvorono, et in un altro loco più sicuro fu murata da loro nel medesimo convento. Dipinse ancora sopra una porta di quella città una Nostra Donna, che ha il Figliuolo in braccio, ch'è stupenda cosa a vedere il vago colorito in fresco di questa opera, dove ne ha riportato da forestieri viandanti, che non hanno visto altro di suo, lode et onore infinito. In S. Antonio ancora di quella città dipinse una tavola, nella qual è una Nostra Donna e S. Maria Madalena, et apresso vi è un putto, che ride, che tiene a guisa di Angioletto un libro in mano, il quale par che rida tanto naturalmente, che muove a riso chi lo guarda, né lo vede persona di natura malinconica che non si rallegri; èvvi ancora un S. Girolamo, ed è colorita di maniera sì maravigliosa e stupenda, che i pittori ammirano quella per colorito mirabile, e che non si possa quasi dipignere meglio. Fece similmente quadri et altre pitture per Lombardia a molti signori; e fra l'altre cose sue, due quadri in Mantova al duca Federigo II, per mandare a lo imperatore, cosa veramente degna di tanto principe. Le quali opere vedendo Giulio Romano, disse non aver mai veduto colorito nessuno ch'aggiugnesse a quel segno: l'uno era una Leda ignuda, e l'altro una Venere, sì di morbidezza colorito e d'ombre di carne lavorate, che non parevano colori ma carni; era in una un paese mirabile, né mai lombardo fu che meglio facesse queste cose di lui, et oltra di ciò, capegli sì leggiadri di colore e con finita pulitezza sfilati e condotti, che meglio di quegli non si può vedere. Eranvi alcuni amori, che de le saette facevano prova su una pietra, quelle d'oro e di piombo, lavorati con bello artificio, e, quel che più grazia donava alla Venere, era una acqua chiarissima e limpida, che correva fra alcuni sassi e bagnava i piedi di quella e quasi nessuno ne ocupava. Onde nello scorgere quella candidezza con quella dilicatezza, faceva agl'occhi compassione nel vedere. Perché certissimamente Antonio meritò ogni grado et ogni onore vivo e con le voci e con gli scritti ogni gloria dopo la morte. Dipinse ancora in Modena una tavola d'una Madonna tenuta da tutti i pittori in pregio e per la maggior pittura di quella città. In Bologna parimente è di sua mano in casa gl'Arcolani, gentiluomini bolognesi, un Cristo che ne l'orto apare a Maria Madalena, cosa molto bella. In Reggio era un quadro bellissimo e raro, che non è molto che passando Messer Luciano Palavigino, il quale molto si diletta delle cose belle di pittura, e vedendolo non guardò a spesa di danari, e come avesse compero una gioia, lo mandò a Genova nella casa sua. È in Reggio medesimamente una tavola, drentovi una Natività di Cristo, ove partendosi da quello uno splendore fa lume a' pastori et intorno alle figure che lo contemplano, e fra molte considerazioni avute in questo suggetto, vi è una femina che volendo fisamente guardare verso Cristo, e per non potere gli occhi mortali sofferire la luce della sua divinità, che con i raggi par che percuota quella figura, si mette la mano dinanzi a-gl'occhi, tanto bene espressa, che è una maraviglia. Èvvi un coro di Angeli sopra la capanna che cantano, che son tanto ben fatti che par che siano piutosto piovuti dal cielo, che fatti dalla mano d'un pittore. È nella medesima città un quadretto di grandezza di un piede, la più rara e bella cosa che si possa vedere di suo di figure piccole, nel quale è un Cristo ne l'orto, pittura finta di notte, dove l'Angelo aparendogli col lume del suo splendore fa lume a Cristo, che è tanto simile al vero che non si può né immaginare né esprimere meglio; giuso a' piè del monte in un piano si veggono tre Apostoli che dormano, sopra' quali fa ombra il monte dove Cristo ora, che dà una forza a quelle figure che non è possibile; e più là, in un paese lontano, finto l'apparire della aurora; e si veggono venire da l'un de' lati alcuni soldati con Giuda; e nella sua piccolezza questa istoria è tanto bene intesa, che non si può né di pazienza, né di studio per tanta opera paragonalla.
Potrebbonsi dire molte cose delle opere di costui, ma perché fra gli uomini eccellenti de l'arte nostra è amirato per cosa divina ogni cosa che si vede di suo, non mi distenderò più. Ho usato ogni diligenzia d'avere il suo ritratto, e perché lui non lo fecie, e da altri non è stato mai ritratto, perché visse sempre positivamente, non l'ho potuto trovare; e nel vero fu persona che non si stimò né si persuase di sapere far l'arte, conoscendo la difficultà sua, con quella perfezzione che egli arebbe voluto. Contentavasi del poco e viveva da bonissimo cristiano.
Desiderava Antonio, sì come quello ch'era aggravato di famiglia, di continuo risparmiare et era divenuto perciò tanto misero che più non poteva essere. Per il che si dice che, essendoli stato fatto in Parma un pagamento di sessanta scudi di quattrini, esso volendoli portare a Correggio per alcune occorenzie sue, carico di quelli si mise in camino a piedi; e per lo caldo grande, che era allora scalmanato dal sole, beendo acqua per rinfrescarsi, si pose nel letto con una grandissima febre, né di quivi prima levò il capo, che finì la vita nell'età sua d'anni XL o circa. Furono le pitture sue circa il 1512. E fece alla pittura grandissimo dono ne' colori da lui maneggiati come vero maestro, e fu cagione che la Lombardia aprisse per lui gl'occhi, dove tanti belli ingegni si son visti nella pittura, seguitandolo in fare opere lodevoli e degne di memoria; perché mostrandoci i suoi capegli fatti con tanta facilità nella difficultà del fargli, ha insegnato come e' si abbino a fare. Di che gli debbono eternamente tutti i pittori; ad istanzia de' quali gli fu fatto questo epiggrama da Mes-ser Fabio Segni, gentiluomo fiorentino:
Huius cum regeret mortales spiritus artus
pictoris, Charites suplicuere Iovi.
Non alia pingi dextra Pater alme rogamus:
hunc praeter, nulli pingere nos liceat.
Annuit his votis summi regnator Olympi:
et iuvenem subito sydera ad alta tulit,
ut posset melius Charitum simulacra referre
praesens et nudas cerneret inde Deas.
Fu in questo tempo medesimo Andrea del Gobbo milanese, pittore e coloritore molto vago, di mano del quale sono sparse molte opere nelle case per Milano sua patria; et alla Certosa di Pavia una tavola grande con la Assunzione di Nostra Donna, ma imperfetta per la morte che li sopravvenne, la quale tavola mostra quanto egli fusse eccellente et amatore delle fatiche dell'arte.
VITA DI PIERO DI COSIMO
PITTOR FIORENTINO

Mentre che Giorgione et il Correggio con grande loro loda e gloria onoravano le parti di Lombardia, non mancava la Toscana ancor ella di belli ingegni, fra' quali non fu de' minimi Piero, figliuolo d'un Lorenzo orafo et allievo di Cosimo Rosselli, e però chiamato sempre, e non altrimenti inteso, che per Piero di Cosimo: poiché invero non meno si ha obligo e si debbe riputare per vero padre quel che c'insegna la virtù e ci dà il bene essere, che quello che ci genera e dà l'essere semplicemente. Questi dal padre, che vedeva nel figliuolo vivace ingegno et inclinazione al disegno, fu dato in cura a Cosimo, che lo prese più che volentieri, e fra molti discepoli ch'egli aveva, vedendolo crescere, con gli anni e con la virtù gli portò amore come a figliuolo e per tale lo tenne sempre. Aveva questo giovane da natura uno spirito molto elevato et era molto stratto e vario di fantasia dagli altri giovani che stavono con Cosimo per imparare la medesima arte. Costui era qualche volta tanto intento a quello che faceva, che ragionando di qualche cosa, come suole avvenire, nel fine del ragionamento, bisognava rifarsi da capo a racontargnene, essendo ito col cervello ad un'altra sua fantasia. Et era similmente tanto amico de la solitudine, che non aveva piacere, se non quando pensoso da sé solo poteva andarsene fantasticando e fare suoi castelli in aria. Onde aveva cagione di volergli ben grande Cosimo suo maestro, perché se ne serviva talmente ne l'opere sue, che spesso spesso gli faceva condurre molte cose che erano d'importanza, conoscendo che Piero aveva e più bella maniera e miglior giudizio di lui. Per questo lo menò egli seco a Roma, quando vi fu chiamato da papa Sisto, per far le storie de la cappella, in una de le quali Piero fece un paese bellissimo, come si disse ne la vita di Cosimo. E perché egli ritraeva di naturale molto eccellentemente, fece in Roma di molti ritratti di persone segnalate e particularmente quello di Verginio Orsino e di Ruberto Sanseverino, i quali misse in quelle istorie. Ritrasse ancora poi il duca Valentino figliuolo di papa Alessandro Sesto; la qual pittura oggi, che io sappia, non si trova; ma bene il cartone di sua mano, et è appresso al reverendo e virtuoso Messer Cosimo Bartoli, proposto di San Giovanni.
Fece in Fiorenza molti quadri a più cittadini, sparsi per le loro case, che ne ho visti de' molto buoni, e così diverse cose a molte altre persone. E nel noviziato di San Marco in un quadro una Nostra Donna ritta col Figliuolo in collo, colorita a olio. E ne la chiesa di Santo Spirito di Fiorenza lavorò a la cappella di Gino Capponi una tavola, che vi è dentro una Visitazione di Nostra Donna, con San Nicolò et un S. Antonio, che legge con un par d'occhiali al naso, che è molto pronto. Quivi contrafece uno libro di carta pecora un po' vecchio, che par vero, e così certe palle a quel San Niccolò con certi lustri ribattendo i barlumi, e riflessi l'una ne l'altra, che si conosceva in fino allora la stranezza del suo cervello, et il cercare che e' faceva de le cose difficili. E bene lo dimostrò meglio dopo la morte di Cosimo, che egli del continuo stava rinchiuso, e non si lasciava veder lavorare, e teneva una vita da uomo più tosto bestiale che umano. Non voleva che le stanze si spazzassino, voleva mangiare all'ora che la fame veniva, e non voleva che si zappasse o potasse i frutti dell'orto, anzi lasciava crescere le viti et andare i tralci per terra, et i fichi non si potavono mai, né gli altri alberi, anzi si contentava veder salvatico ogni cosa come la sua natura, allegando che le cose d'essa natura bisogna lassarle custodire a lei senza farvi altro. Recavasi spesso a vedere o animali o erbe o qualche cosa, che la natura fa per istranezza et accaso di molte volte; e ne aveva un contento et una satisfazione che lo furava tutto a se stesso. E replicavalo ne' suoi ragionamenti tante volte, che veniva talvolta, ancor che e' se n'avesse piacere, a fastidio. Fermavasi tallora a considerare un muro, dove lungamente fusse stato sputato da persone malate e ne cavava le battaglie de' cavagli e le più fantastiche città e più gran paesi che si vedesse mai; simil faceva de' nuvoli de l'aria. Diede opera al colorire a olio, avendo visto certe cose di Lionardo fumeggiate e finite con quella diligenza estrema, che soleva Lionardo quando e' voleva mostrar l'arte, e così Piero piacendoli quel modo cercava imitarlo, quantunque egli fusse poi molto lontano da Lionardo e da l'altre maniere assai stravagante: perché bene si può dire che e' la mutasse quasi a ciò ch'e' faceva. E se Piero non fusse stato tanto astratto et avesse tenuto più conto di sé nella vita che egli non fece, arebbe fatto conoscere il grande ingegno che egli aveva, di maniera che sarebbe stato adorato, dove egli per la bestialità sua fu più tosto tenuto pazzo, ancora che egli non facesse male se non a sé solo nella fine e benefizio et utile con le opere a l'arte sua. Per la qual cosa doverebbe sempre ogni buono ingegno et ogni eccellente artefice ammaestrato da questi esempli aver gli occhi alla fine. Né lasciarò di dire, che Piero nella sua gioventù per essere capriccioso e di stravagante invenzione fu molto adoperato nelle mascherate che si fanno per carnovale. E fu a que' nobili giovani fiorentini molto grato, avendogli lui molto migliorato e d'invenzione e d'ornamento e di grandezze e pompa quella sorte di passatempi; e sì di ciò, che fu de' primi che trovasse di mandargli fuora a guisa di trionfi, o almeno gli migliorò assai, con accomodare l'invenzione della storia non solo con musiche e parole a proposito del subietto, ma con incredibil pompa d'accompagnatura di uomini a piè et a cavallo, di abiti et abigliamenti accomodati alla storia, cosa che riusciva molto ricca e bella, et aveva insieme del grande e dello ingegnoso. E certo era cosa molto bella a vedere, di notte, venticinque o trenta coppie di cavalli richissimamente abigliati co' lor signori travestiti secondo il suggetto della invenzione, sei o otto staffieri per uno vestiti d'una livrea medesima con le torcie in mano, che tal volta passavano il numero di 400, et il carro poi, o trionfo pieno di ornamenti, o di spoglie e bizzarissime fantasie, cosa che fa assotigliare gli ingegni e dà gran piacere e satisfazione a' popoli. Fra questi, che assai furono et ingegnosi mi piace toccare brevemente d'uno, che fu principale invenzione di Piero già maturo di anni, e non come molti piacevole per la sua vaghezza, ma per il contrario per una strana et orribile et inaspettata invenzione di non piccola satisfazione a' popoli, che come ne' cibi tal volta le cose agre, così in quelli passatempi le cose orribili pur che sieno fatte con giudizio et arte, dilettano maravigliosamente il gusto umano, cosa che aparisce nel recitare le tragedie: questo fu il carro della morte da lui segretissimamente lavorato alla sala del papa, che mai se ne potette spiare cosa alcuna ma fu veduto e saputo in un medesimo punto. Era il trionfo un carro grandissimo tirato da bufoli tutto nero e dipinto di ossa di morti, e di croci bianche, e sopra il carro era una morte grandissima in cima con la falce in mano, et aveva in giro al carro molti sepolcri col coperchio, et in tutti que' luoghi che il trionfo si fermava a cantare s'a-privano et uscivano alcuni vestiti di tela nera, sopra la quale erano dipinte tutte le ossature di morto nelle braccia, petto, rene e gambe, che il bianco sopra quel nero, et aparendo di lontano alcune di quelle torcie con maschere che pigliavano col teschio di morto il dinanzi e 'l dirieto e parimente la gola, oltra al parere cosa naturalissima era orribile e spaventosa a vedere. E questi morti al suono di certe trombe sorde, e con suon roco e morto, uscivano mezzi di que' sepolcri, e sedendovi sopra cantavano in musica piena di malenconia quella oggi nobilissima canzone:
Dolor, pianto e penitenzia, etc.
Era inanzi et adrieto al carro gran numero di morti a cavallo, sopra certi cavagli con somma diligenzia scelti de' più secchi e più strutti che si potessino trovare con covertine nere piene di croci bianche, e ciascuno aveva 4 staffieri vestiti da morti con torce nere et uno stendardo grande nero con croci et ossa e teste di morto. Appresso al trionfo si strassinava 10 stendardi neri, e mentre caminavano con voce tremanti et unite diceva quella compagnia il Miserere, psalmo di Davit.
Questo duro spettacolo per la novità, come ho detto, e terribilità sua, misse terrore e maraviglia insieme in tutta quella città, e se bene non parve nella prima giunta cosa da carnovale, nondimeno per una certa novità e per essere accomodato tutto benissimo, satisfece agli animi di tutti, e Piero autore et inventore di tal cosa ne fu sommamente lodato e comendato; e fu cagione che poi di mano in mano si seguitassi di fare cose spiritose e d'ingegnosa invenzione, che invero per tali suggetti e per condurre simil feste non ha avuto questa città mai paragone; et ancora in que' vecchi che lo videro ne rimane viva memoria, né si saziano di celebrar questa capricciosa invenzione. Senti' dire io a Andrea di Cosimo, che fu con lui a fare questa opera, et Andrea del Sarto, che fu suo discepolo e vi si trovò anche egli, che e' fu opinione in quel tempo che questa invenzione fussi fatta per significare la tornata della casa de' Medici del 12 in Firenze, perché allora che questo trionfo si fece erano esuli, e come dire morti che dovessino in breve resuscitare, et a questo fine interpretavano quelle parole che sono nella canzone:
Morti siam come vedete,
così morti vedrem voi.
Fummo già come voi siete,
vo' sarete come noi, etc.
volendo accennare la ritornata loro in casa, e quasi come una ressurrezzione da morte a vita, e la cacciata et abassamento de' contrarii loro; o pure che fusse, che molti dallo effetto che seguì della tornata in Firenze di quella illustre casa, come son vaghi gli ingegni umani di aplicare le parole et ogni atto che nasce prima agli effetti che seguon poi, che gli fu dato questa interpretazione. Certo è che questo fu allora oppinione di molti e se ne parlò assai.
Ma ritornando a l'arte et azzioni di Piero, fu allogato a Piero una tavola a la cappella de' Tedaldi nella chiesa de' frati de' Servi, dove eglino tengono la veste et il guanciale di S. Filippo lor frate, nella quale finse la Nostra Donna ritta, che è rilevata da terra in un dado e con un libro in mano, senza il Figliuolo, che alza la testa al cielo, e sopra quella è lo Spirito Santo, che la illumina. Né ha voluto che altro lume, che quello che fa la colomba, lumeggi e lei e le figure che le sono intorno, come una S. Margherita et una S. Caterina che la adorano ginochioni, e ritti son a guardarla S. Pietro e S. Giovanni Evangelista, insieme con S. Filippo frate de' Servi e S. Antonino arcivescovo di Firenze. Oltra che vi fece un paese bizzarro e per gli alberi strani e per alcune grotte, e per il vero ci sono parti bellissime, come certe teste che mostrano e disegno e grazia, oltra il colorito molto continovato. E certamente che Piero possedeva grandemente il colorire a olio. Fecevi la predella con alcune storiette piccole molto ben fatte; et in fra l'altre ve n'è una, quando S. Margherita esce dal ventre del serpente, che per aver fatto quello animale e contraffatto e brutto, non penso che in quel genere si possa veder meglio, mostrando il veleno per gli occhi, il fuoco e la morte, in uno aspetto veramente pauroso. E certamente che simil cose non credo che nessuno le facesse meglio di lui né le imaginasse a gran pezzo, come ne può render testimonio un mostro marino, che egli fece e donò al Magnifico Giuliano de Medici, che per la deformità sua è tanto stravagante, bizzarro e fantastico, che pare impossibile che la natura usasse e tanta deformità e tanta stranezza nelle cose sue. Questo mostro è oggi ne la guardaroba del Duca Cosimo de' Medici; così come è anco pur di mano di Piero un libro d'animali de la medesima sorte, bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissimamente e con una pazienza inestimabile condotti. Il quale libro gli fu donato da Messer Cosimo Bartoli proposto di S. Giovanni, mio amicissimo e di tutti i nostri artefici, come quello che sempre si è dilettato et ancora si diletta di tale mestiero.
Fece parimente in casa di Francesco del Pugliese intorno a una camera diverse storie di figure piccole, né si può esprimere la diversità de le cose fantastiche che egli in tutte quelle si dilettò dipignere, e di casamenti e d'animali e di abiti e strumenti diversi, et altre fantasie che gli sovennono per essere storie di favole. Queste istorie doppo la morte di Francesco del Pugliese e de' figliuoli sono state levate né so ove sieno capitate. E così un quadro di Marte e Venere con i suoi amori e Vulcano, fatto con una grande arte e con una pazienza incredibile. Dipinse Piero per Filippo Strozzi vecchio, un quadro di figure piccole, quando Perseo libera Andromeda dal mostro, che v'è dentro certe cose bellissime. Il qual è oggi in casa il signor Sforza Almeni primo cameriere del duca Cosimo, donatogli da Messer Giovanni Batista di Lorenzo Strozzi conoscendo quanto quel signore si diletti della pittura e scoltura, et egli ne tien conto grande perché non fece mai Piero la più vaga pittura né la meglio finita di questa, atteso che non è possibile veder la più bizzarra orca marina né la più capricciosa di quella che si immaginò di dipignere Piero con la più fiera attitudine di Perseo, che in aria la percuote con la spada; quivi fra 'l timore e la speranza si vede legata Andromeda, di volto bellissima, e qua inanzi molte genti con diversi abiti strani sonando e cantando, ove sono certe teste che ridano e si rallegrano di vedere liberata Andromeda, che sono divine; il paese è bellissimo et un colorito dolce e grazioso, e quanto si può unire e sfumare colori, condusse questa opera con estrema diligenza.
Dipinse ancora un quadro dove una Venere ignuda con un Marte parimente, che spogliato nudo dorme sopra un prato pien di fiori, et attorno son diversi amori, che chi in qua chi in là traportano la celata, i bracciali e l'altre arme di Mar-te; èvvi un bosco di mirto, et un Cupido che ha paura d'un coniglio; così vi sono le colombe di Venere e l'altre cose di amore. Questo quadro è in Fiorenza in casa Giorgio Vasari tenuto in memoria sua da lui perché sempre gli piacquero i capricci di questo maestro.
Era molto amico di Piero lo spedalingo de li Innocenti, e volendo far fare una tavola, che andava all'entrata di chiesa a man manca alla cappella del Pugliese, la allogò a Piero, il qual con suo agio la condusse al fine, ma prima fece disperare lo spedalingo; che non ci fu mai ordine che la vedesse se non finita, e quanto ciò gli paresse strano, e per l'amicizia e per il sovenirlo tutto il dì di danari e non vedere quel che si faceva, egli stesso lo dimostrò, che all'ultima paga non gliele voleva dare se non vedeva l'opera. Ma minacciato da Piero che guasterebbe quel che aveva fatto, fu forzato dargli il resto, e con maggior collera che prima aver pazienza che la mettesse su, et in questa sono veramente assai cose buone.
Prese a fare per una cappella una tavola ne la chiesa di S. Piero Gattolini, e vi fece una Nostra Donna a sedere con quattro figure intorno e due Angeli in aria che la incoronano. Opera condotta con tanta diligenzia che n'acquistò lode et onore; la quale oggi si vede in S. Friano sendo rovinata quella chiesa. Fece una tavoletta de la Concezzione nel tramezzo de la chiesa di S. Francesco da Fiesole la quale è assai buona cosetta, sendo le figure non molto grandi. Lavorò per Giovan Vespucci, che stava dirimpetto a S. Michele della via de' Servi, oggi di Pier Salviati, alcune storie baccanarie che sono intorno a una camera, nelle quali fece sì strani fauni, satiri e silvani e putti e baccanti, che è una maraviglia a vedere la diversità de' zaini e delle vesti, e la varietà delle cere caprine, con una grazia et imitazione verissima. Èvvi in una storia Sileno a cavallo su uno asino con molti fanciulli, chi lo regge e chi gli dà bere, e si vede una letizia al vivo fatta con grande ingegno. E nel vero si conosce in quel che si vede di suo uno spirito molto vario et astratto dagli altri, e con certa sottilità nello investigare certe sottigliezze della natura, che penetrano, senza guardare a tempo o fatiche, solo per suo diletto e per il piacere dell'arte; e non poteva già essere altrimenti perché innamorato di lei, non curava de' suoi comodi e si riduceva a mangiar continuamente ovva sode che per rispiarmare il fuoco, le coceva quando faceva bollir la colla; e non sei, o otto per volta, ma una cinquantina, e tenendole in una sporta, le consumava a poco a poco. Nella qua-le vita così strattamente godeva, che l'altre appetto alla sua gli parevano servitù. Aveva a noia il piagner de' putti, il tos-sir de gli uomini, il suono delle campane, il cantar de' frati; e quando diluviava il cielo d'acqua, aveva piacere di veder rovinarla a piombo da' tetti e stritolarsi per terra. Aveva paura grandissima de le saette, e quando e' tonava straordinariamente, si inviluppava nel mantello e serrato le finestre e l'uscio della camera, si recava in un cantone finché passasse la furia.
Nel suo ragionamento era tanto diverso e vario, che qualche volta diceva sì belle cose che faceva crepar dalle risa altrui. Ma per la vecchiezza vicino già ad anni 80, era fatto sì strano e fantastico che non si poteva più seco. Non voleva che i garzoni gli stessino intorno, di maniera che ogni aiuto per la sua bestialità gli era venuto meno. Venivagli voglia di lavorare e per il parletico non poteva. Et entrava in tanta collera che voleva sgarare le mani, che stessino ferme, e mentre che e' borbotava, o gli cadeva la mazza da poggiare, o veramente i pennelli, che era una compassione. Adiravasi con le mosche, e gli dava noia infino a l'ombra; e così ammalatosi di vecchiaia e visitato pure da qualche amico, era pregato che dovesse acconciarsi con Dio. Ma non li pareva avere a morire, e tratteneva altrui d'oggi in domane. Non che e' non fussi buono e non avessi fede, ché era zelantissimo, ancora che nella vita fusse bestiale. Ragionava qualche volta de' tormenti che per i mali fanno distruggere i corpi e quanto stento patisce chi consumando gli spiriti a poco a poco si muore, il che è una gran miseria. Diceva male de' medici, degli speziali e di coloro che guardano gli ammalati, e che gli fanno morire di fame; oltra i tormenti degli sciloppi, medicine, cristieri et altri martorii, come il non essere lasciato dormire, quando tu hai sonno, il fare testamento, il veder piagnere i parenti e lo stare in camera al buio; e lodava la giustizia, che era così bella cosa l'andare a la morte; e che si vedeva tanta aria e tanto popolo, che tu eri confortato con i confetti e con le buone parole; avevi il prete et il popolo, che pregava per te; e che andavi con gli Angeli in paradiso; che aveva una gran sorte, chi n'usciva a un tratto. E faceva discorsi e tirava le cose a' più strani sensi che si potes-se udire. Laonde per sì strane sue fantasie vivendo stranamente si condusse a tale, che una mattina fu trovato morto appiè d'una scala, l'anno MDXXI; et in San Pier Maggiore gli fu dato sepoltura.
Molti furono i discepoli di costui, e fra gli altri Andrea del Sarto, che valse per molti. Il suo ritratto, s'è avuto da Francesco da S. Gallo che lo fece mentre Piero era vecchio, come molto suo amico e domestico; il qual Francesco ancora ha di mano di Piero (ché non la debbo passare) una testa bellissima di Cleopatra, con uno aspido avvolto al collo, e dua ritratti, l'uno di Giuliano suo padre, l'altro di Francesco Giamberti, suo avolo, che paion vivi.
VITA DI BRAMANTE DA URBINO
ARCHITETTORE

Di grandissimo giovamento alla architettura fu veramente il moderno operare di Filippo Brunelleschi, avendo egli contrafatto e dopo molte età rimesse in luce l'opere egregie de' più dotti e maravigliosi antichi. Ma non fu manco utile al secolo nostro Bramante, acciò seguitando le vestigie di Filippo, facesse agli altri dopo lui strada sicura nella professione della architettura, essendo egli di animo, valore, ingegno e scienza in quella arte non solamente teorico, ma pratico et esercitato sommamente. Né poteva la natura formare uno ingegno più spedito, che esercitasse e mettesse in opera le cose dell'arte, con maggiore invenzione e misura e con tanto fondamento quanto costui. Ma non meno punto di tutto questo fu necessario il creare in quel tempo Giulio II pontefice animoso e di lasciar memorie desiderosissimo. E fu ventura nostra e sua il trovare un tal principe, il che agli ingegni grandi avviene rare volte, a le spese del quale e' potesse mostrare il valore dello ingegno suo e quelle arteficiose difficultà che nella architettura mostrò Bramante. La virtù del quale si estese negli edifici da lui fabricati, che le modanature delle cornici, i fusi delle colonne, la grazia de' capitegli, le base, le mensole et i cantoni, le volte, le scale, i risalti et ogni ordine d'architettura tirato per consiglio o modello di questo artefice, riuscì sempre maraviglioso a chiunque lo vide. Laonde quello obligo eterno che hanno gli ingegni che studiano sopra i sudori antichi, mi pare che ancora lo debbano avere alle fatiche di Bramante. Perché se pure i Greci furono inventori della architettura et i Romani imitatori, Bramante non solo imitandogli con invenzion nuova ci insegnò, ma ancora bellezza e difficultà accrebbe grandissima all'arte, la quale per lui imbellita oggi veggiamo.
Costui nacque in Castello Durante nello stato di Urbino, d'una povera persona ma di buone qualità, e nella sua fanciullezza oltra il leggere e lo scrivere, si esercitò grandemente nello abbaco. Ma il padre che aveva bisogno che e' guadagnasse, vedendo che egli si dilettava molto del disegno, lo indirizzò ancora fanciulletto a l'arte della pittura, nella quale studiò egli molto le cose di fra' Bartolomeo, altrimenti fra' Carnovale da Urbino, che fece la tavola di S. Maria della Bella in Urbino. Ma perché egli sempre si dilettò de l'architettura e de la prospettiva, si partì da Castel Durante; e condottosi in Lombardia, andava ora in questa, ora in quella città lavorando il meglio che e' poteva. Non però cose di grande spesa o di molto onore, non avendo ancora né nome, né credito. Per il che, deliberatosi di vedere almeno qualcosa notabile, si trasferì a Milano per vedere il Duomo, dove allora si trovava un Cesare Cesariano, reputato buono geometra e buono architettore, il quale comentò Vitruvio e disperato di non averne avuto quella remunerazione che egli si aveva promessa, diventò sì strano, che non volse più operare, e divenuto salvatico morì più da bestia che da persona. Eravi ancora un Bernardino da Trevio milanese, ingegnere et architettore del Duomo e disegnatore grandissimo il quale da Lionardo da Vinci fu tenuto maestro raro, ancora che la sua maniera fusse crudetta et alquanto secca nelle pitture. Vedesi di costui in testa del Chiostro delle Grazie una Resurressione di Cristo, con alcuni scorti bellissimi; et in S. Francesco una cappella a fresco, dentrovi la morte di S. Pietro e di S. Paulo. Costui dipinse in Milano molte altre opere, e per il contado ne fece anche buon numero tenute in pregio, e nel nostro libro è una testa di carbone e biacca d'una fe-mina assai bella che ancor fa fede de la maniera ch'e' tenne.
Ma per tornare a Bramante, considerata che egli ebbe questa fabbrica e conosciuti questi ingegneri, si inanimì di sorte, che egli si risolvé del tutto darsi a l'architettura. Laonde, partitosi da Milano, se ne venne a Roma innanzi lo anno santo del MD dove conosciuto da alcuni suoi amici e del paese e lombardi, gli fu dato da dipignere a S. Giovanni Laterano sopra la porta santa che s'apre per il Giubbileo, una arme di papa Alessandro VI lavorata in fresco, con Angeli e figure che la sostengono. Aveva Bramante recato di Lombardia e guadagnati in Roma a fare alcune cose certi danari; i quali con una masserizia grandissima spendeva, desideroso poter vivere del suo et insieme, senza aver a lavorare, pote-re agiatamente misurare tutte le fabriche antiche di Roma. E messovi mano, solitario e cogitativo se n'andava; e fra non molto spazio di tempo misurò quanti edifizii erano in quella città e fuori per la campagna, e parimente fece fino a Napoli, e dovunque e' sapeva che fossero cose antiche; misurò ciò che era a Tiboli et alla villa Adriana, e come si dirà poi al suo luogo, se ne servì assai. E scoperto in questo modo l'animo di Bramante, il cardinale di Napoli datoli d'occhio prese a favorirlo. Donde Bramante seguitando lo studio, essendo venuto voglia al cardinale detto di far rifare a' frati della Pace il chiostro, di trevertino, ebbe il carico di questo chiostro. Per il che desiderando di acquistare e di gratuirsi molto quel cardinale, si messe a l'opera con ogni industria e diligenzia, e prestamente e perfettamente la condusse al fine. Et ancora che egli non fusse di tutta bellezza, gli diede grandissimo nome per non essere in Roma molti che attendessino alla architettura con tanto amore, studio e prestezza, quanto Bramante.
Servì Bramante, ne' suoi principii, per sotto architettore di papa Alessandro VI alla fonte di Trastevere e parimente a quella che si fece in sulla piazza di S. Pietro; trovossi ancora, essendo cresciuto in reputazione, con altri eccellenti architettori, alla resoluzione di gran parte del palazzo di S. Giorgio e della chiesa di S. Lorenzo in Damaso fatto fare da Raffaello Riario cardinale di S. Giorgio vicino a Campo di Fiore; che quantunque si sia poi fatto meglio, fu non di me-no, et è ancora per la grandezza sua, tenuta comoda e magnifica abitazione, e di questa fabbrica fu esecutore uno Antonio Montecavallo. Trovossi al consiglio dello accrescimento di San Iacopo degli Spagnuoli in Navona e parimente alla deliberazione di Santa Maria de Anima, fatta condurre poi da uno architetto todesco. Fu suo disegno ancora il palazzo del cardinale Adriano da Corneto, in Borgo Nuovo, che si fabricò adagio, e poi finalmente rimase imperfetto per la fuga di detto cardinale; e parimente l'accrescimento della cappella maggiore di Santa Maria del Populo fu suo disegno, le quali opere gli acquistarono in Roma tanto credito che era stimato il primo architettore per essere egli risoluto, presto e bonissimo inventore che da tutta quella città fu del continuo ne' magior bisogni da tutti e' grandi adoperato; per il che creato papa Iulio II l'anno 1503, cominciò a servirlo.
Era entrato in fantasia a quel Pontefice di acconciare quello spazio che era fra belvedere e 'l palazzo ch'egli avessi forma di teatro quadro abbracciando una valletta che era in mezzo al palazzo papale vecchio, e la muraglia che aveva per abitazione del papa fatta di nuovo Innocenzio VIII; e che da dua corridori che mettessino in mezzo questa valletta, si potessi venire di belvedere in palazzo per logge, e così di palazzo per quelle andare in belvedere, e che della valle per ordine di scale in diversi modi si potesse salire sul piano di belvedere; per il che Bramante, che aveva grandissimo giudizio et ingegno capriccioso in tal cose, spartì nel più basso con duoi ordini d'altezze prima una loggia dorica bellissima, simile al Coliseo de' Savegli, ma in cambio di mezze colonne misse pilastri, e tutta di tivertini la murò; e sopra questa uno secondo ordine ionico sodo di finestre, tanto che e' venne al piano delle prime stanze del palazzo papale et al piano di quelle di belvedere, per far poi una loggia più di 400 passi dalla banda di verso Roma, e parimente un'altra di verso il bosco, che l'una e l'altra volse che mettessino in mezzo la valle ove spianata che ella era si aveva a condurre tutta l'acqua di belvedere e fare una bellissima fontana; di questo disegno finì Bramante il primo corridore che esce di palazzo e va in belvedere dalla banda di Roma eccetto l'ultima loggia che dovea andar di sopra; ma la parte verso il bosco riscontro a questa si fondò bene, ma non si poté finire intervenendo la morte di Iulio e poi di Bramante; fu tenuta tanto bella invenzione, che si credette che dagli antichi in qua Roma non avessi veduto meglio. Ma come s'è detto del-l'altro corridore rimasero solo i fondamenti e penato a finirsi fino a questo giorno che Pio IIII gli ha dato quasi perfezzione. Fecevi ancora la testata che è in belvedere allo antiquario delle statue antiche con l'ordine delle nicchie e nel suo tempo vi si messe il Laoconte, statua antica rarissima, e lo Apollo e la Venere; ché poi il resto delle statue furon poste da Leone X, come il Tevere e 'l Nilo e la Cleopatra, e da Clemente VII alcune altre, e nel tempo di Paulo III e di Giulio III fattovi molti acconcimi d'importanzia con grossa spesa.
E tornando a Bramante, s'egli non avessi avuto i suoi ministri avari egli era molto spedito et intendeva maravigliosamente la cosa del fabricare; e questa muraglia di belvedere fu da lui con grandissima prestezza condotta et era tanta la furia di lui che faceva e del papa, che aveva voglia che tali fabriche non si murassero, ma nascessero, che i fondatori portavano di notte la sabbia et il pancone fermo della terra, e la cavavano di giorno in presenza a Bramante; perch'egli senza altro vedere faceva fondare. La quale inavvertenza fu cagione che le sue fatiche sono tutte crepate e stanno a pericolo di ruinare come fece questo medesimo corridore, del quale un pezzo di braccia ottanta ruinò a terra al tempo di Clemente VII e fu rifatto poi da Papa Paulo III et egli ancora lo fece rifondare e ringrossare.
Sono di suo in belvedere molte altre salite di scale variate secondo i luoghi suoi alti e bassi, cosa bellissima con ordine dorico, ionico e corinzio, opera condotta con somma grazia. Et aveva di tutto fatto un modello, che dicono essere stato cosa maravigliosa, come ancora si vede il principio di tale opera così imperfetta. Fece oltra questo una scala a chiocciola su le colonne che salgono, sì che a cavallo vi si cammina, nella quale il dorico entra nello ionico e così nel corinzio, e de l'uno salgono ne l'altro: cosa condotta con somma grazia e con artifizio certo eccellente; la quale non gli fa manco onore che cosa che sia quivi di man sua. Questa invenzione è stata cavata da Bramante de San Niccolò di Pisa, come si disse nella vita di Giovanni e Niccola Pisani. Entrò Bramante in capriccio di fare in belvedere, in un fregio nella facciata di fuori, alcune lettere a guisa di ieroglifi antichi, per dimostrare magiormente l'ingegno ch'aveva e per mettere il nome di quel Pontefice e 'l suo, et aveva così cominciato: “Iulio II Pont. Massimo” et aveva fatto fare una testa in profilo di Iulio Cesare, e con dua archi un ponte che diceva: “Iulio II Pont.”, et una aguglia del circolo Massimo per “Max.” di che il Papa si rise e gli fecie fare le lettere d'un braccio che ci sono oggi alla antica, dicendo che l'aveva cavata questa scioccheria da Viterbo sopra una porta dove un maestro Francesco architettore messe il suo nome in uno architrave intagliato così che fece un San Francesco, un arco, un tetto et una torre che rilevando diceva, a modo suo: “Maestro Francesco architettore”.
Volevagli il Papa per amor della virtù sua della architettura gran bene; per il che meritò da 'l detto Papa, che sommamente lo amava per le sue qualità, di essere fatto degno dell'ufficio del piombo, nel quale fece uno edificio da improntar le bolle con una vite molto bella. Andò Bramante ne' servizii di questo pontefice a Bologna quando l'anno 1504 ella tornò alla chiesa e si adoperò in tutta la guerra della Mirandola a molte cose ingegnose e di grandissima importanza. Fé molti disegni di piante e di edifizii che molto bene erano disegnati da lui come nel nostro libro ne appare alcuni ben misurati e fatti con arte grandissima. Insegnò molte cose d'architettura a Raffaello da Urbino e così gli ordinò i casamenti che poi tirò di prospettiva nella camera del Papa dov'è il monte di Parnaso, nella qual camera Raffaello ritrasse Bramante che misura con certe seste. Si risolvé il Papa di mettere in strada Giulia, da Bramante indrizzata, tutti gli uffici e le ragioni di Roma in un luogo, per la commodità ch'a i negoziatori averia recato nelle faccende, essendo continuamente fino allora state molto scomode. Onde Bramante diede principio al palazzo ch'a San Biagio su 'l Tevere si vede, nel quale è ancora un tempio corinzio non finito, cosa molto rara, et il resto del principio di opera rustica bellissimo che è stato gran danno che una sì onorata et utile e magnifica opra non si sia finita, ché da quelli della professione è tenuto il più bello ordine che si sia visto mai in quel genere.
Fece ancora San Pietro a Montorio di trevertino nel primo chiostro un tempio tondo, del quale non può di proporzione, ordine e varietà imaginarsi, e di grazia il più garbato né meglio inteso; e molto più bello sarebbe se fusse tutta la fabbrica del chiostro, che non è finita, condotta come si vede in uno suo disegno. Fece fare in Borgo il palazzo che fu di Raffaello da Urbino lavorato di mattoni e di getto con casse le colonne, e le bozze di opera dorica e rustica, cosa molto bella et invenzion nuova del fare le cose gettate. Fece ancora il disegno et ordine dell'ornamento di Santa Maria da Lo-reto, che da Andrea Sansovino fu poi continuato, et infiniti modelli di palazzi e tempii, i quali sono in Roma e per lo stato della Chiesa. Era tanto terribile l'ingegno di questo maraviglioso artefice, che e' rifece un disegno grandissimo per restaurare e dirizzare il palazzo del papa. E tanto gli era cresciuto l'animo vedendo le forze del Papa e la volontà sua corrispondere allo ingegno et alla voglia che esso aveva, che sentendolo avere volontà di buttare in terra la chiesa di Santo Pietro per rifarla di nuovo, gli fece infiniti disegni. Ma fra gli altri ne fece uno che fu molto mirabile; dove egli mostrò quella intelligenza che si poteva maggiore con dua campanili che mettono in mezzo la facciata, come si vede nelle monete che batté poi Giulio II e Leon X fatte da Carradosso, eccellentissimo orefice che nel far coni non ebbe pari, come ancora si vede la medaglia di Bramante fatta da lui molto bella. E così resoluto il Papa di dar principio alla grandissima e terribilissima fabrica di San Pietro, ne fece rovinare la metà e postovi mano con animo che di bellezza, arte, invenzione et ordine, così di grandezza, come di ricchezza e d'ornamento avessi a passare tutte le fabbriche che erano state fatte in quella città dalla potenzia di quella Republica e dall'arte et ingegno di tanti valorosi maestri; con la solita prestezza la fondò et in gran parte innanzi alla morte del Papa e sua, la tirò alta fino a la cornice, dove sono gli archi a tutti i quattro pilastri e voltò quegli con somma prestezza et arte. Fece ancora volgere la cappella principale, do-ve è la nicchia, attendendo insieme a far tirare inanzi la cappella che si chiama del re di Francia.
Egli trovò in tal lavoro il modo del buttar le volte con le casse di legno, che intagliate vengano co' suoi fregi e fogliami di mistura di calce; e mostrò negli archi, che sono in tale edificio, il modo del voltargli con i ponti impiccati, come abbiamo veduto seguitare poi con la medesima invenzione da Anton da San Gallo. Vedesi in quella parte, ch'è finita di suo, la cornice che rigira attorno di dentro correre in modo, con grazia, che il disegno di quella non può nessuna mano meglio in essa levare e sminuire. Si vede ne' suoi capitegli, che sono a foglie di ulivo di dentro, et in tutta l'o-pera dorica di fuori stranamente bellissima, di quanta terribilità fosse l'animo di Bramante; che in vero s'egli avesse avuto le forze eguali allo ingegno, di che aveva adorno lo spirito, certissimamente avrebbe fatto cose inaudite più che non fece. Perché oggi questa opera, come si dirà a' suoi luoghi, è stata dopo la morte sua molto travagliata dagli architettori; e talmente che si può dire che da quattro archi in fuori che reggono la tribuna non vi sia rimasto altro di suo, perché Raffaello da Urbino e Giuliano da San Gallo essecutori, doppo la morte di Giulio II, di quella opera, insieme con fra' Giocondo veronese, vollon cominciare ad alterarla e doppo la morte di questi, Baldassarri Peruzzi, facendo nella crociera verso Camposanto la cappella del re di Francia, alterò quell'ordine; e sotto Paulo III Antonio da San Gallo lo mutò tutto; e poi Michelagnolo Buonaroti ha tolto via le tante openioni e spese superflue, riducendolo a quella bellezza e perfezzione che nessuno di questi ci pensò mai, venendo tutto dal disegno e giudizio suo, ancora ch'egli dicesse a me parechie volte che era esecutore del disegno et ordine di Bramante, atteso che coloro che piantano la prima volta uno edifizio grande, sono quegli gli autori.
Apparve smisurato il concetto di Bramante in questa opera e gli diede un principio grandissimo, il quale se nella grandezza di sì stupendo e magnifico edifizio avesse cominciato minore, non valeva, né al San Gallo né agli altri, né anche al Buonaruoto il disegno per acrescerlo come e' valse per diminuillo, perché Bramante aveva concetto di fare magior cosa. Dicesi che egli aveva tanta la voglia di vedere questa fabrica andare innanzi, che e' rovinò in San Pietro molte cose belle, di sepolture di papi, di pitture e di musaici e che perciò aviàno smarrito la memoria di molti ritratti di persone grandi che erano sparse per quella chiesa; come principale di tutti i cristiani, salvò solo lo altare di San Piero e la tribuna vecchia et a torno vi fece uno ornamento di ordine dorico bellissimo, tutto di pietra di perperigno, acciò quando il papa viene in San Piero a dir la messa vi possa stare con tutta la corte e gl'imbasciatori de' principi cristiani, la quale non finì a fatto per la morte; e Baldassare sanese gli dette poi la perfezzione. Fu Bramante persona molto allegra e piacevole, e si dilettò sempre di giovare a' prossimi suoi. Fu amicissimo delle persone ingegnose e favorevole a quelle in ciò che e' poteva; come si vede che egli fece al grazioso Raffaello Sanzio da Urbino, pittor celebratissimo, che da lui fu condotto a Roma. Sempre splendidissimamente si onorò e visse, et al grado, dove i meriti della sua vita l'ave-vano posto, era niente quel che aveva a petto a quello che egli avrebbe speso. Dilettavasi de la poesia, e volentieri udiva e diceva in proviso in su la lira, e componeva qualche sonetto, se non così delicato come si usa ora, grave almeno e senza difetti. Fu grandemente stimato dai prelati e presentato da infiniti signori che lo conobbero. Ebbe in vita grido grandissimo e maggiore ancora dopo morte, perché la fabbrica di San Piero restò a dietro molti anni. Visse Bramante anni 70 et in Roma con onoratissime esequie fu portato dalla corte del papa e da tutti gli scultori, architettori e pittori. Fu sepolto in San Piero l'anno MDXIIII.
Fu di grandissima perdita all'architettura la morte di Bramante, il quale fu investigatore di molte buone arti ch'ag-giunse a quella, come l'invenzione del buttar le volte di getto, lo stucco, l'uno e l'altro usato dagli antichi, ma stato perduto da le ruine loro fino al suo tempo. Onde quegli che vanno misurando le cose antiche d'architettura, trovano in quelle di Bramante non meno scienza e disegno che si faccino in tutte quelle. Onde può rendersi a quegli che conoscono tal perfezzione, uno degli ingegni rari che hanno illustrato il secol nostro.
Lasciò suo domestico amico Giulian Leno, che molto valse nelle fabbriche de' tempi suoi, per provedere et eseguire la volontà di chi disegnava più che per operare di man sua, se bene aveva giudizio e grande sperienza.
Mentre visse Bramante fu adoperato da lui nell'opre sue Ventura, fallegname pistolese, il quale aveva bonissimo ingegno e disegnava assai aconciamente; costui si dilettò assai in Roma di misurare le cose antiche, e tornato a Pistoia per rinpatriarsi seguì che l'anno 1509 in quella città una Nostra Donna, che oggi si chiama della Umiltà, fece miracoli, e perché gli fu porto molte limosine, la Signoria che allora governava, deliberò fare un tempio in onor suo; per che pòrtosi questa occasione a Ventura, fece di sua mano un modello d'un tempio a otto facce largo braccia... et alto braccia... con un vestibulo o portico serrato dinanzi, molto ornato di drento e veramente bello, dove piaciuto a que' signori e capi della città, si cominciò a fabricare con l'ordine di Ventura, il quale, fatto i fondamenti del vestibulo e del tempio e finito a fatto il vestibulo che riuscì ricco di pilastri e cornicioni d'ordine corinto e d'altre pietre intagliate, e con quelle anche tutte le volte di quell'opera furon fatti a quadri scorniciati pur di pietra pien di rosoni. Il tempio [a] otto facce fu anche di poi condotto fino alla cornicie ultima, dove s'aveva a voltare la tribuna; mentre che egli visse Ventura e per non esser egli molto sperto in cose così grandi non considerò al peso della tribuna, che potesse star sicura, avendo egli nella grossezza di quella muraglia fatto nel primo ordine delle finestre e nel secondo dove son le altre un andito che camina a torno, dove egli venne a indebolir le mura ché, sendo quello edifizio da basso senza spalle, era pericoloso il voltarla e massime negli angoli delle cantonate dove aveva a pignere tutto il peso della volta di detta tribuna. Là dove doppo la morte di Ventura non è stato architetto nessuno che gli sia bastato l'animo di voltalla, anzi avevon fatto condurre in sul luogo legni grandi e grossi di alberi per farvi un tetto a capanna, che non piacendo a que' cittadini, non volsono che si mettesse in opra, e sté così scoperta molti anni tanto che l'anno 1561 suplicorno gli Operai di quella fabrica al duca Cosimo perché sua eccellenza facessi loro grazia, che quella tribuna si facesse; dove per compiacergli quel signore ordinò a Giorgio Vasari che vi andasse e vedesse di trovar modo di voltarla, che ciò fatto ne fece un modello che alzava quello edifizio sopra la cornice che aveva lassato Ventura, otto braccia per fargli spalle, e ristrinse il vano che va intorno fra muro e muro dello andito e rinfrancando le spalle, e gli angoli e le parte di sotto degli anditi che aveva fatto Ventura fra le finestre, gl'incatenò con chiave grosse di ferro doppie in sugli angoli che l'asicurava di maniera che sicuramente si poteva voltare. Dove Sua Eccellenza volse andare in sul luogo e piaciutoli tutto diede ordine che si facesse, e così sono condotte tutte le spalle e di già si è dato principio a voltar la tribuna. Sì che l'opra di Ventura verrà ricca e con più grandezza et ornamento e più proporzione, ma nel vero Ventura merita che se ne faccia memoria perché quella opera è la più notabile per cosa moderna che sia in quella città.
VITA DI FRA' BARTOLOMEO DI S. MARCO
PITTOR FIORENTINO

Vicino alla terra di Prato che è lontana a Fiorenza dieci miglia, in una villa chiamata Savignano, nacque Bartolomeo, secondo l'uso di Toscana, chiamato Baccio il quale mostrando nella sua puerizia non solo inclinazione, ma ancora attitudine al disegno, fu col mezzo di Benedetto da Maiano acconcio con Cosimo Rosselli et in casa alcuni suoi parenti, che abitavano alla Porta a San Piero Gattolini, accomodato; ove stette molti anni talché non era chiamato né inteso per altro nome che per Baccio dalla Porta. Costui, doppo che si partì da Cosimo Rosselli, cominciò a studiare con grande affezzione le cose di Lionardo da Vinci et in poco tempo fece tal frutto e tal progresso nel colorito che s'acquistò reputazione e credito d'uno de' miglior giovani dell'arte, sì nel colorito come nel disegno.
Ebbe in compagnia Mariotto Albertinelli, che in poco tempo prese assai bene la sua maniera, e con lui condusse molti quadri di Nostra Donna, sparsi per Fiorenza, de' quali tutti ragionare sarebbe cosa troppo lunga, però toccando solo d'alcuni fatti excelentemente da Baccio, uno n'è in casa di Filippo di Averardo Salviati, bellissimo e tenuto molto in pregio e caro da lui, nel quale è una Nostra Donna; un altro, non è molto, fu comperato (vendendosi fra masserizie vecchie) da Pier Maria delle Pozze, persona molto amico delle cose di pittura, che conosciuto la bellezza sua non lo lasciò per danari, nel quale è una Nostra Donna fatta con una diligenzia straordinaria. Aveva Pier del Pugliese avuto una Nostra Donna piccola di marmo di bassissimo rilievo, di mano di Donatello cosa rarissima, la quale per magiormente onorarla, gli fece fare uno tabernacolo di legno per chiuderla con dua sportellini, che datolo a Baccio dalla Porta vi fece drento dua storiette, che fu una la Natività di Cristo, l'altra la sua Circuncisione, le quali condusse Baccio di figurine a guisa di miniatura che non è possibile a olio poter far meglio; e quando poi si chiude di fuora, in su' detti sportelli dipinse pure a olio di chiaro e scuro la Nostra Donna annunziata dall'Angelo. Questa opera è oggi nello scrittoio del duca Cosimo dove egli ha tutte le antichità di bronzo di figure piccole, medaglie et altre pitture rare di minî, tenuto da Sua Eccellenza Illustrissima per cosa rara come è veramente.
Era Baccio amato in Firenze per la virtù sua, che era assiduo al lavoro, quieto e buono di natura et assai timorato di Dio, e gli piaceva assai la vita quieta e fuggiva le pratiche viziose e molto gli dilettava le predicazioni, e cercava sempre le pratiche delle persone dotte e posate. E nel vero rare volte fa la natura nascere un buono ingegno et uno [art]efice mansueto che anche in qualche tempo di quiete e di bontà non lo provegga come fece a Baccio, il quale, come si dirà di sotto, gli riuscì quello che egli desiderava, che sparsosi l'esser lui non men buono che valente, si divulgò talmente il suo nome, che da Gerozzo di Monna Venna Dini gli fu fatta allogazione d'una cappella nel Cimiterio, dove sono l'ossa de' morti nello spedale di Santa Maria Nuova, e cominciovvi un Giudizio a fresco, il quale condusse con tanta diligenza e bella maniera in quella parte che finì che, acquistandone grandissima fama, oltra quella che aveva, molto fu celebrato per aver egli con bonissima considerazione espresso la gloria del Paradiso e Cristo con i dodici Apostoli giudicare le dodici tribù, le quali con bellissimi panni sono morbidamente colorite. Oltra che si vede nel disegno, che restò a finirsi, queste figure che sono ivi tirate all'Inferno, la disperazione, il dolore e la vergogna della morte eterna, così come si conosce la contentezza e la letizia, che sono in quelle che si salvano, ancora che questa opera rimanesse imperfetta, avendo egli più voglia d'attendere alla religione che alla pittura. Perché trovandosi in questi tempi in San Marco fra' Girolamo Savonarola da Ferrara, dell'ordine de' Predicatori, teologo famosissimo, e continovando Baccio la udienza delle prediche sue, per la devozione che in esso aveva, prese strettissima pratica con lui e dimorava quasi continuamente in convento avendo anco con gli altri frati fatto amicizia.
Avenne che continovando fra' Ieronimo le sue predicazioni e gridando ogni giorno in pergamo che le pitture lascive e le musiche e' libri amorosi spesso inducono gli animi a cose mal fatte, fu persuaso che non era bene tenere in casa, dove son fanciulle, figure dipinte di uomini e donne ignude, per il che riscaldati i popoli dal dir suo il carnovale seguente, che era costume della città far sopra le piazze alcuni capannucci di stipa et altre legne, e la sera del martedì per antico costume arderle queste con balli amorosi, dove presi per mano uno uomo et una donna giravano cantando intorno certe ballate, fé sì fra' Ieronimo che quel giorno si condusse a quel luogo tante pitture e scolture ignude molte di mano di Maestri eccellenti, e parimente libri, liuti e canzonieri che fu danno grandissimo, ma particolare della pittura, dove Baccio portò tutto lo studio de' disegni che egli aveva fatto degli ignudi, e lo imitò anche Lorenzo di Credi e molti altri, che avevon nome di piagnoni; là dove non andò molto per l'affezzione che Baccio aveva a fra' Ieronimo che fece in un quadro el suo ritratto che fu bellissimo, il quale fu portato allora a Ferrara e di lì non è molto che gli è tornato in Fiorenza nella casa di Filippo di Alamanno Salviati, il quale per esser di mano di Baccio l'ha carissimo.
Avvenne poi che un giorno si levarono le parti contrarie a fra' Girolamo per pigliarlo e metterlo nelle forze della giustizia, per le sedizioni che aveva fatte in quella città. Il che vedendo, gli amici del frate si ragunarono essi ancora, in numero più di cinquecento, e si rinchiusero dentro in San Marco; e Baccio insieme con esso loro, per la grandissima affezzione che egli aveva a quella parte. Vero è che essendo pure di poco animo anzi troppo timido e vile, sentendo poco appresso dare la battaglia al convento e ferire et uccidere alcuni, cominciò a dubitare fortemente di se medesimo. Per il che fece voto, se e' campava da quella furia, di vestirsi subito l'abito di quella religione et interamente poi lo osservò. Conciò sia che finito il rumore e preso e condannato il frate alla morte, come gli scrittori delle storie più chiaramente racontano, Baccio andatosene a Prato si fece frate in S. Domenico di quel luogo, secondo che si trova scritto nelle cronache di quel convento, a dì 26 di luglio 1500, e l'anno dopo fece professione in quello stesso convento dove si fece fra-te, con grandissimo dispiacere di tutti gli amici suoi, che infinitamente si dolsero di averlo perduto e massime per sentire che egli aveva postosi in animo di non attendere più alla pittura. Laonde Mariotto Albertinelli, amico e compagno suo, a' preghi di Gerozzo Dini prese le robbe da fra' Bartolomeo, che così lo chiamò il priore nel vestirgli l'abito, e l'o-pra dell'ossa di Santa Maria Nuova condusse a fine, dove ritrasse di naturale lo spedalingo che era allora et alcuni frati valenti in cerusia, e Gerozzo che la faceva fare e la moglie interi nelle faccie dalle bande ginochioni; et in uno ignudo che siede ritrasse Giuliano Bugiardini suo creato giovane, con una zazzera come si costumava allora, che i capegli si conteriano a uno a uno tanto son diligenti; ritrassevi se stesso ancora, che è una testa in zazzera d'uno che esce d'un di quegli sepolcri; èvvi ritratto in quell'opera anche fra' Giovanni da Fiesole pittore, del quale aviàno descritto la vita, che è nella parte de' beati.
Quest'opera fu lavorata e da fra' Bartolomeo e da Mariotto in fresco tutta, che s'è mantenuta e si mantiene benissimo, et è tenuta dagli artefici in pregio perché in quel genere si può far poco più. Ma essendo fra' Bartolomeo stato in Prato molti mesi, fu poi da' sua superiori messo conventuale in San Marco di Fiorenza; e gli fu fatto da que' frati per le virtù sua molte carezze.
Aveva Bernardo del Bianco fatto far nella badia di Fiorenza in que' dì una cappella di macigno intagliata molto ricca e bella col disegno di Benedetto da Rovezzano la quale fu et è ancora oggi molto stimata per una ornata e varia opera, nella quale Benedetto Buglioni fece di terra cotta invetriata in alcune nichie figure et Angeli, tutte tonde, per finimento, e fregii pieni di Cherubini e d'imprese del Bianco; e dessiderando mettervi drento una tavola che fussi degna di quello ornamento, messesi in fantasia che fra' Bartolomeo sarebbe il proposito, et operò tutti que' mezzi amici che maggiori per disporlo; stavasi fra' Bartolomeo in convento, non attendendo ad altro che agli uffici divini et alle cose della Regola ancora che pregato molto dal priore e dagli amici suoi più cari che e' facesse qualche cosa di pittura, et era già passato il termine di quattro anni che egli non aveva voluto lavorar nulla, ma stretto in su questa occasione da Bernardo del Bianco, in fine cominciò quella tavola di San Bernardo che scrive, e nel vedere la Nostra Donna portata col Putto in braccio da molti Angeli e putti da lui coloriti pulitamente, sta tanto contemplativo che bene si conosce in lui un non so che di celeste che resplende in quella opera, a chi la considera attentamente, dove molta diligenza et amor pose insieme con un arco lavorato a fresco che vi è sopra. Fece ancora alcuni quadri per Giovanni cardinale de' Medici, e dipinse per Agnolo Doni un quadro di una Nostra Donna, che serve per altare d'una cappella in casa sua, di straordinaria bellezza.
Venne in questo tempo Raffaello da Urbino pittore a imparare l'arte a Fiorenza et insegnò i termini buoni della prospettiva a fra' Bartolomeo; perché, essendo Raffaello volonteroso di colorire nella maniera del frate e piacendogli il maneggiare i colori e lo unir suo, con lui di continuo si stava. Fece in quel tempo una tavola con infinità di figure in San Marco in Fiorenza, oggi è appresso al re di Francia che fu a lui donata, et in San Marco molti mesi si tenne a mostra. Poi ne dipinse un'altra in quel luogo, dove è posto infinito numero di figure, in cambio di quella che si mandò in Francia; nella quale sono alcuni fanciulli in aria che volano tenendo un padiglione aperto, con arte e con buon disegno e rilievo tanto grande, che paiono spiccarsi da la tavola e coloriti di colore di carne mostrano quella bontà e quella bellezza, che ogni artefice valente cerca di dare alle cose sue, la quale opera ancora oggi per eccellentissima si tiene. Sono molte figure in essa intorno a una Nostra Donna tutte lodatissime e con una grazia et affetto e pronta fierezza vivaci. Ma colorite poi con una gagliarda maniera che paion di rilievo perché volse mostrare che, oltra al disegno, sapeva dar forza e far venire con lo scuro delle ombre innanzi le figure, come appare intorno a un padiglione ove sono alcuni putti che lo tengono, che volando in aria si spiccano dalla tavola, oltre che v'è un Cristo fanciullo che sposa S. Caterina monaca, che non è possibile, in quella scurità di colorito che ha tenuto, far più viva cosa. Èvvi un cerchio di Santi da una banda che diminuiscono in prospettiva, intorno al vano d'una gran nicchia, i quali son posti con tanto ordine che paion veri e parimente dall'altra banda. E nel vero si valse assai d'immitare in questo colorito le cose di Lionardo e massime negli scuri, dove adoprò fumo da stampatori e nero di avorio abruciato; è oggi questa tavola da' detti neri molto riscurata, più che quando la fece, ché sempre sono diventati più tinti e scuri. Fecevi innanzi, per le figure principali, un San Giorgio armato, che ha uno stendardo, in mano, figura fiera, pronta, vivace e con bella attitudine. Èvvi un San Bartolomeo ritto, che merita lode grandissima insieme con due fanciulli che suonano uno il liuto e l'altro la lira; all'un de quali ha fatto raccorre una gamba e posarvi su lo strumento, le man poste alle corde in atto di diminuire, l'orecchio intento all'armonia e la testa volta in alto, con la bocca alquanto aperta, d'una maniera che chi lo guarda non può discredersi di non avere a sentire ancor la voce. Il simile fa l'altro, che acconcio per lato, con uno orecchio appoggiato alla lira, par che senta l'accordamento che fa il suono con il liuto e con la voce mentre che facendo tenore egli con gli occhi a terra va seguitando, con tener fermo e volto l'orecchio al compagno, che suona e canta, avvertenzie e spiriti veramente ingegnosi, e così stando quelli a sedere e vestiti di velo, che maravigliosi et industriosamente dalla dotta mano di fra' Bartolomeo sono condotti e tutta l'opera con ombra scura sfumatamente cacciata.
Fece poco tempo dopo un'altra tavola dirimpetto a quella la quale è tenuta buona, dentrovi la Nostra Donna et altri Santi intorno. Meritò lode straordinaria avendo introdotto un modo di fummeggiar le figure, in modo che all'arte aggiungono unione maravigliosa talmente che paiono di rilievo e vive, lavorate con ottima maniera e perfezzione. Sentendo egli nominare l'opre egregie di Michele Agnolo fatte a Roma così quelle del grazioso Raffaello, e sforzato dal grido che di continuo udiva de le maraviglie fatte dai due divini artefici, con licenza del priore si trasferì a Roma dove trattenuto da fra' Mariano Fetti, frate del Piombo, a Monte Cavallo e San Salvestro luogo suo, gli dipinse due quadri di San Pietro e San Paolo; e perché non gli riuscì molto il far bene in quella aria, come aveva fatto nella fiorentina, atteso che fra le antiche e moderne opere che vide, et in tanta copia, stordì di maniera che grandemente scemò la virtù e la eccellenza che gli pareva avere, deliberò di partirsi: e lasciò a Raffaello da Urbino che finisse uno de' quadri il quale non era finito; che fu il San Piero il quale, tutto ritocco di mano del mirabile Raffaello, fu dato a fra' Mariano. E così se ne tornò a Fiorenza, dove era stato morso più volte che non sapeva fare gli ignudi. Volse egli dunque mettersi a pruova e con fatiche mostrare ch'era attissimo ad ogni eccellente lavoro di quella arte, come alcuno altro. Laonde per prova fece in un quadro, un San Sebastiano ignudo con colorito molto alla carne simile, di dolce aria e di corrispondente bellezza alla persona parimente finito, dove infinite lode acquistò appresso agli artefici. Dicesi che, stando in chiesa per mostra questa figura, avevano trovato i frati nelle confessioni, donne che nel guardarlo avevano peccato per la leggiadria e lasciva imitazione del vivo, datagli dalla virtù di fra' Bartolomeo; per il che levatolo di chiesa, lo misero nel capitolo, do-ve non dimorò molto tempo che, da Giovan Batista della Palla comprato, fu mandato al re di Francia.
Aveva preso collera fra' Bartolomeo con i legnaioli che gli facevano alle tavole e quadri gli ornamenti i quali ave-van per costume come hanno anche oggi di coprire con i battitoi delle cornici sempre uno ottavo delle figure, là dove fra' Bartolomeo deliberò di trovare una invenzione di non fare alle tavole ornamenti et a questo San Bastiano fece fare la tavola in mezzo tondo e vi tirò una nicchia in prospettiva che par di rilievo incavata nella tavola; e così, con le cornici dipinte a torno, fece ornamento a la figura di mezzo; et il medesimo fece al nostro San Vincenzio et al San Marco che si dirà di sotto al San Vincenzio. Fece sopra l'arco d'una porta per andare in sagrestia in legno a olio un San Vincenzio dell'ordine loro che figurando quello predicar del giudizio si vede negli atti e nella testa particularmente quel terrore e quella fierezza, che sogliono essere nelle teste de' predicanti quando più s'affaticano con le minacce de la giustizia di Dio di ridurre gli uomini, ostinati nel peccato, a la vita perfetta; di maniera che non dipinta, ma vera e viva apparisce questa figura a chi la considera attentamente, con sì gran rilievo è condotto; et è peccato che si guasta e crepa tutta, per esser lavorata in su la colla fresca i color freschi, come dissi dell'opere di Piero Perugino, nelli Ingesuati.
Vennegli capriccio, per mostrare che sapeva fare le figure grandi, sendogli stato detto che aveva maniera minuta, di porre ne la faccia, dove è la porta del coro, il San Marco Evangelista, figura di braccia cinque in tavola condotta con bonissimo disegno e grande eccellenzia. Tornato poi da Napoli Salvador Billi, mercatante fiorentino, inteso la fama di fra' Bartolomeo e visto l'opere sue, li fece fare una tavola, dentrovi Cristo Salvatore, alludendo al nome suo, et i quattro Evangelisti che lo circondano, dove sono ancora due putti a' piè che tengono la palla del mondo, i quali di tenera e fresca carne benissimo sono condotti come l'altra opera tutta; sonvi ancora due profeti molto lodati. Questa tavola è posta nella Nunziata di Fiorenza sotto l'organo grande, che così volle Salvadore; et è cosa molto bella e dal frate con grande amore e con gran bontà finita, la quale ha intorno l'ornamento di marmi, tutto intagliato per le mani di Piero Rossegli. Dopo, avendo egli bisogno di pigliare aria, il priore allora amico suo lo mandò fuora ad un lor monasterio, nel quale, mentre che egli stette, accompagnò ultimamente per l'anima e per la casa l'operazione de le mani alla contemplazion de la morte. E fece a San Martino in Lucca una tavola dove a' piè d'una Nostra Donna è uno agnoletto, che suona un liuto, insieme con Santo Stefano e San Giovanni, con bonissimo disegno e colorito, mostrando in quella la virtù sua. Similmente in San Romano fece una tavola in tela, dentrovi una Nostra Donna de la Misericordia, posta su un dado di pietra et alcuni Angeli che tengono il manto, e figurò con essa un popolo su certe scalee, chi ritto, chi a sedere, chi in ginocchioni, i quali risguardano un Cristo in alto, che manda saette e folgori a dosso a' popoli. Certamente mostrò fra' Bartolomeo in questa opera possedere molto il diminuire l'ombre della pittura e gli scuri di quella con grandissimo rilievo operando, dove le difficultà dell'arte mostrò con rara et eccellente maestria e colorito, disegno et invenzione; opra tanto perfetta quanto facesse mai.
Nella chiesa medesima dipinse un'altra tavola pure in tela dentrovi un Cristo e Santa Caterina martire insieme con Santa Caterina da Siena ratta da terra in spirito, che è una figura de la quale in quel grado non si può far meglio. Ritornando egli in Fiorenza, diede opera alle cose di musica e di quelle molto dilettandosi alcune volte per passar tempo usava cantare. Dipinse a Prato dirimpetto alle carcere una tavola d'una Assunta e fece in casa Medici alcuni quadri di Nostre Donne et altre pitture ancora a diverse persone, come un quadro d'una Nostra Donna che è in camera di Lodovico Caponi, e parimente un altro di una Vergine che tiene il Figliuolo in collo con dua teste di Santi apresso allo eccellentissimo Messer Lelio Torelli, segretario maggiore dello illustrissimo Duca Cosimo, il quale lo tiene carissimo sì per virtù di fra' Bartolomeo come anche perché egli si diletta et ama e favorisce non solo gli uomini di questa arte, ma tutti i belli ingegni. In casa Pier del Pugliese oggi di Matteo Botti cittadino e mercante fiorentino fece al sommo d'una scala in un ricetto un San Giorgio armato a cavallo che giostrando amazza il serpente molto pronto; e lo fece a olio di chiaro e scuro, che si dilettò assai tutte le cose sua far così prima nell'opere a uso di cartone innanzi che le colorisse o d'inchio-stro o ombrate di aspalto e come ne apare ancora in molte cose che lassò di quadri e tavole rimase imperfette doppo la morte sua; e come anche molti disegni che di suo si veggono fatti di chiaro scuro oggi la maggior parte nel monasterio di Santa Caterina da Siena in sulla piazza di San Marco, apresso a una monaca che dipigne di cui se ne farà al suo luogo memoria, e molti di simil modo fatti che ornano in memoria di lui il nostro libro de' disegni che ne ha Messer Francesco del Garbo, fisico eccellentissimo.
Aveva openione fra' Bartolomeo quando lavorava tenere le cose vive innanzi, e per poter ritrar panni et arme et altre simil cose fece fare un modello di legno grande quanto il vivo che si snodava nelle congenture, e quello vestiva con panni naturali dove egli fece di bellissime cose, potendo egli a beneplacito suo tenerle ferme fino che egli avesse condotto l'opera sua a perfezzione, il quale modello, così intarlato e guasto come è, è apresso di noi per memoria sua. In Arezzo in Badia de' monaci neri fece la testa d'un Cristo in iscuro, cosa bellissima; e la tavola della Compagnia de' Contemplanti, la quale s'è conservata in casa del Magnifico Messer Ottaviano de' Medici et oggi è stata da Messer Alessandro suo figliuolo messa in una cappella in casa con molti ornamenti, tenendola carissima per memoria di fra' Bartolomeo e perché egli si diletta infinitamente della pittura. Nel noviziato di San Marco nella cappella una tavola della Purificazione molto vaga e con disegno condusse a buon fine. Et a Santa Maria Maddalena, luogo di detti frati, fuor di Fiorenza, dimorandovi per suo piacere, fece un Cristo et una Maddalena; e per il convento alcune cose dipinse in fresco. Similmente lavorò in fresco uno arco sopra la foresteria di San Marco, et in questo dipinse Cristo con Cleofas e Luca, dove ritrasse fra' Niccolò della Magna, quando era giovane, il quale poi arcivescovo di Capova et ultimamente fu cardinale. Cominciò in San Gallo una tavola, la quale fu poi finita da Giuliano Bugiardini, oggi allo altar maggiore di San Iacopo fra' Fossi, al canto agli Alberti. Similmente un quadro del ratto di Dina, il quale è appresso Messer Cristofano Rinieri, che dal detto Giuliano fu poi colorito, dove sono e casamenti et invenzioni molto lodati.
Gli fu da Piero Soderini allogata la tavola della sala del consiglio, che di chiaro oscuro da lui disegnata ridusse in maniera ch'era per farsi onore grandissimo. La quale è oggi in San Lorenzo, alla cappella del Magnifico Ottaviano de' Medici, onoratamente collocata, così imperfetta, nella quale sono tutti e' protettori della città di Fiorenza, e que' Santi che nel giorno loro la città ha aute le sue vittorie; dov'è il ritratto d'esso fra' Bartolomeo fattosi in uno specchio. Perché avendola cominciata e disegnata tutta, avvenne che, per il continuo lavorare sotto una finestra, il lume di quella a dosso percotendogli, da quel lato tutto intenebrato restò, non potendosi muovere punto. Onde fu consigliato che andasse al bagno a San Filippo, essendogli così ordinato da' medici; dove dimorato molto, pochissimo per questo migliorò. Era fra' Bartolomeo delle frutte amicissimo et alla bocca molto gli dilettavano, benché alla salute dannosissime gli fossero. Perché una mattina avendo mangiato molti fichi, oltra il male ch'egli aveva, gli sovragiunse una grandissima febbre; la quale in quattro giorni gli finì il corso della vita, d'età d'anni 48, onde egli con buon conoscimento rese l'anima al cielo. Dolse agli amici suoi et a' frati particolarmente la morte di lui, i quali in S. Marco nella sepoltura loro gli diedero onorato sepolcro, l'anno 1517, alli otto di ottobre. Era dispensato ne' frati che in coro a ufficio nessuno non andasse; ed il guadagno dell'opere sue veniva al convento, restandogli in mano danari per colori e per le cose necessarie del dipignere. Lasciò discepoli suoi Cecchino del Frate, Benedetto Cianfanini, Gabriel Rustici, e fra' Paolo Pistolese, al quale rimasero tutte le cose sue, fece molte tavole e quadri con que' disegni dopo la morte sua, e ne sono in San Domenico di Pistoia tre et una a Santa Maria del Sasso in Casentino. Diede tanta grazia ne' colori fra' Bartolomeo alle sue figure e quelle tanto modernamente augumentò di novità, che per tal cosa merita fra i benefattori dell'arte da noi essere annoverato.
VITA DI MARIOTTO ALBERTINELLI
PITTOR FIORENTINO

Mariotto Albertinelli, familiarissimo e cordialissimo amico e, si può dire, un altro fra' Bartolomeo, non solo per la continua conversazione e pratica, ma ancora per la simiglianza della maniera mentre che egli attese da dovero all'arte, fu figliuolo di Biagio di Bindo Albertinelli, il quale levatosi di età d'anni 20 dal battiloro, dove in fino a quel tempo aveva dato opra, ebbe i primi principi della pittura in bottega di Cosimo Rossegli, nella quale prese tal domestichezza con Baccio dalla Porta, che erono un'anima et un corpo, e fu tra loro tal fratellanza, che quando Baccio partì da Cosimo per far l'arte da sé come maestro, anche Mariotto se n'andò seco, dove alla Porta San Piero Gattolini l'uno e l'altro molto tempo dimorarono, lavorando molte cose insieme; e perché Mariotto non era tanto fondato nel disegno quanto era Baccio, si diede allo studio di quelle anticaglie che erano allora in Fiorenza, la magior parte e le migliori delle quali erano in casa Medici; e disegnò assai volte alcuni quadretti di mezzo rilievo, che erano sotto la loggia nel giardino di verso San Lorenzo, che in uno è Adone con un cane bellissimo et in un altro duoi ignudi, un che siede et ha a' piedi un cane, l'altro è ritto con le gambe sopra poste che s'appoggia ad un bastone, che sono miracolosi; e parimente due altri di simil grandezza: in uno de' quali sono due putti, che portano il fulmine di Giove, nell'altro è uno ignudo vecchio, fatto per l'occasione, che ha le ali sopra le spalle et a' piedi, ponderando con le mani un par di bilance; et oltre a questi era quel giardino tutto pieno di torsi di femine e maschi che erano non solo lo studio di Mariotto, ma di tutti gli scultori e pittori del suo tempo, che una buona parte n'è oggi nella guardaroba del Duca Cosimo et una altra nel medesimo luogo come i dua torsi di Marsia; e le teste sopra le finestre e quelle degli imperatori sopra le porte; a queste anticaglie studiando Mariotto fece gran profitto nel disegno e prese servitù con madonna Alfonsina, madre del Duca Lorenzo, la quale, perché Mariotto attendesse a farsi valente, gli porgeva ogni aiuto.
Costui dunque tramezzando il disegnare col colorire si fé assai pratico come aparì in alcuni quadri che fece per quella signora, che furno mandati da lei a Roma a Carlo e Giordano Orsini, che vennono poi nelle mani di Cesar Borgia. Ritrasse madonna Alfonsina di naturale molto bene, e gli pareva avere trovato per quella familiarità la ventura sua; ma essendo l'anno 1494, che Piero de' Medici fu bandito, mancatogli quell'aiuto e favore, ritornò Mariotto alla stanza di Baccio dove attese più assiduamente a far modegli di terra et a studiare, et affaticatosi intorno al naturale et a imitar le cose di Baccio, onde in pochi anni si fece un diligente e pratico maestro. Perché prese tanto animo, vedendo riuscir sì bene le cose sue che, imitando la maniera e l'andar del compagno, era da molti presa la mano di Mariotto per quella del frate. Perché intervenendo l'andata di Baccio al farsi frate, Mariotto, per il compagno perduto, era quasi smarrito e fuor di se stesso. E sì strana gli parve questa novella che, disperato, di cosa alcuna non si rallegrava. E se in quella parte Mariotto non avesse avuto a noia il commerzio de' frati, de' quali di continuo diceva male, et era della parte che teneva contra la fazzione di frate Girolamo da Ferrara, arebbe l'amore di Baccio operato talmente, che a forza nel convento medesimo col suo compagno si sarebbe incapucciato egli ancora. Ma da Gerozzo Dini, che faceva fare nell'ossa il Giudizio, che Baccio aveva lasciato imperfetto, fu pregato che, avendo quella medesima maniera, gli volesse dar fine. Et inoltre perché v'era il cartone finito di mano di Baccio et altri disegni, e pregato ancora da fra' Bartolomeo, che aveva avuto a quel conto danari e si faceva coscienza di non avere osservato la promessa, Mariotto all'opra diede fine; dove con diligenza e con amore condusse il resto dell'opera, talmente che molti, non lo sapendo, pensano che d'una sola mano ella sia lavorata. Per il che tal cosa gli diede grandissimo credito nell'arte. Lavorò alla Certosa di Fiorenza nel Capitolo un Crocifisso con la Nostra Donna e la Maddalena appiè della Croce et alcuni Angeli in aere, che ricolgono il sangue di Cristo, opera lavorata in fresco e con diligenza e con amore assai ben condotta. Ma, non parendo che i frati del mangiare a lor modo li trattassero, alcuni suoi giovani, che seco imparavano l'arte, non lo sapendo Mariotto, avevano contrafatto la chiave di quelle finestre onde si porge a' frati la pietanza, la quale risponde in camera loro; et alcune volte secretamente quando a uno e quando a uno altro rubavano il mangiare. Fu molto romore di questa cosa tra' frati: perché delle cose della gola si risentono così bene come gli altri; ma, facendo ciò i garzoni con molta destrezza et essendo tenuti buone persone, incolpavano coloro alcuni frati che per odio l'un dell'altro il facessero; dove la cosa pur si scoperse un giorno. Per che i frati, acciò che il lavoro si finisse, raddoppiarono la pietanza a Mariotto et a' suoi garzoni, i quali con allegrezza e risa finirono quella opera.
Alle monache di San Giuliano di Fiorenza fece la tavola dello altar maggiore, che in Gualfonda lavorò in una sua stanza, insieme con un'altra nella medesima chiesa d'un Crocifisso con Angeli e Dio Padre, figurando la Trinità in campo d'oro a olio. Era Mariotto persona inquietissima e carnale nelle cose d'amore e di buon tempo nelle cose del vivere; per che, venendogli in odio le sofisticherie e gli stillamenti di cervello della pittura, et essendo spesso dalle lingue de' pittori morso, come è continua usanza in loro, e per eredità mantenuta, si risolvette darsi a più bassa e meno faticosa e più allegra arte; et aperto una bellissima osteria fuor della porta San Gallo et al ponte Vecchio al Drago una taverna et osteria fece quella molti mesi, dicendo che aveva presa un'arte la quale era senza muscoli, scorti, prospettive e, quel ch'importa più, senza biasmo, e che quella che aveva lasciata era contraria a questa; perché imitava la carne et il sangue, e questa faceva il sangue e la carne, e che quivi ogn'ora si sentiva, avendo buon vino, lodare, et a quella ogni giorno si sentiva biasimare.
Ma pure venutagli anco questa a noia, rimorso dalla viltà del mestiero, ritornò alla pittura, dove fece per Fiorenza quadri e pitture in casa di cittadini. E lavorò a Giovan Maria Benintendi tre storiette di sua mano. Et in casa Medici per la creazione di Leon Decimo dipinse a olio un tondo della sua arme con la Fede, la Speranza e la Carità, il quale sopra la porta del palazzo loro stette gran tempo. Prese a fare nella Compagnia di S. Zanobi, allato alla canonica di Santa Maria del Fiore, una tavola della Nunziata e quella con molta fatica condusse. Aveva fatto far lumi a posta, et in su l'opera la volle lavorare, per potere condurre le vedute che alte e lontane erano, abbagliate, diminuire e crescere a suo modo. Eragli entrato in fantasia che le pitture che non avevano rilievo e forza et insieme anche dolcezza, non fussino da tenere in pregio; e perché conosceva che elle non si potevon fare uscir del piano senza ombre le quali avendo troppa oscurità restano coperte e, se son dolci, non hanno forza, egli arebbe voluto aggiungere con la dolcezza un certo modo di lavorare che l'arte fino allora non gli pareva che avesse fatto a suo modo; onde, perché se gli porse occasione in questa opera di ciò fare, si mise a far perciò fatiche straordinarie, le quali si conoscono in uno Dio Padre che è in aria, et in alcuni putti che son molto rilevati dalla tavola per uno campo scuro d'una prospettiva che egli vi fece col cielo d'una volta intagliata a mezza botte, che girando gli archi di quella e diminuendo le linee al punto, va di maniera in dentro che pare di rilievo; oltra che vi sono alcuni Angeli che volano spargendo fiori, molto graziosi.
Questa opera fu disfatta e rifatta da Mariotto, innanzi che la conducesse al suo fine, più volte; scanbiando ora il colorito o più chiaro, o più scuro e talora più vivace et acceso et ora meno; ma non si satisfacendo a suo modo, né gli parendo avere agiunto con la mano ai pensieri dell'intelletto arebbe voluto trovare un bianco che fusse stato più fiero della biacca: dove egli si mise a purgarla per poter lumeggiare in su i maggior chiari a modo suo; nientedimeno, conosciuto non poter far quello con l'arte che comprende in sé l'ingegno et intelligenzia umana, si contentò di quello che avea fatto, poi che non agiugneva a quel che non si poteva fare; e ne conseguì fra gli artefici di questa opera lode et onore, con credere ancora di cavarne per mezzo di queste fatiche da e' padroni molto più utile che non fece, intravenendo discordia fra quegli che la facevano fare e Mariotto. Ma Pietro Perugino, allora vecchio, Ridolfo Ghirlandaio e Francesco Granacci la stimarono e d'accordo il prezzo di essa opera insieme acconciarono.
Fece in San Brancazio di Fiorenza in un mezzo tondo la Visitazione di Nostra Donna; similmente in Santa Trinita lavorò in una tavola la Nostra Donna, San Girolamo e San Zanobi con diligenza, per Zanobi del Maestro; et alla chiesa della congregazione de' Preti di San Martino fece una tavola della Visitazione, molto lodata. Fu condotto al convento de la Quercia fuori di Viterbo e quivi, poi che ebbe cominciata una tavola, gli venne volontà di veder Roma, e così in quella condottosi lavorò e finì, a frate Mariano Fetti a S. Salvestro di Monte Cavallo alla cappella sua, una tavola a olio con San Domenico, Santa Caterina da Siena che Cristo la sposa, con la Nostra Donna, con delicata maniera. Et alla Quercia ritornato, dove aveva alcuni amori, ai quali, per lo desiderio del non gli avere posseduti, mentre che stette a Roma, vol-se mostrare ch'era ne la giostra valente, per che fece l'ultimo sforzo; e come quel che non era né molto giovane né valoroso in così fatte imprese, fu sforzato mettersi nel letto. Di che, dando la colpa all'aria di quel luogo, si fé portare a Fiorenza in ceste. E non gli valsero aiuti né ristori, che di quel male si morì in pochi giorni d'età d'anni 45, et in San Pier Maggiore di quella città fu sepolto.
De' disegni di mano di costui ne sono nel nostro libro di penna e di chiaro e scuro alcuni molto buoni e particolarmente una scala a chiocciola difficile molto, che bene l'intendea, tirata in prospettiva.
Ebbe Mariotto molti discepoli fra' quali fu Giuliano Bugiardini, il Francia Bigio, fiorentini, et Innocenzio da Imola, de' quali a suo luogo si parlerà. Parimente Visino pittor fiorentino fu suo discepolo e migliore di tutti questi per disegno, colorito e diligenzia e per una miglior maniera, che mostrò nelle cose che e' fece, condotte con molta diligenza. Et ancor che in Fiorenzia ne siano poche, ciò si può vedere oggi in casa di Giovambattista di Agnol Doni in un quadro d'una spera colorito a olio a uso di minio, dove sono Adamo et Eva ignudi che mangiano il pomo, cosa molto diligente; et un quadro d'un Cristo deposto di croce insieme coi ladroni, dove è uno intrigamento bene inteso di scale, quivi alcuni aiutano a dipor Cristo, et altri in sulle spalle portono un ladrone alla sepoltura, con molte varie e capricciose attitudini e varietà di figure atte a quel suggetto, le quale mostrano che egli era valent'uomo; il medesimo fu da alcuni mercanti fiorentini condotto in Ungheria dove fece molte opere e vi fu stimato assai. Ma questo povero uomo fu per poco a rischio di capitarvi male, perché essendo di natura libero e sciolto, né potendo sopportare il fastidio di certi Ungheri importuni che tutto il giorno gli rompevano il capo con lodare le cose di quel paese, come se non fusse altro bene o filicità che in quelle loro stufe e mangiar e bere, né altra grandezza o nobilità che nel loro Re et in quella corte, e tutto il resto del mondo fosse fango, parendo a lui, come è in effetto, che nelle cose d'Italia fusse altra bontà, gentilezza e bellezza, stracco una volta di queste loro sciocchezze e per ventura essendo un poco allegro, gli scappò di bocca che e' valeva più un fiasco di trebbiano et un berlingozzo che quanti re e reine furon mai in que' paesi. E se e' non si abbatteva che la cosa dette nelle mani ad un vescovo galantuomo e pratico delle cose del mondo e (che importò il tutto) discreto e che seppe e volle voltare la cosa in burla, egli imparava a scherzar con bestie, perché quelli animalacci Ungheri, non intendono le parole e pensando che egli avesse detto qualche gran cosa, come s'egli fusse per tôrre la vita e lo stato al loro re, lo volevano a furia di popolo, senza alcuna redenzione, crucifiggere. Ma quel vescovo dabbene lo cavò d'ogni inpaccio, stimando quanto meritava la virtù di quel valent'uomo e, pigliando la cosa per buon verso, lo rimise in grazia del re che, intesa la cosa, se ne prese sollazzo, e poi finalmente fu in quel paese assai stimata et onorata la virtù sua. Ma non durò la sua ventura molto tempo; perché, non potendo tollerare le stufe, né quella aria fredda, nimica della sua complessione, in breve lo condusse a fine, rimanendo però viva la grazia e fama sua in quelli che lo conobbero in vita e che poi di mano in mano videro l'opere sue.
Furono le sue pitture circa l'anno MDXII.
VITA DI RAFFAELLINO DEL GARBO
PITTOR FIORENTINO

Raffaello del Garbo, il quale, essendo mentre era fanciulletto chiamato per vezzi Raffaellino, quel nome si manten-ne poi per sempre, fu ne' suoi principii di tanta espettazione nell'arte che di già si annoverava fra i più eccellenti, cosa che a pochi interviene; ma a pochissimi poi quello che intervenne a lui che, da ottimo principio e quasi certissima speranza, si conducesse a debolissimo fine; essendo per lo più costume così delle cose naturali come delle artificiali, dai piccoli principii venire crescendo di mano in mano fino all'ultima perfezione. Ma certo molte cagioni così dell'arte come della natura ci sono incognite e non sempre, né in ogni cosa, si tiene da loro l'ordine usitato, cosa da fare stare sopra di sé bene spesso i iudizii umani. Come si sia questo si vede in Raffaellino, perché parve che la natura e l'arte si sforzassero di cominciare in lui con certi principii straordinarii, il mezzo de' quali fu meno che mediocre e il fine quasi nulla. Costui nella sua gioventù disegnò tanto quanto pittore che si sia mai esercitato in disegnare per venir perfetto, onde si veggono ancora gran numero di disegni per tutta l'arte, mandati fuora per vilissimo prezzo da un suo figliolo, parte disegnati di stile e parte di penna e d'acquerello, ma tutti sopra fogli tinti, lumeggiati di biacca e fatti con una fierezza e pratica mirabile, come molti ne sono nel nostro libro di bellissima maniera.
Oltre ciò imparò a colorire a tempera et a fresco tanto bene che le cose sue prime son fatte con una pazienzia e diligenzia incredibile, come s'è detto. Nella Minerva intorno alla sepoltura del cardinal Caraffa v'è quel cielo della volta tanto fine che par fatta da miniatori, onde fu allora tenuta dagli artefici in gran pregio, e Filippo suo maestro lo reputava in alcune cose molto migliore maestro di sé, et aveva preso Raffaello in tal modo la maniera di Filippo che pochi la conoscevano per altro che per la sua. Costui poi, nel partirsi dal suo maestro, rindolcì la maniera assai ne' panni e fé più morbidi i capegli e l'arie delle teste; et era in tanta espettazione degli artefici che mentre gli seguitò questa maniera, era stimato il primo giovane dell'arte, per che gli fu allogato dalla famiglia de' Capponi, i quali, avendo sotto la chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto fuor della porta a San Friano sul monte fatto una cappella che si chiama il Paradiso, vollono che Raffaello facesse la tavola, nella quale a olio fece la Resurrezione di Cristo con alcuni soldati, che quasi come morti sono cascati intorno al sepolcro, molto vivaci e begli, et hanno le più graziose teste che si possa vedere; fra e' quali in una testa di un giovane fu ritratto Nicola Capponi che è mirabile, parimente una figura alla quale è cascato adosso il coperchio di pietra del sepolcro ha una testa che grida, molto bella e bizzarra; per che, visto i Capponi l'opera di Raffaello esser cosa rara, gli fecion fare uno ornamento tutto intagliato con colonne tonde e riccamente messe d'oro a bolo brunito; e non andò molti anni che, dando una saetta sopra il campanile di quel luogo, forò la volta e cascò vicino a questa tavola, la quale per essere lavorata a olio non offese niente, ma dove ella passò a canto all'ornamento messo d'oro, lo consumò quel vapore, lassandovi il semplice bolo senza oro. Mi è parso scrivere questo a proposito del dipignere a olio, acciò si veda quanto importi sapere difendersi da simile ingiuria, e non solo a questa opera l'ha fatto, ma a molte altre.
Fece a fresco in sul canto d'una casa, che oggi è di Matteo Botti, fra 'l canto del ponte alla Carraia e quello della Cuculia, un tabernacoletto drentovi la Nostra Donna col Figliolo in collo, Santa Caterina e Santa Barbera ginocchioni, molto grazioso e diligente lavoro. Nella villa di Marignolle de' Girolami fece dua bellissime tavole con la Nostra Donna, San Zanobi et altri Santi, e le predelle sotto piene di figurine di storie di que' Santi fatte con diligenzia. Fece sopra le monache di San Giorgio in muro alla porta della chiesa una Pietà con le Marie intorno, e similmente sotto quello un altro arco con una Nostra Donna nel MDIIII, opera degna di gran lode. Nella chiesa di Santo Spirito in Fiorenza in una tavola sopra quella de' Nerli, di Filippo suo maestro, dipinse una Pietà, cosa tenuta molto buona e lodevole; ma in un'al-tra di San Bernardo manco perfetta di quella. Sotto la porta della sagrestia fece due tavole, una quando San Gregorio papa dice messa, che Cristo gli apare ignudo versando il sangue con la Croce in spalla, et il diacono e subdiacono parati la servono, con dua Angeli che incensano il corpo di Cristo, sotto, [in] una altra cappella, fece una tavola drentovi la Nostra Donna, San Ieronimo e San Bartolomeo, nelle quale due opere durò fatica e non poca, ma andava ogni dì peggiorando, né so a che mi attribuire questa disgrazia sua, che il povero Raffaello non mancava di studio, diligenzia e fatica, ma poco gli valeva; là dove si giudica che, venuto in famiglia grave e povero, et ogni giorno bisognando valersi di quel che guadagnava, oltre che non era di troppo animo e pigliando a far le cose per poco pregio, di mano in mano andò peggiorando, ma sempre nondimeno si vedde del buono nelle cose sue. Fece per i monaci di Cestello nel lor refettorio una storia grande nella facciata colorita in fresco nella quale dipinse il miracolo che fece Iesù Cristo de' cinque pani e duo pesci saziando cinquemila persone.
Fece allo abate de' Panichi, per la chiesa di San Salvi fuor della porta alla Croce, la tavola dello altar maggiore con la Nostra Donna, San Giovan Gualberto, San Salvi e San Bernardo cardinale degli Uberti e San Benedetto abate, e dalle bande San Batista e San Fedele armato in duo nicchie che mettevano in mezzo la tavola, la quale aveva un ricco ornamento e nella predella più storie di figure piccole della vita di San Giovan Gualberto, nel che si portò molto bene, perché fu sovenuto in quella sua miseria da quello abate al qual venne pietà di lui e della sua virtù, e Raffaello nella predella di quella tavola lo ritrasse di naturale insieme col generale loro, che governava a quel tempo. Fece in San Pier Maggiore una tavola a man ritta, entrando in chiesa, e nelle Murate un San Gismondo re. In un quadro e' fece in San Brancazio, per Girolamo Federighi, una Trinità in fresco dove e' fu sepolto ritraendovi lui e la moglie ginochioni, dove e' cominciò a tornare nella maniera minuta. Similmente fece due figure in Cestello a tempera, cioè un San Rocco e Santo Ignazio che sono alla cappella di San Bastiano. Alla coscia del ponte Rubaconte verso le Mulina fece in una cappelluccia una Nostra Donna, San Lorenzo et un altro Santo, et in ultimo si ridusse a far ogni lavoro meccanico; et ad alcune monache et altre genti, che allora ricamavano assai paramenti da chiese, si diede a fare disegni di chiaro scuro e fregiature di Santi e di storie per vilissimo prezzo, perché, ancora che egli avesse peggiorato, talvolta gli usciva di bellissimi disegni e fantasie di mano, come ne fanno fede molte carte che poi doppo la morte di coloro che ricamavono si son venduti qua e là; e nel libro del signore Spedalingo ve n'è molti che mostrano quanto valesse nel disegno. Il che fu cagione che si feciono molti parimenti e fregiature per le chiese di Fiorenza e per il dominio et anche a Roma per cardinali e vescovi, i quali sono tenuti molto begli, et oggi questo modo del ricamare in quel modo che usava Pagolo da Verona, Galieno fiorentino et altri simili, è quasi perduto, essendosi trovato un altro modo di punteggiar largo che non ha né quella bellezza né quella diligenzia, et è meno durabile assai che quello; onde egli per questo benefizio merita, se bene la povertà li diede scomodo e stento in vita, che egli abbi gloria et onore delle virtù sue doppo la morte.
E nel vero fu Raffaello sgraziato nelle pratiche, perché usò sempre con gente povere e basse come quello che avilito si vergognava di sé, atteso che nella sua gioventù fu tenuto in grande spettazione e poi si conosceva lontano dall'opere sue prima fatte in gioventù tanto eccellentemente. E così invecchiando declinò tanto da quel primo buono che le cose non parevano più di sua mano; et ogni giorno l'arte dimenticando, si ridusse poi, oltra le tavole e quadri che faceva, a dipignere ogni vilissima cosa, e tanto avvilì che ogni cosa gli dava noia, ma più la grave famiglia de' figliuoli che ave-va, ch'ogni valor dell'arte trasmutò in goffezza. Perché sovragiunto da infermità et impoverito, miseramente finì la sua vita di età d'anni 58. Fu sepolto dalla Compagnia della Misericordia in San Simone di Fiorenza nel 1524.
Lasciò dopo di sé molti che furono pratiche persone. Andò ad imparare da costui i principii dell'arte nella sua fanciullezza Bronzino, fiorentino pittore, il quale si portò poi sì bene sotto la protezzione di Iacopo da Puntorno, pittor fiorentino, che nell'arte ha fatto i medesimi frutti che Iacopo suo maestro. Il ritratto di Raffaello si è cavato da un disegno che aveva Bastiano da Monte Carlo, che fu anch'egli suo discepolo, il quale fu pratico maestro, per uomo senza disegno.
VITA DI TORRIGIANO
SCULTOR FIORENTINO
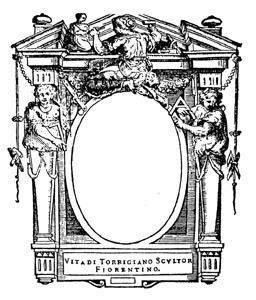
Grandissima possanza ha lo sdegno in uno che cerca con alterigia e con superbia in una professione essere stimato eccellente, e che in tempo che egli non se lo aspetti vegga levarsi di nuovo qualche bello ingegno nella medesima arte, il quale non pure lo paragoni, ma col tempo di gran lunga lo avanzi. Questi tali certamente non è ferro che per rabbia non rodessero o male che, potendo, non facessero. Perché par loro scorno ne' popoli troppo orribile lo avere visto nascere i putti, e da' nati, quasi in un tempo, nella virtù essere raggiunti; non sapendo eglino che ogni dì si vede la volontà spinta dallo studio negli anni acerbi de' giovani, quando con la frequentazione degli studi è da essi esercitata, crescere in infinito; e che i vecchi dalla paura, dalla superbia e dalla ambizione tirati, diventano goffi, e quanto meglio credono fare, peggio fanno e credendo andare inanzi ritornano a dietro. Onde essi, invidiosi, mai non dànno credito alla perfezzione de' giovani nelle cose che fanno, quantunque chiaramente le vegghino, per l'ostinazione ch'è in loro. Per che nelle prove si vede che quando eglino, per volere mostrare quel che sanno, più si sforzano, ci mostrano spesso di loro cose ridicole e da pigliarsene giuoco. E nel vero come gli artefici passano i termini, che l'occhio non sta fermo e la mano lor trema, possono, se hanno avanzato alcuna cosa, dare de' consigli a chi opera, conciò sia che l'arti della pittura e scultura vogliono l'animo tutto svegliato e fiero, sì come è nella età che bolle il sangue e pieno di voglia ardente e de' piaceri del mondo capital nimico. E chi nelle voglie del mondo non è continente, fugga gli studii di qualsivoglia arte o scienza, perciò che non bene convengono fra loro cotali piaceri e lo studio. E da che tanti pesi si recano dietro queste virtù, pochi, per ogni modo, sono coloro che arrivino al supremo grado. Onde più sono quelli che dalle mosse con caldezza si partono, che quegli, che per ben meritare nel corso, acquistino il premio.
Più superbia adunque che arte, ancor che molto valessi, si vide nel Torrigiano, scultore fiorentino; il quale nella sua giovanezza fu da Lorenzo Vecchio de' Medici tenuto nel giardino, che in sulla piazza di San Marco di Firenze aveva quel magnifico cittadino in guisa d'antiche e buone sculture ripieno, che la loggia, i viali e tutte le stanze erano adorne di buone figure antiche di marmo e di pitture et altre così fatte cose di mano de' migliori maestri che mai fussero stati in Italia e fuori. Le quali tutte cose, oltre al magnifico ornamento che facevano a quel giardino, erano come una scuola et academia ai giovanetti pittori e scultori et a tutti gl'altri che attendevano al disegno; e particolarmente ai giovani nobili, atteso che il detto Magnifico Lorenzo teneva per fermo che coloro che nascono di sangue nobile possino più agevolmente in ogni cosa venire a perfezzione, e più presto, che non fanno per lo più le genti basse, nelle quali comunemente non si veggiono quei concetti, né quel maraviglioso ingegno, che nei chiari di sangue si vede; senza che, avendo i manco nobili il più delle volte a difendersi dallo stento e dalla povertà, e per conseguente necessitati a fare ogni cosa meccanica, non possono esercitare l'ingegno, né ai sommi gradi d'eccellenza pervenire. Onde ben disse il dottissimo Alciato parlando dei belli ingegni nati poveramente e che non possono sollevarsi per essere tanto tenuti al basso dalla povertà, quanto inalzati dalle penne dell'ingegno:
Ut me pluma levat, sie grave mergit onus.
Favorì dunque il Magnifico Lorenzo sempre i belli ingegni, ma particolarmente i nobili che avevano a queste arti inclinazione; onde non è gran fatto che di quella scuola uscissero alcuni che hanno fatto stupire il mondo; e, che è più, non solo dava provisione da poter vivere e vestire a coloro che, essendo poveri, non arebbono potuto esercitare lo studio del disegno, ma ancora donativi straordinarii a chi meglio degl'altri si fusse in alcuna cosa adoperato; onde, gareggiando fra loro i giovani studiosi delle nostre arti, ne divennero, come si dirà, eccellentissimi. Era allora custode e capo di detti giovani Bertoldo, scultore fiorentino, vecchio e pratico maestro, e stato già discepolo di Donato; onde insegnava loro e parimente aveva cura alle cose del giardino et a molti disegni, cartoni e modelli di mano di Donato, Pippo, Masaccio, Paulo Ucello, fra' Giovanni, fra' Filippo e d'altri maestri paesani e forestieri. E nel vero queste arti non si possono imparare se non con lungo studio fatto in ritrarre e sforzarsi d'imitare le cose buone. E chi non ha di sì fatte commodità, se bene è dalla natura aiutato, non si può condurre, se non tardi, a perfezzione.
Ma tornando all'anticaglie del detto giardino, elle andarono la maggior parte male l'anno 1494, quando Piero, figliuolo del detto Lorenzo, fu bandito di Firenze; perciò che tutte furono vendute all'incanto. Ma non di meno la maggior parte furono l'anno 1512 rendute al Magnifico Giuliano, allora che egli e gl'altri di casa Medici ritornarono alla patria; et oggi per la maggior parte si conservano nella guardaroba del Duca Cosimo. Il quale esempio veramente magnifico di Lorenzo, sempre che sarà imitato da' principi e da altre persone onorate, recherà loro onore e lode perpetua, perché chi aiuta e favorisce nell'alte imprese i belli e pellegrini ingegni, da e' quali riceve il mondo tanta bellezza, onore, comodo et utile, merita di vivere eternamente per fama negli intelletti degli uomini. Fra gl'altri che studiarono l'arti del disegno in questo giardino riuscirono tutti questi eccellentissimi: Michelagnolo di Lodovico Bonarroti, Giovan Francesco Rustici, Torrigiano Torrigiani, Francesco Granacci, Niccolò di Domenico Soggi, Lorenzo di Credi e Giuliano Bugiardini. E de' forestieri: Baccio da Monte Lupo, Andrea Contucci dal Monte San Sovino et altri de' quali si farà memoria al luogo loro.
Il Torrigiano adunque, del quale al presente scriviamo la vita, praticando nel detto giardino con i sopra detti era di natura tanto superbo e colloroso, oltre all'essere di persona robusta, d'animo fiero e coraggioso, che tutti gl'altri bene spesso soperchiava di fatti e di parole; era la sua principale professione la scoltura, ma non di meno lavorava di terra molto pulitamente e con assai bella e buona maniera, ma, non potendo egli sopportare che niuno con l'opere gli passasse inanzi, si metteva a guastar con le mani quell'opere di man d'altri, alla bontà delle quali non poteva con l'ingegno arrivare. E, se altri di ciò se risentiva, egli spesso veniva ad altro che a parole. Aveva costui particolar odio con Michelagnolo, non per altro se non perché lo vedeva studiosamente attendere all'arte, e sapeva che nascosamente la notte et il giorno delle feste disegnava in casa, onde poi nel giardino riusciva meglio che tutti gl'altri et era per ciò molto carezzato dal Magnifico Lorenzo; per che, mosso da crudele invidia, cercava sempre d'offenderlo di fatti o di parole; onde venuti un giorno alle mani, diede il Torrigiano a Michelagnolo sì fattamente un pugno sul naso, che glielo infranse, di maniera che lo portò poi sempre così stiacciato mentre che visse. La qual cosa avendo intesa il Magnifico ne ebbe tanto sdegno che, se il Torrigiano non si fuggiva di Firenze, n'arebbe ricevuto qualche grave castigo. Andatosene dunque a Roma, dove allora faceva lavorare Alessandro VI Torre Borgia, vi fece il Torrigiano in compagnia d'altri maestri molti lavori di stucchi, poi dandosi danari per lo duca Valentino che faceva guerra ai Romagnuoli, il Torrigiano fu sviato da alcuni giovani fiorentini; e così fattosi in un tratto di scultore soldato, si portò in quelle guerre di Romagna valorosamente; il medesimo fece con Paulo Vitelli nella guerra di Pisa. E con Piero de' Medici si trovò nel fatto d'arme del Garigliano, dove si acquistò una insegna e nome di valente alfiere. Finalmente, conoscendo che non era per mai venire, ancor che lo meritasse, come disiderava al grado di capitano e non avere alcuna cosa avanzato nella guerra anzi aver consumato vanamente il tempo, ritornò alla scoltura, et avendo fatto ad alcuni mercatanti fiorentini operette di marmo e di bronzo in figure piccole, che sono in Fiorenza per le case de' cittadini, e disegnato molte cose con fierezza e buona maniera, come si può vedere in alcune carte del nostro libro di sua mano insieme con altre, le quali fece a concorrenza di Michelagnolo, fu dai su detti mercanti condotto in Inghilterra dove lavorò in servigio di quel re infinite cose di marmo, di bronzo e di legno a concorrenza d'alcuni maestri di quel paese ai quali tutti restò superiore. E ne cavò tanti e così fatti premii che, se non fusse stato, come superbo, persona inconsiderata e senza governo, sarebbe vivuto quietamente e fatto ottima fine, là dove gli avvenne il contrario.
Dopo, essendo condotto d'Inghilterra in Ispagna, vi fece molte opere che sono sparse in diversi luoghi e sono molto stimate; ma in fra l'altre fece un Crocifisso di terra che è la più mirabile cosa che sia in tutta la Spagna. E fuori della città di Siviglia in un monasterio de' frati di San Girolamo fece un altro Crucifisso et un San Girolamo in penitenza col suo lione, nella figura del qual Santo ritrasse un vecchio dispensiero de' Botti, mercanti fiorentini in Ispagna, et una Nostra Donna col Figliuolo, tanto bella ch'ella fu cagione che ne facesse un'altra simile al Duca d'Arcus, il quale per averla fece tante promesse a Torrigiano, che egli si pensò d'esserne ricco per sempre. La quale opera finita, gli donò quel Duca tante di quelle monete che chiamano maravelìs, che vagliono poco o nulla, che il Torrigiano al quale ne andarono due persone a casa cariche si confermò maggiormente nella sua openione d'avere a esser richissimo. Ma avendo poi fatta contare e vedere a un suo amico fiorentino quella moneta e ridurla al modo italiano, vide che tanta somma non arrivava pure a trenta ducati, per che, tenendosi beffato, con grandissima collera andò dove era la figura che aveva fatto per quel Duca e tutta guastolla. Laonde quello Spagnuolo, tenendosi vituperato, accusò il Torrigiano per eretico; onde essendo messo in prigione et ogni dì esaminato e mandato [da] uno inquisitore all'altro, fu giudicato finalmente degno di gravissima punizione. La quale non fu messa altrimenti in esecuzione, perché esso Torrigiano per ciò venne in tanta maninconia che, stato molti giorni senza mangiare e per ciò debilissimo divenuto, a poco a poco finì la vita; e così col torsi il cibo si liberò dalla vergogna in che sarebbe forse caduto, essendo, come si credette, stato condennato a morte.
Furono l'opere di costui circa gl'anni di nostra salute 1515. E morì l'anno 1522.
VITA DI GIULIANO ET ANTONIO DA SAN GALLO
ARCHITETTI FIORENTINI

Francesco di Paulo Giamberti, il quale fu ragionevole architetto al tempo di Cosimo de' Medici e fu da lui molto adoperato, ebbe due figliuoli: Giuliano et Antonio, i quali mise all'arte dell'intagliare di legno, e col Francione legnaiuolo, persona ingegnosa, il quale similmente attendeva agl'intagli di legno et alla prospettiva, e col quale aveva molto dimestichezza, avendo eglino insieme molte cose e d'intaglio e d'architettura operato per Lorenzo de' Medici; acconciò, il detto Francesco, Giuliano uno de' detti suoi figliuoli, il quale Giuliano imparò in modo bene tutto quello che il Francione gl'insegnò, che gl'intagli e le bellissime prospettive, che poi da sé lavorò nel coro del Duomo di Pisa, sono ancor oggi, fra molte prospettive nuove, non senza maraviglia guardate. Mentre che Giuliano attendeva al disegno et il sangue della giovanezza gli bolliva, l'esercito del Duca di Calavria, per l'odio che quel signore portava a Lorenzo de' Medici, s'accampò alla Castellina per occupare il dominio alla Signoria di Fiorenza e per venire, se gli fusse riuscito, a fine di qualche suo disegno maggiore; per che, essendo forzato il Magnifico Lorenzo a mandare uno ingegnero alla Castellina, che facesse molina e bastie e che avesse cura e maneggiasse l'artiglieria, il che pochi in quel tempo sapevano fare, vi mandò Giuliano, come d'ingegno più atto e più destro e spedito e da lui conosciuto, come figliuolo di Francesco, stato amorevole servitore di casa Medici. Arrivato Giuliano alla Castellina, fortificò quel luogo dentro e fuori di buone mura e di mulina, e d'altre cose necessarie alla difesa di quella la provide. Dopo, veggendo gli uomini star lontani all'artiglieria e maneggiarla e caricarla e tirarla timidamente, si gettò a quella e l'acconciò di maniera che da indi in poi a nessuno fece male, avendo ella prima occiso molte persone, le quali nel tirarla, per poco giudizio loro, non avevano saputo far sì che nel tornare a dietro non offendesse. Presa dunque Giuliano la cura della detta artiglieria fu tanta nel tirarla e servirsene la sua prudenza che il campo del Duca impaurì di sorte, che per questo et altri impedimenti ebbe caro di accordarsi e di lì partirsi. Di che conseguì Giuliano non piccola lode in Fiorenza appresso Lorenzo, onde fu poi di continuo ben veduto e carezzato. Intanto, essendosi dato alle cose d'architettura, cominciò il primo chiostro di Cestello, e ne fece quella parte che si vede di componimento ionico, ponendo i capitelli sopra le colonne con la voluta che girando cascava fino al collarino dove finisce la colonna, avendo sotto l'uovolo e fusarola fatto un fregio alto il terzo del diametro di detta colonna; il quale capitello fu ritratto da uno di marmo antichissimo, stato trovato a Fiesole da Messer Lionardo Salutati, vescovo di quel luogo, che lo tenne con altre anticaglie un tempo nella via di San Gallo in una casa e giardino dove abitava dirimpetto a Santa Agata; il quale capitello è oggi appresso Messer Giovanbatista da Ricasoli, vescovo di Pistoia, e tenuto in pregio per la bellezza e varietà sua, essendo che fra gl'antichi non se n'è veduto un altro simile. Ma questo chiostro rimase imperfetto per non potere fare allora quei monaci tanta spesa.
Intanto, venuto in maggior considerazione Giuliano appresso Lorenzo, il quale era in animo di fabricare al Poggio a Caiano, luogo fra Fiorenza e Pistoia, e n'aveva fatto fare più modelli al Francione et ad altri, esso Lorenzo fece fare di quello che aveva in animo di fare un modello a Giuliano, il quale lo fece tanto diverso e vario dalla forma degl'altri e tanto secondo il capriccio di Lorenzo che egli cominciò subitamente a farlo mettere in opera come migliore di tutti; et accresciutogli grado per queste, gli dette poi sempre provisione. Volendo poi fare una volta alla sala grande di detto palazzo nel modo che noi chiamiamo a botte, non credeva Lorenzo che per la distanzia si potesse girare; onde Giuliano, che fabricava in Fiorenza una sua casa, voltò la sala sua a similitudine di quella per far capace la volontà del magnifico Lorenzo; per che egli quella del Poggio felicemente fece condurre. Onde la fama sua talmente era cresciuta che a' preghi del Duca di Calavria fece il modello d'un palazzo, per commissione del Magnifico Lorenzo che doveva servire a Napoli, e consumò gran tempo a condurlo. Mentre adunque lo lavorava, il castellano di Ostia, vescovo allora della Rovere, il quale fu poi co 'l tempo Papa Giulio II, volendo acconciare e mettere in buono ordine quella fortezza, udita la fama di Giuliano, mandò per lui a Fiorenza, et ordinatoli buona provisione ve lo tenne due anni a farvi tutti quegli utili e comodità che poteva con l'arte sua. E perché il modello del Duca di Calavria non patisse e finir si potesse, ad Antonio suo fratello lasciò che con suo ordine lo finisse, il quale nel lavorarlo aveva con diligenza seguitato e finito, essendo Antonio ancora di sofficienza in tale arte non meno che Giuliano. Per il che fu consigliato Giuliano da Lorenzo Vecchio a presentarlo egli stesso, acciò che in tal modello potesse mostrare le difficultà che in esso aveva fatto; laonde partì per Napoli e, presentato l'opera, onoratamente fu ricevuto, non con meno stupore de lo averlo il Magnifico Lorenzo mandato con tanto garbata maniera, quanto con maraviglia per il magisterio de l'opera nel modello; il quale piacque sì che si diede con celerità principio all'opera vicino al Castel Nuovo.
Poi che Giuliano fu stato a Napoli un pezzo, nel chiedere licenza al Duca per tornare a Fiorenza, gli fu fatto dal re presenti di cavalli e vesti e fra l'altre d'una tazza d'argento con alcune centinaia di ducati, i quali Giuliano non volle accettare, dicendo che stava con padrone il quale non aveva bisogno d'oro né d'argento. E se pure gli voleva far presente o alcun segno di guidardone, per mostrare che vi fosse stato, gli donasse alcuna de le sue anticaglie a sua elezzione. Le quali il re liberalissimamente per amor del Magnifico Lorenzo e per le virtù di Giuliano gli concesse, e queste furono: la testa d'uno Adriano imperatore, oggi sopra la porta del giardino in casa Medici, una femmina ignuda più che 'l naturale et un Cupido che dorme, di marmo tutti tondi; le quali Giuliano mandò a presentare al Magnifico Lorenzo, che per ciò ne mostrò infinita allegrezza, non restando mai di lodar l'atto del liberalissimo artefice, il quale rifiutò l'oro e l'ar-gento per l'artificio, cosa che pochi averebbono fatto; questo Cupido è oggi in guardaroba del Duca Cosimo.
Ritornato dunque Giuliano a Fiorenza fu gratissimamente raccolto dal Magnifico Lorenzo, al quale venne capriccio, per sodisfare a frate Mariano da Ghinazzano, literatissimo de l'Ordine de' frati eremitani di Santo Agostino, di edificargli, fuor de la porta S. Gallo, un convento capace per cento frati, del quale ne fu da molti architetti fatto modelli, et in ultimo si mise in opera quello di Giuliano. Il che fu cagione che Lorenzo lo nominò da questa opera Giuliano da San Gallo. Onde Giuliano, che da ognuno si sentiva chiamare da San Gallo, disse un giorno burlando al Magnifico Lorenzo: “Colpa del vostro chiamarmi da San Gallo, mi fate perdere il nome del casato antico; e credendo avere andare inanzi per antichità, ritorno a dietro”. Per che Lorenzo gli rispose che più tosto voleva che per la sua virtù egli fosse principio d'un casato nuovo che dependessi da altri; onde Giuliano di tal cosa fu contento. Seguitandosi pertanto l'opera di San Gallo insieme con le altre fabriche di Lorenzo, non fu finita né quella né l'altre per la morte di esso Lorenzo. E poi ancora poco viva in piede rimase tal fabrica di San Gallo, perché nel 1530 per lo assedio di Fiorenza fu rovinata e buttata in terra insieme col borgo, che di fabriche molto belle aveva piena tutta la piazza; et al presente non vi si vede alcun vestigio né di casa, né di chiesa, né di convento.
Successe in quel tempo la morte del re di Napoli, e Giuliano Gondi, ricchissimo mercante fiorentino, se ne tornò a Fiorenza, e dirimpetto a San Firenze, di sopra dove stavano i lioni fece di componimento rustico fabricare un palazzo da Giuliano, col quale, per la gita di Napoli, aveva stretta dimestichezza. Questo palazzo doveva fare la cantonata finita e voltare verso la Mercatanzia Vecchia, ma la morte di Giuliano Gondi la fece fermare; nel qual palazzo fece fra l'altre cose un cammino molto ricco d'intagli e tanto vario di componimento e bello che non se n'era insino alora veduto un simile, né con tanta copia di figure.
Fece il medesimo per un viniziano, fuor de la porta a Pinti in Camerata, un palazzo, et a' privati cittadini molte case, delle quali non accade far menzione. E volendo il Magnifico Lorenzo, per utilità publica et ornamento dello stato lasciar fama e memoria, oltre alle infinite che procacciate si aveva, fare la fortificazione del Poggio Imperiale sopra Poggibonzi su la strada di Roma per farci una città, non la volle disegnare senza il consiglio e disegno di Giuliano; onde per lui fu cominciata quella fabbrica famosissima, nella quale fece quel considerato ordine di fortificazione e di bellezza che oggi veggiamo. Le quali opere gli diedero tal fama che dal Duca di Milano, a ciò che gli facesse il modello d'un palazzo per lui, fu per il mezzo poi di Lorenzo condotto a Milano, dove non meno fu onorato Giuliano dal Duca che e' si fusse stato onorato prima dal re quando lo fece chiamare a Napoli. Perché, presentando egli il modello per parte del Magnifico Lorenzo, riempié quel Duca di stupore e di maraviglia nel vedere in esso l'ordine e la distribuzione di tanti begli ornamenti, e con arte tutti e con leggiadria accomodati ne' luoghi loro. Il che fu cagione che, procacciate tutte le cose a ciò necessarie, si cominciasse a metterlo in opera. Nella medesima città furono insieme Giuliano e Lionardo da Vinci, che lavorava col Duca, e parlando esso Lionardo del getto che far voleva del suo cavallo, n'ebbe bonissimi documenti. La quale opra fu messa in pezzi per la venuta de' Franzesi, e così il cavallo non si finì, né ancora si poté finire il palazzo.
Ritornato Giuliano a Fiorenza, trovò che Antonio suo fratello, che gli serviva ne' modegli, era divenuto tanto egregio che nel suo tempo non c'era chi lavorasse et intagliasse meglio di esso e massimamente Crocifissi di legno grandi, come ne fa fede quello sopra lo altar maggiore nella Nunziata di Fiorenza, et uno che tengono i frati di San Gallo in San Iacopo tra' Fossi et uno altro nella Compagnia dello Scalzo, i quali sono tutti tenuti bonissimi. Ma egli lo levò da tale essercizio et alla architettura in compagnia sua lo fece attendere, avendo egli per il privato e publico a fare molte faccende. Avvenne, come di continuo avviene, che la fortuna nimica della virtù levò gli appoggi delle speranze a' virtuosi con la morte di Lorenzo de' Medici; la quale non solo fu cagione di danno agli artefici virtuosi et alla patria sua, ma a tutta l'Italia ancora; onde rimase Giuliano con gli altri spirti ingegnosi sconsolatissimo, e per lo dolore si trasferì a Prato vicino a Fiorenza a fare il tempio della Nostra Donna delle carcere, per essere ferme in Fiorenza tutte le fabbriche publiche e private. Dimorò dunque in Prato tre anni continui, con sopportare la spesa, il disagio e 'l doloro come potette il meglio. Dopo, avendosi a ricoprire la chiesa della Madonna di Loreto e voltare la cupola, già stata cominciata e non finita da Giuliano da Maiano, dubitavano coloro che di ciò avevano la cura, che la debolezza de' pilastri non reggesse così gran peso; per che scrivendo a Giuliano che, se voleva, tale opera andasse a vedere, egli come animoso e valente andò e mostrò con facilità quella poter voltarsi e che a ciò gli bastava l'animo; e tante e tali ragioni allegò loro che l'opera gli fu allogata. Dopo la quale allogazione fece spedire l'opera di Prato e coi medesimi maestri muratori e scarpellini a Loreto si condusse. E perché tale opra avesse fermezza nelle pietre, e saldezza e forma e stabilità e facesse legazione, mandò a Roma per la pozzolana; né calce fu che con essa non fosse temperata e murata ogni pietra; e così in termine di tre anni quella finita e libera rimase perfetta.
Andò poi a Roma, dove a papa Alessandro vi restaurò il tetto di Santa Maria Maggiore, che ruinava; e vi fece quel palco ch'al presente si vede. Così nel praticare per la corte il vescovo della Rovere, fatto cardinale di San Pietro in Vincola, già amico di Giuliano fin quando era castellano d'Ostia, gli fece fare il modello del palazzo di S. Pietro in Vincola. E poco dopo questo, volendo edificare a Savona sua patria un palazzo, volle farlo similmente col disegno e con la presenzia di Giuliano. La quale andata gli era difficile, perciò che il palco non era ancor finito e papa Alessandro non voleva ch'e' partisse. Per il che lo fece finire per Antonio suo fratello, il quale, per avere ingegno buono e versatile, nel praticare la corte contrasse servitù col Papa, che gli mise grandissimo amore e glielo mostrò nel volere fondare e rifondare con le difese a uso di castello, la Mole di Adriano, oggi detta Castel Santo Agnolo; alla quale impresa fu preposto Antonio. Così si fecero i torrioni da basso, i fossi e l'altre fortificazioni che al presente veggiamo. La quale opera gli diè credito grande appresso il Papa e col duca Valentino, suo figliuolo; e fu cagione ch'egli facesse la rocca che si vede oggi a Civita Castellana. E così, mentre quel Pontefice visse, egli di continuo attese a fabbricare, e per esso lavorando fu non meno premiato che stimato da lui.
Già aveva Giuliano a Savona condotto l'opera innanzi quando il cardinale, per alcuno suoi bisogni, ritornò a Roma e lasciò molti Operai ch'alla fabbrica dessero perfezzione con l'ordine e col disegno di Giuliano, il quale ne menò seco a Roma et egli fece volentieri questo viaggio per rivedere Antonio e l'opere d'esso, dove dimorò alcuni mesi. Ma venendo in quel tempo il cardinale in disgrazia del Papa, si partì da Roma per non esser fatto prigione e Giuliano gli tenne sempre compagnia. Arrivati dunque a Savona crebbero maggior numero di maestri da murare et altri artefici in sul lavoro. Ma facendosi ognora più vivi i romori del Papa contra il cardinale, non stette molto che se n'andò in Avignone, e d'un modello, che Giuliano aveva fatto d'un palazzo per lui, fece fare un dono al re; il quale modello era maraviglioso, ricchissimo d'ornamenti e molto capace per lo allogiamento di tutta la sua corte. Era la corte reale in Lione quando Giuliano presentò il modello, il quale fu tanto caro et accetto al re che largamente lo premiò e gli diede lode infinite e ne rese molte grazie al cardinale che era in Avignone. Ebbero intanto nuove che il palazzo di Savona era già presso alla fine; per il che il cardinale deliberò che Giuliano rivedesse tale opera, per che andato Giuliano a Savona poco vi dimorò che fu finito a fatto. Laonde Giuliano, desiderando tornare a Firenze, dove per lungo tempo non era stato, con que' maestri prese il cammino e, perché aveva in quel tempo il re di Francia rimesso Pisa in libertà e durava ancora la guerra tra Fiorentini e Pisani, volendo Giuliano passare, si fece in Lucca fare un salvo condotto, avendo eglino de' soldati pisani non poco sospetto. Ma non di meno nel lor passare vicino ad Altopascio furono da' Pisani fatti prigioni, non curando essi salvo condotto né cosa che avessero. E per sei mesi fu ritenuto in Pisa, con taglia di trecento ducati; né prima che gl'avesse pagati se ne tornò a Fiorenza.
Aveva Antonio a Roma inteso queste cose, et avendo desiderio di rivedere la patria e 'l fratello, con licenzia partì da Roma, e nel suo passaggio disegnò al Duca Valentino la rocca di Monte Fiascone. E così a Fiorenza si ricondusse l'an-no 1503, e quivi con allegrezza di loro e degli amici si goderono. Seguì allora la morte di Alessandro VI e la successione di Pio III che poco visse e fu creato pontefice il cardinale di S. Pietro in Vincola, chiamato papa Giulio II, la qual cosa fu di grande allegrezza a Giuliano per la lunga servitù che aveva seco. Onde deliberò andare a baciargli il piede, perché giunto a Roma fu lietamente veduto e con carezze raccolto, e subito fu fatto esecutore delle sue prime fabbriche innanzi la venuta di Bramante. Antonio, che era rimasto a Fiorenza, sendo gonfaloniere Pier Soderini, non ci essendo Giuliano continuò la fabbrica del Poggio Imperiale, dove si mandavano a lavorare tutti i prigioni pisani per finire più tosto tal fabbrica. Fu poi per i casi d'Arezzo rovinata la fortezza vecchia, et Antonio fece il modello della nuova col consenso di Giuliano; il quale da Roma perciò partì e subito vi tornò. E fu questa opera cagione che Antonio fosse fatto architetto del comune di Fiorenza sopra tutte le fortificazioni. Nel ritorno di Giuliano in Roma si praticava se 'l divino Michele Agnolo Buonarroti dovesse fare la sepoltura di Giulio, perché Giuliano confortò il Papa all'impresa, aggiugnendo che gli pareva che per quello edifizio si dovesse fabricare una cappella a posta senza porre quella nel vecchio San Piero, non vi essendo luogo, perciò che quella cappella renderebbe quell'opera più perfetta. Avendo dunque molti architetti fatti disegni, si venne in tanta considerazione a poco a poco che, in cambio di fare una cappella, si mise mano alla gran fabrica del nuovo San Piero. Et essendo di que' giorni capitato in Roma Bramante da Castel Durante architetto, il quale tornava di Lombardia, egli si adoperò di maniera con mezzi et altri modi straordinarii e con suoi ghiribizzi, avendo in suo favore Baldassarri Peruzzi, Raffaello da Urbino et altri architetti, che mise tutta l'opera in confusione; onde si consumò molto tempo in ragionamenti. E finalmente l'opera (in guisa seppe egli adoperarsi) fu data a lui, come a persona di più giudizio, migliore ingegno e maggiore invenzione; per che Giuliano sdegnato, parendogli avere ricevuto ingiuria dal Papa col quale aveva avuto stretta servitù quando era in minor grado e la promessa di quella fabrica, domandò licenza, e così, nonostante che egli fusse ordinato compagno di Bramante in altri edifizii che in Roma si facevano, si partì e se ne tornò con molti doni avuti dal Papa a Fiorenza. Il che fu molto caro a Piero Soderini, il quale lo mise subito in opera.
Né passarono sei mesi che Messer Bartolomeo della Rovere, nipote del Papa e compare di Giuliano, gli scrisse, a nome di Sua Santità, che egli dovesse per suo utile ritornare a Roma; ma non fu possibile né con patti né con promesse svolgere Giuliano, parendogli essere stato schernito dal Papa. Ma finalmente, essendo scritto a Piero Soderini che per ogni modo mandasse Giuliano a Roma perché Sua Santità voleva fornire la fortificazione del Torrion tondo, cominciata da Nicola Quinto, e così quella di Borgo e Belvedere et altre cose, si lasciò Giuliano persuadere dal Soderino, e così andò a Roma, dove fu dal Papa ben raccolto e con molti doni. Andando poi il Papa a Bologna, cacciati che ne furono i Bentivogli, per consiglio di Giuliano deliberò far fare da Michelagnolo Buonarroti un papa di bronzo, il che fu fatto, sì come si dirà nella vita di esso Michelagnolo. Seguitò similmente Giuliano il Papa alla Mirandola e, quella presa, avendo molti disagi e fatiche sopportato, se ne tornò con la corte a Roma. Né essendo ancora la rabbia di cacciare i Franzesi d'Italia uscita di testa al Papa, tentò di levare il governo di Fiorenza delle mani a Piero Soderini, essendogli ciò, per fare quello che aveva in animo, di non piccolo impedimento. Onde per queste cagioni, essendosi diviato il Papa dal fabrica-re e nelle guerre intricato, Giuliano già stanco si risolvette dimandare licenza al Papa, vedendo che solo alla fabrica di San Piero si attendeva et anco a quella non molto. Ma rispondendogli il Papa in collera: “Credi tu che non si trovino de' Giuliani da San Gallo?”, egli rispose che non mai di fede, né di servitù pari alla sua, ma che ritrovarebbe bene egli de' principi di più integrità nelle promesse che non era stato il Papa verso sé. Insomma, non gli dando altramente licenza, il Papa gli disse che altra volta gliene parlassi.
Aveva intanto Bramante condotto a Roma Raffaello da Urbino, messelo in opera a dipignere le camere papali, onde Giuliano vedendo che in quelle pitture molto si compiaceva il Papa, e che egli disiderava che si dipignesse la volta del-la cappella di Sisto suo zio, gli ragionò di Michelagnolo, aggiugnendo che egli aveva già in Bologna fatta la statua di bronzo. La qual cosa piacendo al Papa, fu mandato per Michelagnolo, e giunto in Roma allogatagli la volta della detta cappella. Poco dopo, tornando Giuliano a chiedere di nuovo al Papa licenza, Sua Santità vedendolo in ciò deliberato, fu contento che a Fiorenza se ne tornasse con sua buona grazia; e poi che l'ebbe benedetto, in una borsa di raso rosso gli donò cinquecento scudi, dicendogli che se ne tornasse a casa a riposarsi e che in ogni tempo gli sarebbe amorevole. Giuliano dunque, baciatogli il santo piede, se ne tornò a Fiorenza in quel tempo a punto che Pisa era circondata et assediata dall'esercito fiorentino; onde non sì tosto fu arrivato, che Piero Soderini, dopo l'accoglienze, lo mandò in campo ai comissarii, i quali non potevano riparare che i Pisani non mettessino per Arno vettovaglie in Pisa. Giuliano dunque, disegnato che a tempo migliore si facesse un ponte in sulle barche, se ne tornò a Fiorenza, e venuta la primavera, menando seco Antonio suo fratello, se n'andò a Pisa, dove condussero un ponte che fu cosa molto ingegnosa, perché, oltre che alzandosi et abbassandosi si difendeva dalle piene e stava saldo, essendo bene incatenato, fece di maniera quello che i commessarii disideravano, assediando Pisa dalla parte d'Arno verso la marina che furono forzati i Pisani, non avendo più rimedio al mal loro, a fare accordo coi Fiorentini e così si resero. Né passò molto che il medesimo Piero Soderini mandò di nuovo Giuliano a Pisa con infinito numero di maestri, dove con celerità straordinaria fabbricò la fortezza, che è oggi alla porta a San Marco; è la detta porta di componimento dorico. E mentre che Giuliano continuò questo lavoro che fu insino all'anno 1512, Antonio andò per tutto il dominio a rivedere e restaurare le fortezze et altre fabbriche pubbliche. Essendo poi col favore di esso papa Giulio stata rimessa in Fiorenza et in governo la casa de' Medici, onde ella era nella venuta in Italia di Carlo Ottavo, re di Francia, stata cacciata, e stato cavato di palazzo Piero Soderini, fu riconosciuta dai Medici la servitù che Giuliano et Antonio avevano ne' tempi a dietro avuta con quella illustrissima Casa. Et assunto non molto dopo la morte di Giulio Secondo Giovanni cardinale de' Medici, fu forzato di nuovo Giuliano a trasferirsi a Roma, dove, morto non molto dopo Bramante, fu voluta dar la cura della fabbrica di San Piero a Giuliano, ma essendo egli macero dalle fatiche et abbattuto dalla vecchiezza e da un male di pietra che lo cruciava, con licenzia di Sua Santità se ne tornò a Fiorenza e quel carico fu dato al graziosissimo Raffaello da Urbino. E Giuliano passati due anni fu in modo stretto da quel suo male che si morì d'anni 74 l'anno 1517, lasciando il nome al mondo, il corpo alla terra e l'animo a Dio.
Lasciò nella sua partita dolentissimo Antonio, che teneramente l'amava, et un suo figliuolo, nominato Francesco, che attendeva alla scultura ancora fusse d'assai tenera età. Questo Francesco, il quale ha salvato infino a oggi tutte le cose de' suoi vecchi, e l'ha in venerazione, oltre a molte altre opere fatte in Fiorenza et altrove di scultura e d'architettu-ra, è di sua mano in Or San Michele la Madonna, che vi è di marmo, col Figliuolo in collo, et in grembo a Santa Anna; la quale opera, che è di figure tonde et in un sasso solo, fu ed è tenuta bell'opera. Ha fatto similmente la sepoltura che papa Clemente fece fare a Monte Cassino di Piero de' Medici, et altre opere, molte delle quali non si fa menzione, per essere el detto Francesco vivo. Antonio, dopo la morte di Giuliano, come quello che mal volentieri si stava, fece due Crucifissi grandi di legno, l'uno de' quali fu mandato in Ispagna e l'altro fu da Domenico Buoninsegni, per ordine del cardinale Giulio de' Medici vice cancelliere, portato in Francia. Avendosi poi a fare la fortezza di Livorno vi fu mandato, dal cardinale de' Medici, Antonio a farne il disegno, il che egli fece se bene non fu poi messo interamente in opera, né in quel modo che Antonio l'aveva disegnato. Dopo, deliberando gl'uomini di Monte Pulciano, per i miracoli fatti da una imagine di Nostra Donna, di fare un tempio di grandissima spesa, Antonio fece il modello e ne divenne capo; onde due volte l'anno visitava quella fabbrica, la quale oggi si vede condotta a l'ultima perfezzione, che fu nel vero di bellissimo componimento e vario dall'ingegno d'Antonio con somma grazia condotta; e tutte le pietre sono di certi sassi che tirano al bianco in modo di tivertini; la quale opra è fuor della porta di San Biagio a man destra et a mezzo la salita del Poggio. In questo tempo ancora diede principio al palazzo d'Antonio di Monte cardinale di Santa Prassedia, nel castello del Monte San Savino, et un altro per il medesimo ne fece a Monte Pulciano, cose di bonissima grazia, lavorato e finito. Fece l'ordine della banda delle case de' frati de' Servi, su la piazza loro, secondo l'ordine della loggia degli Innocenti. Et in Arezzo fece i modelli delle navate della Nostra Donna delle Lagrime che fu molto male intesa perché scompagna con la fabbrica prima, e gli archi delle teste non tornano in mezzo; similmente fece un modello della Madonna di Cortona, il quale non penso che si mettesse in opera.
Fu adoprato nello assedio per le fortificazioni e bastioni dentro alla città, et ebbe a cotale impresa per compagnia Francesco, suo nipote. Dopo, essendo stato messo in opera il gigante di piazza, di mano di Michelagnolo, al tempo di Giuliano fratello di esso Antonio, e dovendovisi condurre quel[l'] altro che aveva fatto Baccio Bandinelli, fu data la cura ad Antonio di condurvelo a salvamento; et egli, tolto in sua compagnia Baccio d'Agnolo, con ingegni molto gagliardi lo condusse e posò salvo in su quella base che a questo effetto si era ordinata. In ultimo, essendo egli già vecchio divenuto, non si dilettava d'altro che dell'agricoltura, nella quale era intelligentissimo. Laonde, quando più non poteva per la vecchiaia patire gli incomodi del mondo, l'anno 1534 rese l'anima a Dio, et insieme con Giuliano suo fratello nella chiesa di Santa Maria Novella, nella sepoltura de' Giamberti, gli fu dato riposo.
Le opere maravigliose di questi duoi fratelli faranno fede al mondo dello ingegno mirabile che egli ebbono e della vita e costumi onorati e delle azzioni loro, avute in pregio da tutto il mondo. Lasciarono Giuliano et Antonio ereditaria l'arte dell'architettura dei modi dell'architetture toscane, con miglior forma che gli altri fatto non avevano, e l'ordine do-rico con miglior misure e proporzione che alla vitruviana opinione e regola prima non s'era usato di fare. Condussero in Fiorenza nelle lor case una infinità di cose antiche di marmo bellissime che non meno ornarono et ornano Fiorenza ch'eglino ornassero sé et onorassero l'arte. Portò Giuliano da Roma il gettare le volte di materie che venissero intagliate; come in casa sua ne fa fede una camera et al Poggio a Caiano nella sala grande la volta che vi si vede ora; onde obligo si debbe avere alle fatiche sue avendo fortificato il dominio fiorentino et ornata la città, e per tanti paesi dove lavorarono dato nome a Fiorenza et agli ingegni toscani, che per onorata memoria hanno fatto loro questi versi:
Cedite Romani structores, cedite Grai,
artis Vitruvi tu quoque cede parens.
Hetruscos celebrate viros, testudinis arcus,
urna, tholus, statuae, templa, domusque petunt.
VITA DI RAFFAELLO D'URBINO
PITTORE ET ARCHITETTO

Quanto largo e benigno si dimostri talora il cielo nell'accumulare in una persona sola l'infinite richezze de' suoi tesori e tutte quelle grazie e' più rari doni che in lungo spazio di tempo suol compartire fra molti individui, chiaramente poté vedersi nel non meno eccellente che grazioso Raffael Sanzio da Urbino. Il quale fu dalla natura dotato di tutta quella modestia e bontà che suole alcuna volta vedersi in coloro che più degl'altri hanno a una certa umanità di natura gentile aggiunto un ornamento bellissimo d'una graziata affabilità, che sempre suol mostrarsi dolce e piacevole con ogni sorte di persone et in qualunche maniera di cose. Di costui fece dono al mondo la natura quando vinta dall'arte, per mano di Michelagnolo Buonarroti, volle in Raffaello esser vinta dall'arte e dai costumi insieme.
E nel vero, poi che la maggior parte degl'artefici stati insino allora si avevano dalla natura recato un certo che di pazzia e di salvatichezza che, oltre all'avergli fatti astratti e fantastichi, era stata cagione che molte volte si era più dimostrato in loro l'ombra e lo scuro de' vizii che la chiarezza e splendore di quelle virtù che fanno gli uomini immortali, fu ben ragione che, per contrario, in Raffaello facesse chiaramente risplendere tutte le più rare virtù dell'animo, accompagnate da tanta grazia, studio, bellezza, modestia et ottimi costumi, quanti sarebbono bastati a ricoprire ogni vizio quantunque brutto et ogni macchia ancor che grandissima. Laonde, si può dire sicuramente che coloro che sono possessori di tante rare doti, quante si videro in Raffaello da Urbino, sian non uomini semplicemente, ma, se è lecito dire, dèi mortali; e che coloro che nei ricordi della fama lasciano quaggiù fra noi mediante l'opere loro onorato nome, possono anco sperare d'avere a godere in cielo con degno guidardone alle fatiche e merti loro.
Nacque adunque Raffaello in Urbino, città notissima in Italia, l'anno 1483, in venerdì santo a ore tre di notte, d'un Giovanni de' Santi, pittore non molto eccellente, ma sì bene uomo di buono ingegno et atto a indirizzare i figliuoli per quella buona via che a lui, per mala fortuna sua, non era stata mostra nella sua gioventù. E perché sapeva Giovanni quanto importi allevare i figliuoli non con il latte delle balie, ma delle proprie madri, nato che gli fu Raffaello, al quale così pose nome al battesimo con buono augurio, volle, non avendo altri figliuoli come non ebbe anco poi, che la propria madre lo allattasse e che più tosto ne' teneri anni aparasse in casa i costumi paterni che per le case de' villani e plebei uomini, men gentili o rozzi costumi e creanze. E cresciuto che fu cominciò a esercitarlo nella pittura, vedendolo a cotal arte molto inclinato, di bellissimo ingegno; onde non passarono molti anni che Raffaello, ancor fanciullo, gli fu di grande aiuto in molte opere che Giovanni fece nello stato d'Urbino.
In ultimo, conoscendo questo buono et amorevole padre che poco poteva appresso di sé acquistare il figliuolo, si dispose di porlo con Pietro Perugino il quale, secondo che gli veniva detto, teneva in quel tempo fra i pittori il primo luogo; per che andato a Perugia, non vi trovando Pietro, si mise, per più comodamente poterlo aspettare, a lavorare in San Francesco alcune cose. Ma tornato Pietro da Roma, Giovanni, che persona costumata era e gentile, fece seco amicizia e quando tempo gli parve, col più acconcio modo che seppe, gli disse il desiderio suo. E così Pietro, che era cortese molto et amator de' belli ingegni, accettò Raffaello; onde Giovanni andatosene tutto lieto a Urbino e preso il putto, non senza molte lacrime della madre che teneramente l'amava, lo menò a Perugia, là dove Pietro, veduto la maniera del disegnare di Raffaello e le belle maniere e' costumi, ne fé quel giudizio che poi il tempo dimostrò verissimo con gl'effetti. È cosa notabilissima che, studiando Raffaello la maniera di Pietro, la imitò così a punto et in tutte le cose che i suo' ritratti non si conoscevano dagl'originali del maestro e fra le cose sue e di Pietro non si sapeva certo discernere, come apertamente dimostrano ancora in San Francesco di Perugia alcune figure che egli vi lavorò in una tavola a olio per madonna Madalena degli Oddi, e ciò sono: una Nostra Donna assunta in cielo e Gesù Cristo che la corona, e di sotto intorno al sepolcro sono i dodici Apostoli che contemplano la gloria celeste. Et a' piè della tavola in una predella di figure piccole, spartite in tre storie, è la Nostra Donna annunziata dall'Angelo; quando i Magi adorano Cristo e quando nel tempio è in braccio a Simeone, la quale opera certo è fatta con estrema diligenza e chi non avesse in pratica la maniera, crederebbe fermamente che ella fusse di mano di Pietro, là dove ell'è senza dubbio di mano di Raffaello. Dopo questa opera, tornando Pietro per alcuni suoi bisogni a Firenze, Raffaello, partitosi di Perugia, se n'andò con alcuni amici suoi a Città di Castello, dove fece una tavola in Santo Agostino, di quella maniera e similmente in S. Domenico una d'un Crucifisso, la quale, se non vi fusse il suo nome scritto, nessuno la crederebbe opera di Raffaello, ma sì bene di Pietro. In San Francesco ancora della medesima città fece in una tavoletta lo Sposalizio di Nostra Donna, nel quale espressamente si conosce l'augumento della virtù di Raffaello venire con finezza assotigliando e passando la maniera di Pietro. In questa opera è tirato un tempio in prospettiva con tanto amore che è cosa mirabile a vedere le difficultà che egli in tale esercizio andava cercando.
In questo mentre, avendo egli acquistato fama grandissima nel seguito di quella maniera, era stato allogato da Pio Secondo pontefice la libreria del Duomo di Siena al Pinturicchio, il quale, essendo amico di Raffaello e conoscendolo ottimo disegnatore, lo condusse a Siena, dove Raffaello gli fece alcuni dei disegni e cartoni di quell'opera; e la cagione che egli non continuò fu che, essendo in Siena da alcuni pittori con grandissime lodi celebrato il cartone che Lionardo da Vinci aveva fatto nella sala del palazzo in Fiorenza d'un gruppo di cavalli bellissimo per farlo nella sala del palazzo e similmente alcuni nudi fatti a concorrenza di Lionardo da Michelagnolo Buonarroti molto migliori; venne in tanto desiderio Raffaello, per l'amore che portò sempre all'eccellenza dell'arte, che, messo da parte quell'opera et ogni utile e comodo suo, se ne venne a Fiorenza. Dove arrivato, perché non gli piacque meno la città, che quell'opere le quali gli parvero divine, deliberò di abitare in essa per alcun tempo; e così, fatta amicizia con alcuni giovani pittori, fra' quali furono Ridolfo Ghirlandaio, Aristotile San Gallo et altri, fu nella città molto onorato e particolarmente da Taddeo Taddei, il quale lo volle sempre in casa sua et alla sua tavola, come quegli che amò sempre tutti gli uomini inclinati alla virtù. E Raffaello, che era la gentilezza stessa, per non esser vinto di cortesia, gli fece due quadri che tengono della maniera prima di Pietro e dell'altra che poi studiando apprese molto migliore, come si dirà. I quali quadri sono ancora in casa degli eredi del detto Taddeo. Ebbe anco Raffaello amicizia grandissima con Lorenzo Nasi, al quale avendo preso donna in que' giorni, dipinse un quadro, nel quale fece fra le gambe alla Nostra Donna un Putto, al quale un San Giovannino tutto lieto porge un uccello con molta festa e piacere dell'uno e dell'altro; e nell'attitudine d'ambi due una certa simplicità puerile e tutta amorevole, oltre che sono tanto ben coloriti e con tanta diligenza condotti che più tosto paiono di carne viva che lavorati di colori, e disegnò parimente la Nostra Donna, [che] ha un'aria veramente piena di grazia e di divinità, et insomma il piano, i paesi e tutto il resto dell'opera è bellissimo. Il quale quadro fu da Lorenzo Nasi tenuto con grandissima venerazione mentre che visse, così per memoria di Raffaello statogli amicissimo, come per la dignità et eccellenza dell'opera. Ma capitò poi male quest'opera l'anno 1548 a dì 17 novembre, quando la casa di Lorenzo insieme con quelle ornatissime e belle degl'eredi di Marco del Nero, per uno smottamento del Monte di San Giorgio rovinarono insieme con altre case vicine. Nondimeno, ritrovati i pezzi d'essa fra i calcinacci della rovina, furono da Batista, figliuolo di esso Lorenzo, amorevolissimo dell'arte, fatti rimettere insieme in quel miglior modo che si potette.
Dopo queste opere fu forzato Raffaello a partirsi di Firenze et andare a Urbino, per avere là, essendo la madre e Giovanni suo padre morti, tutte le sue cose in abandono. Mentre che dunque dimorò in Urbino, fece per Guidobaldo da Montefeltro, allora capitano de' Fiorentini, due quadri di Nostra Donna piccoli, ma bellissimi e della seconda maniera. I quali sono oggi appresso lo illustrissimo et eccellentissimo Guidobaldo, Duca d'Urbino. Fece al medesimo un quadretto d'un Cristo che ora nell'orto e, lontani alquanto, i tre Apostoli che dormono. La qual pittura è tanto finita che un minio non può essere né migliore né altrimenti. Questa, essendo stata gran tempo appresso Francesco Maria, Duca d'Urbino, fu poi dalla illustrissima signora Leonora, sua consorte, donata a don Paulo Iustiniano e don Pietro Quirini viniziani e romiti del sacro eremo di Camaldoli, e da loro fu poi come reliquia e cosa rarissima, et insomma di mano di Raffaello da Urbino e per memoria di quella illustrissima signora, posta nella camera del Maggiore di detto Eremo, dove è tenuta in quella venerazione ch'ella merita. Dopo queste opere et avere accomodate le cose sue, ritornò Raffaello a Perugia, dove fece nella chiesa de' frati de' Servi in una tavola alla cappella degl'Ansidei una Nostra Donna, San Giovanni Battista e San Nicola. Et in San Severo della medesima città, piccol monasterio dell'Ordine di Camaldoli, alla cappella della Nostra Donna, fece in fresco un Cristo in gloria, un Dio Padre con alcuni Angeli a torno e sei Santi a sedere, cioè tre per banda: San Benedetto, San Romualdo, San Lorenzo, San Girolamo, San Mauro e San Placido; et in questa opera, la quale per cosa in fresco fu allora tenuta molto bella, scrisse il nome suo in lettere grandi e molto bene apparenti. Gli fu anco fatto dipignere nella medesima città, dalle donne di Santo Antonio da Padoa, in una tavola la Nostra Donna et in grembo a quella, sì come piacque a quelle semplici e venerande donne, Gesù Cristo vestito, e dai lati di essa Madonna San Piero, San Paulo, Santa Cecilia e Santa Caterina. Alle qual due Sante vergini fece le più belle e dolci arie di teste e le più varie acconciature da capo, il che fu cosa rara in que' tempi, che si possino vedere. E sopra questa tavola in un mezzo tondo dipinse un Dio Padre bellissimo e nella predella dell'altare tre storie di figure piccole: Cristo quando fa orazione nell'orto; quando porta la Croce, dove sono bellissime movenze di soldati che lo stracinano, e quando è morto in grembo alla Madre: opera certo mirabile, devota e tenuta da quelle donne in gran venerazione e da tutti i pittori molto lodata. Né tacerò, che si conobbe, poi che fu stato a Firenze, che egli variò et abbellì tanto la maniera, mediante l'a-ver vedute molte cose e di mano di maestri eccellenti, che ella non aveva che fare alcuna cosa con quella prima se non come fussino di mano di diversi e più e meno eccellenti nella pittura. Prima che partisse di Perugia, lo pregò madonna Atlanta Baglioni che egli volesse farle per la sua cappella nella chiesa di San Francesco una tavola, ma, perché egli non poté servirla allora, le promise che tornato che fusse da Firenze, dove allora per suoi bisogni era forzato d'andare, non le mancherebbe. E così venuto a Firenze, dove attese con incredibile fatica agli studi dell'arte, fece il cartone per la detta cappella con animo d'andare, come fece quanto prima gli venisse in acconcio, a metterlo in opera.
Dimorando, adunque, in Fiorenza Agnolo Doni, il quale quanto era assegnato nell'altre cose tanto spendeva volentieri, ma con più risparmio che poteva, nelle cose di pittura e di scultura, delle quali si dilettava molto, gli fece fare il ritratto di sé e della sua donna in quella maniera che si veggiono appresso Giovanbatista, suo figliuolo, nella casa che detto Agnolo edificò bella e comodissima in Firenze nel corso de' Tintori, appresso al canto degl'Alberti. Fece anco a Domenico Canigiani in un quadro la Nostra Donna con il putto Gesù che fa festa a un San Giovannino portogli da Santa Elisabetta che mentre lo sostiene con prontezza vivissima guarda un San Giuseppo, il quale standosi appoggiato con ambe le mani a un bastone china la testa verso quella vecchia, quasi maravigliandosi e lodandone la grandezza di Dio che così attempata avesse un sì picciol figliuolo. E tutti pare che stupischino del vedere con quanto senno in quella età sì tenera i due cugini, l'uno reverente all'altro, si fanno festa; senza che ogni colpo di colore nelle teste, nelle mani e ne' piedi sono anzi pennellate di carne che tinta di maestro che faccia quell'arte. Questa nobilissima pittura è oggi appresso gl'eredi del detto Domenico Canigiani, che la tengono in quella stima che merita un'opera di Raffaello da Urbino.
Studiò questo eccellentissimo pittore nella città di Firenze le cose vecchie di Masaccio, e quelle che vide nei lavori di Lionardo e di Michelagnolo lo feciono attendere maggiormente agli studi e per conseguenza acquistarne miglioramento straordinario all'arte et alla sua maniera. Ebbe oltre gl'altri, mentre stette Raffaello in Fiorenza, stretta dimestichezza con fra' Bartolomeo di San Marco, piacendogli molto e cercando assai d'imitare il suo colorire, et all'incontro insegnò a quel buon padre i modi della prospettiva, alla quale non aveva il frate atteso insino a quel tempo. Ma in sulla maggior frequenza di questa pratica fu richiamato Raffaello a Perugia, dove primieramente in San Francesco finì l'ope-ra della già detta madonna Atalanta Baglioni, della quale aveva fatto, come si è detto, il cartone in Fiorenza. E in questa divinissima pittura un Cristo morto portato a sotterrare, condotto con tanta freschezza e sì fatto amore, che a vederlo pare fatto pur ora. Immaginossi Raffaello nel componimento di questa opera il dolore che hanno i più stretti et amorevoli parenti nel riporre il corpo d'alcuna più cara persona, nella quale veramente consista il bene, l'onore e l'utile di tutta una famiglia: vi si vede la Nostra Donna venuta meno, e le teste di tutte le figure molto graziose nel pianto e quella particolarmente di San Giovanni, il quale, incrocicchiate le mani, china la testa con una maniera da far comuovere qual è più duro animo a pietà. E di vero chi considera la diligenza, l'amore, l'arte e la grazia di quest'opera, ha gran ragione di maravigliarsi perché ella fa stupire chiunque la mira per l'aria delle figure, per la bellezza de' panni et insomma per una estrema bontà ch'ell'ha in tutte le parti. Finito questo lavoro e tornato a Fiorenza, gli fu dai Dei, cittadini fiorentini, allogata una tavola che andava alla cappella dell'altar loro in Santo Spirito; et egli la cominciò e la bozza a bonissimo termine condusse, et intanto fece un quadro che si mandò in Siena, il quale nella partita di Raffaello rimase a Ridolfo del Ghirlandaio, perch'egli finisse un panno azzurro che vi mancava. E questo avvenne perché Bramante da Urbino, essendo a' servigi di Giulio II, per un poco di parentela ch'aveva con Raffaello e per essere di un paese medesimo, gli scrisse che aveva operato col Papa, il quale aveva fatto fare certe stanze ch'egli potrebbe in quelle mostrar il valor suo. Piacque il partito a Raffaello, perché lasciate l'opere di Fiorenza e la tavola dei Dei non finita, ma in quel modo che poi la fece porre Messer Baldassarre da Pescia nella Pieve della sua patria dopo la morte di Raffaello, si trasferì a Roma, dove giunto, Raffaello trovò che gran parte delle camere di palazzo erano state dipinte e tuttavia si dipignevano da più maestri; e così stavano, come si vedeva, che ve n'era una che da Pietro della Francesca vi era una storia finita, e Luca da Cortona aveva condotta a buon termine una facciata, e don Pietro della Gatta, abbate di San Clemente di Arezzo, vi aveva cominciato alcune cose; similmente Bramantino da Milano vi aveva dipinto molte figure, le quali la maggior parte erano ritratti di naturale che erano tenuti bellissimi.
Laonde Raffaello, nella sua arrivata avendo ricevute molte carezze da papa Iulio, cominciò nella camera della Segnatura una storia quando i Teologi accordano la filosofia e l'astrologia con la teologia, dove sono ritratti tutti i savi del mondo che disputano in vari modi; sonvi in disparte alcuni astrologi che hanno fatto figure sopra certe tavolette e caratteri in varii modi di geomanzia e d'astrologia, et ai Vangelisti le mandano per certi Angeli bellissimi, i quali Evangelisti le dichiarano. Fra costoro è un Diogene con la sua tazza a giacere in su le scalee, figura molto considerata et astratta, che per la sua bellezza e per lo suo abito così accaso è degna d'essere lodata. Similmente vi è Aristotile e Platone, l'uno col Timeo in mano, l'altro con l'Etica, dove intorno li fanno cerchio una grande scuola di filosofi. Né si può esprimere la bellezza di quelli astrologi e geometri che disegnano con le seste in su le tavole moltissime figure e caratteri. Fra i medesimi, nella figura d'un giovane di formosa bellezza, il quale apre le braccia per maraviglia e china la testa, è il ritratto di Federigo II, Duca di Mantova, che si trovava allora in Roma. Èvvi similmente una figura che, chinata a terra con un paio di seste in mano, le gira sopra le tavole, la quale dicono essere Bramante architettore, che egli non è men desso che se e' fusse vivo, tanto è ben ritratto. Et allato a una figura che volta il didietro et ha una palla del cielo in mano, è il ritratto di Zoroastro, et allato a esso è Raffaello, maestro di questa opera, ritrattosi da sé medesimo nello specchio: questo è una testa giovane e d'aspetto molto modesto, acompagnato da una piacevole e buona grazia, con la berretta nera in capo. Né si può esprimere la bellezza e la bontà che si vede nelle teste e figure de' Vangelisti, a' quali ha fatto nel viso una certa attenzione et accuratezza molto naturale e massimamente a quelli che scrivono. E così fece dietro ad un San Matteo mentre che egli cava di quelle tavole dove sono le figure i caratteri tenuteli da uno Angelo e che le distende in su un libro, un vecchio che messosi una carta in sul ginocchio copia tanto quanto San Matteo distende. E mentre che sta attento in quel disagio pare che egli torca le mascella e la testa, secondo che egli allarga et allunga la penna. Et oltra le minuzie delle considerazioni, che son pure assai, vi è il componimento di tutta la storia che certo è spartito tanto con ordine e misura, che egli mostrò veramente un sì fatto saggio di sé, che fece conoscere che egli voleva, fra coloro che toccavano i pennelli, tenere il campo senza contrasto. Adornò ancora questa opera di una prospettiva e di molte figure finite con tanto delicata e dolce maniera che fu cagione che papa Giulio facesse buttare atterra tutte le storie degli altri maestri e vecchi e moderni, e che Raffaello solo avesse il vanto di tutte le fatiche che in tali opere fussero state fatte sino a quell'ora. E se bene l'opera di Giovan Antonio Soddoma da Vercelli, la quale era sopra la storia di Raffaello, si doveva per commessione del Papa gettare per terra, volle nondimeno Raffaello servirsi del partimento di quella e delle grottesche, e dove erano alcuni tondi, che son quattro, fece per ciascuno una figura del significato delle storie di sotto, volte da quella banda dove era la storia; a quella prima, dove egli aveva dipinto la Filosofia e l'Astrolo-gia, Geometria e Poesia che si accordano con la Teologia, v'è una femmina fatta per la cognizione delle cose, la quale siede in una sedia che ha per reggimento da ogni banda una dea Cibele, con quelle tante poppe con che dagli antichi era figurata Diana Polimaste; e la veste sua è di quattro colori, figurati per li elementi, da la testa in giù v'è il color del fuoco e sotto la cintura quel dell'aria, da la natura al ginocchio è il color della terra e dal resto per fino a' piedi è il colore dell'acqua. E così la accompagnano alcuni putti veramente bellissimi.
In un altro tondo volto verso la finestra che guarda in Belvedere, è finta Poesia, la quale è in persona di Polinnia coronata di lauro e tiene un suono antico in una mano et un libro nell'altra e sopra poste le gambe; e con aria e bellezza di viso immortale sta elevata con gl'occhi al cielo, accompagnandola due putti che sono vivaci e pronti e che insieme con essa fanno vari componimenti, e con le altre e da questa banda vi fé poi, sopra la già detta finestra, il monte di Parnaso. Nell'altro tondo, che è fatto sopra la storia dove i Santi Dottori ordinano la messa, è una Teologia con libri et altre cose attorno, co' medesimi putti, non men bella che gl'altri. E sopra l'altra finestra che volta nel cortile, fece nell'altro tondo una Giustizia con le sue bilance e la spada inalberata, con i medesimi putti che a l'altre di somma bellezza, per aver egli nella storia di sotto della faccia fatto come si dà le leggi civili e le canoniche, come a suo luogo diremo. E così nella volta medesima in su le cantonate de' peducci di quella, fece quattro storie disegnate e colorite con una gran diligenza, ma di figure di non molta grandezza. In una delle quali verso la Teologia fece il peccar di Adamo, lavorato con leggiadrissima maniera, il mangiare del pomo; et in quella dove è la Astrologia vi è ella medesima che pone le stelle fisse e l'erranti a' luoghi loro. Nell'altra poi del monte di Parnaso è Marsia fatto scorticare a uno albero da Apollo; e, di verso la storia dove si danno i decretali, è il giudizio di Salamone quando egli vuol fare dividere il fanciullo. Le quali quattro istorie sono tutte piene di senso e di affetto, e lavorate con disegno bonissimo e di colorito vago e graziato. Ma finita oramai la volta, cioè il cielo di quella stanza, resta che noi raccontiamo quello che e' fece faccia per faccia appiè delle cose dette di sopra.
Nella facciata dunque di verso Belvedere, dove è il monte Parnaso e il fonte di Elicona, fece intorno a quel monte una selva onbrosissima di lauri, ne' quali si conosce per la loro verdezza quasi il tremolare delle foglie per l'aure dolcissime e nella aria una infinità di Amori ignudi con bellissime arie di viso, che colgono rami di lauro e ne fanno ghirlande, e quelle spargano e gettano per il monte; nel quale pare che spiri veramente un fiato di divinità nella bellezza delle figure e da la nobiltà di quella pittura, la quale fa maravigliare chi intensissimamente la considera, come possa ingegno umano con l'imperfezzione di semplici colori ridurre con l'eccellenzia del disegno le cose di pittura a parere vive, sì come sono anco vivissimi que' poeti che si veggono sparsi per il monte, chi ritti, chi a sedere e chi scrivendo, altri ragionando et altri cantando o favoleggiando insieme, a quattro, a sei, secondo che gli è parso di scompartirgli. Sonvi ritratti di naturale tutti i più famosi et antichi e moderni poeti che furono e che erano fino al suo tempo, i quali furono cavati parte da statue, parte da medaglie e molti da pitture vecchie et ancora di naturale mentre che erano vivi da lui medesimo. E, per cominciarmi da un capo, quivi è Ovidio, Virgilio, Ennio, Tibullo, Catullo, Properzio et Omero che, cieco con la testa elevata cantando versi, ha a' piedi uno che gli scrive; vi sono poi tutte in un gruppo le nove Muse et Appollo con tanta bellezza d'arie e divinità nelle figure, che grazia e vita spirano ne' fiati loro. Èvvi la dotta Saffo et il divinissimo Dante, il leggiadro Petrarca e lo amoroso Boccaccio, che vivi vivi sono; il Tibaldeo similmente et infiniti altri moderni. La quale istoria è fatta con molta grazia e finita con diligenza.
Fece in un'altra parete un cielo con Cristo e la Nostra Donna, San Giovanni Batista, gli Apostoli e gli Evangelisti e Martiri su le nugole con Dio Padre, che sopra tutti manda lo Spirito Santo e massimamente sopra un numero infinito di Santi, che sotto scrivono la Messa; e sopra l'Ostia, che è sullo altare, disputano. Fra i quali sono i quattro Dottori della chiesa, che intorno hanno infiniti santi. Èvvi Domenico, Francesco, Tomaso d'Aquino, Buonaventura, Scoto, Nicolò de Lira, Dante, fra' Girolamo Savonarola da Ferrara e tutti i teologi cristiani et infiniti ritratti di naturale; et in aria sono quattro fanciulli che tengono aperti gli Evangeli. Dalle quali figure non potrebbe pittore alcuno formar cosa più leggiadra, né di maggior perfezzione. Avvenga che nell'aria et in cerchio son figurati que' Santi a sedere, che nel vero, oltra al parer vivi di colori, scortano di maniera e sfuggono che non altrimenti farebbono se fussino di rilievo. Oltra che sono vestiti diversamente, con bellissime pieghe di panni e l'arie delle teste più celesti che umane, come si vede in quella di Cristo, la quale mostra quella clemenza e quella pietà che può mostrare agli uomini mortali divinità di cosa dipinta. Conciò fusse che Raffaello ebbe questo dono dalla natura di far l'arie sue delle teste dolcissime e graziosissime, come ancora ne fa fede la Nostra Donna che, messesi le mani al petto, guardando e contemplando il Figliuolo, pare che non possa dinegar grazia; senza che egli riservò un decoro certo bellissimo, mostrando nell'arie de' Santi Patriarchi l'antichi-tà, negli Apostoli la semplicità e ne' Martiri la fede. Ma molto più arte et ingegno mostrò ne' Santi Dottori cristiani, i quali a sei, a tre, a due disputando per la storia, si vede nelle cere loro una certa curiosità et uno affanno nel voler trova-re il certo di quel che stanno in dubbio, faccendone segno co 'l disputar con le mani e co 'l far certi atti con la persona, con attenzione degli orecchi, con lo increspare delle ciglia e con lo stupire in molte diverse maniere, certo variate e proprie, salvo che i quattro Dottori della Chiesa che, illuminati dallo Spirito Santo, snodano e risolvono con le Scritture sacre tutte le cose degli Evangeli, che sostengano que' putti che gli hanno in mano volando per l'aria. Fece nell'altra faccia, dove è l'altra finestra, da una parte Giustiniano che dà le leggi ai dottori che le corregghino, e sopra la Temperanza, la Fortezza e la Prudenza. Dall'altra parte fece il papa che dà le decretali canoniche, et in detto papa ritrasse papa Giulio di naturale; Giovanni cardinale de' Medici assistente, che fu papa Leone, Antonio cardinale di Monte et Alessandro Farnese cardinale, che fu poi papa Paulo Terzo, con altri ritratti.
Restò il Papa di questa opera molto sodisfatto, e per fargli le spalliere di prezzo, come era la pittura, fece venire da Monte Oliveto di Chiusuri, luogo in quel di Siena, fra' Giovanni da Verona, allora gran maestro di commessi di prospettive di legno, il quale vi fece non solo le spalliere attorno, ma ancora usci bellissimi e sederi lavorati in prospettive, i quali appresso al Papa grandissima grazia, premio et onore gli acquistarono. E certo che in tal magisterio mai non fu più nessuno più valente di disegno e d'opera che fra' Giovanni, come ne fa fede ancora in Verona sua patria una sagrestia di prospettive di legno bellissima in Santa Maria in Organo, il coro di Monte Oliveto di Chiusuri e quel di San Benedetto di Siena et ancora la sagrestia di Monte Oliveto di Napoli, e nel luogo medesimo nella cappella di Paolo da Tolosa il coro lavorato dal medesimo. Per il che meritò che dalla Religion sua fosse stimato e con grandissimo onor tenuto, nella quale si morì d'età d'anni 68, l'anno 1537. E di costui come di persona veramente eccellente e rara ho voluto far menzione, parendomi che così meritasse la sua virtù, la quale fu cagione come si dirà in altro luogo di molte opere rare fatte da altri maestri dopo lui.
Ma per tornare a Raffaello, crebbero le virtù sue di maniera ch'e' seguitò, per commissione del Papa, la camera seconda verso la sala grande. Et egli, che nome grandissimo aveva acquistato, ritrasse in questo tempo papa Giulio in un quadro a olio, tanto vivo e verace, che faceva temere il ritratto a vederlo, come se proprio egli fosse il vivo, la quale opera è oggi in Santa Maria del Popolo, con un quadro di Nostra Donna bellissimo, fatto medesimamente in questo tempo, dentrovi la Natività di Iesù Cristo, dove è la Vergine che con un velo cuopre il Figliuolo, il quale è di tanta bellezza che nell'aria della testa e per tutte le membra dimostra essere vero Figliuolo di Dio. E non manco di quello è bella la testa et il volto di essa Madonna, conoscendosi in lei, oltra la somma bellezza, allegrezza e pietà. Èvvi un Giuseppo che, appoggiando ambe le mani ad una mazza, pensoso in contemplare il Re e la Regina del Cielo, sta con una ammirazione da vecchio santissimo. Et amendue questi quadri si mostrano le feste solenni.
Aveva acquistato in Roma Rafaello in questi tempi molta fama et ancora che egli avesse la maniera gentile da ognuno tenuta bellissima, e con tutto che egli avesse veduto tante anticaglie in quella città e che egli studiasse continovamente, non aveva però per questo dato ancora alle sue figure una certa grandezza e maestà che e' diede loro da qui avanti. Avenne, adunque, in questo tempo che Michelagnolo fece al Papa nella cappella quel romore e paura di che parleremo nella vita sua, onde fu sforzato fuggirsi a Fiorenza; per il che avendo Bramante la chiave della capella, a Rafael-lo, come amico, la fece vedere, acciò che i modi di Michelagnolo comprendere potesse. Onde tal vista fu cagione che in Santo Agostino sopra la Santa Anna di Andrea Sansovino in Roma Rafaello subito rifacesse di nuovo lo Esaia profeta che ci si vede, che di già lo aveva finito. Nella quale opera per le cose vedute di Michelagnolo migliorò et ingrandì fuor di modo la maniera e diedele più maestà. Perché, nel veder poi Michelagnolo l'opera di Raffaello, pensò che Bramante, com'era vero, gli avesse fatto quel male innanzi per fare utile e nome a Rafaello. Al quale Agostino Chisi sanese, ricchissimo mercante, e di tutti gl'uomini virtuosi amicissimo, fece non molto dopo allogazione d'una cappella; e ciò per avergli poco inanzi Raffaello dipinto in una loggia del suo palazzo, oggi detto i Chisii in Trastevere, con dolcissima maniera una Galatea nel mare sopra un carro tirato da due dolfini a cui sono intorno i tritoni e molti dèi marini. Avendo dunque fatto Rafaello il cartone per la detta capella, la quale è all'entrata della chiesa di S. Maria della Pace a man destra entrando in chiesa per la porta principale, la condusse lavorata in fresco della maniera nuova, alquanto più magnifica e grande che non era la prima. Figurò Raffaello in questa pittura, avanti che la cappella di Michelagnolo si discoprisse publicamente, avendola nondimeno veduta, alcuni profeti e sibille che nel vero delle sue cose è tenuta la migliore e, fra le tante belle, bellissima; perché nelle femine e nei fanciulli che vi sono si vede grandissima vivacità e colorito perfetto. E questa opera lo fé stimar grandemente vivo e morto, per essere la più rara et eccellente opera che Raffaello facesse in vita sua. Poi, stimolato da' prieghi d'un cameriere di papa Giulio, dipinse la tavola dello altar maggiore di Araceli, nella quale fece una Nostra Donna in aria, con un paese bellissimo, un San Giovanni et un San Francesco, e San Girolamo ritratto da cardinale; nella qual Nostra Donna è una umiltà e modestia veramente da madre di Cristo; et oltre che il Putto con bella attitudine scherza co 'l manto della Madre, si conosce nella figura del San Giovanni quella penitenza che suole fare il digiuno, e nella testa si scorge una sincerità d'animo et una prontezza di sicurtà, come in coloro che lontani dal mondo lo sbeffano e nel praticare il publico odiano la bugia e dicono la verità. Similmente il San Girolamo ha la testa elevata con gli occhi alla Nostra Donna, tutta contemplativa, ne' quali par che ci accenni tutta quella dottrina e sapienzia che egli scrivendo mostrò nelle sue carte, offerendo con ambe le mani il cameriero, in atto di raccomandarlo, il qual cameriero nel suo ritratto è non men vivo che si sia dipinto. Né mancò Raffaello fare il medesimo nella figura di San Francesco, il quale ginocchioni in terra, con un braccio steso e con la testa elevata, guarda in alto la Nostra Donna, ardendo di carità nello affetto della pittura, la quale nel lineamento e nel colorito mostra che e' si strugga di affezzione, pigliando conforto e vita dal mansuetissimo guardo della bellezza di lei e dalla vivezza e bellezza del Figliuolo. Fecevi Raffaello un putto ritto in mezzo della tavola sotto la Nostra Donna, che alza la testa verso lei e tiene un epitaffio, che di bellezza di volto e di corrispondenza della persona non si può fare, né più grazioso, né meglio, oltre che v'è un paese che in tutta perfezzione è singulare e bellissimo. Dappoi, continuando le camere di palazzo, fece una storia del miracolo del Sacramento del corporale d'Orvieto o di Bolsena, che eglino se 'l chiamino; nella quale storia si vede al prete, mentre che dice messa, nella testa infocata di rosso, la vergogna che egli aveva nel veder per la sua incredulità fatto liquefar l'Ostia in sul corporale e che spaventato negli occhi e fuor di sé smarrito nel cospetto de' suoi uditori, pare persona inrisoluta; e si conosce nell'attitudine delle mani quasi il tremito e lo spavento che si suole in simili casi avere. Fecevi Raffaello intorno molte varie e diverse figure, alcuni servono alla messa, altri stanno su per una scala ginocchioni, et alterate dalla novità del caso fanno bellissime attitudini in diversi gesti, esprimendo in molte uno affetto di rendersi in colpa, e tanto ne' maschi, quanto nelle femmine, fra le quali ve n'ha una che a' piè della storia da basso siede in terra tenendo un putto in collo, la quale sentendo il ragionamento che mostra un'altra di dirle del caso successo al prete, maravigliosamente si storce mentre che ella ascolta ciò, con una grazia donnesca molto propria e vivace. Finse dall'altra banda papa Giulio che ode quella messa, cosa maravigliosissima, dove ritrasse il cardinale di San Giorgio et infiniti; e nel rotto della finestra accomodò una salita di scalee che la storia mostra intera, anzi pare che, se il vano di quella finestra non vi fosse, quella non sarebbe stata punto bene.
Laonde veramente si gli può dar vanto che nelle invenzioni dei componimenti di che storie si fossero nessuno già mai più di lui nella pittura è stato accomodato et aperto e valente come mostrò ancora in questo medesimo luogo dirimpetto a questa in una storia quando San Piero nelle mani d'Erode in prigione è guardato dagli armati, dove tanta è l'ar-chitettura che ha tenuto in tal cosa e tanta la discrezione nel casamento della prigione che invero gli altri appresso a lui hanno più di confusione ch'egli non ha di bellezza; avendo egli cercato di continuo figurare le storie come elle sono scritte e farvi dentro cose garbate et eccellenti, come mostra in questa l'orrore della prigione nel veder legato fra que' due armati con le catene di ferro quel vecchio, il gravissimo sonno nelle guardie et il lucidissimo splendor dell'Angelo nelle scure tenebre della notte luminosamente far discernere tutte le minuzie delle carcere e vivacissimamente risplendere l'armi di coloro, in modo che i lustri paiono bruniti più che se fussino verissimi e non dipinti. Né meno arte et ingegno è nello atto quando egli sciolto da le catene esce fuor di prigione accompagnato dall'Angelo, dove mostra nel viso San Piero più tosto d'essere un sogno, che visibile, come ancora si vede terrore e spavento in altre guardie che arma-te fuor della prigione sentono il romore de la porta di ferro, et una sentinella con una torcia in mano desta gli altri, e mentre con quella fa lor lume riverberano i lumi della torcia in tutte le armi, e dove non percuote quella serve un lume di luna. La quale invenzione, avendola fatta Raffaello sopra la finestra, viene a esser quella facciata più scura, avvenga che quando si guarda tal pittura ti dà il lume nel viso e contendono tanto bene insieme la luce viva con quella dipinta co' diversi lumi della notte, che ti par vedere il fumo della torcia, lo splendor dell'Angelo con le scure tenebre della notte sì naturali e sì vere, che non diresti mai che ella fussi dipinta, avendo espresso tanto propriamente sì difficile imaginazione. Qui si scorgono nell'arme l'ombre, gli sbattimenti, i reflessi e le fumosità del calor de' lumi lavorati con ombra sì abbacinata che in vero si può dire che egli fosse il maestro degli altri. E, per cosa che contrafaccia la notte più simile di quante la pittura ne fece già mai, questa è la più divina e da tutti tenuta la più rara.
Egli fece ancora, in una delle pareti nette, il culto divino e l'arca degli Ebrei et il candelabro e papa Giulio che caccia l'avarizia della Chiesa, storia di bellezza e di bontà simile alla notte detta di sopra. Nella quale storia si veggono alcuni ritratti di palafrenieri, che vivevano allora, i quali in su la sedia portano papa Giulio veramente vivissimo. Al quale mentre che alcuni popoli e femmine fanno luogo perché e' passi, si vede la furia d'uno armato a cavallo, il quale accompagnato da due appiè, con attitudine ferocissima, urta e percuote il superbissimo Eliodoro, che per comandamento d'Antioco vuole spogliare il Tempio di tutti i depositi delle vedove e de' pupilli, e già si vede lo sgombro delle robbe et i tesori che andavano via, ma per la paura del nuovo accidente di Eliodoro abbattuto e percosso aspramente dai tre predetti che, per essere ciò visione, da lui solamente sono veduti e sentiti, si veggono tutti traboccare e versare per terra, cadendo chi gli portava per un subito orrore e spavento che era nato in tutte le genti di Eliodoro. Et appartato da questi si vede il santissimo Onia pontefice, pontificalmente vestito, con le mani e con gli occhi al cielo, ferventissimamente orare, afflitto per la compassione de' poverelli che quivi perdevano le cose loro et allegro per quel soccorso che dal ciel sente sopravenuto. Veggonsi oltra ciò, per bel capriccio di Raffaello, molti saliti sopra i zoccoli del basamento et abbracciatisi alle colonne, con attitudini disagiatissime, stare a vedere; et un popolo tutto attonito in diverse e varie maniere, che aspetta il successo di questa cosa. E fu questa opera tanto stupenda in tutte le parti che anco i cartoni sono tenuti in grandissima venerazione; onde Messer Francesco Masini, gentiluomo di Cesena, il quale senza aiuto di alcun maestro, ma infin da fanciulezza guidato da straordinario instinto di natura, dando da sé medesimo opera al disegno et alla pittura, ha dipinto quadri che sono stati molto lodati dagli intendenti dell'arte, ha, fra molti suoi disegni et alcuni rilievi di marmo antichi, alcuni pezzi del detto cartone che fece Raffaello per questa istoria d'Eliodoro, e gli tiene in quella stima che veramente meritano. Né tacerò che Messer Niccolò Masini, il quale mi ha di queste cose dato notizia, è come in tutte l'altre cose virtuosissimo delle nostre arti veramente amatore. Ma, tornando a Raffaello, nella volta poi che vi è sopra fece quattro storie: l'apparizione di Dio ad Abraam nel promettergli la moltiplicazione del seme suo, il sacrificio d'Isaac, la scala di Iacob e 'l rubo ardente di Moisè, nella quale non si conosce meno arte, invenzione, disegno e grazia che nelle altre cose lavorate di lui.
Mentre che la felicità di questo artefice faceva di sé tante gran maraviglie, la invidia della fortuna privò de la vita Giulio Secondo, il quale era alimentatore di tal virtù et amatore d'ogni cosa buona. Laonde fu poi creato Leon Decimo, il quale volle che tale opera si seguisse, e Raffaello ne salì con la virtù in cielo e ne trasse cortesie infinite avendo in-contrato in un principe sì grande, il quale per eredità di casa sua era molto inclinato a tale arte. Per il che Raffaello si mise in cuore di seguire tale opera e nell'altra faccia fece la venuta d'Atila a Roma e lo incontrarlo appiè di Monte Mario che fece Leon III pontefice, il quale lo cacciò con le sole benedizzioni. Fece Raffaello in questa storia San Pietro e San Paulo in aria con le spade in mano, che vengono a difender la Chiesa. E se bene la storia di Leon III non dice que-sto, egli nondimeno per capriccio suo volse figurarla forse così, come interviene molte volte che così le pitture come le poesie vanno vagando, per ornamento dell'opera, non si discostando però per modo non conveniente dal primo intendimento. Vedesi in quegli Apostoli quella fierezza et ardire celeste che suole il giudizio divino molte volte mettere nel volto de' servi suoi per difender la santissima religione; e ne fa segno Atila, il quale si vede sopra un cavallo nero balzano e stellato in fronte, bellissimo quanto più si può, il quale con attitudine spaventosa alza la testa e volta la persona in fuga. Sonovi altri cavalli bellissimi e massimamente un gianetto macchiato, che è cavalcato da una figura, la quale ha tutto lo ignudo coperto di scaglie a guisa di pesce, il che è ritratto da la colonna Traiana, nella quale son i popoli armati in quella foggia. E si stima ch'elle siano arme fatte di pelle di coccodrilli. Èvvi Monte Mario che abrucia, mostrando che nel fine della partita de' soldati gli aloggiamenti rimangono sempre in preda alle fiamme. Ritrasse ancora di naturale alcuni mazzieri che accompagnano il papa, i quali son vivissimi e così i cavalli dove son sopra et il simile la corte de' cardinali et alcuni palafrenieri che tengono la chinea sopra cui è a cavallo in pontificale, ritratto non men vivo che gli altri, Leon X e molti cortigiani, cosa leggiadrissima da vedere a proposito in tale opera et utilissima a l'arte nostra, massimamente per quegli che di tali cose son digiuni. In questo medesimo tempo fece a Napoli una tavola, la quale fu posta in San Domenico nella cappella dove è il Crocifisso che parlò a San Tomaso d'Aquino; dentro vi è la Nostra Donna, San Girolamo vestito da cardinale et uno angelo Raffaello ch'accompagna Tobia. Lavorò un quadro al signor Leonello da Carpi, signor di Meldola, il quale ancor vive di età più che novanta anni, il quale fu miracolosissimo di colorito e di bellezza singulare. Atteso che egli è condotto di forza e d'una vaghezza tanto leggiadra che io non penso che e' si possa far meglio; vedendosi nel viso della Nostra Donna una divinità e ne la attitudine una modestia che non è possibile migliorarla. Finse che ella a man giunte adori il Figliuolo che le siede in su le gambe, facendo carezze a San Giovanni piccolo fanciullo, il quale lo adora insieme con Santa Elisabetta e Giuseppo. Questo quadro era già appresso il reverendissimo cardinale di Carpi, figliuolo di detto signor Leonello, delle nostre arti amator grandissimo, et oggi dee essere appresso gli eredi suoi. Dopo essendo stato creato Lorenzo Pucci, cardinale di Santi quattro, sommo penitenziere, ebbe grazia con esso che egli facesse per San Giovanni in Monte di Bologna una tavola, la quale è oggi locata nella capella, dove è il corpo della beata Elena da l'Olio, nella quale opera mostrò quanto la grazia nelle delicatissime mani di Raffaello potesse insieme con l'arte. Èvvi una Santa Cecilia che, da un coro in cielo d'Angeli abbagliata, sta a udire il suono, tutta data in preda alla armonia, e si vede nella sua testa quella astrazzione che si vede nel vivo di coloro che sono in estasi; oltra che sono sparsi per terra instrumenti musici che non dipinti, ma vivi e veri si conoscono, e similmente alcuni suoi veli e vestimenti di drappi d'oro e di seta, e sotto quelli un ciliccio maraviglioso. Et in un San Paulo, che ha posato il braccio destro in su la spada ignuda e la testa appoggiata alla mano, si vede non meno espressa la considerazione della sua scienzia che l'aspetto della sua fierezza conversa in gravità; questi è vestito d'un panno rosso semplice per mantello e d'una tonica verde sotto quella, alla apostolica e scalzo; èvvi poi Santa Maria Maddalena che tiene in mano un vaso di pietra finissima, in un posar leggiadrissimo e svoltando la testa par tutta allegra della sua conversione, che certo in quel genere penso che meglio non si potesse fare: e così sono anco bellissime le teste di Santo Agostino e di San Giovanni Evangelista. E nel vero che l'altre pitture, pitture nominare si possono, ma quelle di Raffaello cose vive: perché trema la carne, vedesi lo spirito, battono i sensi alle figure sue e vivacità viva vi si scorge; per il che questo li diede, oltra le lodi, che aveva più nome assai. Laonde furono però fatti a suo onore molti versi e latini e vulgari, de' quali metterò questi soli per non far più lunga storia di quel che io mi abbi fatto.
Pingant sola alii, referantque coloribus ora;
Ceciliae os Raphael atque animum explicuit.
Fece ancora doppo questo un quadretto di figure piccole, oggi in Bologna medesimamente in casa il conte Vincenzio Arcolano, dentrovi un Cristo a uso di Giove in cielo e d'attorno i quattro Evangelisti, come gli descrive Ezechiel; uno a guisa di uomo e l'altro di leone e quello d'aquila e di bue, con un paesino sotto figurato per la terra, non meno raro e bello nella sua piccolezza che sieno l'altre cose sue nelle grandezze loro. A Verona mandò della medesima bontà un gran quadro ai conti da Canossa, nel quale è una Natività di Nostro Signore bellissima con una aurora molto lodata, sì come è ancora Santa Anna; anzi tutta l'opera, la quale non si può meglio lodare che dicendo che è di mano di Raffaello da Urbino. Onde que' conti meritamente l'hanno in somma venerazione; né l'hanno mai, per grandissimo prezzo che sia stato loro offerto da molti prìncipi, a niuno voluto concederla. Et a Bindo Altoviti fece il ritratto suo quando era giovane che è tenuto stupendissimo. E similmente un quadro di Nostra Donna che egli mandò a Fiorenza, il qual quadro è oggi nel palazzo del duca Cosimo nella cappella delle stanze nuove e da me fatte e dipinte, e serve per tavola del-l'altare, et in esso è dipinta una Santa Anna vecchissima a sedere, la quale porge alla Nostra Donna il suo Figliuolo di tanta bellezza ne l'ignudo e nelle fatezze del volto che nel suo ridere rallegra chiunque lo guarda; senzaché Raffaello mostrò nel dipignere la Nostra Donna tutto quello che di bellezza si può fare nell'aria di una Vergine, dove sia accompagnata negli occhi modestia, nella fronte onore, nel naso grazia e nella bocca virtù, senzaché l'abito suo è tale che mostra una semplicità et onestà infinita. E nel vero io non penso che per tanta cosa si possa veder meglio; èvvi un San Giovanni a sedere ignudo et un'altra Santa ch'è bellissima anch'ella. Così per campo vi è un casamento, dove egli ha finto una finestra impannata che fa lume alla stanza dove le figure son dentro.
Fece in Roma un quadro di buona grandezza, nel quale ritrasse papa Leone, il cardinale Giulio de' Medici e il cardinale de' Rossi, nel quale si veggono non finte, ma di rilievo tonde le figure; quivi è il veluto che ha il pelo, il damasco a dosso a quel Papa, che suona e lustra; le pelli della fodera morbide e vive, e gli ori e le sete contrafatti sì che non colori, ma oro e seta paiono. Vi è un libro di carta pecora miniato che più vivo si mostra che la vivacità, et un campanello d'ar-gento lavorato, che non si può dire quanto è bello. Ma fra l'altre cose vi è una palla della seggiola brunita e d'oro nella quale, a guisa di specchio, si ribattono (tanta è la sua chiarezza) i lumi de le finestre, le spalle del Papa et il rigirare delle stanze; e sono tutte queste cose condotte con tanta diligenza che credasi pure, e sicuramente, che maestro nessuno di questo meglio non faceria né abbia a fare. La quale opera fu cagione che il Papa di premio grande lo rimunerò, e questo quadro si trova ancora in Fiorenza nella guardaroba del Duca. Fece similmente il Duca Lorenzo e 'l Duca Giuliano con perfezzione non più da altri che da esso dipinta nella grazia del colorito, i quali sono appresso agli eredi di Ottaviano de' Medici in Fiorenza. Laonde di grandezza fu la gloria di Raffaello accresciuta e de' premii parimente, perché per lasciare memoria di sé fece murare un palazzo a Roma in Borgo Nuovo, il quale Bramante fece condurre di getto; per queste e molte altre opere, essendo passata la fama di questo nobilissimo artefice insino in Francia et in Fiandra, Alberto Durero tedesco, pittore mirabilissimo et intagliatore di rame di belissime stampe, divenne tributario delle sue opere a Raffaello e gli mandò la testa d'un suo ritratto condotta da lui a guazzo su una tela di bisso, che da ogni banda mostrava parimente e senza biacca i lumi trasparenti, se non che con acquerelli di colori era tinta e macchiata, e de' lumi del pan-no aveva campato i chiari, la quale cosa parve maravigliosa a Raffaello, perché egli gli mandò molte carte disegnate di man sua, le quali furono carissime ad Alberto. Era questa testa fra le cose di Giulio Romano, ereditario di Raffaello in Mantova. Avendo dunque veduto Raffaello lo andare nelle stampe d'Alberto Durero, volonteroso ancor egli di mostrare quel che in tale arte poteva, fece studiare Marco Antonio Bolognese in questa pratica infinitamente, il quale riuscì tanto eccellente che gli fece stampare le prime cose sue: la carta degli Innocenti, un Cenacolo, il Nettuno e la Santa Cecilia quando bolle nell'olio.
Fece poi Marco Antonio per Raffaello un numero di stampe, le quali Raffaello donò poi al Baviera suo garzone ch'aveva cura d'una sua donna, la quale Raffaello amò sino alla morte e di quella fece un ritratto bellissimo che pareva viva viva, il quale è oggi in Fiorenza appresso il gentilissimo Matteo Botti, mercante fiorentino, amico e familiare d'o-gni persona virtuosa e massimamente dei pittori, tenuta da lui come reliquia per l'amore che egli porta all'arte e particularmente a Raffaello. Né meno di lui stima l'opere dell'arte nostra e gli artefici il fratello suo Simon Botti, che oltra lo esser tenuto da tutti noi per uno de' più amorevoli che faccino beneficio agli uomini di queste professioni è da me particulare tenuto e stimato per il migliore e maggiore amico che si possa per lunga esperienza aver caro; oltra al giudicio buono che egli ha e mostra nelle cose dell'arte. Ma, per tornare alle stampe, il favorire Raffaello il Baviera fu cagione che si destasse poi Marco da Ravenna et altri infiniti, per sì fatto modo che le stampe in rame fecero, de la carestia loro, quella copia che al presente veggiamo. Per che Ugo da Carpi con belle invenzioni, avendo il cervello volto a cose ingegnose e fantastiche, trovò le stampe di legno, che con tre stampe possono il mezzo, il lume e l'ombra contrafare, le carte di chiaro oscuro, la quale certo fu cosa di bella e capricciosa invenzione e di questa ancora è poi venuta abbondanza, come si dirà nella vita di Marcantonio Bolognese più minutamente.
Fece poi Raffaello per il monasterio di Palermo detto Santa Maria dello Spasmo, de' frati di Monte Oliveto, una tavola d'un Cristo che porta la croce, la quale è tenuta cosa maravigliosa; conoscendosi in quella la impietà de' crocifissori che lo conducono alla morte al monte Calvario con grandissima rabbia, dove il Cristo, appassionatissimo nel tormento dello avvicinarsi alla morte, cascato in terra per il peso del legno della croce e bagnato di sudore e di sangue, si volta verso le Marie, che piangono dirotissimamente. Oltre ciò si vede fra loro Veronica che stende le braccia porgendoli un panno, con uno affetto di carità grandissima; senzaché l'opera è piena di armati a cavallo et a piede, i quali sboccano fuora della porta di Gerusalemme con gli stendardi della giustizia in mano, in attitudini varie e bellissime. Questa tavola, finita del tutto, ma non condotta ancora al suo luogo, fu vicinissima a capitar male, perciò che, secondo che e' dicono, essendo ella messa in mare per essere portata in Palermo, una orribile tempesta percosse ad uno scoglio la nave che la portava, di maniera che tutta si aperse e si perderono gli uomini e le mercanzie, eccetto questa tavola solamente che, così incassata come era, fu portata dal mare in quel di Genova; dove ripescata e tirata in terra, fu veduta essere cosa divina e per questo messa in custodia; essendosi mantenuta illesa e senza macchia o difetto alcuno, perciò che sino alla furia de' venti e l'onde del mare ebbono rispetto alla bellezza di tale opera, della quale, divulgandosi poi la fama, procacciarono i monaci di riaverla, et appena che con favori del Papa ella fu renduta loro, che satisfecero, e bene, coloro che l'avevano salvata. Rimbarcatala dunque di nuovo e condottola pure in Sicilia, la posero in Palermo, nel qual luogo ha più fama e riputazione che 'l monte di Vulcano.
Mentre che Raffaello lavorava queste opere, le quali non poteva mancare di fare, avendo a servire per persone gran-di e segnalate, oltra che ancora per qualche interesse particulare non poteva disdire, non restava però con tutto questo di seguitare l'ordine che egli aveva cominciato de le camere del papa e de le sale, nelle quali del continuo teneva delle genti che con i disegni suoi medesimi gli tiravano innanzi l'opera et egli, continuamente rivedendo ogni cosa, suppliva con tutti quelli aiuti migliori che egli più poteva ad un peso così fatto. Non passò dunque molto che egli scoperse la camera di torre Borgia, nella quale aveva fatto in ogni faccia una storia, due sopra le finestre e due altre in quelle libere. Era in uno lo incendio di Borgo Vecchio di Roma che, non possendosi spegnere il fuoco, San Leone IIII si fa alla loggia di palazzo e con la benedizzione lo estingue interamente. Nella quale storia si veggiono diversi pericoli figurati, da una parte vi sono femmine che dalla tempesta del vento, mentre elle portano acqua per ispegnere il fuoco con certi vasi in mano et in capo, sono aggirati loro i capegli et i panni con una furia terribilissima; altri che si studiano buttare acqua, accecati dal fummo, non cognoscono se stessi. Dall'altra parte v'è figurato, nel medesimo modo che Vergilio descrive che Anchise fu portato da Enea, un vecchio ammalato, fuor di sé per l'infermità e per le fiamme del fuoco; dove si vede nella figura del giovane, l'animo e la forza et il patire di tutte le membra dal peso del vecchio abbandonato a dosso a quel giovane; seguitalo una vecchia scalza e sfibbiata che viene fuggendo il fuoco et un fanciulletto 'gnudo, loro innanzi. Così dal sommo d'una rovina si vede una donna ignuda tutta rabbuffata la quale avendo il figliuolo in mano, lo getta ad un suo, che è campato dalle fiame e sta nella strada in punta di piede a braccia tese per ricevere il fanciullo in fasce; dove non meno si conosce in lei l'affetto del cercare di campare il figliuolo che il patire di sé nel pericolo dello ardentissimo fuoco che la avvampa; né meno passione si scorge in colui che lo piglia, per cagione d'esso putto che per cagion del proprio timor della morte; né si può esprimere quello che si imaginò questo ingegnosissimo e mirabile artefice in una madre che, messosi i figlioli innanzi, scalza, sfibbiata, scinta e rabbuffato il capo, con parte delle veste in mano, gli batte perché e' fugghino dalla rovina e da quello incendio del fuoco. Oltre che vi sono ancor alcune femmine che, inginocchiate dinanzi al Papa, pare che prieghino Sua Santità che faccia che tale incendio finisca.
L'altra storia è del medesimo S. Leon IIII dove ha finito il porto di Ostia occupato da una armata di Turchi, che era venuta per farlo prigione. Veggonvisi i Cristiani combattere in mare l'armata e già al porto esser venuti prigioni infiniti che d'una barca escano tirati da certi soldati per la barba con bellissime cere e bravissime attitudini e con una differenza di abiti da galeotti sono menati innanzi a S. Leone che è figurato e ritratto per papa Leone X. Dove fece Sua Santità in pontificale, in mezzo del cardinale Santa Maria in Portico, cioè Bernardo Divizio da Bibbiena, e Giulio de' Medici cardinale che fu poi Papa Clemente. Né si può contare minutissimamente le belle avvertenze che usò questo ingegnosissimo artefice nelle arie de' prigioni, che senza lingua si conosce il dolore, la paura e la morte. Sono nelle altre due storie quando papa Leone X sagra il re cristianissimo Francesco I di Francia, cantando la messa in pontificale e benedicendo gli olii per ugnerlo et insieme la corona reale: dove, oltra il numero de' cardinali e vescovi in pontificale che ministrano, vi ritrasse molti ambasciatori et altre persone di naturale, e così certe figure con abiti alla franzese, secondo che si usava in quel tempo. Nell'altra storia fece la coronazione del detto re, nella quale è il papa et esso Francesco ritratti di naturale, l'uno armato e l'altro pontificalmente. Oltra che tutti i cardinali, vescovi, camerieri, scudieri, cubicularii, sono in pontificale a loro luoghi a sedere ordinatamente come costuma la cappella, ritratti di naturale, come Giannozo Pandolfini vescovo di Troia, amicissimo di Raffaello e molti altri che furono segnalati in quel tempo. E vicino al re è un putto ginocchioni che tiene la corona reale, che fu ritratto Ipolito de' Medici, che fu poi cardinale e vice cancelliere, tanto pregiato et amicissimo non solo di questa virtù, ma di tutte le altre: alle benignissime ossa del quali i' mi conosco molto obbligato, poiché il principio mio, quale egli si fusse, ebbe origine da lui.
Non si può scrivere le minuzie delle cose di questo artefice, ché invero ogni cosa nel suo silenzio par che favelli; oltra i basamenti fatti sotto a queste con varie figure di difensori e remuneratori della Chiesa, messi in mezzo da varii termini e condotto tutto d'una maniera, che ogni cosa mostra spirito et affetto e considerazione, con quella concordanzia et unione di colorito l'una con l'altra, che migliore non si può imaginare. E perché la volta di questa stanza era dipinta da Pietro Perugino suo maestro, Raffaello non la volse guastar per la memoria sua e per l'affezzione che gli portava, sendo stato principio del grado che egli teneva in tal virtù. Era tanta la grandezza di questo uomo che teneva disegnatori per tutta Italia, a Pozzuolo e fino in Grecia; né restò d'avere tutto quello che di buono per questa arte potesse giovare. Perché seguitando egli ancora fece una sala, dove di terretta erano alcune figure di Apostoli et altri Santi in tabernacoli; e per Giovanni da Udine suo discepolo, il quale per contrafare animali è unico, fece in ciò tutti quegli animali che papa Leone aveva: il camaleonte, i zibetti, le scimie, i papagalli, i lioni, i liofanti et altri animali più stranieri. Et oltre che di grottesche e vari pavimenti egli tal palazzo abbellì assai, diede ancora disegno alle scale papali et alle logge cominciate bene da Bramante architettore, ma rimase imperfette per la morte di quello e seguite poi col nuovo disegno et architettura di Raffaello, che ne fece un modello di legname con maggiore ordine et ornamento che non avea fatto Bramante. Per che volendo papa Leone mostrare la grandezza della magnificenza e generosità sua, Raffaello fece i disegni degli ornamenti di stucchi e delle storie che vi dipinsero e similmente de' partimenti e quanto allo stucco et alle grotesche fece capo di quella opera Giovanni da Udine; e sopra le figure Giulio Romano, ancora che poco vi lavorasse, così Giovan Francesco, il Bologna, Perino del Vaga, Pellegrino da Modona, Vincenzio da San Gimignano e Polidoro da Caravaggio, con molti altri pittori che feciono storie e figure et altre cose che accadevano per tutto quel lavoro. Il quale fece Raffaello finire con tanta perfezzione che sino da Fiorenza fece condurre il pavimento da Luca della Robbia. Onde certamente non può per pitture, stucchi, ordine e belle invenzioni, né farsi, né imaginarsi di fare più bell'opera. E fu cagione la bellezza di questo lavoro che Raffaello ebbe carico di tutte le cose di pittura et architettura che si facevano in palazzo.
Dicesi ch'era tanta la cortesia di Raffaello, che coloro che muravano, perché egli accomodasse gli amici suoi, non tirarono la muraglia tutta soda e continuata, ma lasciarono sopra le stanze vecchie da basso alcune aperture e vani da potervi riporre botti, vettine e legne, le quali buche e vani fecero indebilire i piedi della fabbrica sì che è stato forza che si riempia dappoi, perché tutta cominciava ad aprirsi. Egli fece fare a Gian Barile in tutte le porte e' palchi di legname assai cose d'intaglio, lavorate e finite con bella grazia. Diede disegni d'architettura alla vigna del papa, et in Borgo a più case e particularmente al palazzo di Messer Giovan Batista dall'Aquila, il quale fu cosa bellissima. Ne disegnò ancora uno al vescovo di Troia, il quale lo fece fare in Fiorenza nella via di San Gallo. Fece a' monaci neri di San Sisto in Piacenza la tavola dello altar maggiore dentrovi la Nostra Donna con San Sisto e Santa Barbara, cosa veramente rarissima e singulare. Fece per in Francia molti quadri e particularmente per il re San Michele che combatte col diavolo, tenuto cosa maravigliosa. Nella quale opera fece un sasso arsiccio per il centro della terra che fra le fessure di quello usciva fuori con alcuna fiamma di fuoco e di zolfo; et in Lucifero incotto et arso nelle membra con incarnazione di diverse tinte si scorgeva tutte le sorti della collera che la superbia invelenita e gonfia adopera contra chi opprime la grandezza di chi è privo di regno dove sia pace, e certo di avere a provare continovamente pena. Il contrario si scorge nel San Michele, che ancora che e' sia fatto con aria celeste, accompagnato dalle armi di ferro e di oro, ha nondimeno bravura e forza e terrore, avendo già fatto cader Lucifero, e quello con una zagaglia gettato rovescio; insomma fu sì fatta questa opera che meritò averne da quel re onoratissimo premio. Ritrasse Beatrice Ferrarese et altre donne e particularmente quella sua et altre infinite.
Fu Raffaello persona molto amorosa et affezzionata alle donne, e di continuo presto ai servigi loro. La qual cosa fu cagione che, continuando i diletti carnali, egli fu dagl'amici, forse più che non conveniva, rispettato e compiaciuto. Onde facendogli Agostin Ghigi, amico suo caro, dipignere nel palazzo suo la prima loggia, Raffaello non poteva molto attendere a lavorare per lo amore che portava ad una sua donna; per il che Agostino si disperava di sorte, che per via d'altri e da sé, e di mezzi ancora, operò sì che appena ottenne che questa sua donna venne a stare con esso in casa continuamente, in quella parte dove Raffaello lavorava, il che fu cagione che il lavoro venisse a fine. Fece in questa opera tutti i cartoni e molte figure colorì di sua mano in fresco. E nella volta fece il concilio degli dèi in cielo; dove si veggono nelle loro forme molti abiti e lineamenti cavati dall'antico, con bellissima grazia e disegno espressi; e così fece le nozze di Psiche con ministri che servon Giove, e le Grazie che spargono i fiori per la tavola; e ne' peducci della volta fece molte storie, fra le quali in una è Mercurio col flauto che volando par che scenda dal cielo, et in un'altra è Giove con gravità celeste che bacia Ganimede; e così di sotto nell'altra il carro di Venere e le Grazie che con Mercurio tirano al ciel Psiche e molte altre storie poetiche negli altri peducci. E negli spicchi della volta, sopra gl'archi fra peduccio e peduccio, sono molti putti che scortano, bellissimi, i quali volando portano tutti gli strumenti degli dèi: di Giove il fulmine e le saette, di Marte gli elmi, le spade e le targhe, di Vulcano i martelli, di Ercole la clava e la pelle del lione, di Mercurio il caduceo, di Pan la sampogna, di Vertunno i rastri della agricoltura. E tutti hanno animali appropriati alla natura loro: pittura e poesia veramente bellissima. Fecevi fare da Giovanni da Udine un ricinto alle storie d'ogni sorte fiori, foglie e frutte in festoni che non possono esser più belli. Fece l'ordine delle architetture delle stalle de' Ghigi e nella chiesa di Santa Maria del Popolo l'ordine della cappella di Agostino sopra detto. Nella quale, oltre che la dipinse, diede ordine che si facesse una maravigliosa sepoltura; et a Lorenzetto scultor fiorentino fece lavorar due figure, che sono ancora in casa sua al Macello de' Corbi in Roma. Ma la morte di Raffaello e poi quella di Agostino fu cagione che tal cosa si desse a Sebastian Viniziano.
Era Raffaello in tanta grandezza venuto che Leon X ordinò che egli cominciasse la sala grande di sopra, dove sono le vittorie di Gostantino, alla quale egli diede principio. Similmente venne volontà al Papa di far panni d'arazzi ricchissimi d'oro e di seta in filaticci; per che Raffaello fece in propria forma e grandezza di tutti di sua mano i cartoni coloriti, i quali furono mandati in Fiandra a tessersi, e finiti i panni vennero a Roma. La quale opera fu tanto miracolosamente condotta che reca maraviglia il vederla et il pensare come sia possibile avere sfilato i capegli e le barbe e dato col filo morbidezza alle carni; opera certo più tosto di miracolo che d'artificio umano, perché in essi sono acque, animali, casamenti e talmente ben fatti che non tessuti, ma paiono veramente fatti col pennello. Costò questa opra 70 mila scudi e si conserva ancora nella cappella papale. Fece al cardinale Colonna un San Giovanni in tela, il quale, portandogli per la bellezza sua grandissimo amore e trovandosi da una infirmità percosso, gli fu domandato in dono da Messer Iacopo da Carpi medico che lo guarì e, per averne egli voglia, a sé medesimo lo tolse parendogli aver seco obligo infinito et ora si ritrova in Fiorenza nelle mani di Francesco Benintendi. Dipinse a Giulio cardinale de' Medici e vice cancelliere una tavola della Trasfigurazione di Cristo per mandare in Francia, la quale egli di sua mano, continuamente lavorando, ridusse ad ultima perfezzione. Nella quale storia figurò Cristo trasfigurato nel Monte Tabor et appié di quello gli undici Discepoli che lo aspettano; dove si vede condotto un giovanetto spiritato acciò che Cristo sceso del monte lo liberi, il qua-le giovanetto mentre che con attitudine scontorta si prostende gridando e stralunando gli occhi, mostra il suo patire dentro nella carne, nelle vene e ne' polsi contaminati dalla malignità dello spirto e con pallida incarnazione fa quel gesto forzato e pauroso. Questa figura sostiene un vecchio che, abbracciatola e preso animo, fatto gli occhi tondi con la luce in mezzo, mostra con lo alzare le ciglia et increspar la fronte, in un tempo medesimo e forza e paura. Pure mirando gli Apostoli fiso pare che sperando in loro faccia animo a se stesso. Èvvi una femina fra molte, la quale è principale figura di quella tavola, che inginocchiata dinanzi a quegli, voltando la testa loro e coll'atto delle braccia verso lo spiritato, mostra la miseria di colui. Oltra che gli Apostoli chi ritto e chi a sedere et altri ginocchioni mostrano avere grandissima compassione di tanta disgrazia. E nel vero egli vi fece figure e teste, oltra la bellezza straordinaria, tanto nuove, varie e belle che si fa giudizio commune degli artefici che questa opera, fra tante quant'egli ne fece, sia la più celebrata, la più bella e la più divina. Avvenga che chi vuol conoscere [e] mostrare [in] pittura Cristo trasfigurato alla divinità lo guardi in questa opera, nella quale egli lo fece sopra a questo monte diminuito in una aria lucida con Mosè et Elia, che alluminati da una chiarezza di splendore si fanno vivi nel lume suo; sono in terra prostrati Pietro, Iacopo e Giovanni, in varie e belle attitudini: chi ha a terra il capo e chi con fare ombra agl'occhi con le mani si difende dai raggi e dalla immensa luce dello splendore di Cristo. Il quale vestito di colore di neve, pare che aprendo le braccia et alzando la testa, mostri la essenza e la deità di tutt'e tre le Persone unitamente ristrette nella perfezzione dell'arte di Raffaello, il quale pare che tanto si restrignesse insieme con la virtù sua, per mostrare lo sforzo et il valor dell'arte nel volto di Cristo, che finitolo, come ultima cosa che a fare avesse, non toccò più pennelli, sopragiugnendoli la morte.
Ora, avendo raccontate l'opere di questo eccellentissimo artefice, prima che io venga a dire altri particolari della vita e morte sua, non voglio che mi paia fatica discorrere alquanto per utile de' nostri artefici intorno alle maniere di Raffaello. Egli dunque, avendo nella sua fanciullezza imitato la maniera di Pietro Perugino suo maestro, e fattala molto migliore, per disegno, colorito et invenzione, e parendogli aver fatto assai, conobbe, venuto in migliore età, esser troppo lontano dal vero. Perciò che vedendo egli l'opere di Lionardo da Vinci, il quale nell'arie delle teste, così di maschi come di femmine, non ebbe pari e nel dar grazia alle figure e ne' moti superò tutti gl'altri pittori, restò tutto stupefatto e maravigliato; et insomma, piacendogli la maniera di Lionardo più che qualunche altra avesse veduta mai, si mise a studiarla e lasciando, se bene con gran fatica a poco a poco la maniera di Pietro, cercò, quanto seppe e poté il più, d'imitare la maniera di esso Lionardo. Ma per diligenza o studio che facesse, in alcune difficultà non poté mai passare Lionardo; e se bene pare a molti che egli lo passasse nella dolcezza et in una certa facilità naturale, egli nondimeno non gli fu punto superiore in un certo fondamento terribile di concetti e grandezza d'arte, nel che pochi sono stati pari a Lionardo. Ma Raffaello se gli è avvicinato bene più che nessuno altro pittore, e massimamente nella grazia de' colori.
Ma tornando a esso Raffaello, gli fu col tempo di grandissimo disaiuto e fatica quella maniera che egli prese di Pietro, quando era giovanetto; la quale prese agevolmente per essere minuta, secca e di poco dissegno; perciò che, non potendosela dimenticare, fu cagione che con molta difficultà imparò la bellezza degl'ignudi et il modo degli scorti difficili dal cartone, che fece Michelagnolo Buonarroti per la sala del Consiglio di Fiorenza, et un altro che si fusse perso d'a-nimo, parendogli avere insino allora gettato via il tempo, non arebbe mai fatto, ancor che di bellissimo ingegno, quello che fece Raffaello, il quale smorbatosi e levatosi da dosso quella maniera di Pietro per apprender quella di Michelagnolo piena di difficultà in tutte le parti, diventò quasi di maestro nuovo discepolo; e si sforzò con incredibile studio di fa-re, essendo già uomo, in pochi mesi quello che arebbe avuto bisogno di quella tenera età che meglio apprende ogni cosa e de lo spazzio di molti anni. E nel vero chi non impara a buon'ora i buoni principii e la maniera che vuol seguitare et a poco a poco non va facilitando con l'esperienza le difficultà dell'arti, cercando d'intendere le parti e metterle in pratica, non diverrà quasi mai perfetto; e se pure diverrà, sarà con più tempo e molto maggior fatica. Quando Raffaello si diede a voler mutare e migliorare la maniera, non aveva mai dato opera agl'ignudi con quello studio che si ricerca, ma solamente gli aveva ritratti di naturale, nella maniera che aveva veduto fare a Pietro suo maestro, aiutandogli con quella grazia che aveva dalla natura. Datosi dunque allo studiare gl'ignudi et a riscontrare i musculi delle notomie e degl'uo-mini morti e scorticati con quelli de' vivi, che per la coperta della pelle non appariscono terminati nel modo che fanno levata la pelle, e veduto poi in che modo si facciano carnosi e dolci ne' luoghi loro e come nel girare delle vedute si facciano con grazia certi storcimenti, e parimente gl'effetti del gonfiare et abbassare et alzare o un membro o tutta la persona, et oltre ciò l'incatenatura dell'ossa, de' nervi e delle vene; si fecce eccellente in tutte le parti che in uno ottimo dipintore sono richieste. Ma, conoscendo nondimeno che non poteva in questa parte arrivare alla perfezzione di Michelagnolo, come uomo di grandissimo giudizio, considerò che la pittura non consiste solamente in fare uomini nudi, ma che ell'ha il campo largo e che fra i perfetti dipintori si possono anco coloro annoverare che sanno esprimere bene e con facilità l'invenzioni delle storie et i loro capricci con bel giudizio e che nel fare i componimenti delle storie chi sa non confonderle col troppo et anco farle non povere col poco, ma con bella invenzione et ordine accomodarle, si può chiamare valente e giudizioso artefice. A questo, sì come bene andò pensando Raffaello, s'aggiugne lo arrichirle con la varietà e stravaganza delle prospettive, de' casamenti e de' paesi, il leggiadro modo di vestire le figure, il fare che elle si perdino alcuna volta nello scuro et alcuna volta venghino innanzi col chiaro; il fare vive e belle le teste delle femmine, de' putti, de' giovani e de' vecchi e dar loro, secondo il bisogno, movenza e bravura. Considerò anco quanto importi la fuga de' cavalli nelle battaglie, la fierezza de' soldati, il saper fare tutte le sorti d'animali e sopra tutto il far in modo nei ritratti somigliar gl'uomini che paino vivi e si conoschino per chi eglino sono fatti et altre cose infinite, come sono abigliamenti di panni, calzari, celate, armadure, acconciature, di femmine, capegli, barbe, vasi, alberi, grotte, sassi, fuochi, arie torbide e serene, nuvoli, pioggie, saette, sereni, notte, lumi di luna, splendori di sole et infinite altre cose, che seco portano ognora i bisogni dell'arte della pittura.
Queste cose, dico, considerando Raffaello, si risolvé, non potendo aggiungere Michelagnolo in quella parte dove egli aveva messo mano, di volerlo in queste altre pareggiare e forse superarlo; e così si diede, non ad imitare la maniera di colui, per non perdervi vanamente il tempo, ma a farsi un ottimo universale in queste altre parti che si sono raccontate. E se così avessero fatto molti artefici dell'età nostra che, per aver voluto seguitare lo studio solamente delle cose di Michelagnolo, non hanno imitato lui, né potuto aggiugnere a tanta perfezzione, eglino non arebbono faticato in vano, né fatto una maniera molto dura, tutta piena di difficultà, senza vaghezza, senza colorito e povera d'invenzione, là dove arebbono potuto cercando d'essere universali e d'imitare l'altre parti, essere stati a se stessi et al mondo di giovamento. Raffaello adunque, fatta questa risoluzione e conosciuto che fra' Bartolomeo di San Marco aveva un assai buon modo di dipignere, disegno ben fondato et una maniera di colorito piacevole, ancor che talvolta usasse troppo gli scuri per dar maggior rilievo, prese da lui quello che gli parve secondo il suo bisogno e capriccio, cioè un modo mezzano di fare, così nel dissegno, come nel colorito; e, mescolando col detto modo alcuni altri scelti delle cose migliori d'altri maestri, fece di molte maniere una sola che fu poi sempre tenuta sua propria, la quale fu e sarà sempre stimata dagl'artefici infinitamente. E questa si vide perfetta poi nelle Sibille e ne' Profeti dell'opera che fece, come si è detto, nella Pace. Al fare della quale opera gli fu di grande aiuto l'aver veduto nella capella del papa l'opera di Michelagnolo. E se Raffaello si fusse in questa sua detta maniera fermato, né avesse cercato di aggrandirla e variarla, per mostrare che egli intendeva gl'ignudi così bene come Michelagnolo, non si sarebbe tolto parte di quel buon nome che acquistato si aveva; perciò che gli ignudi che fece nella camera di Torre Borgia, dove è l'incendio di Borgo Nuovo, ancora che siano buoni, non sono in tutto eccellenti. Parimente non sodisfeciono affatto quelli che furono similmente fatti da lui nella volta del palazzo d'Agostin Chigi in Trastevere, perché mancano di quella grazia e dolcezza che fu propria di Raffaello; del che fu anche in gran parte cagione l'avergli fatto colorire ad altri col suo disegno. Dal quale errore ravedutosi, come giudizioso, volle poi lavorare da sé solo, e senza aiuto d'altri, la tavola di San Pietro a Montorio della Trasfigurazione di Cristo; nella quale sono quelle parti, che già s'è detto, che ricerca e debbe avere una buona pittura. E se non avesse in questa opera, quasi per capriccio, adoperato il nero di fumo da stampatori, il quale, come più volte si è detto, di sua natura di-venta sempre col tempo più scuro et offende gl'altri colori coi quali è mescolato, credo che quell'opera sarebbe ancor fresca come quando egli la fece, dove oggi pare più tosto tinta che altrimenti.
Ho voluto quasi nella fine di questa vita fare questo discorso per mostrare con quanta fatica, studio e diligenza si governasse sempremai questo onorato artefice; e particolarmente per utile degl'altri pittori, acciò si sappiano difendere da quelli impedimenti dai quali seppe la prudenza e virtù di Raffaello difendersi. Aggiugnerò ancor questo: che doverebbe ciascuno contentarsi di fare volentieri quelle cose alle quali si sente da naturale instinto inclinato e non volere por mano, per gareggiare, a quello che non gli vien dato dalla natura, per non faticare invano e spesso con vergogna e dan-no. Oltre ciò quando basta il fare non si dee cercare di volere strafare per passare innanzi a coloro che, per grande aiuto di natura e per grazia particolare data loro da Dio, hanno fatto o fanno miracoli nell'arte. Perciò che chi non è atto a una cosa non potrà mai, et affatichisi quanto vuole, arivare dove un altro con l'aiuto della natura è caminato agevolmente. E ci sia, per esempio, fra i vecchi Paulo Ucello, il quale, affaticandosi contra quello che poteva per andare inanzi, tornò sempre indietro. Il medesimo ha fatto ai giorni nostri, e poco fa, Iacopo da Puntormo. E si è veduto per isperienza in molti altri, come si è detto e come si dirà. E ciò forse avviene perché il cielo va compartendo le grazie, acciò stia contento ciascuno a quella che gli tocca. Ma avendo oggimai discorso sopra queste cose dell'arte, forse più che bisogno non era, per ritornare alla vita e morte di Raffaello dico che, avendo egli stretta amicizia con Bernardo Divizio cardinale di Bibbiena, il cardinale l'aveva molti anni infestato per dargli moglie e Raffaello non aveva espressamente ricusato di fare la voglia del cardinale, ma aveva ben trattenuto la cosa, con dire di volere aspettare che passassero tre o quattro anni; il quale termine venuto, quando Raffaello non se l'aspettava, gli fu dal cardinale ricordata la promessa et egli vedendosi obligato, come cortese non volle mancare della parola sua e così accettò per donna una nipote di esso cardinale. E perché sempre fu malissimo contento di questo laccio, andò in modo mettendo tempo in mezzo, che molti mesi passarono, che 'l matrimonio non consumò. E ciò faceva egli non senza onorato proposito. Perché, avendo tanti anni servito la corte et essendo creditore di Leone di buona somma, gli era stato dato indizio che alla fine della sala, che per lui si faceva, in ricompensa delle fatiche e delle virtù sue, il Papa gli avrebbe dato un capello rosso, avendo già deliberato di farne un buon numero e fra essi qualcuno di manco merito che Raffaello non era. Il quale Raffaello, attendendo in tanto a' suoi amori così di nascosto, continuò fuor di modo i piaceri amorosi, onde avvenne ch'una volta fra l'altre disordinò più del solito; perché tornato a casa con una grandissima febbre, fu creduto da' medici che fosse riscaldato; onde, non confessando egli il disordine che aveva fatto, per poca prudenza, loro gli cavarono sangue; di maniera che indebilito si sentiva mancare, là dove egli aveva bisogno di ristoro. Perché fece testamento e prima come cristiano mandò l'amata sua fuor di casa e le lasciò modo di vivere onestamente; dopo divise le cose sue fra' discepoli suoi: Giulio Romano, il quale sempre amò molto, Giovan Francesco Fiorentino detto il Fattore, et un non so chi prete da Urbino suo parente. Ordinò poi che delle sue facultà in Santa Maria Ritonda si restaurasse un tabernacolo di quegli antichi di pietre nuove et uno altare si facesse con una statua di Nostra Donna di marmo, la quale per sua sepoltura e riposo dopo la morte s'elesse; e lasciò ogni suo avere a Giulio e Giovan Francesco, faccendo essecutore del testamento Messer Baldassarre da Pescia, allora datario del Papa. Poi confesso e contrito finì il corso della sua vita il giorno medesimo che nacque, che fu il venerdì santo d'anni XXXVII, l'anima del quale è da credere che come di sue virtù ha abbellito il mondo, così abbia di sé medesima adorno il cielo.
Gli misero alla morte al capo nella sala, ove lavorava, la tavola della Trasfigurazione che aveva finita per il cardinale de' Medici, la quale opera nel vedere il corpo morto e quella viva, faceva scoppiare l'anima di dolore a ogni uno che quivi guardava. La quale tavola per la perdita di Raffaello fu messa dal cardinale a San Pietro a Montorio allo altar maggiore; e fu poi sempre per la rarità d'ogni suo gesto in gran pregio tenuta. Fu data al corpo suo quella onorata sepoltura che tanto nobile spirito aveva meritato, perché non fu nessuno artefice che dolendosi non piagnesse et insieme alla sepoltura non l'accompagnasse. Dolse ancora sommamente la morte sua a tutta la corte del Papa, prima per avere egli avuto in vita uno officio di cubiculario et appresso per essere stato sì caro al Papa che la sua morte amaramente lo fece piagnere. O felice e beata anima, da che ogn'uomo volentieri ragiona di te e celebra i gesti tuoi et ammira ogni tuo disegno lasciato. Ben poteva la pittura, quando questo nobile artefice morì, morire anche ella che quando egli gli occhi chiuse, ella quasi cieca rimase. Ora a noi che dopo lui siamo rimasi, resta imitare il buono, anzi ottimo modo, da lui lasciatoci in esempio e come merita la virtù sua e l'obligo nostro, tenerne nell'animo graziosissimo ricordo e farne con la lingua sempre onoratissima memoria. Che invero noi abbiamo per lui l'arte, i colori e la invenzione unitamente ridotti a quella fine e perfezzione che appena si poteva sperare, né di passar lui già mai si pensi spirito alcuno. Et oltre a questo beneficio che e' fece all'arte, come amico di quella, non restò vivendo mostrarci come si negozia con gli uomini grandi, co' mediocri e con gl'infimi. E certo fra le sue doti singulari ne scorgo una di tal valore che in me stesso stupisco: che il cielo gli diede forza di poter mostrare ne l'arte nostra uno effetto sì contrario alle complessioni di noi pittori; questo è che naturalmente gli artefici nostri, non dico solo i bassi, ma quelli che hanno umore d'esser grandi (come di questo umore l'arte ne produce infiniti), lavorando ne l'opere in compagnia di Raffaello stavano uniti e di concordia tale che tutti i mali umori nel veder lui si amorzavano et ogni vile e basso pensiero cadeva loro di mente. La quale unione mai non fu più in altro tempo che nel suo. E questo avveniva perché restavano vinti dalla cortesia e dall'arte sua, ma più dal genio della sua buona natura. La quale era sì piena di gentilezza e sì colma di carità, che egli si vedeva che fino agli animali l'onoravano, non che gli uomini. Dicesi che ogni pittore che conosciuto l'avesse, et anche chi non lo avesse conosciuto, se lo avessi richiesto di qualche disegno che gli bisognasse, egli lasciava l'opera sua per sovvenirlo. E sempre tenne infiniti in opera, aiutandoli et insegnandoli con quello amore che non ad artifici, ma a figliuoli proprii si conveniva. Per la qual cagione si vedeva che non andava mai a corte che partendo di casa non avesse seco cinquanta pittori tutti valenti e buoni che gli facevono compagnia per onorarlo. Egli insomma non visse da pittore, ma da principe: per il che
o arte della pittura, tu pur ti potevi allora stimare felicissima avendo un tuo artefice che di virtù e di costumi t'alzava sopra il cielo; beata veramente ti potevi chiamare, da che per l'orme di tanto uomo, hanno pur visto gli allievi tuoi come si vive e che importi l'avere accompagnato insieme arte e virtute; le quali in Raffaello congiunte, potettero sforzare la grandezza di Giulio II e la generosità di Leone X nel sommo grado e degnità che egli erono a farselo familiarissimo et usarli ogni sorte di liberalità, tal che poté col favore e con le facultà che gli diedero fare a sé et a l'arte grandissimo onore. Beato ancora si può dire chi stando a' suoi servigi sotto lui operò, perché ritrovo chiunche che lo imitò essersi a onesto porto ridotto e così quegli che imiteranno le sue fatiche nell'arte saranno onorati dal mondo e, ne' costumi santi lui somigliando, remunerati dal cielo. Ebbe Raffaello dal Bembo questo epitaffio:
D.O.M. RAPHAEL SANCTIO IOANNIS FILIO URBINATI PICTORI EMINENTISSIMO VETERUMQUE AEMULO CUIUS SPIRANTEIS PROPE IMAGINEIS SI CONTEMPLERE NATURAE ATQUE ARTIS FOEDUS FACILE INSPEXERIS IULII II ET LEONIS X PONTT MAXX. PICTURAE ET ARCHITECTURAE OPERIBUS GLORIAM AUXIT VIXIT ANNOS XXXVII INTEGER INTEGROS QUO DIE NATUS EST EO ESSE DESIIT VIII D APRILIS MDXX. ILLE HIC EST RAPHAEL, TIMUIT QUO SOSPITE VINCI RERUM MAGNA PARENS, ET MORIENTE MORI.
Et il conte Baldassarre Castiglione scrisse de la sua morte in questa maniera:
Quod lacerum corpus medica sanaverit arte;
Hippolytum Stigiis et revocarit aquis;
ad Stygias ipse est raptus Epidaurius undas;
sic precium vitae, mors fuit artifici.
Tu quoque dum toto laniatam corpore Romam
componis miro Raphael ingenio;
atque Urbis lacerum ferro, igni, annisque cadaver,
ad vitam, antiquum iam revocasque decus,
movisti superum invidiam indignataque Mors est,
te dudum extinctis reddere posse animam,
et quod longa dies paulatim aboleverat, hoc te
mortali spreta lege parare iterum.
Sic miser heu prima cadis intercepte juventa,
deberi et morti, nostraque nosque mones.
VITA DI GUGLIELMO DA MARCILLA PITTORE FRANZESE E MAESTRO DI FINESTRE INVETRIATE

In questi medesimi tempi, dotati da Dio di quella maggior felicità che possino aver l'arti nostre, fiorì Guglielmo da Marcilla franzese, il quale, per la ferma abitazione et affezione che e' portò alla città d'Arezzo, si può dire se la eleggesse per patria, che da tutti fussi reputato e chiamato aretino. E veramente de' benefizii che si cavano della virtù è uno, che sia pure di che strana e lontana regione o barbara et incognita nazione quale uomo si voglia, pure che egli abbia lo animo ornato di virtù e con le mani faccia alcuno esercizio ingegnoso, nello apparir nuovo in ogni città dove e' camina, mostrando il valor suo, tanta forza ha l'opera virtuosa che di lingua in lingua in poco spazio gli fa nome e le qualità di lui diventano pregiatissime et onoratissime.
E spesso avviene a infiniti, che di lontano hanno lasciato le patrie loro, nel dare d'intoppo in nazioni che siano amiche delle virtù e de' forestieri per buono uso di costumi, trovarsi accarezzati e riconosciuti sì fattamente, ch'e' si scordano il loro nido natìo et un altro nuovo s'eleggono per ultimo riposo; come per ultimo suo nido elesse Arezzo, Guglielmo, il quale nella sua giovanezza attese in Francia all'arte del disegno et insieme con quello diede opera alle finestre di vetro, nelle quali faceva figure di colorito non meno unite che se elle fossero d'una vaghissima et unitissima pittura a olio.
Costui ne' suoi paesi, persuaso da' prieghi d'alcuni amici suoi, si ritrovò alla morte d'un loro inimico, per la qual cosa fu sforzato nella Religione di San Domenico in Francia pigliare l'abito di frate, per essere libero dalla corte e da la giustizia. E se bene egli dimorò nella religione, non però mai abbandonò gli studi dell'arte, anzi continuando gli condusse ad ottima perfezzione. Fu per ordine di papa Giulio II dato commissione a Bramante da Urbino di far fare in palazzo molte finestre di vetro, perché nel domandare che egli fece de' più eccellenti, fra gli altri, che di tal mestiero lavoravano, gli fu dato notizia d'alcuni che facevano in Francia cose maravigliose, e ne vide il saggio per lo ambasciator francese che negoziava allora appresso Sua Santità, il quale aveva in un telaro, per finestra dello studio, una figura lavorata in un pezzo di vetro bianco con infinito numero di colori sopra il vetro lavorati a fuoco; onde per ordine di Bramante fu scritto in Francia che venissero a Roma, offerendogli buone provisioni. Laonde maestro Claudio Franzese, capo di questa arte, avuto tal nuova, sapendo l'eccellenza di Guglielmo, con buone promesse e danari, fece sì che non gli fu difficile trarlo fuor de' frati, avendo egli per le discortesie usategli e per le invidie, che son di continuo fra loro, più voglia di partirsi che maestro Claudio bisogno di trarlo fuora. Vennero dunque a Roma, e lo abito di San Domenico si mutò in quello di San Piero. Aveva Bramante fatto fare allora due fenestre di trevertino nel palazzo del papa, le quali erano nella sala dinanzi alla cappella, oggi abbellita di fabbrica in volta per Antonio da San Gallo, e di stucchi mirabili per le mani di Perino del Vaga fiorentino, le quali fenestre da maestro Claudio e da Guglielmo furono lavorate, ancora che poi per il sacco spezzate per trarne i piombi per le palle degli archibusi, le quali erano certamente maravigliose. Oltra queste ne fecero per le camere papali infinite, delle quali il medesimo avvenne che dell'altre due. Et oggi ancora se ne vede una nella camera del fuoco di Raffaello sopra torre Borgia, nelle quali sono Angeli che tengono l'arme di Leon
X.
Fecero ancora in S. Maria del Popolo due fenestre nella capella di dietro alla Madonna con le storie della vita di lei, le quali di quel mestiero furono lodatissime. E queste opere non meno gli acquistarono fama e nome che comodità alla vita. Ma maestro Claudio disordinando molto nel mangiare e bere, come è costume di quella nazione, cosa pestifera al-l'aria di Roma, ammalò d'una febbre sì grave che in sei giorni passò a l'altra vita. Per che Guglielmo, rimanendo solo e quasi perduto senza il compagno, da sé dipinse una fenestra in Santa Maria de Anima, chiesa de' Tedeschi in Roma, pur di vetro, la quale fu cagione che Silvio cardinale di Cortona gli fece offerte e convenne seco perché in Cortona sua patria alcune fenestre et altre opere gli facesse, onde seco in Cortona lo condusse a abitare. E la prima opera che facesse fu la facciata di casa sua, che è volta su la piazza, la quale dipinse di chiaro oscuro e dentro vi fece Crotone e gli altri primi fondatori di quella città. Laonde il cardinale, conoscendo Guglielmo non meno buona persona che ottimo maestro di quella arte, gli fece fare nella Pieve di Cortona la fenestra della cappella maggiore; nella quale fece la Natività di Cristo et i Magi che l'adorano. Aveva Guglielmo bello spirito, ingegno e grandissima pratica nel maneggiare i vetri, e massimamente nel dispensare in modo i colori che i chiari venissero nelle prime figure et i più oscuri, di mano in mano, in quelle che andavano più lontane; et in questa parte fu raro e veramente eccellente. Ebbe poi nel dipignergli ottimo giudizio, onde conduceva le figure tanto unite che elle si allontanavano a poco a poco, per modo che non si apiccavano, né con i casamenti, né con i paesi, e parevano dipinte in una tavola o più tosto di rilievo. Ebbe invenzione e varietà nella composizione delle storie e le fece ricche e molto accomodate, agevolando il modo di fare quelle pitture che vanno commesse di pezzi di vetri, il che pareva et è veramente, a chi non ha questa pratica e destrezza, difficilissimo. Disegnò costui le sue pitture per le finestre con tanto buon modo et ordine, che le commettiture de' piombi e de' ferri che attraversano in certi luoghi l'accomodarono di maniera nelle congiunture delle figure e nelle pieghe de' panni, che non si conoscano, anzi davano tanta grazia che più non arebbe fatto il pennello e così seppe fare della necessità virtù.
Adoprava Guglielmo solamente di due sorti colori per ombrare que' vetri che voleva reggessino al fuoco: l'uno fu scaglia di ferro e l'altro scaglia di rame. Quella di ferro nera gl'ombrava i panni, i capelli et i casamenti, e l'altra, cioè quella di rame, che fa tané, le carnagioni. Si serviva anco assai d'una pietra dura, che viene di Fiandra e di Francia, che oggi si chiama lapis amotica, che è di colore rosso e serve molto per brunire l'oro; e pesta prima in un mortaio di bronzo e poi con un macinello di ferro sopra una piastra di rame o d'ottone e temperata a gomma, in sul vetro fa divinamente. Non aveva Guglielmo, quando prima arivò a Roma, se bene era pratico nell'altre cose, molto disegno, ma conosciuto il bisogno, se bene era in là con gl'anni, si diede a disegnare e studiare, e così a poco a poco le migliorò, quanto si vide poi nelle finestre che fece nel palazzo del detto cardinale in Cortona et in quell'altro di fuori et in un occhio, che è nella detta pieve sopra la facciata dinanzi a man ritta entrando in chiesa, dove è l'arme di papa Leone X, e parimente in due finestre piccole che sono nella Compagnia del Gesù; in una delle quali è un Cristo e nell'altra un Santo Onofrio, le quali opere sono assai differenti e molto migliori delle prime. Dimorando dunque, come si è detto, costui in Cortona, morì in Arezzo Fabiano di Stagio Sassoli aretino, stato bonissimo maestro di fare finestre grande. Onde avendo gl'Operai del vescovado allogato tre finestre, che sono nella cappella principale di venti braccia l'una, a Stagio figliuolo del detto Fabiano et a Domenico Pecori pittore, quando furono finite e poste ai luoghi loro, non molto sodisfecero agl'Aretini, ancora che fossero assai buone e più tosto lodevoli che no. Ora avvenne che, andando in quel tempo Messer Lodovico Bellichini, medico eccellente e de' primi che governasse la città d'Arezzo, a medicare in Cortona la madre del detto cardinale, egli si dimesticò assai col detto Guglielmo, col quale, quando tempo gl'avanzava, ragionava molto volentieri e Guglielmo parimente, che allora si chiamava il priore, per avere di que' giorni avuto il beneficio d'una prioria, pose affezzione al detto medico; il quale un giorno domandò Guglielmo se con buona grazia del cardinale anderebbe a fare in Arezzo alcune finestre; et avendogli promesso, con licenza e buona grazia del cardinale, là si condusse. Stagio dunque, del quale si è ragionato di sopra, avendo divisa la compagnia con Domenico, raccettò in casa sua Guglielmo; il quale per la prima opera in una finestra di Santa Lucia, cappella degl'Albergotti nel Vescovado d'Arezzo, fece essa Santa et un S. Salvestro, tanto bene che questa opera può dirsi veramente fatta di vivissime figure e non di vetri colorati e trasparenti o, almeno, pittura lodata e maravigliosa perché, oltre al magisterio delle carni, sono squagliati i vetri, cioè levata in alcun luogo la prima pelle e poi colorita d'altro colore, come sarebbe a dire posto in sul vetro rosso squagliato opera gialla et in su l'azzurro bianca e verde lavorata, la qual cosa in questo mestiero è difficile e miracolosa.
Il vero, dunque, e primo colorato viene tutto da uno de' lati, come dire il colore rosso, azzurro o verde, e l'altra parte, che è grossa quanto il taglio d'un coltello o poco più, bianca. Molti per paura di non spezzare i vetri, per non avere gran pratica nel maneggiargli, non adoperano punta di ferro per squagliarli, ma in quel cambio, per più sicurtà, vanno incavando i detti vetri con una ruota di rame in cima un ferro, e così a poco a poco tanto fanno con lo smeriglio che lasciano la pelle sola del vetro bianco, il quale viene molto netto. Quando poi sopra detto vetro rimaso bianco si vuol fare di colore giallo, allora si dà, quando si vuole metter a fuoco a punto per cuocerlo, con un pennello, d'argento calcinato che è un colore simile al bolo, ma un poco grosso e questo al fuoco si fonde sopra il vetro e fa che scorrendo si attacca, penetrando a detto vetro, e fa un bellissimo giallo, i quali modi di fare niuno adoperò meglio, né con più artificio et ingegno del priore Guglielmo; et in queste cose consiste la difficultà, perché il tignere di colori a olio o in altro modo è poco o niente, e che sia diaffano e trasparente non è cosa di molto momento, ma il cuocergli a fuoco e fare che regghino alle percosse dell'acqua e si conservino sempre, è ben fatica degna di lode. Onde questo eccellente maestro merita lode grandissima, per non essere chi in questa professione di disegno, d'invenzione, di colore e di bontà abbia mai fatto tanto.
Fece poi l'occhio grande di detta chiesa dentrovi la veduta dello Spirito Santo e così il battesimo di Cristo, per San Giovanni, dove egli fece Cristo nel Giordano che aspetta San Giovanni, il quale ha preso una tazza d'acqua per battezarlo, mentre che un vecchio nudo si scalza e certi Angeli preparano la veste per Cristo, e sopra è il Padre, che manda lo Spirito Santo al Figliuolo. Questa finestra è sopra il battesimo in detto Duomo, nel quale ancora lavorò la finestra della resurrezione di Lazzaro quattriduano, dove è impossibile mettere in sì poco spazio tante figure, nelle quali si conosce lo spavento e lo stupire di quel popolo et il fetore del corpo di Lazaro, il quale fa piangere et insieme rallegrare le due sorelle della sua resurressione. Et in questa opera sono squagliamenti infiniti di colore sopra colore nel vetro e vivissima certo pare ogni minima cosa nel suo genere. E chi vuol vedere quanto abbia in questa arte potuto la mano del priore nella finestra di San Matteo sopra la cappella di esso Apostolo, guardi la mirabile invenzione di questa istoria e vedrà vivo Cristo chiamare Matteo dal banco, che lo seguiti, il quale aprendo le braccia per riceverlo in sé, abbandona le acquistate ricchezze e tesori. Et in questo mentre uno Apostolo, addormentato appiè di certe scale, si vede essere svegliato da un altro con prontezza grandissima, e nel medesimo modo vi si vede ancora un S. Piero favellare con San Giovanni, sì belli l'uno e l'altro che veramente paiono divini; in questa finestra medesima sono i tempi di prospettiva, le scale e le figure talmente composte, et i paesi sì proprii fatti che mai non si penserà che sien vetri, ma cosa piovuta da cielo a consolazione degli uomini. Fece in detto luogo la finestra di Santo Antonio e di San Niccolò bellissime e due altre, dentrovi nella una la storia quando Cristo caccia i vendenti del tempio e nell'altra l'adultera, opere veramente tutte tenute egregie e maravigliose. E talmente furono di lode, di carezze e di premii le fatiche e le virtù del priore dagli Aretini riconosciute et egli di tal cosa tanto contento e sodisfatto, che si risolvette eleggere quella città per patria, e di Franzese che era diventare Aretino.
Appresso, considerando seco medesimo l'arte de' vetri essere poco eterna per le rovine che nascono ognora in tali opre, gli venne desiderio di darsi alla pittura e così dagli Operai di quel Vescovo prese a fare tre grandissime volte a fresco, pensando lasciar di sé memoria. E gli Aretini in ricompensa, gli fecero dare un podere, ch'era della Fraternità di Santa Maria della Misericordia, vicino alla terra, con bonissime case a godimento della vita sua. E volsero che, finita tale opera, fosse stimato per uno egregio artefice il valor di quella e che gli Operai di ciò gli facessino buono il tutto. Perché egli si mise in animo di farsi in ciò valere et alla similitudine delle cose della cappella di Michelagnolo, fece le figure per la altezza grandissime. E poté in lui talmente la voglia di farsi eccellente in tale arte, che ancora che ei fosse di età di cinquanta anni, migliorò di cosa in cosa di modo che mostrò non meno conoscere et intendere il bello, che in opera dilettarsi contrafare il buono. Figurò i principi del Testamento Nuovo, come nelle tre grandi il principio del Vecchio aveva fatto. Onde per questa cagione voglio credere che ogni ingegno che abbia volontà di pervenire a la perfezzione, possa passare (volendo affaticarsi) il termine d'ogni scienza. Egli si spaurì bene nel principio di quelle per la grandezza e per non aver più fatto. Il che fu cagione ch'egli mandò a Roma per maestro Giovanni Franzese miniatore, il quale, venendo in Arezzo, fece in fresco sopra Santo Antonio uno arco con un Cristo e nella Compagnia il segno che si porta a processione, che gli furono fatti lavorare dal priore. Et egli molto diligentemente gli condusse. In questo medesimo tempo fece alla chiesa di San Francesco l'occhio della chiesa nella facciata dinanzi, opera grande, nel quale finse il papa nel consistoro e la residenza de' cardinali, dove San Francesco porta le rose di gennaio e per la confermazione della Regola va a Roma. Nella quale opera mostrò quanto egli de' componimenti s'intendesse, che veramente si può di-re lui esser nato per quello essercizio. Quivi non pensi artefice alcuno, di bellezza, di copia di figure, né di grazia già mai paragonarlo. Sono infinite opere di finestre per quella città tutte bellissime e nella Madonna delle Lagrime l'occhio grande con l'Assunzione della Madonna et Apostoli et una d'una Annunziata bellissima. Un occhio con lo Sponsalizio et un altro dentrovi un San Girolamo per gli Spadari. Similmente giù per la chiesa tre altre finestre e nella chiesa di San Girolamo un occhio, con la Natività di Cristo, bellissimo, et ancora un altro in San Rocco. Mandonne eziandio in diversi luoghi come a Castiglion del Lago et a Fiorenza a Lodovico Capponi una per in Santa Felicita, dove è la tavola di Iacopo da Puntormo, pittore eccellentissimo, e la cappella lavorata da lui a olio in muro et in fresco et in tavola, la qua-le finestra venne nelle mani de' frati Gesuati, che in Fiorenza lavorano di tal mestiere, et essi la scommessero tutta per vedere i modi di quello e molti pezzi per saggi ne levarono e di nuovo vi rimessero, e finalmente la mutarono di quel ch'ella era.
Volse ancora colorire a olio e fece in San Francesco d'Arezzo alla cappella della Concezzione una tavola, nella qua-le sono alcune vestimenta molto ben condotte e molte teste vivissime e tanto belle che egli ne restò onorato per sempre, essendo questa la prima opera che egli avese mai fatta ad olio. Era il priore persona molto onorevole e si dilettava cultivare et acconciare, onde, avendo compero un bellissimo casamento, fece in quello infiniti bonificamenti. E come uomo religioso tenne di continuo costumi bonissimi et il rimorso della conscienza, per la partita che fece da' frati, lo teneva molto aggravato. Per il che a San Domenico d'Arezzo, convento della sua Religione, fece una finestra alla cappella del-l'altar maggiore bellissima, nella quale fece una vite ch'esce di corpo a San Domenico e fa infiniti santi frati i quali fanno lo albero della Religione et a sommo è la Nostra Donna e Cristo che sposa Santa Caterina sanese, cosa molto lodata e di gran maestria della quale non volse premio, parendoli avere molto obligo a quella Religione. Mandò a Perugia in San Lorenzo una bellissima finestra et altre infinite in molti luoghi intorno ad Arezzo. E perché era molto vago delle cose d'architettura, fece per quella terra a' cittadini assai disegni di fabbriche e di ornamenti per la città, le due porte di San Rocco di pietra e lo ornamento di macigno che si mise alla tavola di maestro Luca in San Girolamo. Nella Badia a Cipriano d'Anghiari ne fece uno e nella Compagnia della Trinità alla cappella del Crocifisso un altro ornamento et un lavamani ricchissimo nella sagrestia, i quali Santi Scarpellino condusse in opera perfettamente. Laonde egli, che di lavorare sempre aveva diletto, continuando il verno e la state il lavoro del muro, il quale chi è sano fa divenire infermo, prese tanta umidità che la borsa de' granelli si gli riempié d'acqua, talmente che, foratagli da' medici, in pochi giorni re-se l'anima a chi gliene aveva donata. E come buon cristiano prese i Sacramenti della chiesa e fece testamento. Appresso, avendo speziale divozione nei romiti camaldolesi, i quali vicino ad Arezzo venti miglia sul giogo d'Apennino fanno congregazione, lasciò loro l'avere et il corpo suo. Et a Pastorino da Siena suo garzone, ch'era stato seco molti anni, lasciò i vetri e le masserizie da lavorare et i suoi disegni che n'è nel nostro libro una storia, quando Faraone somerge nel Mar Rosso. Il Pastorino ha poi atteso a molte altre cose pur dell'arte et alle finestre di vetro, ancora che abbia fatto poi poche cose di quella professione. Lo seguitò anco molto un Maso Porro cortonese che valse più nel commetterle e nel cuocere i vetri che nel dipignerle. Furono suoi creati Battista Borro aretino, il quale delle fenestre molto lo va imitando et insegnò i primi principii a Benedetto Spadari et a Giorgio Vasari aretino.
Visse il priore anni LXII e morì l'anno MDXXXVII. Merita infinite lodi il priore, da che per lui in Toscana è condotta l'arte del lavorare i vetri con quella maestria e sottigliezza che desiderare si puote. E perciò, sendoci stato di tanto beneficio, ancora saremo a lui d'onore e d'eterne lode amorevoli esaltandolo nella vita e nell'opere del continovo.
VITA
DEL CRONACA
ARCHITETTO FIORENTINO

Molti ingegni si perdono, i quali farebbono opere rare e degne, se nel venire al mondo percotessero in persone che sapessino e volessino mettergli in opera a quelle cose dove e' son buoni. Dove egli avviene bene spesso che, chi può, non fa e non vuole; e se pure chi che sia vuole fare una qualche eccellente fabbrica, non si cura altrimenti cercare d'uno architetto rarissimo e d'uno spirito molto elevato; anzi mette lo onore e la gloria sua in mano a certi ingegni ladri che vituperano spesso il nome e la fama delle memorie. E per tirare in grandezza chi dependa tutto da lui (tanto puote la ambizione) dà spesso bando a' disegni buoni che si gli dànno e mette in opera il più cattivo, onde rimane alla fama sua la goffezza dell'opera, stimandosi, per quegli che sono giudiciosi, l'artefice e chi lo fa operare essere d'uno animo istesso, da che ne l'opere si coniungono. E per lo contrario, quanti sono stati i principi poco intendenti, i quali per essersi incontrati in persone eccellenti e di giudizio, hanno doppo la morte loro non minor fama avuto per le memorie delle fabriche che in vita si avessero per il dominio ne' popoli. Ma veramente il Cronaca fu nel suo tempo avventurato; perciò che egli seppe fare, trovò chi di continuo lo mise in opera, et in cose tutte grandi e magnifiche. Di costui si racconta che mentre Antonio Pollaiuolo era in Roma a lavorare le sepolture di bronzo che sono in San Pietro, gli capitò a casa un giovanetto suo parente, chiamato per proprio nome Simone, fuggitosi da Fiorenza per alcune quistioni, il quale, avendo molta inclinazione all'arte dell'architettura per essere stato con un maestro di legname, cominciò a considerare le bellissime anticaglie di quella città e dilettandosene le andava misurando con grandissima diligenzia. Laonde seguitando, non molto poi che fu stato a Roma, dimostrò avere fatto molto profitto, sì nelle misure e sì nel metterete in opera alcuna cosa; per il che, fatto pensiero di tornarsene a Firenze, si partì di Roma et arrivato alla patria, per essere divenuto assai buon ragionatore, contava le maraviglie di Roma e d'altri luoghi, con tanta accuratezza che fu nominato da indi in poi il Cronaca: parendo veramente a ciascuno che egli fusse una cronaca di cose nel suo ragionamento. Era dunque costui fattosi tale ch'e' fu ne' moderni tenuto il più eccellente architettore che fusse nella città di Fiorenza; per avere nel discernere i luoghi giudizio e per mostrare che era con lo ingegno più elevato che molti altri che attendevano a quel mestiero. Conoscendosi per le opere sue quanto egli fussi buono imitatore delle cose antiche e quanto egli osservasse le regole di Vetruvio e le opere di Filippo di Ser Brunellesco.
Era allora in Fiorenza quel Filippo Strozzi, che oggi a differenza del figliuolo si chiama il Vecchio, il quale per le sue ricchezze desiderava lassare di sé alla patria et a' figliuoli, tra le altre, memoria di un bel palazzo. Per la qual cosa Benedetto da Maiano, chiamato a questo effetto da lui, gli fece un modello isolato intorno intorno, che poi si mise in opera, ma non interamente, come si dirà di sotto, non volendo alcuni vicini fargli commodità de le case loro. Onde cominciò il palazzo in quel modo che poté e condusse il guscio di fuori, avanti la morte di esso Filippo, presso che alla fine; il quale guscio è d'ordine rustico e graduato, come si vede, perciò che la parte de' bozzi dal primo finestrato in giù, insieme con le porte, è rustica grandemente e la parte che è dal primo finestrato al secondo è meno rustica assai. Ora accadde che, partendosi Benedetto di Fiorenza, tornò a punto il Cronaca da Roma; onde essendo messo per le mani a Filippo, gli piacque tanto per il modello che gli fece del cortile e del cornicione che va di fuori intorno al palazzo, che, conosciuta l'eccellenza di quell'ingegno, volle che poi il tutto passasse per le sue mani, servendosi sempre poi di lui. Fecevi dunque il Cronaca, oltra la bellezza di fuori con ordine toscano, in cima una cornice corinzia molto magnifica, che è per fine del tetto; della quale la metà al presente si vede finita con tanta singolar grazia che non vi si può apporre, né si può più bella disiderare. Questa cornice fu ritratta dal Cronaca e tolta e misurata a punto in Roma da una antica che si truova a Spoglia Cristo, la quale, fra molte che ne sono in quella città, è tenuta bellissima; bene è vero ch'ella fu dal Cronaca ringrandita a proporzione del palazzo, acciò facesse proporzionato fine et anche col suo agetto tetto a quel palazzo, e così l'ingegno del Cronaca seppe servirsi delle cose d'altri e farle quasi diventar sue. Il che non riesce a molti, perché il fatto sta non in aver solamente ritratti e' disegni di cose belle, ma in saperle accommodare secondo che è quello a che hanno a servire, con grazia, misura, proporzione e convenienza. Ma quanto fu e sarà sempre lodata questa cornice del Cronaca, tanto fu biasimata quella che fece nella medesima città al palazzo de' Bartolini Baccio d'Agnolo, il quale pose sopra una facciata piccola e gentile di membra, per imitare il Cronaca, una gran cornice antica misurata a punto dal frontespizio di Monte Cavallo, ma tornò tanto male, per non avere saputo con giudizio accommodarla, che non potrebbe star peggio e pare sopra un capo piccino una gran berretta. Non basta agl'artefici, come molti dicono, fatto ch'egli hanno l'opere, scusarsi con dire: elle sono misurate a punto dall'antico e sono cavate da' buoni maestri, atteso che il buon giudizio e l'occhio più giuoca in tutte le cose, che non fa la misura de le seste.
Il Cronaca dunque condusse la detta cornice con grande arte, insino al mezzo intorno intorno a quel palazzo, col dentello et uovolo, e da due bande la finì tutta, contrapesando le pietre in modo perché venissino bilicate e legate, che non si può veder cosa murata meglio, né condotta con più diligenza a perfezzione. Così anche tutte l'altre pietre di que-sto palazzo sono tanto finite e ben commesse ch'elle paiono non murate, ma tutte d'un pezzo. E perché ogni cosa corrispondesse fece fare per ornamento del detto palazzo ferri bellissimi per tutto e le lumiere che sono in su' canti, e tutti furono da Niccolò Grosso Caparra, fabro fiorentino, con grandissima diligenza lavorate. Vedesi in quelle lumiere maravigliose le cornici, le colonne, i capitegli e le mensole saldate di ferro con maraviglioso magistero. Né mai ha lavorato moderno alcuno di ferro machine sì grandi e sì difficili con tanta scienza e pratica. Fu Niccolò Grosso persona fantastica e di suo capo, ragionevole nelle sue cose e d'altri, né mai voleva di quel d'altrui. Non volse mai far credenza a nessuno de' suoi lavori, ma sempre voleva l'arra. E per questo Lorenzo de' Medici lo chiamava il Caparra e da molti altri ancora per tal nome era conosciuto. Egli aveva appiccato alla sua bottega una insegna, ne la quale erano libri ch'arde-vano; per il che, quando uno gli chiedeva tempo a pagare, gli diceva: “Io non posso, perché i miei libri abbrucciano e non vi si può più scrivere debitori”. Gli fu dato a fare, per i signori Capitani di parte Guelfa, un paio d'alari, i quali a-vendo egli finiti, più volte gli furono mandati a chiedere. Et egli di continuo usava dire: “Io sudo e duro fatica su questa encudine e voglio che qui su mi siano pagati i miei danari”. Per che essi di nuovo rimandorno per il lor lavoro et a dirgli che per i danari andasse che subito sarebbe pagato, et egli ostinato rispondeva che prima gli portassero i danari. Laonde il proveditore venuto in collera, perché i capitani gli volevano vedere, gli mandò dicendo ch'esso aveva avuto la metà dei danari e che mandasse gli alari che del rimanente lo sodisfarebbe. Per la qual cosa il Caparra, avvedutosi del vero, diede al donzello uno alar solo, dicendo: “Te' porta questo ch'è il loro e, se piace a essi, porta l'intero pagamento che te gli darò, perciò che questo è mio”. Gli ufficiali, veduto l'opera mirabile che in quello aveva fatto, gli mandarono i danari a bottega et esso mandò loro l'altro alare. Dicono ancora che Lorenzo de' Medici volse far fare ferramenti per mandare a donar fuora, acciò che l'eccellenza del Caparra si vedesse; per che andò egli stesso in persona a bottega sua e per avventura trovò che lavorava alcune cose che erano di povere persone da le quali aveva avuto parte del pagamento per arra; richiedendolo dunque Lorenzo, egli mai non gli volse promettere di servirlo se prima non serviva coloro, dicendogli che erano venuti a bottega inanzi a lui e che tanto stimava i danari loro quanto quei di Lorenzo.
Al medesimo portarono alcuni cittadini giovani un disegno perché facesse loro un ferro da sbarrare e rompere altri ferri con una vite, ma egli non gli volle altrimenti servire, anzi sgridandogli disse loro: “Io non voglio per niun modo in così fatta cosa servirvi, perciò che non sono se non instrumenti da ladri e da rubare o svergognare fanciulle. Non sono vi dico cosa per me, né per voi, i quali mi parete uomini da bene”. Costoro, veggendo che il Caparra non voleva servirgli, dimandarono chi fusse in Fiorenza che potesse servirgli; per che venuto egli in collera con dir loro una gran villania se gli levò d'intorno. Non volle mai costui lavorare a Giudei, anzi usava dire che i loro danari erano fraccidi e putivano. Fu persona buona e religiosa, ma di cervello fantastico et ostinato: né volendo mai partirsi di Firenze, per offerte che gli fussero fatte, in quella visse e morì. Ho di costui voluto fare questa memoria, perché invero nell'esercizio suo fu singolare e non ha mai avuto, né averà pari, come si può particolarmente vedere ne' ferri e nelle bellissime lumiere di questo palazzo degli Strozzi, il quale fu condotto a fine dal Cronaca et adornato d'un ricchissimo cortile d'ordine corinzio e do-rico con ornamenti di colonne, capitelli, cornici, fenestre e porte bellissime. E se a qualcuno paresse che il didentro di questo palazzo non corrispondesse al difuori, sappia che la colpa non è del Cronaca, perciò che fu forzato accommodarsi dentro al guscio principiato da altri e seguitare in gran parte quello che da altri era stato messo inanzi, e non fu poco che lo riducesse a tanta bellezza, quanta è quella che vi si vede. Il medesimo si risponde a coloro che dicessino che la salita delle scale non è dolce, né di giusta misura, ma troppo erta e repente; e così anco a chi dicesse che le stanze e gl'altri apartamenti di dentro non corrispondessino, come si è detto, alla grandezza e magnificenza di fuori. Ma non perciò sarà mai tenuto questo palazzo, se non veramente magnifico e pari a qualsivoglia privata fabrica, che sia stata in Italia a' nostri tempi edificata. Onde meritò e merita il Cronaca, per questa opera, infinita comendazione.
Fece il medesimo la sagrestia di Santo Spirito in Fiorenza, che è un tempio a otto facce, con bella proporzione e condotto molto pulitamente. E fra l'altre cose, che in questa opera si veggiono, vi sono alcuni capitelli condotti dalla felice mano d'Andrea dal Monte Sansovino, che sono lavorati con somma perfezzione. E similmente il ricetto della detta sagrestia, che è tenuto di bellissima invenzione, se bene il partimento come si dirà non è su le colonne ben partito. Fece anco il medesimo la chiesa di S. Francesco dell'Osservanza in sul poggio di San Miniato fuor di Firenze e similmente tutto il convento de' frati de' Servi, che è cosa molto lodata. Ne' medesimi tempi, dovendosi fare, per consiglio di fra' Ieronimo Savonarola, allora famosissimo predicatore, la gran sala del Consiglio nel palazzo della Signoria di Firenze, ne fu preso parere con Lionardo da Vinci, Michelagnolo Buonaroti, ancora che giovanetto, Giuliano da San Gallo, Baccio d'Agnolo e Simone del Pollaiuolo detto il Cronaca, il quale era molto amico e divoto del Savonarola. Costoro dunque, dopo molte dispute, dettono ordine d'accordo che la sala si facesse in quel modo ch'ell'è poi stata sempre insino che ella si è ai giorni nostri quasi rinovata, come si è detto e si dirà in altro luogo. E di tutta l'opera fu dato il carico al Cronaca, come ingegnoso et anco come amico di fra' Girolamo detto, et egli la condusse con molta prestezza e diligenza e particolarmente mostrò bellissimo ingegno nel fare il tetto, per essere l'edifizio grandissimo per tutti i versi. Fece dunque l'asticciuola del cavallo, che è lunga braccia trentotto da muro a muro, di più travi commesse insieme, augnate et incatenate benissimo, per non esser possibile trovar legni a proposito di tanta grandezza e dove gl'altri cavalli hanno un monaco solo, tutti quelli di questa sala n'hanno tre per ciascuno, uno grande nel mezzo et uno da ciascun lato, minori. Gl'arcali sono lunghi a proporzione e così i puntoni di ciascun monaco, né tacerò che i puntoni de' monaci minori pontano dal lato verso il muro nell'arcale e verso il mezzo nel puntone del monaco maggiore.
Ho voluto raccontare in che modo stanno questi cavalli, perché furono fatti con bella considerazione et io ho veduto disegnargli da molti, per mandare in diversi luoghi. Tirati su questi così fatti cavalli e posti l'uno lontano dall'altro sei braccia e posto similmente in brevissimo tempo il tetto, fu fatto dal Cronaca conficcare il palco, il quale allora fu fatto di legname semplice e compartito a quadri, de' quali ciascuno per ogni verso era braccia quattro, con ricignimento a torno di cornice e pochi membri; e, tanto quanto erano grosse le travi, fu fatto un piano che rigirava intorno ai quadri et a tutta l'opera, con borchioni in su le crociere e cantonate di tutto il palco. E perché le due testate di questa sala, una per ciascun lato, erano fuor di squadra otto braccia, non presono, come arebbono potuto fare, risoluzione d'ingrossare le mura per ridurla in isquadra, ma seguitarono le mura eguali insino al tetto, con fare tre finestre grandi per ciascuna delle facciate delle teste. Ma, finito il tutto, riuscendo loro questa sala per la sua straordinaria grandezza cieca di lumi e, rispetto al corpo così lungo e largo, nana e con poco sfogo d'altezza et insomma quasi tutta sproporzionata, cercarono, ma non giovò molto, l'aiutarla col fare dalla parte di levante due finestre nel mezzo della sala e quattro dalla banda di ponente. Appresso, per darle ultimo fine, feciono in sul piano del mattonato, con molta prestezza, essendo a ciò sollecitati dai cittadini, una ringhiera di legname intorno intorno alle mura di quella, larga et alta tre braccia, con i suoi sederi a uso di teatro e con balaustri dinanzi, sopra la quale ringhiera avevano a stare tutti i magistrati della città. E nel mezzo della facciata, che è volta a levante, era una residenza più eminente, dove col Confaloniere di iustizia stavano i Signori; e da ciascun lato di questo più eminente luogo erano due porte, una delle quali entrava nel segreto e l'altra nello specchio, e nella facciata che è dirimpetto a questa, dal lato di ponente, era un altare dove si diceva messa con una tavola di mano di fra' Bartolomeo, come si è detto, et a canto all'altare la bigoncia da orare. Nel mezzo poi della sala erano panche in fila et a traverso, per i cittadini; e nel mezzo della ringhiera et in su le cantonate erano alcuni passi con sei gradi che facevano salita e commodo ai tavolacini, per raccorre i partiti. In questa sala, che fu allora molto lodata, come fatta con prestezza e con molte belle considerazioni, ha poi meglio scoperto il tempo gli errori dell'esser bassa, scura, malinconica e fuor di squadra. Ma nondimeno meritano il Cronaca e gl'altri di esser scusati, sì per la prestezza con che fu fatta, come volleno i cittadini, con animo d'ornarla col tempo di pitture e metter il palco d'oro, e sì perché infino allora non era stato fatto in Italia la maggior sala, ancor che grandissime siano quella del palazzo di S. Marco in Roma, quella del Vaticano fatta da Pio II et Innocenzio Ottavo, quella del castello di Napoli, del palazzo di Milano, d'Urbino, di Vinezia e di Padoa.
Dopo questo fece il Cronaca, col consiglio dei medesimi, per salire a questa sala, una scala grande, larga sei braccia, ripiegata in due salite e ricca d'ornamenti di macigno, con pilastri e capitelli corinzi e cornici doppie, e con archi della medesima pietra, le volte a mezza botte e le finestre con colonne di mischio et i capitelli di marmo intagliato. Et ancora che questa opera fusse molto lodata, più sarebbe stata se questa scala non fusse riuscita malagevole e troppo ritta, essendo che si poteva far più dolce, come si sono fatte al tempo del Duca Cosimo, nel medesimo spazio di larghezza e non più, le scale nuove fatte da Giorgio Vasari, dirimpetto a questa del Cronaca, le quali sono tanto dolci et agevoli che è quasi il salirle come andare per piano. E ciò è stato opera del detto signor Duca Cosimo, il quale, come è in tutte le cose e nel governo de' suoi popoli di felicissimo ingegno e di grandissimo giudizio, non perdona né a spesa, né a cosa veruna, perché tutte le fortificazioni et edificii publici e privati corrispondino alla grandezza del suo animo e siano non meno belli che utili, né meno utili che belli. Considerando dunque Sua Eccellenza che il corpo di questa sala è il maggiore e più magnifico e più bello di tutta Europa, si è risoluta, in quelle parti che sono difettose, d'acconciarla et in tutte l'altre col disegno et opera di Giorgio Vasari aretino farla ornatissima sopra tutti gl'edifizii d'Italia; e così, alzata la grandezza delle mura sopra il vecchio dodici braccia, di maniera che è alta, dal pavimento al palco, braccia trentadua, si sono ristaurati i cavalli fatti dal Cronaca, che reggono il tetto, e rimessi in alto con nuovo ordine e rifatto il palco vecchio che era ordinario e semplice e non ben degno di quella sala, con vario spartimento, ricco di cornici, pieno d'intagli e tutto messo d'oro, con trentanove tavole di pitture in quadri, tondi et ottangoli, la maggior parte de' quali sono di nove braccia l'uno et alcuni maggiori, con istorie di pitture a olio, di figure, di sette o otto braccia le maggiori. Nelle quali storie, cominciandosi dal primo principio, sono gl'accrescimenti e gl'onori, le vittorie e tutti i fatti egregii della città di Fiorenza e del dominio; e particolarmente la guerra di Pisa e di Siena con una infinità d'altre cose, che troppo sarei lungo a raccontarle. E si è lasciato conveniente spazio di sessanta braccia per ciascuna delle facciate dalle bande, per fare in ciascuna tre storie che corrispondino al palco quanto tiene lo spazio di sette quadri da ciascun lato che trattano delle guerre di Pisa e di Siena. I quali spartimenti delle facciate sono tanto grandi che non si sono anco veduti maggiori spazii per fare istorie di pitture, né dagl'antichi, né dai moderni. E sono i detti spartimenti ornati di pietre grandissime, le quali si congiungono alle teste della sala, dove da una parte, cioè verso tramontana, ha fatto finire il signor Duca, secondo che era stata cominciata e condotta a buon termine da Baccio Bandinelli, una facciata piena di colonne e pilastri e di nicchie piene di statue di marmo, il quale appartamento ha da servire per udienza publica, come a suo luogo si dirà. Dall'altra banda dirimpetto a questa, ha da esser in un'altra simile facciata, che si fa dall'Amannato, scultore et architetto, una fonte che getti acqua nella sala, con ricco e bellissimo ornamento di colonne e di statue di marmo e di bronzo. Non tacerò che per essersi alzato il tetto di questa sala dodici braccia, ella n'ha acquistato non solamente sfogo, ma lumi assaissimi, perciò che oltre gl'altri, che sono più in alto, in ciascuna di queste testate vanno tre grandissime finestre, che verranno col piano sopra un corridore, che fa loggia dentro la sala e da un lato, sopra l'opera del Bandinello, donde si scoprirà tutta la piazza con bellissima veduta. Ma di questa sala e degli altri acconcimi che in questo palazzo si sono fatti e fanno si ragionerà in altro luogo più lungamente. Questo per ora dirò io, che, se il Cronaca e quegli altri ingegnosi artefici che dettono il disegno di questa sala potessino ritornar vivi, per mio credere non riconoscerebbero né il palazzo, né la sala, né cosa che vi sia; la qual sala, cioè quella parte che è in isquadra, è lunga braccia novanta e larga braccia trentotto, senza l'opere del Bandinello e dell'Amannato.
Ma tornando al Cronaca, ne gl'ultimi anni della sua vita, eragli entrato nel capo tanta frenesia delle cose di fra' Girolamo Savonarola che altro che di quelle sue cose non voleva ragionare. E così vivendo, finalmente d'anni LV d'una infirmità assai lunga si morì. E fu onoratamente sepolto nella chiesa di Santo Ambruogio di Fiorenza nel MDIX, e non dopo lungo spazio di tempo gli fu fatto questo epitaffio da Messer Giovanbattista Strozzi:
CRONACA
Vivo, e mille, e mille anni, e mille ancora mercé de' vivi miei palazzi e tempi bella Roma vivrà l'alma mia Flora.
Ebbe il Cronaca un fratello chiamato Matteo, che attese alla scultura e stette con Antonio Rossellino scultore, et ancor che fusse di bello e buono ingegno, disegnasse bene et avesse buona pratica ne lavorare di marmo, non lasciò alcuna opera finita perché, togliendolo al mondo la morte d'anni XIX, non poté adempiere quello che di lui, chiunque lo conobbe, si prometteva.
VITA DI DOMENICO PULIGO
PITTORE FIORENTINO

È cosa maravigliosa, anzi stupenda, che molti nell'arte della pittura, nel continuo esercitare e maneggiare i colori, per instinto di natura, o per un uso di buona maniera presa senza disegno alcuno o fondamento, conducono le cose loro a sì fatto termine che elle si abbattono molte volte a essere così buone che, ancor che gl'artefici loro non siano de' rari, elle sforzano gl'uomini ad averle in somma venerazione e lodarle. E si è veduto già molte volte et in molti nostri pittori che coloro che fanno l'opere loro più vivaci e più perfette, i quali hanno naturalmente bella maniera e si esercitano con fatica e studio continuamente, perché ha tanta forza questo dono della natura che, benché costoro stracurino e lascino gli studi dell'arte et altro non seguino che l'uso solo del dipignere e del maneggiare i colori con grazia infuso dalla natura, apparisce nel primo aspetto dell'opere loro ch'ella mostrano tutte le parti eccellenti e maravigliose che sogliono minutamente apparire ne' lavori di que' maestri che noi tenghiamo migliori. E che ciò sia vero l'esperienza ce lo dimostra a' tempi nostri nell'opere di Domenico Puligo, pittore fiorentino, nelle quali da chi ha notizia delle cose dell'arte si conosce quello che si è detto di sopra chiaramente.
Mentre che Ridolfo di Domenico Grillandaio lavorava in Firenze assai cose di pittura, come si dirà, seguitando l'u-more del padre, tenne sempre in bottega molti giovani a dipignere, il che fu cagione, per concorrenza l'uno dell'altro, che assai ne riuscirono bonissimi maestri, alcuni in fare ritratti di naturale, altri in lavorare a fresco et altri a tempera et in dipignere speditamente drappi. A costoro facendo Ridolfo lavorare quadri, tavole e tele, in pochi anni ne mandò con suo molto utile una infinità in Inghilterra, nell'Alemagna et in Ispagna. E Baccio Gotti e Toto del Nunziata, suoi discepoli, furono condotti, uno in Francia al re Francesco e l'altro in Inghilterra al re, che gli chiesono per aver prima veduto dell'opere loro. Due altri discepoli del medesimo restarono e si stettono molti anni con Ridolfo, perché, ancora che avessero molte richieste da mercanti e da altri in Ispagna et in Ungheria, non vollono mai, né per promesse, né per danari privarsi delle dolcezze della patria, nella quale avevano da lavorare più che non potevano. Uno di questi fu Antonio del Ceraiuolo fiorentino, il quale essendo molti anni stato con Lorenzo di Credi aveva da lui particolarmente imparato a ritrarre tanto bene di naturale, che con facilità grandissima faceva i suoi ritratti similissimi al naturale, ancor che in altro non avesse molto disegno. Et io ho veduto alcune teste di sua mano ritratte dal vivo che, ancor che abbiano, verbi grazia, il naso torto, un labro piccolo et un grande et altre sì fatte disformità, somigliano nondimeno il naturale, per aver egli ben preso l'aria di colui. Là dove per contrario molti eccellenti maestri hanno fatto pitture e ritratti di tutta perfezzione in quanto all'arte, ma non somigliano, né poco, né assai colui per cui sono stati fatti. E per dire il vero chi fa ritratti, dee ingegnarsi, senza guardare a quello che si richiede in una perfetta figura, fare che somiglino colui per cui si fanno. Ma quando somigliano e sono anco belli allora si possono dir opere singolari e gl'artefici loro eccellentissimi. Que-sto Antonio dunque, oltre a molti ritratti fece molte tavole per Firenze, ma farò solamente, per brevità, menzione di due che sono una in San Jacopo tra' Fossi al canto agl'Alberti, nella quale fece un Crocifisso con Santa Maria Madalena e San Francesco; nell'altra, che è nella Nunziata, è un San Michele che pesa l'anime.
L'altro dei due sopra detti fu Domenico Puligo, il quale fu di tutti gl'altri sopra nominati più eccellente nel disegno e più vago e grazioso nel colorito. Costui dunque, considerando che il suo dipignere con dolcezza senza tignere l'opere o dar loro crudezza, ma che il fare a poco a poco sfuggire i lontani, come velati da una certa nebbia, dava rilievo e grazia alle sue pitture, e che se bene i contorni delle figure che faceva si andavano perdendo, in modo che occultando gl'errori non si potevano vedere ne' fondi dove erano terminate le figure; che nondimeno il suo colorire e la bell'aria delle teste facevano piacere l'opere sue; tenne sempre il medesimo modo di fare e la medesima maniera che lo fece essere in pregio mentre che visse. Ma lasciando da canto il far memoria de' quadri e de' ritratti che fece stando in bottega di Ridolfo, che parte furono mandati di fuori e parte servirono la città, dirò solamente di quelle che fece quando fu più tosto amico e concorrente di esso Ridolfo che discepolo; e di quelle che fece essendo tanto amico d'Andrea del Sarto, che niuna cosa aveva più cara che vedere quell'uomo in bottega sua, per imparare da lui, mostrargli le sue cose e pigliarne parere, per fuggire i diffetti e gl'errori in che incorrono molte volte coloro che non mostrano a nessuno dell'arte quello che fanno; i quali, troppo fidandosi del proprio giudizio, vogliono anzi essere biasimati dall'universale, fatte che sono l'opere, che corregerle mediante gl'avvertimenti degl'amorevoli amici. Fece fra le prime cose Domenico un bellissimo quadro di Nostra Donna a Messer Agnolo della Stufa, che l'ha alla sua badia di Capalona nel contado d'Arezzo e lo tiene carissimo, per essere stato condotto con molta diligenza e bellissimo colorito. Dipinse un altro quadro di Nostra Donna, non meno bello che questo, a Messer Agnolo Niccolini, oggi arcivescovo di Pisa e cardinale, il quale l'ha nelle sue case a Fiorenza al Canto de' Pazzi. E parimente un altro di simile grandezza e bontà, che è oggi appresso Filippo dell'Antella in Fiorenza. In un altro, che è grande circa tre braccia, fece Domenico una Nostra Donna intera col Putto fra le ginocchia, un San Giovannino et un'altra testa; il qual quadro, che è tenuto delle migliori opere che facesse, non si potendo vedere il più dolce colorito, è oggi appresso Messer Filippo Spini, tesauriere dell'illustrissimo Prencipe di Fiorenza magnifico gentiluomo e che molto si diletta delle cose di pittura.
Fra' molti ritratti che Domenico fece di naturale, che tutti sono belli e molto somigliano, quello è bellissimo che fece di monsignore Messer Piero Carnesecchi allora bellissimo giovinetto, al quale fece anco alcuni altri quadri tutti belli e condotti con molta diligenza. Ritrasse anco in un quadro la Barbara Fiorentina in quel tempo famosa, bellissima cortigiana e molto amata da molti non meno che per la bellezza, per le sue buone creanze e particolarmente per essere bonissima musica e cantare divinamente. Ma la migliore opera che mai condusse Domenico fu un quadro grande, dove fece quanto il vivo una Nostra Donna con alcuni Angeli e putti et un San Bernardo che scrive; il qual quadro è oggi appresso Giovangualberto del Giocondo e Messer Niccolò suo fratello, canonico di San Lorenzo di Firenze. Fece il medesimo molti altri quadri che sono per le case de' cittadini e particolarmente alcuni dove si vede la testa di Cleopatra, che si fa mordere da un aspide la poppa; et altri dove è Lucrezia romana, che si uccide con un pugnale. Sono anco di mano del medesimo alcuni ritratti di naturale e quadri molto belli alla porta a Pinti in casa di Giulio Scali, uomo non meno di bellissimo giudizio nelle cose delle nostre arti che in tutte l'altre migliori e più lodate professioni. Lavorò Domenico a Francesco del Giocondo, in una tavola per la sua capella nella tribuna maggiore della chiesa de' Servi in Fiorenza, un San Francesco che riceve le stimmate; la quale opera è molto dolce di colorito e morbidezza e lavorata con molta diligenza. E nella chiesa di Cestello intorno al tabernacolo del Sagramento lavorò a fresco due Angeli; e nella tavola d'una cappella della medesima chiesa fece la Madonna co'l Figliuolo in braccio, San Giovanni Battista e San Bernardo et altri Santi. E perché parve ai monaci di quel luogo che si portasse in queste opere molto bene, gli feciono fare alla loro Badia di Settimo fuor di Fiorenza in un chiostro le visioni del conte Ugo, che fece sette badie. E non molto dopo dipinse il Puligo in sul canto di via Mozza da Santa Caterina in un tabernacolo una Nostra Donna ritta col Figliuolo in collo, che sposa Santa Caterina; et un San Piero martire. Nel castello d'Anghiari fece in una Compagnia un Deposto di Croce, che si può fra le sue migliori opere annoverare. Ma perché fu più sua professione attendere a quadri di Nostre Donne, ritratti et altre teste che a cose grandi, consumò quasi tutto il tempo in quelle. E se egli avesse seguitato le fatiche dell'arte e non più tosto i piaceri del mondo come fece, arebbe fatto senza alcun dubbio molto profitto nella pittura, e massimamente avendolo Andrea del Sarto suo amicissimo aiutato in molte cose di disegni e di consiglio. Onde molte opere di costui si veggiono non meno ben disegnate che colorite, con bella e buona maniera. Ma l'avere per suo uso Domenico non volere durare molta fatica e lavorare più per fare opere e guadagnare che per fama, fu cagione che non passò più oltre: perché praticando con persone allegre e di buon tempo e con musici e con femmine, seguitando certi suoi amori, si morì d'anni cintuantadua l'anno MDXXVII per avere presa la peste in casa d'una sua innamorata.
Furono da costui i colori con sì buona et unita maniera adoperati, che più per questo merita lode che per altro. Fu suo discepolo fra gl'altri Domenico Beceri fiorentino, il quale, adoperando i colori pulitamente, con buonissima maniera conduce l'opere sue.
VITA DI ANDREA DA FIESOLE SCULTORE E D'ALTRI FIESOLANI

Perché non meno si richiede agli scultori avere pratica de' ferri che a chi esercita la pittura quella de' colori, di qui avviene che molti fanno di terra benissimo, che poi di marmo non conducono l'opere a veruna perfezzione; et alcuni per lo contrario lavorano bene il marmo, senza avere altro disegno che un non so che che hanno nell'idea di buona maniera, la imitazione della quale si trae da certe cose che al giudizio piacciano, e che poi, tolte all'imaginazione, si mettono in opera. Onde è quasi una maraviglia vedere alcuni scultori, che senza saper punto disegnare in carta, conducono nondimeno coi ferri l'opere loro a buono e lodato fine; come si vide in Andrea di Piero di Marco Ferrucci, scultore da Fiesole, il quale nella sua prima fanciullezza imparò i principii della scultura da Francesco di Simone Ferucci, scultore da Fiesole. E, se bene da principio imparò solamente a intagliare fogliami, acquistò nondimeno a poco a poco tanta pratica nel fare che non passò molto che si diede a far figure; di maniera che, avendo la mano resoluta e veloce, condusse le sue cose di marmo più con un certo giudizio e pratica naturale, che per disegno che egli avesse. Ma nondimeno attese un poco più all'arte, quando poi seguitò nel colmo della sua gioventù Michele Maini scultore, similmente da Fiesole. Il quale Michele fece nella Minerva di Roma il San Sebastiano di marmo, che fu tanto lodato in que' tempi. Andrea dunque, essendo condotto a lavorare a Imola, fece negl'Innocenti di quella città una cappella di macigno che fu molto lodata. Dopo la quale opera se n'andò a Napoli, essendo là chiamato da Antonio di Giorgio da Settignano, grandissimo ingegneri et architetto del re Ferrante, appresso al quale era in tanto credito Antonio, che non solo maneggiava tutte le fabriche del regno, ma ancora tutti i più importanti negozii dello stato. Giunto Andrea in Napoli, fu messo in opera e lavorò molte cose nel castello di San Martino et in altri luoghi della città per quel re. Ma venendo a morte Antonio, poi che fu fatto sepelire da quel re non con esequie da architettore, ma reali e con venti coppie d'imbastiti che l'accompa-gnarono alla sepoltura, Andrea si partì da Napoli, conoscendo che quel paese non faceva per lui, e se ne tornò a Roma, dove stette per qualche tempo attendendo agli studi dell'arte et a lavorare.
Dopo, tornato in Toscana, lavorò in Pistoia, nella chiesa di San Iacopo, la cappella di marmo dove è il battesimo, e con molta diligenza condusse il vaso di detto battesimo con tutto il suo ornamento. E nella faccia della cappella fece due figure grandi quanto il vivo di mezzo rilievo, cioè San Giovanni che battezza Cristo, molto ben condotta e con bella maniera. Fece nel medesimo tempo alcune altre opere piccole, delle quali non accade far menzione. Dirò bene che, ancora che queste cose fussero fatte da Andrea più con pratica che con arte, si conosce nondimeno in loro una resoluzione et un gusto di bontà molto lodevole. E nel vero se così fatti artefici avessero congiunto alla buona pratica et al giudizio il fondamento del disegno, vincerebbono d'eccellenza coloro che, disegnando perfettamente, quando si mettono a lavorare il marmo lo graffiano e con istento in mala maniera lo conducono, per non avere pratica e non sapere maneggiare i ferri con quella pratica che si richiede. Dopo queste cose, lavorò Andrea nella chiesa del Vescovado di Fiesole una tavola di marmo, posta nel mezzo fra le due scale che sagliono al coro di sopra, dove fece tre figure tonde et alcune storie di basso rilievo. Et in San Girolamo di Fiesole fece la tavolina di marmo che è murata nel mezzo della chiesa. Per la fama di queste opere venuto Andrea in cognizione, gli fu da gl'Operai di Santa Maria del Fiore, allora che Giulio cardinale de' Medici governava Fiorenza, dato a fare la statua d'uno Apostolo di quattro braccia, in quel tempo dico che altre quattro simili ne furono allogate in un medesimo tempo: una a Benedetto da Maiano, una a Iacopo Sansovino, una a Baccio Bandinelli e l'altra a Michelagnolo Buonarroti; le quali statue avevano a essere insino al numero di dodici e doveano porsi dove i detti Apostoli sono in quel magnifico tempio dipinti di mano di Lorenzo di Bicci.
Andrea, dunque, condusse la sua con più bella pratica e giudizio che con disegno e n'acquistò, se non lode quanto gl'altri, nome di assai buono e pratico maestro. Onde lavorò poi quasi di continuo per l'opera di detta chiesa e fece la testa di Marsilio Ficino, che in quella si vede dentro alla porta che va alla canonica. Fece anco una fonte di marmo che fu mandata al re d'Ungheria, la quale gli acquistò grande onore; fu di sua mano ancora una sepoltura di marmo che fu mandata similmente in Strigonia città d'Ungheria, nella quale era una Nostra Donna molto ben condotta con altre figure, nella quale sepoltura fu poi riposto il corpo del cardinale di Strigonia. A Volterra mandò Andrea due Angeli tondi di marmo, et a Marco del Nero, fiorentino, fece un Crocifisso di legno grande quanto il vivo, che è oggi in Fiorenza nella chiesa di Santa Felicita. Un altro minore ne fece per la Compagnia dell'Assunta di Fiesole. Dilettossi anco Andrea del-l'architettura e fu maestro del Mangone, scarpellino et architetto, che poi in Roma condusse molti palazzi et altre fabriche assai acconciamente. Andrea finalmente, essendo fatto vecchio, attese solamente alle cose di quadro, come quello che, essendo persona modesta e da bene, più amava di vivere quietamente che alcun'altra cosa. Gli fu allogata da Madonna Antonia Vespucci la sepoltura di Messer Antonio Strozzi suo marito, ma non potendo egli molto lavorare da per sé, gli fece i due Angeli Maso Boscoli da Fiesole, suo creato, che ha poi molte opere lavorato in Roma et altrove; e la Madonna fece Silvio Cosini da Fiesole, ma non fu messa su subito che fu fatta, il che fu l'anno MDXXII, perché Andrea si morì e fu sotterrato dalla Compagnia dello Scalzo ne' Servi.
E Silvio poi, posta su la detta Madonna e finita di tutto punto la detta sepoltura dello Strozzi, seguitò l'arte della scultura con fierezza straordinaria, onde ha poi molte cose lavorato leggiadramente e con bella maniera, et ha passato infiniti e massimamente in bizzarria di cose alla grottesca, come si può vedere nella sagrestia di Michelagnolo Buonarroti in alcuni capitelli di marmo intagliati sopra i pilastri delle sepolture con alcune maschere tanto bene straforate che non è possibile veder meglio. Nel medesimo luogo fece alcune fregiature di maschere che gridano, molto belle; per che, veduto il Buonarroto l'ingegno e la pratica di Silvio, gli fece cominciare alcuni trofei per fine di quelle sepolture, ma rimasono imperfetti insieme con altre cose per l'assedio di Firenze. Lavorò Silvio una sepoltura per i Minerbetti nella loro cappella nel tramezzo della chiesa di Santa Maria Novella, tanto bene quanto sia possibile, perché, oltre la cassa, che è di bel garbo, vi sono intagliate alcune targhe, cimieri et altre bizzarrie con tanto disegno quanto si possa in simile cosa desiderare. Essendo Silvio a Pisa, l'anno MDXXVIII, vi fece un Angelo che mancava sopra una colonna all'altare maggiore del Duomo, per riscontro di quello del Tribolo, tanto simile al detto che non potrebbe essere più quando fussero d'una medesima mano. Nella chiesa di Monte Nero vicino a Livorno fece una tavoletta di marmo con due figure ai frati Ingesuati; et in Volterra fece la sepoltura di Messer Raffaello Volaterrano, uomo dottissimo, nella quale lo ritrasse di naturale sopra una cassa di marmo con alcuni ornamenti e figure. Essendo poi mentre era l'assedio intorno a Firenze, Niccolò Caponi onoratissimo cittadino, morto in Castel Nuovo della Garfagnana nel ritornare da Genoa, dove era stato ambasciatore della sua republica all'imperatore, fu mandato con molta fretta Silvio a formarne la testa, perché poi ne facesse una di marmo, sì come n'aveva condotto una di cera bellissima. E perché abitò Silvio qualche tempo con tutta la famiglia in Pisa, essendo della Compagnia della Misericordia, che in quella città accompagna i condannati alla morte insino al luogo della iustizia, gli venne una volta capriccio, essendo sagrestano, della più strana cosa del mondo. Trasse una notte il corpo d'uno, che era stato impiccato il giorno inanzi, della sepoltura, e dopo averne fatto notomia per conto dell'arte, come capriccioso e forse maliastro e persona che prestava fede agl'incanti e simili sciocchezze, lo scorticò tutto, et acconciata la pelle, secondo che gl'era stato insegnato, se ne fece, pensando che avesse qualche gran virtù, un coietto, e quello portò per alcun tempo sopra la camicia, senza che nessuno lo sapesse già mai. Ma essendone una volta sgridato da un buon padre, a cui confessò la cosa, si trasse costui di dosso il coietto e, secondo che dal frate gli fu imposto, lo ripose in una sepoltura. Molte altre simili cose si potrebbono raccontare di costui, ma non facendo al proposito della nostra storia si passono con silenzio.
Essendogli morta la prima moglie in Pisa, se n'andò a Carrara e qui standosi a lavorare alcune cose, prese un'altra donna, colla quale non molto dopo se n'andò a Genoa, dove, stando a' servigii del Principe Doria, fece di marmo sopra la porta del suo palazzo un'arme bellissima e per tutto il palazzo molti ornamenti di stucchi, secondo che da Perino del Vaga pittore gli erano ordinati; fecevi anco un bellissimo ritratto di marmo di Carlo V imperatore. Ma perché Silvio per suo natural costume non dimorava mai lungo tempo in un luogo, né aveva fermezza, increscendogli lo stare troppo be-ne in Genova, si mise in cammino per andare in Francia, ma partitosi prima che fusse al Monsanese tornò indietro e, fermatosi in Milano, lavorò nel Duomo alcune storie e figure e molti ornamenti con sua molta lode. E finalmente vi si morì d'età d'anni quarantacinque.
Fu costui di bello ingegno, capriccioso e molto destro in ogni cosa e persona che seppe condurre con molta diligenza qualunche cosa si metteva fra mano; si dilettò di comporre sonetti e di cantare all'improvviso, e nella sua prima giovanezza attese all'armi. Ma se egli avesse fermo il pensiero alla scultura et al disegno, non arebbe avuto pari; e come passò Andrea Ferruzzi suo maestro, così arebbe ancora, vivendo, passato molti altri ch'hanno avuto nome d'eccellenti maestri.
Fiorì ne' medesimi tempi d'Andrea e di Silvio un altro scultore fiesolano, detto il Cicilia, il quale fu persona molto pratica; vedesi di sua mano nella chiesa di San Iacopo in campo Corbolini di Fiorenza la sepoltura di Messer Luigi Tornabuoni cavaliere, la quale è molto lodata e massimamente per avere egli fatto lo scudo dell'arme di quel cavaliere nella testa d'un cavallo, quasi per mostrare, secondo gl'antichi, che dalla testa del cavallo fu primieramente tolta la forma degli scudi. Ne' medesimi tempi ancora Antonio da Carrara, scultore rarissimo, fece in Palermo al Duca di Monte Lione, di casa Pignatella napoletano e viceré di Cicilia, tre statue, cioè tre Nostre Donne in diversi atti e maniere, le quali furono poste sopra tre altari nel Duomo di Monte Lione in Calabria. Fece al medesimo alcune storie di marmo che sono in Palermo. Di costui rimase un figliuolo, che è oggi scultore, anch'egli, e non meno eccellente che si fusse il padre.
VITA DI VINCENZIO DA SAN GIMIGNANO E TIMOTEO DA URBINO
PITTORI

Dovendo io scrivere, dopo Andrea da Fiesole scultore, la vita di due eccellenti pittori, cioè di Vincenzio da S. Gimignano di Toscana e di Timoteo da Urbino, ragionerò prima di Vincenzo, essendo quello che è di sopra il suo ritratto e poi immediate di Timoteo, essendo stati quasi in un medesimo tempo et ambidue discepoli et amici di Raffaello. Vincenzio dunque, il quale per il grazioso Raffaello da Urbino lavorò in compagnia di molti altri nelle logge papali, si portò di maniera che fu da Raffaello e da tutti gl'altri molto lodato. Onde, essendo perciò messo a lavorare in Borgo dirimpetto al palazzo di Messer Giovanbattista dall'Aquila, fece con molta sua lode in una faccia di terretta un fregio, nel quale figurò le nove Muse con Apollo in mezzo e sopra alcuni leoni, impresa del papa, i quali sono tenuti bellissimi. Aveva Vincenzio la sua maniera diligentissima, morbida nel colorito e le figure sue erano molto grate nell'aspetto, et insomma egli si sforzò sempre d'imitare la maniera di Raffaello da Urbino; il che si vede anco nel medesimo Borgo dirimpetto al palazzo del cardinale d'Ancona in una facciata della casa che fabricò Messer Giovanantonio Battiferro da Urbino, il quale, per la stretta amicizia che ebbe con Raffaello, ebbe da lui il disegno di quella facciata, et in corte per mezzo di lui molti benefici e grosse entrate. Fece dunque Raffaello in questo disegno, che poi fu messo in opera da Vincenzio, alludendo al casato de' Battiferri, i Ciclopi che battono i fulmini a Giove; et in un'altra parte Vulcano che fabrica le saette a Cupido, con alcuni ignudi bellissimi et altre storie e statue bellissime. Fece il medesimo Vincenzo, in su la piazza di San Luigi de' Franzesi in Roma, in una facciata, moltissime storie: la morte di Cesare et un trionfo della Giustizia, et in un fregio una battaglia di cavalli fieramente e con molta diligenza condotti. Et in questa opera, vicino al tetto fra le finestre, fece alcune virtù molto ben lavorate. Similmente nella facciata degl'Epifanii dietro alla curia di Pompeo, e vicino a Campo di Fiore fece i Magi che seguono la stella et infiniti altri lavori per quella città, la cui aria e sito par che sia in gran parte cagione che gl'animi operino cose maravigliose. E l'esperienza fa conoscere che molte vol-te uno stesso uomo non ha la medesima maniera, né fa le cose della medesima bontà in tutti i luoghi, ma migliori e peggiori secondo la qualità del luogo.
Essendo Vincenzio in bonissimo credito in Roma, seguì l'anno MDXXVII la rovina et il sacco di quella misera città, stata signora delle genti. Perché egli oltre modo dolente se ne tornò alla sua patria, San Gimignano. Là dove fra i disagi patiti e l'amore venutogli, meno delle cose dell'arti, essendo fuor dell'aria che i begli ingegni alimentando fa loro operare cose rarissime, fece alcune cose, le quali io mi tacerò per non coprire con queste la lode et il gran nome che s'a-veva in Roma onorevolmente acquistato. Basta, che si vede espressamente che le violenze deviano forte i pellegrini ingegni da quel primo obietto e le fanno torcere la strada in contrario; il che si vede anco in un compagno di costui chiamato Schizzone, il quale fece in Borgo alcune cose molto lodate, e così in Camposanto di Roma et in Santo Stefano de-gl'Indiani. E poi anch'egli dalla poca discrezione de' soldati fu fatto deviare dall'arte et indi a poco perdere la vita.
Morì Vincenzio in San Gimignano sua patria, essendo vissuto sempre poco lieto, dopo la sua partita di Roma.
Timoteo pittore da Urbino nacque di Bartolomeo della Vite, cittadino d'onesta condizione, e di Calliope, figliuola di maestro Antonio Alberto da Ferrara, assai buon pittore del tempo suo, secondo che le sue opere in Urbino et altrove ne dimostrano. Ma essendo ancor fanciullo Timoteo, mortogli il padre, rimase al governo della madre Calliope con buono e felice augurio, per essere Calliope una delle nove Muse e per la conformità che hanno in fra di loro la pittura e la poesia. Poi, dunque, che fu il fanciullo allevato dalla prudente madre costumatamente, e da lei incaminato nei studi delle prime arti e del disegno parimente, venne apunto il giovane in cognizione del mondo quando fioriva il divino Raffaello Sanzio, et attendendo nella sua prima età all'orefice, fu chiamato da Messer Pierantonio suo maggiore fratello, che allora studiava in Bologna, in quella nobilissima patria, acciò sotto la disciplina di qualche buon maestro seguitasse quel-l'arte a che pareva fusse inclinato da natura. Abitando dunque in Bologna, nella quale città dimorò assai tempo e fu molto onorato e trattenuto in casa con ogni sorte di cortesia dal magnifico e nobile Messer Francesco Gombruti, praticava continuamente Timoteo con uomini virtuosi e di bello ingegno; per ché, essendo in pochi mesi per giovane giudizioso conosciuto et inchinato molto più alle cose di pittura che all'orefice, per averne dato saggio in alcuni molto ben condotti ritratti d'amici suoi e d'altri, parve al detto suo fratello, per seguitare il genio del giovane, essendo anco a ciò persuaso dagl'amici, levarlo dalle lime e dagli scarpelli e che si desse tutto allo studio del disegnare. Di che essendo egli contentissimo, si diede subito al disegno et alle fatiche dell'arte, ritraendo e disegnando tutte le migliori opere di quella città, e, tenendo stretta dimestichezza con pittori, si incaminò di maniera nella nuova strada, che era maraviglia il profitto che faceva di giorno in giorno, e tanto più quanto senza alcuna particolare disciplina di appartato maestro apprendeva facilmente ogni difficile cosa. Laonde, innamorato del suo esercizio et apparati molti segreti della pittura, vedendo solamente alcuna fiata a cotali pittori idioti fare le mestiche et adoperare i pennelli, da se stesso guidato e dalla mano della natura, si pose arditamente a colorire, pigliando una assai vaga maniera e molto simile a quella del nuovo Apelle suo compatriota, ancor che di mano di lui non avesse veduto se non alcune poche cose in Bologna. E così avendo assai felicemente, secondo che il suo buono ingegno e giudizio lo guidava, lavorato alcune cose in tavole et in muro, e parendogli che tutto a comparazione degl'altri pittori gli fosse molto bene riuscito, seguitò animosamente gli studi della pittura per sì fatto modo, che in processo di tempo si trovò aver fermato il piede nell'arte e con buona openione dell'u-niversale in grandissima aspettazione. Tornato dunque alla patria, già uomo di ventisei anni, vi si fermò per alquanti mesi dando bonissimo saggio del saper suo; perciò che fece la prima tavola della Madonna nel Duomo, dentrovi, oltre la Vergine, San Crescenzio e San Vitale, all'altare di Santa Croce, dove è un Angeletto sedente in terra, che suona la viola con grazia veramente angelica e con semplicità fanciullesca, condotta con arte e giudizio. Appresso dipinse un'al-tra tavola per l'altare maggiore della chiesa della Trinità, con una Santa Apollonia a man sinistra del detto altare. Per queste opere et alcune altre, delle quali non accade far menzione, spargendosi la fama et il nome di Timoteo, egli fu da Raffaello con molta instanza chiamato a Roma; dove andato di bonissima voglia, fu ricevuto con quella amorevolezza et umanità, che fu non meno propria di Raffaello, che si fusse l'eccellenza dell'arte. Lavorando dunque con Raffaello, in poco più d'un anno fece grande acquisto, non solamente nell'arte, ma ancora nella robba; perciò che in detto tempo rimise a casa buone somme di danari. Lavorò col maestro nella chiesa della Pace le Sibille di sua mano et invenzione, che sono nelle lunette a man destra, tanto stimate da tutti i pittori; il che affermano alcuni che ancora si ricordano averle veduto lavorare, e ne fanno fede i cartoni che ancor si ritruovano appresso i suoi successori. Parimente da sua posta fece poi il cataletto e dentrovi il corpo morto con l'altre cose che gli sono intorno tanto lodate, nella scuola di Santa Caterina da Siena; et ancora che alcuni sanesi, troppo amatori della lor patria, attribuischino queste opere ad altri, facilmente si conosce ch'elleno sono fattura di Timoteo, così per la grazia e dolcezza del colorito, come per altre memorie lasciate da lui in quel nobilissimo studio d'eccellentissimi pittori. Ora, benché Timoteo stesse bene et onoratamente in Roma, non potendo, come molti fanno, sopportare la lontananza della patria, essendovi anco chiamato ogni ora e tiratovi da-gl'avisi degl'amici e dai preghi della madre già vecchia, se ne tornò a Urbino, con dispiacere di Raffaello, che molto per le sue buone qualità l'amava. Né molto dopo, avendo Timoteo a persuasione de' suoi preso moglie in Urbino et innamoratosi della patria, nella quale si vedeva essere molto onorato, e, che è più, avendo cominciato ad avere figliuoli, fermò l'animo et il proposito di non volere più andare attorno nonostante, come si vede ancora per alcune lettere, che egli fusse da Raffaello richiamato a Roma. Ma non perciò restò di lavorare e fare di molte opere in Urbino e nelle città all'in-torno. In Forlì dipinse una cappella insieme con Girolamo Genga suo amico e compatriota. E dopo fece una tavola tutta di sua mano che fu mandata a Città di Castello, et un'altra similmente ai Cagliesi. Lavorò anco in fresco a Castel Durante alcune cose che sono veramente da esser lodate, sì come tutte l'altre opere di costui, le quali fanno fede che fu leggiadro pittore nelle figure, ne' paesi et in tutte l'altre parti della pittura. In Urbino fece in Duomo la cappella di San Martino ad instanza del vescovo Arrivabene mantovano, in compagnia del detto Genga; ma la tavola dell'altare et il mezzo della cappella sono interamente di mano di Timoteo. Dipinse ancora in detta chiesa una Madalena in piedi e vestita con picciol manto e coperta sotto di capelli infino a terra, i quali sono così belli e veri, che pare che il vento gli muova, oltre la divinità del viso, che nell'atto mostra veramente l'amore ch'ella portava al suo Maestro.
In Santa Agata è un'altra tavola di mano del medesimo, con assai buone figure; et in San Bernardino fuor della città fece quella tanto lodata opera, che è a man diritta all'altare de' Bonaventuri, gentiluomini urbinati; nella quale è con bellissima grazia per l'Annunziata, figurata la Vergine in piedi con la faccia e con le mani giunte e gl'occhi levati al cielo; e di sopra in aria in mezzo a un gran cerchio di splendore è un Fanciullo diritto, che tiene il piede sopra lo Spirito Santo in forma di colomba, e nella man sinistra una palla figurata per l'imperio del mondo; e con l'altra elevata, dà la benedizione; e dalla destra del Fanciullo è un Angelo, che mostra alla Madonna co 'l dito il detto Fanciullo. Abbasso, cioè al pari della Madonna, sono dal lato destro il Battista vestito d'una pelle di camelo squarciata a studio, per mostrare il nudo della figura, e dal sinistro un San Sebastiano tutto nudo, legato con bella attitudine a un arbore e fatto con tanta diligenza che non potrebbe aver più rilievo, né essere in tutte le parti più bello. Nella corte degl'illustrissimi d'Urbino sono di sua mano Apollo e due Muse mezze nude, in uno studiolo secreto, belle a maraviglia. Lavorò per i medesimi molti quadri e fece alcuni ornamenti di camere, che sono bellissimi. E dopo in compagnia del Genga dipinse alcune barde da cavalli, che furono mandate al re di Francia, con figure di diversi animali sì belli, che pareva ai riguardanti che avessino movimento e vita. Fece ancora alcuni archi trionfali simili agl'antichi quando andò a marito l'illustrissima Duchessa Leonora, moglie del signor Duca Francesco Maria, al quale piacquero infinitamente, sì come ancora a tutta la corte; onde fu molti anni della famiglia di detto signore con onorevole provisione.
Fu Timoteo gagliardo disegnatore, ma molto più dolce e vago coloritore, in tanto che non potrebbono essere le sue opere più pulitamente, né con più diligenza lavorate. Fu allegro uomo e di natura gioconda e festevole, destro della persona, e nei motti e ragionamenti arguto e facetissimo. Si dilettò sonare d'ogni sorte strumento, ma particolarmente di lira, in su la quale cantava all'improvviso con grazia straordinaria. Morì l'anno di nostra salute MDXXIIII e della sua vita cinquantaquattresimo, lasciando la patria ricca del suo nome e delle sue virtù, quanto dolente della sua perdita. Lasciò in Urbino alcune opere imperfette, le quali essendo poi state finite da altri, mostrano col paragone quanto fusse il valore e la virtù di Timoteo; di mano del quale sono alcuni disegni nel nostro libro, i quali ho avuto dal molto virtuoso e gentile Messer Giovan Maria, suo figliuolo, molto belli e certamente lodevoli, cioè uno schizzo del ritratto del Magnifico Giuliano de' Medici in penna, il quale fece Timoteo mentre che esso Giuliano si riparava nella corte d'Urbino in quella famosissima accademia, et un Noli me tangere et un Giovanni Evangelista che dorme, mentre che Cristo ora nel-l'orto, tutti bellissimi.
VITA DI ANDREA DAL MONTE SANSOVINO
SCULTORE ET ARCHITETTO

Ancor che Andrea di Domenico Contucci dal Monte Sansovino fusse nato di poverissimo padre, lavoratore di terra e levato da guardare gl'armenti, fu nondimeno di concetti tanto alti, d'ingegno sì raro e d'animo sì pronto nell'opere e nei ragionamenti delle difficultà dell'architettura e della prospettiva, che non fu nel suo tempo, né il migliore, né il più sottile e raro intelletto del suo, né chi rendesse i maggiori dubbii più chiari et aperti di quello che fece egli. Onde meritò essere tenuto ne' suoi tempi da tutti gl'intendenti singolarissimo nelle dette professioni. Nacque Andrea, secondo che si dice, l'anno MCCCCLX, e nella fanciullezza guardando gl'armenti, sì come anco si dice di Giotto, disegnava tutto giorno nel sabbione e ritraeva di terra qualcuna delle bestie che guardava. Onde avvenne che, passando un giorno dove costui si stava guardando le sue bestiuole, un cittadino fiorentino, il quale dicono essere stato Simone Vespucci, podestà allora del Monte, che egli vide questo putto starsi tutto intento a disegnare o formare di terra; per che chiamatolo a sé, poi che ebbe veduta l'inclinazione del putto et inteso di cui fusse figliuolo, lo chiese a Domenico Contucci e da lui l'ot-tenne graziosamente, promettendo di volerlo far attendere agli studii del disegno, per vedere quanto potesse quella inclinazione naturale aiutata dal continuo studio. Tornato dunque Simone a Firenze, lo pose all'arte con Antonio del Pollaiuolo, appresso al quale imparò tanto Andrea, che in pochi anni divenne bonissimo maestro. Et in casa del detto Simone al ponte Vecchio si vede ancora un cartone da lui lavorato in quel tempo, dove Cristo è battuto alla colonna, condotto con molta diligenza, et oltre ciò due teste di terra cotta mirabili, ritratte da medaglie antiche: l'una è di Nerone, l'altra di Galba imperatori; le quali teste servivano per ornamento d'un camino; ma il Galba è oggi in Arezzo nelle case di Giorgio Vasari. Fece dopo, standosi pure in Firenze, una tavola di terra cotta, per la chiesa di Santa Agata del Monte Sansovino, con un San Lorenzo et alcuni altri Santi, e picciole storiette benissimo lavorate. Et indi a non molto ne fece un'altra simile, dentrovi l'Assunzione di Nostra Donna, molto bella, Santa Agata, Santa Lucia e San Romualdo, la quale tavola fu poi invetriata da quegli Della Robbia. Seguitando poi l'arte della scultura, fece nella sua giovanezza per Simone Pollaiuolo, altrimenti il Cronaca, due capitelli di pilastri per la sagrestia di Santo Spirito, che gl'acquistarono grandissima fama e furono cagione che gli fu dato a fare il ricetto, che è fra la detta sagrestia e la chiesa; e perché il luogo era stretto, bisognò che Andrea andasse molto ghiribizzando. Vi fece dunque di macigno un componimento d'ordine corinto, con dodici colonne tonde, cioè sei da ogni banda; e sopra le colonne posto l'architrave, fregio e cornice, fece una volta a botte, tutta della medesima pietra, con uno spartimento pieno d'intagli, che fu cosa nuova, varia, ricca e molto lodata. Ben è vero che se il detto spartimento della volta fusse ne' diritti delle colonne venuto a cascare con le cornici, che vanno facendo divisione intorno ai quadri e tondi che ornano quello spartimento con più giusta misura e proporzione, questa opera sarebbe in tutte le parti perfettissima e sarebbe stato cosa agevole il ciò fare. Ma secondo che io già intesi da certi vecchi amici d'Andrea, egli si difendeva con dire l'avere osservato nella volta il modo del partimento della Ritonda di Roma, dove le costole, che si partono dal tondo del mezzo di sopra, cioè dove ha il lume quel tempio, fanno dall'una all'altra i quadri degli sfondati dei rosoni, che a poco a poco diminuiscono, et il medesimo fa la costola, perché non casca in su la dirittura delle colonne. Aggiugneva Andrea, se chi fece quel tempio della Ritonda, che è il meglio inteso e misurato che sia e fatto con più proporzione, non tenne di ciò conto in una volta di maggior grandezza e di tanta importanza, molto meno dovea tenerne egli in uno spartimento di sfondati minori. Nondimeno molti artefici, e particolarmente Michelagnolo Buonarotti, sono stati d'opinione che la ritonda fusse fatta da tre architetti e che il primo la conducesse al fine della cornice, che è sopra le colonne; l'altro dalla cornice in su, dove sono quelle finestre d'opera più gentile; perché invero questa seconda parte è di maniera varia e diversa dalla parte di sotto, essendo state seguitate le volte senza ubidire ai diritti con lo spartimento; il terzo si crede che facesse quel portico, che fu cosa rarissima; per le quali cagioni i maestri, che oggi fanno questa arte, non cascherebbono in così fatto errore per iscusarsi poi come faceva Andrea. Al quale essendo, dopo questa opera, allogata la cappella del Sagramento nella medesima chiesa della famiglia de' Corbinelli, egli la lavorò con molta diligenza, imitando ne' bassi rilievi Donato e gl'altri artefici eccellenti, e non perdonando a niuna fatica per farsi onore, come veramente fece. In due nicchie, che mettono in mezzo un bellissimo tabernacolo, fece due Santi, poco maggiori d'un braccio l'uno, cioè San Iacopo e San Matteo, lavorati con tanta vivacità e bontà, che si conosce in loro tutto il buono e niuno errore. Così fatti anco sono due Angeli tutti tondi, che sono in questa opera per finimento, con i più bei panni, essendo essi in atto di volare, che si possino vedere; et in mezzo è un Cristo piccolino ignudo molto grazioso. Vi sono anco alcune storie di figure piccole nella predella e sopra il tabernacolo, tanto ben fatte, che la punta d'un pennello a pena farebbe quello che fece Andrea con lo scarpello.
Ma chi vuole stupire della diligenza di questo uomo singolare guardi tutta l'opera di quella architettura, tanto bene condotta e commessa per cosa piccola, che pare tutta scarpellata in un sasso solo. È molto lodata ancora una Pietà grande di marmo, che fece di mezzo rilievo nel dossale dell'altare, con la Madonna e San Giovanni che piangono. Né si può immaginare il più bel getto di quello che sono le grate di bronzo col finimento di marmo, che chiuggono quella cappella e con alcuni corvi, impresa, o vero arme de' Corbinelli, che fanno ornamento ai candelieri di bronzo. Insomma questa opera fu fatta senza risparmio di fatica e con tutti quelli avvertimenti, che migliori si possono imaginare. Per queste e per l'altre opere d'Andrea divolgatosi il nome suo, fu chiesto al Magnifico Lorenzo Vecchio de' Medici, nel cui giardino avea, come si è detto, atteso agli studii del disegno, dal re di Portogallo, per che mandatogli da Lorenzo lavorò per quel re molte opere di scultura e d'architettura, e particolarmente un bellissimo palazzo con quattro torri et altri molti edifizii. Et una parte del palazzo fu dipinta secondo il disegno e cartoni di mano d'Andrea, che disegnò benissimo, come si può vedere nel nostro libro in alcune carte di sua propria mano finite con la punta d'un carbone, con alcune altre carte d'architettura benissimo intesa. Fece anco un altare, a quel re, di legno intagliato, dentrovi alcuni profeti; e similmente di terra, per farla poi di marmo, una battaglia bellissima, rappresentando le guerre che ebbe quel re con i Mori, che furono da lui vinti; della quale opera non si vide mai di mano d'Andrea la più fiera, né la più terribile cosa, per le movenze e varie attitudini de' cavalli, per la strage de' morti e per la spedita furia de' soldati in menar le mani. Fecevi ancora una figura d'un San Marco di marmo, che fu cosa rarissima. Attese anco Andrea, mentre stette con quel re, ad alcune cose stravaganti e difficili d'architettura, secondo l'uso di quel paese, per compiacere al re, delle quali cose io vidi già un libro al Monte Sansovino appresso gl'eredi suoi: il quale dicono che è oggi nelle mani di maestro Girolamo Lombardo, che fu suo discepolo et a cui rimase a finire, come si dirà, alcune opere cominciate da Andrea. Il quale, essendo stato nove anni in Portogallo, increscendogli quella servitù e desiderando di rivedere in Toscana i parenti e gl'amici, deliberò, avendo messo insieme buona somma di danari, con buona grazia del re, tornarsene a casa; e così avuta, ma con difficultà, licenza, se ne tornò a Fiorenza, lasciando chi là desse fine all'opere che rimanevano imperfette.
Arrivato in Fiorenza, cominciò nel MD un San Giovanni di marmo che battezza Cristo, il quale aveva a essere mes-so sopra la porta del tempio di San Giovanni, che è verso la Misericordia; ma non lo finì, perché fu quasi forzato andare a Genova, dove fece due figure di marmo, un Cristo et una Nostra Donna, o vero San Giovanni, le quali sono veramente lodatissime. E quelle di Firenze così imperfette si rimasono, et ancor oggi si ritruovano nell'Opera di San Giovanni detto. Fu poi condotto a Roma da papa Giulio Secondo, e fattogli allogazione di due sepolture di marmo, poste in Santa Maria del Popolo, cioè una per il cardinale Ascanio Sforza e l'altra per il cardinale di Ricanati, strettissimo parente del Papa; le quali opere così perfettamente da Andrea furono finite, che più non si potrebbe desiderare; perché così sono elleno di nettezza, di bellezza e di grazia ben finite e ben condotte, che in esse si scorge l'osservanza e le misure dell'ar-te; vi si vede anco una Temperanza, che ha in mano un oriuolo da polvere, che è tenuta cosa divina e nel vero non pare cosa moderna, ma antica e perfettissima. Et ancora che altre ve ne siano simili a questa, ella nondimeno per l'attitudine e grazia è molto migliore, senzaché non può esser più vago e bello un velo, ch'ell'ha intorno, lavorato con tanta leggiadria, che il vederlo è un miracolo. Fece di marmo in Santo Agostino di Roma, cioè in un pilastro a mezzo la chiesa, una Santa Anna, che tiene in collo una Nostra Donna con Cristo, di grandezza poco meno che il vivo; la quale opera si può fra le moderne tenere per ottima; per che, sì come si vede nella vecchia una viva allegrezza e proprio naturale e nella Madonna una bellezza divina, così la figura del fanciullo Cristo è tanto ben fatta, che niun'altra fu mai condotta simile a quella di perfezzione e di leggiadria. Onde meritò che per tanti anni si frequentasse d'appicarvi sonetti et altri varii e dotti componimenti, che i frati di quel luogo ne hanno un libro pieno, il quale ho veduto io con non piccola maraviglia. E di vero ebbe ragione il mondo di così fare, perciò che non si può tanto lodare questa opera che basti.
Cresciuta perciò la fama d'Andrea, Leone Decimo risoluto di far fare a Santa Maria di Loreto l'ornamento della ca-mera di Nostra Donna di marmi lavorati, secondo che da Bramante era stato cominciato, ordinò che Andrea seguitasse quell'opera insino alla fine. L'ornamento di quella camera, che aveva cominciato Bramante, faceva in su le cantonate quattro risalti doppii, i quali ornati da pilastri con base e capitelli intagliati posavano sopra un basamento ricco d'intagli alto due braccia e mezzo; sopra il qual basamento fra i due pilastri detti aveva fatto una nicchia grande per mettervi figure a sedere e sopra ciascuna di quelle un'altra nicchia minore, che giugnendo al collarino di capitegli di que' pilastri, faceva tanta fregiatura quanto erano alti; e sopra questi veniva poi posato l'architetture, il fregio e la cornice riccamente intagliata, e, rigirando intorno intorno a tutt'e quattro le facciate e risaltando sopra le quattro cantonate, fa una nel mezzo di ciascuna facciata maggiore (perché è quella camera più lunga che larga) due vani: onde era il medesimo risalto nel mezzo che in sui cantoni e la nicchia maggiore di sotto e la minore di sopra, venivano a essere messe in mezzo da uno spazio di cinque braccia da ciascun lato: nel quale spazio erano due porte, cioè una per lato, per le quali si aveva l'entrata alla detta cappella; e sopra le porte era un vano fra nicchia e nicchia di braccia cinque, per farvi storie di marmo. La facciata dinanzi era simile, ma senza nicchie nel mezzo, e l'altezza dell'imbasamento faceva col risalto uno alta-re, il quale accompagnavano le cantonate de' pilastri e le nicchie de' canti. Nella medesima facciata era nel mezzo una larghezza della medesima misura che gli spazii dalle bande per alcune storie della parte di sopra e di sotto in tanta altezza quanta era quella della parte, ma cominciando sopra l'altare, era una grata di bronzo dirimpetto all'altare di dentro per la quale si udiva la messa e vedeva il didentro della camera et il detto altare della Madonna. In tutto, dunque, erano gli spazii e vani per le storie sette: uno dinanzi sopra la grata, due per ciascun lato maggiore e due di sopra, ciò dietro all'altare della Madonna, et oltre ciò otto nicchie grandi et otto piccole, con altri vani minori per l'arme et imprese del Papa e della chiesa. Andrea dunque, avendo trovato la cosa in questo termine, scompartì con ricco e bello ordine nei sottospazii istorie della vita della Madonna; in una delle due facciate dai lati cominciò per una parte la Natività della Madonna e la condusse a mezzo, onde fu poi finita del tutto da Baccio Bandinelli; nell'altra parte cominciò lo Sposalizio, ma essendo anco questa rimasa imperfetta fu, dopo la morte d'Andrea, finita in quel modo che si vede da Raffaello da Monte Lupo; nella facciata dinanzi ordinò in due piccoli quadri, che mettono in mezzo la grata di bronzo, che si facesse in uno la Visitazione e nell'altro quando la Vergine e Giuseppo vanno a farsi descrivere. E queste storie furono poi fatte da Francesco da San Gallo allora giovane. In quella parte, poi, dove è lo spazio maggiore, fece Andrea l'angelo Gabbriello che annunzia la Vergine (il che fu in quella stessa camera che questi marmi rinchiuggono) con tanta bella grazia, che non si può veder meglio, avendo fatta la Vergine intensissima a quel saluto e l'Angelo ginocchioni, che non di marmo, ma pare veramente celeste e che di boca gl'esca “Ave Maria”. Sono in compagnia di Gabbriello due altri Angeli tutti tondi e spiccati uno de' quali camina appresso di lui e l'altro pare che voli. Due altri Angeli stanno dopo un casamento, in modo traforati dallo scarpello che paiono vivi; in aria e sopra una nuvola trasforata, anzi quasi tutta spiccata dal marmo, sono molti putti che sostengono un Dio Padre che manda lo Spirito Santo per un raggio di marmo, che, partendosi da Lui, tutto spiccato pare naturalissimo, sì come è anco la colomba, che sopra esso rappresenta esso Spirito Santo; né si può dire quanto sia bello e lavorato con sottilissimo intaglio un vaso pieno di fiori, che in questa opera fece la graziosa mano d'Andrea, il quale nelle piume degl'Angeli, nella capigliatura, nella grazia de' volti e de' panni et insomma in ogni altra cosa sparse tanto del buono che non si può tanto lodare questa divina opra che basti. E nel vero quel santissimo luogo, che fu propria casa et abitazione della Madre del Figliuol di Dio, non poteva quanto al mondo ricevere maggiore, né più ricco e bello ornamento di quello che egli ebbe dall'architettura di Bramante e dalla scultura d'Andrea Sansavino, come che se tutto fusse delle più preziose gemme orientali, non sarebbe se non poco più che nulla a tanti meriti.
Consumò Andrea tanto tempo in questa opera, che quasi non si crederebbe, onde non ebbe tempo a finire l'altre che aveva cominciato: perché oltre alle dette di sopra cominciò in una facciata da uno dei lati la Natività di Gesù Cristo, i pastori e quattro Angeli che cantano; e questi tutti finì tanto bene che paiono vivissimi; ma la storia, che sopra questa cominciò, de' Magi fu poi finita da Girolamo Lombardo suo discepolo e da altri. Nella testa di dietro ordinò che si facessero due storie grandi, cioè una sopra l'altra: in una la morte di essa Nostra Donna e gl'Apostoli che la portano a seppellire, quattro Angeli in aria e molti Giudei che cercano di rubar quel corpo santissimo; e questa fu finita, dopo la vita d'Andrea, dal Bologna scultore. Sotto questa poi ordinò che si facesse la storia del Miracolo di Loreto et in che modo quella capella, che fu la camera di Nostra Donna e dove ella nacque, fu allevata e salutata dall'Angelo, e dove ella nutrì il Figliuolo insino a dodici anni e dimorò poi sempre dopo la morte di lui, fusse finalmente dagl'Angeli portata prima in Ischiavonia, dopo nel territorio di Ricanati in una selva, e per ultimo dove ella è oggi tenuta con tanta venerazione e con solenne frequenza di tutti i popoli cristiani continuamente visitata. Questa storia, dico, secondo che da Andrea era stato ordinato, fu in quella facciata fatta di marmo dal Tribolo scultore fiorentino, come al suo luogo si dirà. Abbozzò similmente Andrea i Profeti delle nicchie, ma non avendo interamente finitone se non uno, gl'altri sono poi stati finiti dal detto Girolamo Lombardo e da altri scultori, come si vedrà nelle vite che seguono. Ma quanto in questa parte appartiene ad Andrea, questi suoi lavori sono i più belli e meglio condotti di scultura che mai fussero stati fatti insino a quel tempo. Il palazzo similmente della canonica di quella chiesa fu similmente seguitato da Andrea, secondo che Bramante di commessione di papa Leone aveva ordinato; ma essendo anco rimaso dopo Andrea imperfetto, fu seguitata la fabrica sotto Clemente Settimo da Antonio da San Gallo e poi da Giovanni Boccalino architetto, sotto il reverendissimo cardinale di Carpi, insino all'anno 1563. Mentre che Andrea lavorò alla detta cappella della Vergine, si fece la fortificazione di Loreto et altre cose, che molto furono lodate dall'invittissimo signor Giovanni de' Medici, col quale ebbe Andrea stretta dimestichezza, essendo stato da lui conosciuto primieramente in Roma.
Avendo Andrea di vacanza quattro mesi dell'anno, per suo riposo, mentre lavorò a Loreto, consumava il detto tempo al Monte, sua patria, in agricoltura, godendosi in tanto un tranquillissimo riposo con i parenti e con gl'amici. Standosi dunque la state al monte, vi fabbricò per sé una comoda casa e comperò molti beni, et ai frati di Santo Agostino di quel luogo fece fare un chiostro, che, per piccolo che sia, è molto bene inteso, se bene non è quadro, per averlo voluto que' padri fabricare in sulle mura vecchie. Nondimeno Andrea lo ridusse nel mezzo quadro ingrossando i pilastri ne' cantoni, per farlo tornare, essendo sproporzionato, a buona e giusta misura. Disegnò anco a una Compagnia, che è in detto chiostro, intitolata Santo Antonio, una bellissima porta di componimento dorico, e similmente il tramezzo et il pergamo della chiesa di esso Santo Agostino. Fece anco fare nello scendere, per andare alla fonte, fuor d'una porta, verso la pieve vecchia a mezza costa una cappelletta per i frati, ancor che non ne avessero voglia. In Arezzo fece il disegno della casa di Messer Pietro astrologo peritissimo, e di terra una figura grande per Monte Pulciano, cioè un re Porsena, che era cosa singulare, ma non l'ho mai rivista dalla prima volta in poi, onde dubito non sia male capitata. Et a un prete tedesco amico suo, fece un San Rocco di terra cotta grande quanto il naturale e molto bello; il quale prete lo fece porre nella chiesa di Battifolle, contado d'Arezzo: e questa fu l'ultima scultura che facesse. Diede anco il disegno delle scale della salita al Vescovado d'Arezzo. E per la Madonna delle Lagrime della medesima città fece il disegno d'uno ornamento che si aveva a fare di marmo, bellissimo con quattro figure di braccia quatro l'una, ma non andò questa opera inanzi per la morte di esso Andrea; il quale pervenuto all'età di LXVIII anni, come quello che mai non stava ozioso, mettendosi in villa a tramutare certi pali da luogo a luogo, prese una calda et in pochi giorni, aggravato da continua febre, si morì l'anno 1529.
Dolse la morte d'Andrea, per l'onore alla patria e per l'amore et utile a' tre suoi figliuoli maschi et alle femmine parimente; e non è molto tempo che Muzio Camillo, un de' tre predetti figliuoli, il quale negli studii delle buone lettere riusciva ingegno bellissimo, gl'andò dietro con molto danno della sua casa e dispiacere degl'amici. Fu Andrea, oltre alla professione dell'arte, persona invero assai segnalata; perciò che fu nei discorsi prudente e d'ogni cosa ragionava benissimo; fu provido e costumato in ogni sua azzione, amicissimo degl'uomini dotti e filosofo naturalissimo. Attese assai alle cose di cosmografia e lasciò ai suoi alcuni disegni e scritti di lontananze e di misure. Fu di statura alquanto piccolo, ma benissimo formato e complessionato. I capegli suoi erano distesi e molli, gl'occhi bianchi, il naso aquilino, la carne bianca e rubiconda, ma ebbe la lingua alquanto impedita. Furono suoi discepoli Girolamo Lombardo detto, Simone Cioli fiorentino, Domenico dal Monte San Savino, che morì poco dopo lui, Lionardo del Tasso fiorentino, che fece in Santo Ambruogio di Firenze sopra la sua sepoltura un San Bastiano di legno e la tavola di marmo delle monache di Santa Chiara. Fu similmente suo discepolo Iacopo Sansovino fiorentino, così nominato dal suo maestro, del quale si ragionerà a suo luogo distesamente.
Sono, dunque, l'architettura e la scultura molto obligate ad Andrea, per aver egli nell'una aggiunto molti termini di misure et ordini di tirar pesi et un modo di diligenza che non si era per innanzi usato, e nell'altra avendo condotto a perfezzione il marmo con giudizio, diligenza e pratica maravigliosa.
VITA DI BENEDETTO DA ROVEZZANO
SCULTORE FIORENTINO

Gran dispiacere, mi penso io, che sia quello di coloro che, avendo fatto alcuna cosa ingegnosa, quando sperano goderla nella vecchiezza e vedere le prove e le bellezze degl'ingegni altrui in opere somiglianti alle loro e potere conoscere quanto di perfezzione abbia quella parte che essi hanno esercitato, si trovano dalla fortuna contraria o dal tempo o cattiva complessione o altra causa privi del lume degl'occhi. Onde non possono come prima facevano conoscere né il difetto, né la perfezzione di coloro che sentono esser vivi et esercitarsi nel loro mestiero. E molto più credo gli attristi il sentire le lode de' nuovi, non per invidia, ma per non potere essi ancora esser giudici, si quella fama viene a ragione o no. La qual cosa avvenne [a] Benedetto da Rovezzano scultore fiorentino, del quale al presente scriviamo la vita, acciò sappia il mondo quanto egli fusse valente e pratico scultore e con quanta diligenza campasse il marmo spiccato, facendo cose meravigliose. Fra le prime di molte opre che costui lavorò in Firenze, si può annoverare un camino di macigno ch'è in casa di Pierfrancesco Borgherini, dove sono di sua mano intagliati capitegli, fregi et altri molti ornamenti straforati con diligenza. Parimente in casa di Messer Bindo Altoviti è di mano del medesimo un camino et uno acquaio di macigno con alcune altre cose molto sottilmente lavorate, ma quanto appartiene all'architettura, col disegno di Iacopo Sansovino allora giovane.
L'anno poi 1512, essendo fatta allogazione a Benedetto d'una sepoltura di marmo con ricco ornamento nella cappella maggiore del Carmine di Firenze, per Piero Soderini stato gonfaloniere in Fiorenza, fu quella opera con incredibile diligenza da lui lavorata, perché, oltre ai fogliami et intagli di morte e figure, vi fece di basso rilievo un padiglione a uso di panno nero, di paragone, con tanta grazia e con tanto bel pulimento e lustro, che quella pietra pare più tosto un bellissimo raso nero che pietra di paragone. E per dirlo brevemente: tutto quello che è di mano di Benedetto in tutta questa opera, non si può tanto lodare che non sia poco. E perché attese anco all'architettura si rassettò col disegno di Benedetto, a Santo Apostolo di Firenze, la casa di Messer Oddo Altoviti, patrone e priore di quella chiesa; e Benedetto vi fece di marmo la porta principale e, sopra la porta della casa, l'arme degl'Altoviti di pietra di macigno et in essa il lupo scorticato, secco e tanto spiccato a torno, che par quasi disgiunto dal corpo dell'arme, con alcuni svolazzi trasforati e così sottili, che non di pietra, ma paiono di sottilissima carta. Nella medesima chiesa fece Benedetto sopra le due cap-pelle di Messer Bindo Altoviti, dove Giorgio Vasari aretino dipinse a olio la tavola della Concezzione, la sepoltura di marmo del detto Messer Oddo, con un ornamento intorno, pieno di lodatissimi fogliami e la cassa parimente bellissima. Lavorò ancora Benedetto a concorrenza di Iacopo Sansovino e di Baccio Bandinelli, come si è detto, uno degli Apostoli di quattro braccia e mezzo per Santa Maria del Fiore, cioè un San Giovanni Evangelista, che è figura assai ragionevole e lavorata con buon disegno e pratica. La quale figura è nell'Opera in compagnia dell'altre.
L'anno poi 1515, volendo i capi e maggiori dell'Ordine di Vallombrosa traslatar il corpo di San Giovanni Gualberto dalla Badia di Passignano nella chiesa di Santa Trinita di Fiorenza, badia del medesimo Ordine, feciono fare a Benedetto il disegno e metter mano a una cappella e sepoltura insieme, con grandissimo numero di figure tonde e grandi quanto il vivo, che accomodatamente venivano nel partimento di quell'opera in alcune nicchie tramezzate di pilastri, pieni di fregiature e di grottesche intagliate sottilmente. E sotto a tutta questa opera aveva ad essere un basamento alto un braccio e mezzo, dove andavano storie della vita di detto San Giovangualberto et altri infiniti ornamenti avevano a essere intorno alla cassa e per finimento dell'opera. In questa sepoltura dunque lavorò Benedetto, aiutato da molti intagliatori, dieci anni continui, con grandissima spesa di quella Congregazione, e condusse a fine quel lavoro nelle case del Guarlondo, luogo vicino a San Salvi, fuor della porta alla Croce, dove abitava quasi di continuo il generale di quell'Ordine che faceva far l'opera. Benedetto dunque condusse di maniera questa cappella e sepoltura, che fece stupire Fiorenza. Ma come volle la sorte (essendo anco i marmi e l'opere egregie degl'uomini eccellenti sottoposte alla fortuna) essendosi fra que' monaci, dopo molte discordie, mutato governo, si rimase nel medesimo luogo quell'opera imperfetta insino al 1530. Nel qual tempo, essendo la guerra intorno a Fiorenza, furono da e' soldati guaste tante fatiche e quelle teste lavorate con tanta diligenza spiccate empiamente da quelle figurine et in modo rovinato e spezzato ogni cosa, che que' monaci hanno poi venduto il rimanente per piccolissimo prezzo. E chi ne vuole veder una parte, vada nell'Opera di Santa Maria del Fiore, dove ne sono alcuni pezzi stati comperi per marmi rotti, non sono molti anni, dai ministri di quel luogo. E nel vero sì come si conduce ogni cosa a buon fine in que' monasteri e luoghi dove è la concordia e la pace, così per lo contrario dove non è se non ambizione e discordia, niuna cosa si conduce mai a perfezzione, né a lodato fine; perché quanto acconcia un buono e savio in cento anni, tanto rovina un ignorante villano e pazzo in un giorno. E pare che la sorte voglia, che bene spesso coloro che manco sanno e di niuna cosa virtuosa si dilettano, siano sempre quelli che comandino e governino, anzi rovinino ogni cosa; sì come anco disse de' principi secolari non meno dottamente che con verità l'Ariosto nel principio del XVII canto.
Ma tornando a Benedetto, fu peccato grandissimo che tante sue fatiche e spese di quella Religione siano così sgraziatamente capitate male. Fu ordine et architettura del medesimo la porta e vestibulo della Badia di Firenze, e parimente alcune cappelle, et infra l'altre quella di Santo Stefano, fatta dalla famiglia de' Pandolfini. Fu ultimamente Benedetto condotto in Inghilterra a' servigi del re, al quale fece molti lavori di marmo e di bronzo, e particolarmente la sua sepoltura, delle quali opere, per la liberalità di quel re, cavò da poter vivere il rimanente della vita acconciamente; per che tornato a Firenze, dopo aver finito alcune piccole cose, le vertigini, che insino in Inghilterra gl'avevano cominciato a dar noia a gl'occhi, et altri impedimenti causati, come si disse, dallo star troppo intorno al fuoco a fondere i metalli, o pure d'altre cagioni, gli levarono in poco tempo del tutto il lume degl'occhi. Onde restò di lavorare intorno all'anno 1550 e di vivere pochi anni dopo. Portò Beneddetto con buona e cristiana pacienza quella cecità negl'ultimi anni della sua vita, ringraziando Dio che prima gl'aveva proveduto, mediante le sue fatiche, da poter vivere onestamente. Fu Benedetto cortese e galantuomo e si dilettò sempre di praticare con uomini virtuosi. Il suo ritratto si è cavato da uno che fu fatto quando egli era giovine, da Agnolo di Donino. Il quale proprio è in sul nostro libro de' disegni, dove sono anco alcune carte di mano di Benedetto molto ben disegnate. Il quale per queste opere merita di essere fra questi eccellenti artefici annoverato.
VITA DI BACCIO DA MONTE LUPO SCULTORE E DI RAFFAELLO SUO FIGLIUOLO

Quanto manco pensano i popoli che gli straccurati delle stesse arti che e' voglion fare, possino quelle già mai condurre ad alcuna perfezzione, tanto più contra il giudizio di molti imparò Baccio da Monte Lupo l'arte della scultura. E questo gli avvenne perché nella sua giovanezza sviato da' molti piaceri quasi mai non istudiava; et ancora che da molti fusse sgridato e sollecitato, nulla o poco stimava l'arte. Ma venuti gli anni della discrezione, i quali arrecano il senno seco, gli fecero subitamente conoscere quanto egli era lontano da la buona via. Per il che, vergognatosi dagli altri, che in tale arte gli passavono innanzi, con bonissimo animo si propose seguitare et osservare con ogni studio quello che con la infingardaggine sino allora aveva fuggito. Questo pensiero fu cagione ch'egli fece nella scultura que' frutti che la credenza di molti da lui più non aspettava.
Datosi dunque alla arte con tutte le forze et esercitandosi molto in quella, divenne eccellente e raro. E ne mostrò saggio in una opera di pietra forte lavorata di scarpello, in Fiorenza sul cantone del giardino appiccato col palazzo de' Pucci; che fu l'arme di papa Leone X, dove son due fanciulli che la reggono, con bella maniera e pratica condotti. Fece uno Ercole per Pier Francesco de' Medici, e fugli allogato dall'Arte di porta Santa Maria una statua di S. Giovanni Evangelista per farla di bronzo; la quale prima che avesse, ebbe assai contrarii, perché molti maestri fecero modelli a concorrenza. La quale figura fu posta poi sul canto di S. Michele in Orto, dirimpetto all'ufficio. Fu questa opera finita da lui con somma diligenzia. Dicesi che quando egli ebbe fatto la figura di terra, chi vide l'ordine delle armadure e le forme fattele addosso, l'ebbe per cosa bellissima, considerando il bello ingegno di Baccio in tal cosa; e quegli, che con tanta facilità la videro gettare, diedero a Baccio il titolo di avere con grandissima maestria saldissimamente fatto un bel getto. Le quali fatiche durate in quel mestiero, nome di buono, anzi di ottimo maestro gli diedero, et oggi più che mai da tutti gli artefici è tenuta bellissima questa figura. Mettendosi anco a lavorare di legno, intagliò crocifissi grandi quanto il vivo, onde infinito numero per Italia ne fece, e fra gli altri uno a' frati di San Marco in Fiorenza sopra la porta del coro. Questi tutti sono ripieni di bonissima grazia; ma pure ve ne sono alcuni molto più perfetti degli altri, come quello delle Murate di Fiorenza et uno che è in San Pietro Maggiore, mon manco lodato di quello. Et a' monaci di Santa Fiora e Lucilla ne fece un simile che lo locarono sopra l'altar maggiore nella loro badia in Arezzo, che è tenuto molto più bello degli altri. Nella venuta di papa Leone Decimo in Fiorenza, fece Baccio fra il palagio del podestà e badia un arco trionfale bellissimo di legname e di terra e molte cose piccole che si sono smarrite e sono per le case de' cittadini. Ma venutogli a noia lo stare a Fiorenza, se n'andò a Lucca, dove lavorò alcune opere di scultura, ma molte più d'architettu-ra, in servigio di quella città; e particolarmente il bello e ben composto tempio di San Paulino, avvocato de' Lucchesi, con buona e dotta intelligenza di dentro e di fuori e con molti ornamenti. Dimorando dunque in quella città infino al 88 anno della sua età, vi finì il corso della vita, et in San Paulino predetto ebbe onorata sepoltura da coloro che egli aveva in vita onorato.
Fu coetaneo di costui Agostino Milanese, scultore et intagliatore molto stimato, il quale in Santa Marta di Milano cominciò la sepoltura de Monsignor di Fois, oggi rimasa imperfetta; nella quale si veggiono ancora molte figure grandi e finite et alcune mezze fatte et abbozzate, con assai storie di mezzo rilievo in pezzi e non murate e con moltissimi fogliami e trofei. Fece anco un'altra sepoltura, che è finita e murata in San Francesco, fatta a' Biraghi, con sei figure gran-di et il basamento storiato, con altri bellissimi ornamenti che fanno fede della pratica e maestria di quel valoroso artefice.
Lasciò Baccio alla morte sua, fra gl'altri figliuoli, Raffaello, che attese alla scultura e non pure paragonò suo padre, ma lo passò di gran lunga. Questo Raffaello, cominciando nella sua giovanezza a lavorare di terra, di cera e di bronzo, s'acquistò nome d'eccellente scultore e perciò, essendo condotto da Antonio da San Gallo a Loreto, insieme con molti altri per dar fine all'ornamento di quella camera, secondo l'ordine lasciato da Andrea Sansovino, finì del tutto Raffaello lo Sposalizio di Nostra Donna, stato cominciato dal detto Sansovino, conducendo molte cose a perfezzione con bella maniera, parte sopra le bozze d'Andrea, parte di sua fantasia. Onde fu meritamente stimato de' migliori artefici che vi lavorassino al tempo suo. Finita quell'opera, Michelagnolo mise mano, per ordine di papa Clemente Settimo, a dar fine, secondo l'ordine cominciato, alla sagrestia nuova et alla libreria di San Lorenzo di Firenze; onde Michelagnolo, conosciuta la virtù di Raffaello, si servì di lui in quell'opera, e fra l'altre cose gli fece fare, secondo il modello che n'aveva egli fatto, il San Damiano di marmo che è oggi in detta sagrestia, statua bellissima e sommamente lodata da ognuno. Dopo la morte di Clemente, trattenendosi Raffaello appresso al duca Alessandro de' Medici, che allora faceva edificare la fortezza del Prato, gli fece di pietra bigia in una punta del baluardo principale di detta fortezza, cioè dalla parte di fuori, l'arme di Carlo Quinto imperatore, tenuta da due Vittorie ignude e grandi quanto il vivo, che furono e sono molto lodate. E nella punta d'un altro, cioè verso la città dalla parte di mezzogiorno, fece l'arme del detto duca Alessandro del-la medesima pietra con due figure. E non molto dopo lavorò un Crucifisso grande di legno per le monache di Santa Apollonia. E per Alessandro Antinori, allora nobilissimo e ricchissimo mercante fiorentino, nelle nozze d'una sua figliuola, un apparato ricchissimo con statue, storie e molti altri ornamenti bellissimi.
Andato poi a Roma, dal Buonarroto gli furono fatte fare due figure di marmo, grandi braccia cinque, per la sepoltura di Giulio Secondo a San Pietro in Vincula, murata e finita allora da Michelagnolo. Ma amalandosi Rafaello mentre faceva questa opera, non poté mettervi quello studio e diligenza che era solito, onde ne perdé di grado e sodisfece poco a Michelagnolo. Nella venuta di Carlo Quinto imperatore a Roma, facendo fare papa Paulo Terzo un apparato degno di quell'invittissimo principe, fece Raffaello in sul ponte Santo Agnolo di terra e stucchi quattordici statue tanto belle ch'elle furono giudicate le migliori che fussero state fatte in quell'apparato; e, che è più, le fece con tanta prestezza, che fu a tempo a venir a Firenze, dove si aspettava similmente l'imperatore, a fare nello spazio di cinque giorni, e non più, in sulla coscia del ponte a Santa Trinita due fiumi di terra di nove braccia l'uno: cioè il Reno per la Germania et il Danubio per l'Ungheria. Dopo, essendo condotto a Orvieto, fece di marmo in una capella dove aveva prima fatto il Mosca, scultore eccellente, molti ornamenti bellissimi, di mezzo rilievo la storia de' Magi, che riuscì opera molto bella per la varietà di molte figure che egli vi fece con assai buona maniera. Tornato poi a Roma, da Tiberio Crispo, castellano allora di Castel Sant'Agnolo, fu fatto architetto di quella gran mole, onde egli vi acconciò et ornò molte stanze con intagli di molte pietre e mischi di diverse sorti ne' camini, finestre e porte. Fecegli, oltre ciò, una statua di marmo alta cinque braccia, cioè l'Angelo di Castello, che è in cima del torrion quadro di mezzo, dove sta lo stendardo, a similitudine di quello che apparve a San Gregorio, quando avendo pregato per il popolo oppresso da crudelissima pestilenza, lo vide rimettere la spada nella guaina. Appresso, essendo il detto Crispo fatto cardinale, mandò più volte Raffaello a Bolsena dove fabricava un palazzo. Né passò molto che il reverendissimo cardinale Salviati e Messer Baldassarri Turrini da Pescia diedero a fare a Raffaello, già toltosi da quella servitù del Castello e del cardinale Crispo, la statua di papa Leone, che è oggi sopra la sua sepoltura nella Minerva di Roma. E, quella finita, fece Raffaello al detto Messer Baldassarri per la chiesa di Pescia, dove aveva murato una capella di marmo, una sepoltura, et alla Consolazione di Roma fece tre figure di marmo di mezzo rilievo in una capella. Ma datosi poi a una certa vita più da filosofo che da scultore, si ridusse, amando di vivere quietamente, a Orvieto, dove presa la cura della fabrica di Santa Maria, vi fece molti acconcimi, trattenendovisi molti anni et invecchiando inanzi tempo; credo che se Raffaello avesse preso a fare opere grandi, come avrebbe potuto, arebbe fatto molto più cose e migliori che non fece nell'arte. Ma l'essere egli troppo buono e rispettoso, fuggendo le noie e contentandosi di quel tanto che gli aveva la sorte proveduto, lasciò molte occasioni di fare opere segnalate. Disegnò Raffaello molto praticamente et intese molto meglio le cose dell'arte che non aveva fatto Baccio suo padre. E di mano così dell'uno come dell'altro sono alcuni disegni nel nostro libro, ma molto migliori sono e più graziosi e fatti con miglior arte quelli di Raffaello, il quale negl'ornamenti d'architettura seguitò assai la maniera di Michelagnolo, come ne fanno fede i camini e le porte e le finestre che egli fece in detto Castello Sant'Agnolo et alcune capelle fatte di suo ordine a Orvieto di bella e rara maniera. Ma tornando a Baccio, dolse assai la sua morte ai Lucchesi, avendo essi conosciuto giusto e buono uomo e verso ognuno cortese et amorevole molto. Furono l'opere di Baccio circa gl'anni del Signore 1533. Fu suo grandissimo amico e da lui imparò molte cose Zaccaria da Volterra, che in Bologna ha molte cose lavorato di terra cotta, delle quali alcune ne sono nella chiesa di San Giuseppo.
VITA DI LORENZO DI CREDI
PITTORE FIORENTINO

Mentre che maestro Credi, orefice ne' suoi tempi eccellente, lavorava in Fiorenza con molto buon credito e nome, Andrea Sciarpelloni acconciò con esso lui, acciò imparasse quel mestiero, Lorenzo suo figliuolo, giovanetto di bellissimo ingegno e d'ottimi costumi. E perché quanto il maestro era valente et insegnava volentieri, tanto il discepolo apprendeva con studio e prestezza qualunche cosa se gli mostrava, non passò molto tempo che Lorenzo divenne non solamente diligente e buon disegnatore, ma orefice tanto pulito e valente, che niuno giovane gli fu pari in quel tempo, e ciò con tanta lode di Credi che Lorenzo da indi in poi fu sempre chiamato, non Lorenzo Sciarpelloni, ma di Credi da ognuno. Cresciuto dunque l'animo a Lorenzo, si pose con Andrea del Verrocchio, che allora per un suo così fatto umore si era dato al dipignere; e, sotto lui, avendo per compagni e per amici, se bene erano concorrenti, Pietro Perugino e Lionardo da Vinci, attese con ogni diligenza alla pittura. E perché a Lorenzo piaceva fuor di modo la maniera di Lionardo, la seppe così bene imitare che niuno fu che nella pulitezza e nel finir l'opere con diligenza l'imitasse più di lui, come si può vedere in molti disegni fatti e di stile e di penna o d'acquerello, che sono nel nostro libro; fra i quali sono alcuni ritratti da medaglie di terra, acconci sopra con pannolino incerato e con terra liquida; con tanta diligenza imitati e con tanta pacienza finiti, che non si può a pena credere non che fare. Per queste cagioni adunque fu tanto Lorenzo dal suo maestro amato, che quando Andrea andò a Vinezia a gettare di bronzo il cavallo e la statua di Bartolomeo da Bergamo, egli lasciò a Lorenzo tutto il maneggio et amministrazione delle sue entrate e de' negozii e parimente tutti i disegni, rilievi, statue e masserizie dell'arte. Et all'incontro amò tanto Lorenzo esso Andrea suo maestro, che oltre all'adoperarsi in Firenze con incredibile amore in tutte le cose di lui, andò anco più d'una volta a Vinezia a vederlo e rendergli conto del-la sua buona amministrazione; e ciò con tanta sodisfazione d'Andrea, che se Lorenzo l'avesse acconsentito egli se l'a-rebbe instituito erede; né di questo buono animo fu punto ingrato Lorenzo, poi che egli, morto Andrea, andò a Vinezia e condusse il corpo di lui a Firenze; et agl'eredi poi consegnò ciò che si trovava in mano d'Andrea, eccetto i disegni, pitture, sculture et altre cose dell'arte.
Le prime pitture di Lorenzo furono un tondo d'una Nostra Donna, che fu mandato al re di Spagna, il disegno della qual pittura ritrasse da una d'Andrea suo maestro; et un quadro, molto meglio che l'altro, che fu similmente da Lorenzo ritratto da uno di Lionardo da Vinci e mandato anch'esso in Ispagna, ma tanto simile a quello di Lionardo, che non si conosceva l'uno dall'altro. È di mano di Lorenzo una Nostra Donna in una tavola molto ben condotta, la quale è a canto alla chiesa grande di San Iacopo di Pistoia. E parimente una che n'è nello spedale del Ceppo, che è delle migliori pitture che siano in quella città. Fece Lorenzo molti ritratti e quando era giovane fece quello di se stesso, che è oggi appresso Gianiacopo suo discepolo, pittore in Fiorenza, con molte altre cose lasciategli da Lorenzo, fra le quali sono il ritratto di Pietro Perugino e quello d'Andrea del Verrocchio suo maestro. Ritrasse anco Girolamo Benivieni, uomo dottissimo e suo molto amico. Lavorò nella Compagnia di S. Bastiano dietro la chiesa de' Servi in Fiorenza in una tavola la Nostra Donna, S. Bastiano et altri Santi, e fece all'altare di S. Giuseppo in Santa Maria del Fiore esso Santo. Mandò a Monte Pulciano una tavola, che è nella chiesa di Santo Agostino, dentrovi un Crucifisso, la Nostra Donna e S. Giovanni, fatti con molta diligenza. Ma la migliore opera che Lorenzo facesse mai, e quella in cui pose maggiore studio e diligenza per vincere se stesso, fu quella che è in Cestello a una capella dove in una tavola è la Nostra Donna, S. Giuliano e S. Niccolò; e chi vuol conoscere che il lavorare pulito a olio è necessario a volere che l'opere si conservino, veggia questa tavola lavorata con tanta pulitezza che non si può più. Dipinse Lorenzo essendo ancor giovane, in un pilastro d'Or S. Michele, un San Bartolomeo, et alle monache di Santa Chiara in Fiorenza una tavola della Natività di Cristo, con alcuni pastori et Angeli; et in questa, oltre l'altre cose, mise gran diligenza in contrafare alcune erbe tanto bene, che paiono naturali; nel medesimo luogo fece in un quadro una S. Madalena in penitenza, et in un altro appresso la casa di Messer Ottaviano de' Medici fece un tondo d'una Nostra Donna. In S. Friano fece una tavola, et in San Matteo dello spedale di Lelmo lavorò alcune figure; in Santa Reparata dipinse l'angelo Michele in un quadro, e nella Compagnia dello Scalzo una tavola fatta con molta diligenza; et oltre a queste opere, fece molti quadri di Madonne e d'altre pitture, che sono per Fiorenza nelle case de' cittadini.
Avendo dunque Lorenzo, mediante queste fatiche, messo insieme alcune somme di danari, come quello che più tosto che arrichire disiderava quiete, si commise in S. Maria Nuova di Fiorenza, là dove visse et ebbe commoda abitazione insino alla morte. Fu Lorenzo molto parziale della setta di fra' Girolamo da Ferrara e visse sempre come uomo onesto e di buona vita, usando amorevolmente cortesia dovunque se gliene porgeva occasione. Finalmente pervenuto al 78 anno della sua vita, si morì di vecchiezza e fu sepellito in S. Piero Maggiore l'anno 1530. Fu costui tanto finito e pulito ne' suoi lavori, che ogni altra pittura a comparazione delle sue parrà sempre abbozzata e mal netta. Lasciò molti discepoli e fra gl'altri Giovanni Antonio Sogliani e Tommaso di Stefano. Ma perché del Sogliano si parlerà in altro luogo, dirò quanto a Tommaso ch'egli imitò molto nella pulitezza il suo maestro e fece in Fiorenza e fuori molte opere; nella villa d'Arcetri a Marco del Nero una tavola d'una Natività di Cristo condotta molto pulitamente. Ma la principal professione di Tommaso fu col tempo di dipignere drapperie, onde lavorò i drappelloni meglio che alcun'altro. E perché Stefano, padre di Tommaso, era stato miniatore et anco aveva fatto qualche cosa d'architettura, Tommaso per imitarlo condusse dopo la morte di esso suo padre il ponte a Sieve, lontano a Fiorenza X miglia, che allora era per una piena rovinato; e similmente quello di S. Piero a ponte in sul fiume di Bisenzio, che è una bell'opera. E dopo molte fabriche fatte per monasterii et altri luoghi, ultimamente, essendo architettore dell'Arte della Lana, fece il modello delle case nuove che fece fare quell'Arte dietro alla Nunziata; e finalmente si morì essendo già vecchio di 70 anni o più, l'anno 1564, e fu sepolto in S. Marco, dove fu onorevolmente accompagnato dall'Accademia del Disegno.
Ma tornando a Lorenzo, ei lasciò molte opere imperfette alla sua morte, e particolarmente un quadro d'una Passione di Cristo, molto bello, che venne nelle mani d'Antonio da Ricasoli et una tavola di Messer Francesco da Castiglioni canonico di Santa Maria del Fiore, che la mandò a Castiglioni, molto bella. Non si curò Lorenzo di fare molte opere gran-di, perché penava assai a condurle e vi durava fatica incredibile e massimamente perché i colori ch'egli adoperava erano troppo sottilmente macinati; oltre che, purgava gl'olii di noce e stillavagli e faceva in sulle tavolelle le mestiche de' colori in gran numero, tanto che dalla prima tinta chiara all'ultima oscura si conduceva a poco a poco con troppo e vera-mente soverchio ordine, onde n'aveva alcuna volta in sulla tavolella 25 e trenta e per ciascuna teneva il suo pennello appartato, e dove egli lavorava non voleva che si facesse alcun movimento che potesse far polvere, la quale troppo estrema diligenza non è forse più lodevole punto che si sia una strema negligenza: perché in tutte le cose si vuole avere un certo mezzo e star lontano dagl'estremi che sono comunemente viziosi.
VITA DI LORENZETTO SCULTORE ET ARCHITETTO FIORENTINO E DI BOCCACCINO PITTORE CREMONESE

Quando la fortuna ha tenuto un pezzo a basso con la povertà la virtù di qualche bell'ingegno, alcuna volta suole ravvedersi et in un punto non aspettato procacciare a colui, che dianzi gl'era nimico, in varii modi beneficii, per ristorare in un anno i dispetti e l'incomodità di molti.
Il che si vide in Lorenzo di Lodovico campanaio fiorentino, il quale si adoperò così nelle cose d'architettura, come di scultura, e fu tanto amato da Raffaello da Urbino, che non solo fu da lui aiutato et adoperato in molte cose, ma ebbe dal medesimo per moglie una sorella di Giulio Romano, discepolo di esso Raffaello. Finì Lorenzetto (che così fu sempre chiamato) nella sua giovanezza, la sepoltura del cardinale Forteguerri, posta in San Iacopo di Pistoia e stata già cominciata da Andrea del Verrocchio; e fra l'altre cose vi è di mano di Lorenzetto una Carità che non è se non ragionevole; e poco dopo fece a Giovanni Bartolini per il suo orto una figura, la quale finita, andò a Roma, dove lavorò ne' primi anni molte cose, delle quali non accade fare altra memoria.
Dopo, essendogli allogata da Agostino Ghigi per ordine di Raffaello da Urbino, la sua sepoltura in Santa Maria del Popolo, dove aveva fabricato una capella, Lorenzo si mise a questa opera con tutto quello studio, diligenza e fatica che mai gli fu possibile, per uscirne con lode, per piacere a Raffaello, dal quale poteva molti favori et aiuti sperare, e per esserne largamente rimunerato dalla liberalità d'Agostino, uomo ricchissimo. Né cotali fatiche furono se non benissimo spese, perché, aiutato dal giudizio di Raffaello, condusse a perfezzione quelle figure, cioè un Iona ignudo uscito del ventre del pesce, per la ressurezzione de' morti, et uno Elia, che col vaso d'acqua e col pane subcinerizio vive di grazia sotto il ginepro. Queste statue, dunque, furono da Lorenzo a tutto suo potere con arte e diligenza a somma bellezza finite, ma egli non ne conseguì già quel premio che il bisogno della sua famiglia e tante fatiche meritavano; perciò che a-vendo la morte chiusi gl'occhi ad Agostino e quasi in un medesimo tempo a Raffaello, le dette figure, per la poca pietà degl'eredi d'Agostino, se gli rimasono in bottega dove stettono molti anni; pure oggi sono state messe in opera nella detta chiesa di Santa Maria del Popolo alla detta sepoltura. Lorenzo dunque, caduto d'ogni speranza per le dette cagioni, si trovò per allora avere gettato il tempo e la fatica. Dovendosi poi essequire il testamento di Raffaello gli fu fatta fare una statua di marmo di quattro braccia d'una Nostra Donna, per lo sepolcro di esso Raffaello nel tempio di Santa Maria Ritonda, dove per ordine suo fu restaurato quel tabernacolo. Fece il medesimo Lorenzo per un mercante de' Perini alla Trinità di Roma una sepoltura con due fanciulli di mezzo rilievo. E d'architettura fece il disegno di molte case e particolarmente quello del palazzo di Messer Bernardino Caffarelli; e nella Valle la facciata di dentro e così il disegno delle stalle et il giardino di sopra, per Andrea cardinale della Valle, dove accomodò nel partimento di quell'opera colonne basse e capitegli antichi, e spartì attorno per basamento di tutta quell'opera pili antichi pieni di storie. E più alto fece sotto certe nicchione un altro fregio di rottami di cose antiche, e di sopra nelle dette nicchie pose alcune statue pur antiche e di marmo, le quali se bene non erano intere, per essere quale senza testa, quale senza braccia et alcuna senza gambe, et insomma ciascuna con qualche cosa meno, l'accomodò non di meno benissimo, avendo fatto rifare a buoni scultori tutto quello che mancava. La quale cosa fu cagione che altri signori hanno poi fatto il medesimo e restaurato molte cose antiche, come il cardinale Cefis, Ferrara, Farnese e, per dirlo in una parola, tutta Roma. E nel vero hanno molto più grazia queste anticaglie in questa maniera restaurate, che non hanno que' tronchi imperfetti e le membra senza capo o in altro modo difettose e manche.
Ma tornando al giardino detto, fu posto sopra le nicchie la fregiatura che vi si vede di storie antiche di mezzo rilievo bellissima e rarissima. La quale invenzione di Lorenzo gli giovò infinitamente, perché passati gl'infortunii di papa Clemente, egli fu adoperato con suo molto onore et utile; perciò che avendo il Papa veduto, quando si combatté Castello Santo Agnolo, che due cappellette di marmo, che erano all'entrare del ponte, avevano fatto danno, perché standovi dentro alcuni soldati archibugieri amazzavano chiunche s'affacciava alle mura e con troppo danno, stando essi al sicuro levavano le diffese, si risolvé Sua Santità levare le dette cappelle e ne' luoghi loro mettere sopra due basamenti due statue di marmo. E così, fatto metter su il San Paulo di Paulo Romano, del quale si è in altro luogo ragionato, fu data a fare l'altra, cioè un San Pietro, a Lorenzetto, il quale si portò assai bene, ma non passò già quella di Paulo Romano. Le quali due statue furono poste e si veggiono oggi all'entrata del ponte. Venuto poi a morte papa Clemente, furono allogate a Baccio Bandinelli le sepolture di esso Clemente e quella di Leone Decimo et a Lorenzo data la cura del lavoro di quadro che vi si aveva a fare di marmo; onde egli si andò in questa opera qualche tempo trattenendo.
Finalmente quando fu creato pontefice papa Paulo III, essendo Lorenzo molto male condotto et assai consumato, e non avendo altro che una casa, la quale egli stesso si aveva al Macello de' Corbi fabricato, et aggravato di cinque figliuoli et altre spese, si voltò la fortuna a ingrandirlo e ristorarlo per altra via. Perciò che volendo papa Paulo che si seguitasse la fabrica di San Piero e non essendo più vivo né Baldassarri Sanese, né altri di coloro che vi avevano atteso, Antonio da San Gallo mise Lorenzo in quell'opera per architetto, dove si facevano le mura in cottimo a tanto la canna. Laonde in pochi anni fu più conosciuto e ristorato Lorenzo senza affaticarsi, che non era stato in molti con mille fatiche, avendo in quel punto propizio Dio, gl'uomini e la fortuna; e se egli fusse più lungamente vivuto, averebbe anco molto meglio ristorato que' danni che la violenza della sorte, quando bene operava, indegnamente gli avea fatto. Ma condottosi all'età d'anni XLVII si morì di febre l'anno 1541. Dolse infinitamente la morte di costui a molti amici suoi, che lo conobbero sempre amorevole e discreto; e perché egli visse sempre da uomo da bene e costumatamente, i deputati di San Piero gli diedero in un deposito onorato sepolcro e posero in quello lo infrascritto epitaffio:
SCULPTORI LAURENTIO FLORENTINO
Roma mihi tribuit tumulum, Florentia vitam;
Nemo alio vellet nasci et obire loco.
MDXLI
Vixit annos XLVII. Menses II. Dies XV.
Avendosi Boccaccino cremonese, il quale fu quasi ne' medesimi tempi, nella sua patria e per tutta Lombardia acquistato fama di raro e d'eccellente pittore, erano sommamente lodate l'opere sue, quando egli andato a Roma per vedere l'opere di Michelagnolo tanto celebrate non l'ebbe sì tosto vedute che quanto poté il più cercò d'avilirle et abbassarle, parendogli quasi tanto inalzare se stesso quanto biasimava un uomo veramente nelle cose del disegno, anzi in tutte generalmente eccellentissimo. A costui dunque essendo allogata la capella di Santa Maria Traspontina, poi che l'ebbe finita di dipignere e scoperta, chiarì tutti coloro i quali, pensando che dovesse passare il cielo, non lo videro pur aggiugnere al palco degl'ultimi solari delle case. Perciò che veggendo i pittori di Roma la incoronazione di Nostra Donna, che egli aveva fatto in quell'opera con alcuni fanciulli volanti, cambiarono la maraviglia in riso. E da questo si può conoscere, che quando i popoli cominciano ad inalzare col grido alcuni più eccellenti nel nome che nei fatti, è difficile cosa potere, ancora che a ragione, abbattergli con le parole, insino a che l'opere stesse contrarie in tutto a quella credenza non discuoprono quello che coloro tanto celebrati sono veramente. Et è questo certissimo, che il maggior danno che agl'altri uomini facciano gl'uomini, sono le lodi che si dànno troppo presto agli ingegni che si affaticano nell'operare, perché facendo cotali lodi coloro gonfiare acerbi, non gli lasciano andare più avanti, e coloro tanto lodati, quando non riescono l'opere di quella bontà che si aspettavano, accorandosi di quel biasimo, si disperano al tutto di potere mai più bene operare; laonde coloro che savi sono deono assai più temere le lodi che il biasimo: perché quelle adulando ingannano, e questo, scoprendo il vero, insegna. Partendosi addunque Boccaccino di Roma per sentirsi da tutte le parti trafitto e lacero, se ne tornò a Cremona, e quivi il meglio che seppe, e poté, continuò d'essercitar la pittura; e dipinse nel Duomo, sopra gl'archi di mezzo, tutte le storie della Madonna, la quale opera è molto stimata in quella città; fece anco altre opere e per la città e fuori, delle quali non accade far menzione. Insegnò costui l'arte a un suo figliuolo, chiamato Camillo, il quale attendendo con più studio all'arte s'ingegnò di rimediare dove aveva mancato la vanagloria di Boccaccino. Di mano di questo Camillo sono alcune opere in San Gismondo lontano da Cremona un miglio, le quali dai cremonesi so-no stimate la miglior pittura che abbiano; fece ancora in piazza nella facciata d'una casa et in Santa Agata tutti i parimenti delle volte et alcune tavole e la facciata di Santo Antonio con altre cose, che lo fecero conoscere per molto pratico. E se la morte non l'avesse anzi tempo levato del mondo, averebbe fatto onoratissima riuscita, perché caminava per buona via. Ma quelle opere nondimeno che ci ha lasciate meritano che di lui si faccia memoria.
Ma tornando a Boccaccino, senza aver mai fatto alcun miglioramento nell'arte, passò di questa vita d'anni 58.
Ne' tempi di costui fu in Milano un miniatore assai valente chiamato Girolamo, di mano del quale si veggiono assai opere e quivi et in tutta Lombardia. Fu similmente milanese, e quasi ne' medesimi tempi, Bernardino del Lupino, pittore dilicatissimo e molto vago, come si può vedere in molte opere che sono di sua mano in quella città et a Sarone, luogo lontano da quella 12 miglia, in uno sposalizio di Nostra Donna et in altre storie che sono nella chiesa di Santa Maria, fatte in fresco perfettissimamente. Lavorò anco a olio molto pulitamente e fu persona cortese et amorevole molto delle cose sue: onde se gli convengono meritamente tutte quelle lodi che si deono a qualunche artefice che con l'ornamento della cortesia fa non meno risplendere l'opere et i costumi della vita, che con l'essere eccellente quelle dell'arte.
VITA DI BALDASSARRE PERUZZI SANESE
PITTORE ET ARCHITETTO

Fra tutti i doni che distribuisce il cielo ai mortali, nessuno giustamente si puote o dee tener maggior della virtù e quiete e pace dell'animo, facendoci quella per sempre immortali e questa beati; e però chi di queste è dotato, oltre l'o-bligo che ne dee avere grandisimo a Dio, tra gl'altri, quasi fra le tenebre un lume, si fa conoscere; nella maniera che ha fatto ne' tempi nostri Baldassarre Peruzzi pittore et architetto sanese; del quale sicuramente possiamo dire che la modestia e la bontà che si videro in lui fussino rami non mediocri della somma tranquillità che sospirano sempre le menti di chi ci nasce e che l'opere da lui lasciateci siano onoratissimi frutti di quella vera virtù che fu in lui infusa dal cielo. Ma se bene ho detto di sopra Baldassarre sanese, perché fu sempre per sanese conosciuto, non tacerò che, sì come sette città combatterono fra loro Omero, volendo ciascuno che egli fusse suo cittadino, così tre nobilissime città di Toscana, cioè Fiorenza, Volterra e Siena, hanno tenuto ciascuna che Baldassarre sia suo. Ma a dirne il vero, ciascheduna ci ha parte, perciò che essendo già travagliata Fiorenza dalle guerre civili, Antonio Peruzzi, nobile cittadino fiorentino, se n'andò, per vivere più quietamente, ad abitare a Volterra: là dove avendo qualche tempo dimorato, l'anno 1482 prese moglie in quella città et in pochi anni ebbe due figliuoli, uno maschio chiamato Baldassarre et una femmina che ebbe nome Virginia. Ora avvenne, correndo dietro la guerra a costui che null'altro cercava che pace e quiete, che Volterra indi a non molto fu saccheggiata; perché fu sforzato Antonio fuggirsi a Siena, e lì, avendo perduto quasi tutto quello che aveva, a starsi assai poveramente.
Intanto, essendo Baldassarre cresciuto, praticava sempre con persone ingegnose e particolarmente con orafi e disegnatori, per che, cominciatogli a piacere quell'arti, si diede del tutto al disegno. E non molto dopo morto il padre, si diede alla pittura con tanto studio, che in brevissimo tempo fece in essa meraviglioso acquisto imitando, oltre l'opere de' maestri migliori, le cose vive e naturali; e così facendo qualche cosa, poté con quell'arte aiutare se stesso, la madre e la sorella e seguitare gli studii della pittura. Furono le sue prime opere (oltre alcune cose in Siena non degne di memoria) una capelletta in Volterra appresso alla porta Fiorentina, nella quale condusse alcune figure con tanta grazia, che elle furono cagione che fatto amicizia con un pittore volterrano chiamato Piero, il quale stava il più del tempo in Roma, egli se n'andasse là con esso lui che lavorava per Alessandro Sesto alcune cose in palazzo. Ma essendo morto Alessandro e non lavorando più maestro Piero in quel luogo, si mise Baldassarre in bottega del padre di Maturino, pittore non molto eccellente, che in quel tempo di lavori ordinarii aveva sempre molte cose da fare. Colui dunque, messo innanzi a Baldassarre un quadro ingessato, gli disse, senza dargli altro cartone o disegno, che vi facesse dentro una Nostra Donna. Baldassarre, preso un carbone, in un tratto ebbe con molta pratica disegnato quello che voleva dipignere nel quadro; et appresso, dato di mano ai colori, fece in pochi giorni un quadro tanto bello e ben finito, che fece stupire non solo il maestro della bottega, ma molti pittori che lo videro. I quali conosciuta la virtù sua, furono cagione che gli fu dato a fa-re nella chiesa di Santo Onofrio la capella dell'altar maggiore, la quale egli condusse a fresco con molto bella maniera e con molta grazia. Dopo nella chiesa di Santo Rocco a Ripa fece due altre capellette in fresco; per che cominciato a essere in buon credito fu condotto a Ostia, dove nel Maschio della Rocca dipinse di chiaro scuro in alcune stanze storie bellissime, e particolarmente una battaglia da mano, in quella maniera che usavano di combattere anticamente i Roma-ni; et appresso uno squadrone di soldati che danno l'assalto a una rocca, dove si veggiono i soldati con bellissima e pronta bravura, coperti colle targhe, appoggiare le scale alla muraglia e quelli di dentro ributtargli con fierezza terribile. Fece anco in questa storia molti instrumenti da guerra antichi e similmente diverse sorti d'armi, et in una sala molte altre storie tenute quasi delle migliori cose che facesse; bene è vero, che fu aiutato in questa opera da Cesare da Milano.
Ritornato Baldassarre dopo questi lavori in Roma, fece amicizia strettissima con Agostino Ghigi sanese, sì perché Agostino naturalmente amava tutti i virtuosi e sì perché Baldassarre si faceva sanese, onde poté con l'aiuto di tanto uomo trattenersi e studiare le cose di Roma, massimamente d'architettura, nelle quali, per la concorrenza di Bramante, fece in poco tempo maraviglioso frutto, il che gli fu poi, come si dirà, di onore e d'utile grandissimo. Attese anco alla prospettiva e si fece in quella scienzia tale che in essa pochi pari a lui abbiam veduti a' tempi nostri operare; il che si vede manifestamente in tutte l'opere sue. Avendo intanto papa Giulio Secondo fatto un corridore in palazzo e vicino al tetto un'ucelliera, vi dipinse Baldassarre tutti i mesi di chiaro scuro e gl'essercizii che si fanno per ciascun d'essi in tutto l'anno; nella quale opera si veggiono infiniti casamenti, teatri, anfiteatri, palazzi et altre fabbriche con bella invenzione in quel luogo accomodate; lavorò poi nel palazzo di San Giorgio, per il cardinale Raffaello Riario vescovo d'Ostia, in compagnia d'altri pittori, alcune stanze, e fece una facciata dirimpetto a Messer Ulisse da Fano e similmente quella di esso Messer Ulisse, nella quale le storie che egli vi fece d'Ulisse gli diedero nome e fama grandissima. Ma molto più gliene diede il modello, del palazzo d'Agostino Ghigi, condotto con quella bella grazia che si vede, non murato, ma veramente nato, e l'adornò fuori di terretta con istorie di sua mano molto belle. La sala similmente è fatta in partimenti di colonne, figurate in prospettiva, le quali con istrafori mostrano quella essere maggiore. E, quello che è di stupenda maraviglia, vi si vede una loggia in sul giardino dipinta da Baldassarre, con le storie di Medusa, quando ella converte gl'uomini in sasso, che non può immaginarsi più bella; et appresso quando Perseo le taglia la testa, con molte altre storie ne' peducci di quella volta; e l'ornamento tirato in prospettiva di stucchi e colori contrafatti è tanto naturale e vivo, che anco agl'artefici eccellenti pare di rilievo. E mi ricorda che, menando io il cavaliere Tiziano, pittore eccellentissimo et onorato, a vedere quella opera, egli per niun modo voleva credere che quella fusse pittura: per che, mutato veduta, ne rimase maravigliato. Sono in questo luogo alcune cose fatte da fra' Sebastian Viniziano della prima maniera, e di mano del divino Raffaello vi è (come si è detto) una Galatea rapita dagli dii marini. Fece anco Baldassarre, passato Campo di Fiore, per andare a piazza Giudea, una facciata bellissima di terretta con prospettive mirabili, la quale fu fatta finire da un cubiculario del papa et oggi è posseduta da Iacopo Strozzi fiorentino. Similmente fece nella Pace una capella a Mes-ser Ferrando Ponzetti, che fu poi cardinale, all'entrata della chiesa a man manca, con istorie piccole del Testamento Vecchio e con alcune figure anco assai grandi, la quale opera, per cosa in fresco, è lavorata con molta diligenza. Ma molto più mostrò quanto valesse nella pittura e nella prospettiva nel medesimo tempio vicino all'altar maggiore, dove fece, per Messer Filippo da Siena cherico di camera, in una storia quando la Nostra Donna salendo i gradi va al Tempio, con molte figure degne di lode, come un gentiluomo vestito all'antica, il quale, scavalcato d'un suo cavallo, porge, mentre i servidori l'aspettano, la limosina a un povero ignudo e meschinissimo, il quale si vede che con grande affetto gliela chiede. Sono anco in questo luogo casamenti varii et ornamenti bellissimi; et in questa opera, similmente lavorata in fresco, sono contrafatti ornamenti di stucco intorno intorno, che mostrano essere con campanelle grandi appiccati al muro, come fusse una tavola dipinta a olio. E ne l'onoratissimo apparato, che fece il popolo romano in Campidoglio, quando fu dato il bastone di Santa Chiesa al duca Giuliano de' Medici, di sei storie di pittura che furono fatte da sei diversi eccellenti pittori, quella che fu di mano di Baldassarri, alta sette canne e larga tre e mezzo, nella quale era quando Giulia Tarpea fa tradimento ai Romani, fu senza alcun dubbio di tutte l'altre giudicata la migliore.
Ma quello che fece stupire ognuno fu la prospettiva, o vero scena d'una comedia, tanto bella che non è possibile immaginarsi più: perciò che la varietà e bella maniera de' casamenti, le diverse loggie, la bizzarria delle porte e finestre e l'altre cose che vi si videro d'architettura, furono tanto belle intese e di così straordinaria invenzione, che non si può dirne la millesima parte. A Messer Francesco da Norcia fece, per la sua casa in sulla piazza de' Farnesi, una porta d'or-dine dorico molto graziosa; et a Messer Francesco Buzio, vicino alla piazza degl'Altieri, una molto bella facciata, e nel fregio di quella mise tutti i cardinali romani che allora vivevano, ritratti di naturale, e nella facciata figurò le storie di Cesare, quando gli sono presentati i tributi da tutto il mondo, e sopra vi dipinse i dodici imperatori, i quali posano sopra certe mensole e scortano le vedute al disotto in su e sono con grandissima arte lavorati, per la quale tutta opera meritò commendazzione infinita. Lavorò in Banchi un'arme di papa Leone, con tre fanciulli a fresco che di tenerissima carne e vivi parevano; et a fra' Mariano Fetti, frate del Piombo, fece a Monte Cavallo, nel giardino, un San Bernardo di terretta, bellissimo. Et alla Compagnia di Santa Caterina da Siena in strada Giulia, oltre una bara da portar morti alla sepoltura, che è mirabile, molte altre cose tutte lodevoli; similmente in Siena diede il disegno dell'organo del Carmino e fece altre cose in quella città, ma di non molta importanza. Dopo, essendo condotto a Bologna dagl'Operai di San Petronio perché facesse il modello della facciata di quel tempio, ne fece due piante grandi e due proffili, uno alla moderna et un altro alla tedesca, che ancora si serba come cosa veramente rara, per avere egli in prospettiva di maniera squartata e tirata quella fabrica che pare di rilievo, nella sagrestia di detto San Petronio. Nella medesima città, in casa del conte Giovambatista Bentivogli, fece per la detta fabrica più disegni, che furono tanto belli che non si possono a bastanza lodare le belle investigazioni da quest'uomo trovate per non rovinare il vecchio, che era murato, e con bella proporzione congiugnerlo col nuovo. Fece al conte Giovambatista sopra detto un disegno d'una Natività, con i Magi di chiaro scuro, nella quale è cosa maravigliosa vedere i cavalli, i carriaggi, le corti dei tre Re, condotti con bellissima grazia, sì come anco sono le muraglie de' tempii et alcuni casamenti intorno alla capanna; la quale opera fece poi colorire il conte da Girolamo Trevigi, che la condusse a buona perfezzione. Fece ancora il disegno della porta della chiesa di San Michele in Bosco, bellissimo monasterio de' monaci di Monte Oliveto, fuor di Bologna; et il disegno e modello del Duomo di Carpi, che fu molto bello e secondo le regole di Vitruvio con suo ordine fabbricato. E nel medesimo luogo diede principio alla chiesa di San Niccola, la quale non venne a fine in quel tempo perché Baldassarri fu quasi forzato tornare a Siena a fare i disegni per le fortificazioni delle città, che poi furono secondo l'ordine suo messe in opera.
Di poi, tornato a Roma e fatta la casa che è dirimpetto a' Farnese et alcun'altre che sono dentro a quella città, fu da papa Leone X in molte cose adoperato; il quale Pontefice, volendo finire la fabbrica di San Piero cominciata da Giulio Secondo col disegno di Bramante, e parendogli che fusse troppo grande edifizio e da reggersi poco insieme, fece Baldassarre un nuovo modello magnifico e veramente ingegnoso, e con tanto buon giudizio, che d'alcune parti di quello si sono poi serviti gl'altri architetti. E di vero questo artefice fu tanto diligente e di sì raro e bel giudizio che le cose sue furono sempre in modo ordinate che non ha mai avuto pari nelle cose d'architettura, per avere egli, oltre l'altre cose, quella professione con bella e buona maniera di pittura accompagnato. Fece il disegno della sepoltura di Adriano Sesto e quello che vi è dipinto intorno è di sua mano, e Michelagnolo, scultore sanese, condusse la detta sepoltura di marmo, con l'aiuto di esso Baldassarre; e quando si recitò al detto papa Leone la Calandra, comedia del cardinale di Bibbiena, fece Baldassarre l'apparato e la prospettiva che non fu manco bella, anzi più assai che quella che aveva altra volta fatto, come si è detto di sopra; et in queste sì fatte opere meritò tanto più lode, quanto per un gran pezzo adietro l'uso delle comedie e conseguentemente delle scene e prospettive era stato dismesso, facendosi in quella vece feste e rappresentazioni. Et o prima o poi che si recitasse la detta Calandra, la quale fu delle prime comedie volgari che si vedesse o recitasse, basta che Baldassarre fece al tempo di Leone X due scene che furono maravigliose et apersono la via a coloro che ne hanno poi fatto a' tempi nostri. Né si può immaginare come egli in tanta strettezza di sito accomodasse tante strade, tanti palazzi e tante bizzarrie di tempii, di loggie e d'andare di cornici, così ben fatte che parevano non finte, ma verissime, e la piazza non una cosa dipinta e picciola, ma vera e grandissima. Ordinò egli similmente le lumiere, i lumi di dentro che servono alla prospettiva e tutte l'altre cose che facevano di bisogno con molto giudizio, essendosi, come ho detto, quasi perduto del tutto l'uso delle comedie, la quale maniera di spettacolo avanza, per mio creder, quando ha tutte le sue appartenenze, qualunche altro quanto si voglia magnifico e sontuoso. Nella creazione poi di papa Clemente Settimo l'anno 1524, fece l'apparato della coronazione e finì in San Piero la facciata della capella maggiore di preperigni, già stata cominciata da Bramante. E nella capella, dove è la sepoltura di bronzo di papa Sisto, fece di pittura quegli Apostoli che sono di chiaro scuro nelle nicchie dietro l'altare, et il disegno del tabernacolo del Sagramento, che è molto grazioso. Venuto poi l'anno 1527, nel crudelissimo sacco di Roma, il povero Baldassarre fu fatto prigione degli Spagnuoli, e non solamente perdé ogni suo avere, ma fu anco molto straziato e tormentato: per che, avendo egli l'aspetto grave, nobile e grazioso, lo credevano qualche gran prelato travestito, o altro uomo atto a pagare una grossissima taglia. Ma finalmente, avendo trovato quegli impiissimi barbari che egli era un dipintore, gli fece un di loro, stato affezionatissimo di Borbone fare il ritratto di quel sceleratissimo capitano nimico di Dio e degli uomini, o che gliele facesse vedere così morto o in altro modo che glielo mostrasse con disegni o con parole. Dopo ciò, essendo uscito Baldassarre delle mani loro, imbarcò per andarsene a Porto Ercole e di lì a Siena, ma fu per la strada di maniera sua ligato e spogliato d'ogni cosa, che se n'andò a Siena in camicia. Nondimeno, essendo onoratamente ricevuto e rivestito dagl'amici, gli fu poco appresso ordinato provisione e salario dal publico, acciò attendesse alla fortificazione di quella città, nella quale dimorando ebbe due figliuoli, et oltre quello che fece per il publico, fece molti disegni di case ai suoi cittadini, e nella chiesa del Carmino il disegno dell'ornamento dell'organo, che è molto bello. Intanto venuto l'essercito imperiale e del papa all'assedio di Firenze, Sua Santità mandò Baldassarre in campo a Baccio Valori comissario, acciò si servisse del-l'ingegno di lui ne' bisogni del campo e nell'espugnazione della città. Ma Baldassarre, amando più la libertà dell'antica patria che la grazia del Papa, senza temer punto l'indignazione di tanto Pontefice, non si volle mai adoperare in cosa alcuna di momento, di che accortosi il Papa, gli portò per un pezzo non piccolo odio. Ma finita la guerra, desiderando Baldassarre di ritornare a Roma, i cardinali Salviati, Triulzi e Cesarino, i quali tutti aveva in molte cose amorevolmente serviti, lo ritornarono in grazia del Papa e ne' primi maneggi, onde poté liberamente ritornarsene a Roma, dove, dopo non molti giorni, fece per i signori Orsini il disegno di due bellissimi palazzi che furono fabbricati in verso Viterbo, e d'alcuni altri edifizii per la Paglia. Ma non intermettendo in questo mentre gli studii d'astrologia, né quelli della matematica e gl'altri, di che molto si dilettava, cominciò un libro dell'antichità di Roma et a comentare Vitruvio facendo i disegni di mano in mano delle figure, sopra gli scritti di quell'autore, di che ancor oggi se ne vede una parte appresso Francesco da Siena, che fu suo discepolo; dove in alcune carte sono i disegni dell'antichità e del modo di fabricare alla moderna. Fece anco, stando in Roma, il disegno della casa de' Massimi girato in forma ovale, con bello e nuovo modo di fabbrica; e nella facciata dinanzi fece un vestibulo di colonne doriche molto artifizioso e proporzionato, et un bello spartimento nel cortile e nell'acconcio delle scale, ma non poté vedere finita quest'opera, sopragiunto dalla morte.
Ma ancor che tante fussero le virtù e le fatiche di questo nobile artefice, elle giovarono poco nondimeno a lui stesso et assai ad altri, perché, se bene fu adoperato da papi, cardinali et altri personaggi grandi e ricchissimi, non però alcuno d'essi gli fece mai rilevato benefizio; e ciò poté agevolmente avvenire non tanto dalla poca liberalità de' signori, che per lo più meno sono liberali dove più doverebbono, quanto dalla timidità e troppa modestia, anzi, per dir meglio in questo caso, dappocaggine di Baldassarri. E per dire il vero quanto si deve esser discreto con i principi magnanimi e liberali, tanto bisogna essere con gl'avari, ingrati e discortesi, importuno sempre e fastidioso, perciò che, sì come con i buoni l'importunità et il chieder sempre sarebbe vizio, così con gl'avari ell'è virtù, e vizio sarebbe con i sì fatti essere discreto. Si trovò dunque negl'ultimi anni della vita sua Baldassarre vecchio, povero e carico di famiglia. E finalmente, essendo vivuto sempre costumatissimo, amalato gravemente, si mise in letto. Il che intendendo papa Paulo Terzo, e tardi conoscendo il danno che riceveva nella perdita di tanto uomo, gli mandò a donare per Iacomo Melighi, computista di San Piero, cento scudi, et a fargli amorevolissime offerte. Ma egli aggravato nel male, o pure che così avesse a essere (come si crede) sollecitatagli la morte con veleno da qualche suo emulo che il suo luogo disiderava, del quale traeva scudi 250 di provisione, il che fu tardi dai medici conosciuto, si morì malissimo contento, più per cagione della sua povera famiglia che di se medesimo, vedendo in che mal termine egli la lasciava. Fu dai figliuoli e dagl'amici molto pianto e nella Ritonda appresso a Raffaello da Urbino, dove fu da tutti i pittori, scultori et architettori di Roma onorevolmente pianto et accompagnato, datogli onorata sepoltura con questo epitaffio:
Balthasari Perutio senensi, viro et pictura et architectura,
aliisque ingeniorum artibus adeo
excellenti, ut si priscorum occubuisset temporibus,
nostra illum felicius legerent.
Vixit annos LV. Menses XI. Dies XX.
Lucretia et Io. Salustius optimo coniugi et parenti,
non sine lachrimis
Simonis, Honorii, Claudii AEmiliae ac Sulpitiae
minorum filiorum, dolentes posuerunt.
Die IIII Ianuarii M.D.XXXVI.
Fu maggiore la fama et il nome di Baldassarre essendo morto che non era stato in vita; et allora massimamente fu la sua virtù desiderata che papa Paulo Terzo si risolvé di far finire San Piero, perché l'avidero allora di quanto aiuto egli sarebbe stato ad Antonio da San Gallo; perché, se bene Antonio fece quello che si vede, avrebbe nondimeno (come si crede) meglio veduto in compagnia di Baldassarre alcune difficultà di quell'opera. Rimase erede di molte cose di Baldassarre Sebastiano Serlio bolognese, il quale fece il terzo libro dell'architetture et il quarto dell'antichità di Roma misurate, et in questi le già dette fatiche di Baldassarre furono parte messe in margine e parte furono di molto aiuto all'au-tore. I quali scritti di Baldassarre rimasero per la maggior parte in mano a Iacopo Melighino ferrarese, che fu poi fatto architetto da papa Paulo detto nelle sue fabbriche; et al detto Francese Sanese, stato suo creato e discepolo, di mano del quale Francesco è in Roma l'arme del cardinale di Trani in Navona molto lodata et alcune altre opere. E da costui avemo avuto il ritratto di Baldassarre e notizia di molte cose che non potei sapere quando uscì la prima volta fuori questo libro. Fu anco discepolo di Baldassarre Virgilio Romano, che nella sua patria fece a mezzo Borgo Nuovo una facciata di granito con alcuni prigioni e molte altre opere belle. Ebbe anco dal medesimo i primi principii d'architettura Antonio del Rozzo, cittadino sanese, et ingegneri eccellentissimo. E seguitollo parimente il Riccio, pittore sanese, se bene ha poi imitato assai la maniera di Giovan Antonio Soddoma da Vercelli. Fu anco suo creato Giovambatista Peloro, architetto sanese, il quale attese molto alle matematiche ed alla cosmografia e fece di sua mano bussole, quadranti e molti ferri e stromenti da misurare, e similmente le piante di molte fortificazioni, che sono per la maggior parte appresso maestro Giuliano orefice sanese, amicissimo suo. Fece questo Giovambatista al Duca Cosimo de' Medici tutto di rilievo e bello affatto il sito di Siena, con le valli e ciò che ha intorno a un miglio e mezzo, le mura, le strade, i forti et insomma del tutto un bellissimo modello. Ma perché era costui instabile, si partì, ancor che avesse buona provisione da quel principe, e, pensando di far meglio, si condusse in Francia dove, avendo seguitato la corte senza alcun frutto molto tempo, si morì finalmente in Avignone. Ma ancor che costui fusse molto pratico et intendente architetto, non si vede però in alcun luogo fabbriche fatte da lui o con suo ordine, stando egli sempre tanto poco in un luogo, che non si poteva risolvere niente; onde consumò tutto il tempo in disegni, capricci, misure e modelli. Ha meritato nondimeno, come professor del-le nostre arti, che di lui si faccia memoria.
Disegnò Baldassare eccellentemente in tutt'i modi e con gran giudizio e diligenza, ma più di penna, d'acquerello e chiaro scuro che d'altro, come si vede in molti disegni suoi, che sono appresso gl'artefici e particolarmente nel nostro libro in diverse carte: in una delle quali è una storia finta per capriccio, cioè una piazza piena d'archi, colossi, teatri, obelisci, piramidi, tempii di diverse maniere, portici et altre cose tutte fatte all'antica, e sopra una base è Mercurio al qua-le correndo intorno tutte le sorti d'archimisti con soffietti, mantici, bocce et altri instrumenti da stillare, gli fanno un serviziale per farlo andar del corpo, con non meno ridicola che bella invenzione e capriccio.
Furono amici e molto domestici di Baldassarre, il quale fu con ognuno sempre cortese, modesto e gentile, Domenico Beccafumi sanese, pittore eccellente, et il Capanna, il quale, oltre molte cose che dipinse in Siena, fece la facciata de' Turchi et un'altra che v'è sopra la piazza.
VITA DI GIOVAN FRANCESCO DETTO IL FATTORE FIORENTINO E DI PELLEGRINO DA MODANA PITTORI

Giovanfrancesco Penni, detto il Fattore, pittor fiorentino, non fu manco obligato alla fortuna che egli si fusse alla bontà della sua natura, poiché i costumi, l'inclinazione alla pittura e l'altre sue virtù, furono cagione che Raffaello da Urbino se lo prese in casa et insieme con Giulio Romano se l'allevò e tenne poi sempre l'uno e l'altro come figliuoli, dimostrando alla sua morte quanto conto tenesse d'amendue, nel lasciargli eredi delle virtù sue e delle facultadi insieme. Giovanfrancesco dunque, il quale cominciando da putto, quando prima andò in casa di Raffaello, a esser chiamato il Fattore, si ritenne sempre quel nome, immitò ne' suoi disegni la maniera di Raffaello e quella osservò del continuo, come ne possono far fede alcuni suoi disegni che sono nel nostro libro. E non è gran fatto che molti se ne veggiano e tutti con diligenza finiti, perché si dilettò molto più di disegnare che di colorire. Furono le prime cose di Giovan Francesco da lui lavorate nelle logge del papa a Roma in compagnia di Giovanni da Udine, di Perino del Vaga e d'altri eccellenti maestri. Nelle quali opere si vede una bonissima grazia e di maestro che attendesse alla perfezzione delle cose; fu universale e dilettossi molto di far paesi e casamenti; colorì bene a olio, a fresco et a tempera e ritrasse di naturale eccellentemente e fu in ogni cosa molto aiutato dalla natura, intanto che senza molto studio intendeva bene tutte le cose dell'arte, onde fu di grande aiuto a Raffaello a dipignere gran parte de' cartoni dei panni d'arazzo della cappella del papa e del Concistoro, e particolarmente le fregiature. Lavorò anco molte altre cose con i cartoni et ordine di Raffaello, come la volta d'Agostino Chigi in Trastevere e molti quadri, tavole et altre opere diverse. Nelle quali si portò tanto bene, che meritò più l'un giorno che l'altro da Raffaello essere amato.
Fece in Monte Giordano in Roma una facciata di chiaro scuro et in Santa Maria di Anima, alla porta del fianco che va alla Pace, in fresco un San Cristofano d'otto braccia, che è bonissima figura; et in quest'opera è un romito in una grotta con una lanterna in mano, con buon disegno e grazia unitamente condotto. Venuto poi Giovan Francesco a Firenze, fece a Lodovico Capponi a Montughi, luogo fuor della porta a San Gallo, un tabernacolo con una Nostra Donna molto lodata. Intanto, venuto a morte Raffaello, Giulio Romano e Giovan Francesco, stati suoi discepoli, stettono molto tempo insieme e finirono di compagnia l'opere che di Raffaello erano rimase imperfette, e particolarmente quelle che egli aveva cominciato nella vigna del papa e similmente quelle della sala grande di palazzo; dove sono di mano di questi due dipinti le storie di Gostantino con bonissime figure e condotte con bella pratica e maniera, ancor che le invenzioni e gli schizzi delle storie venissero in parte da Raffaello. Mentre che questi lavori si facevano, Perino del Vaga, pittore molto eccellente, tolse per moglie una sorella di Giovan Francesco, onde fecero molti lavori insieme, e seguitando poi Giulio e Giovan Francesco fecero in compagnia una tavola di due pezzi, drentovi l'assunzione di Nostra Donna che andò a Perugia a Monteluci, e così altri lavori e quadri per diversi luoghi. Avendo poi commessione da Papa Clemente di fare una tavola simile a quella di Raffaello che è a San Piero a Montorio, la quale si aveva a mandare in Francia, dove quella era prima stata da Raffaello destinata, la cominciarono et appresso venuti a divisione e partita la roba, i disegni et ogni altra cosa lasciata loro a Raffaello, Giulio se n'andò a Mantova, dove al Marchese lavorò infinite cose; là dove, non molto dopo, capitando ancor Giovan Francesco, o tiratovi dall'amicizia di Giulio o da speranza di dovervi lavorare, fu sì poco da Giulio accarezzato, che se ne partì tostamente e, girata la Lombardia, se ne tornò a Roma; e da Roma in sulle galee se n'andò a Napoli dietro al Marchese del Vasto, portando seco la tavola finita, che era imposta, di San Piero a Montorio et altre cose, le quali fece posare in Ischia, isola del Marchese. Ma la tavola fu posta poi, dove è oggi, in Napoli nella chiesa di Santo Spirito degl'Incurabili. Fermatosi dunque Giovan Francesco in Napoli et attendendo a disegnare e dipignere, si tratteneva, essendo da lui molto carezzato, con Tommaso Cambi, mercante fiorentino che governava le cose di quel signore. Ma non vi dimorò lungamente perché, essendo di mala complessione, ammalatosi vi si morì con incredibile dispiacere di quel signor Marchese e di chiunche lo conosceva.
Ebbe costui un fratello, similmente dipintore, chiamato Luca, il quale lavorò in Genoa con Perino suo cognato et in Lucca et in molti altri luoghi d'Italia. E finalmente se n'andò in Inghilterra dove avendo alcune cose lavorato al re e per alcuni mercanti, si diede finalmente a far disegni per mandar fuori stampe di rame che si conoscono, oltre alla maniera, al nome suo: e fra l'altre è sua opera una carta, dove alcune femmine sono in un bagno, l'originale della quale di propria mano di Luca è nel nostro libro. Fu discepolo di Giovan Francesco Lionardo, detto il Pistoia per esser pistolese, il quale lavorò alcune cose in Lucca et in Roma fece molti ritratti di naturale; et in Napoli per il vescovo d'Ariano Diomede Caraffa, oggi cardinale, fece in San Domenico una tavola della lapidazione di Santo Stefano in una sua cappella. Et in Monte Oliveto ne fece un'altra, che fu posta all'altar maggiore, e levatane poi per dar luogo a un'altra di simile invenzione di mano di Giorgio Vasari aretino. Guadagnò Lionardo molti danari con que' signori napoletani, ma ne fece poco capitale, perché se gli giocava di mano in mano. E finalmente si morì in Napoli, lasciando nome di essere stato buono coloritore, ma non già d'avere avuto molto buon disegno. Visse Giovan Francesco anni 40, e l'opere sue furono circa al 1528.
Fu amico di Giovan Francesco e discepolo anch'egli di Raffaello, Pellegrino da Modana, il quale avendosi nella pittura acquistato nome di bello ingegno nella patria, deliberò, udite le maraviglie di Raffaello da Urbino, per corrispondere mediante l'affaticarsi alla speranza già conceputa di lui, andarsene a Roma; là dove, giunto, si pose con Raffaello, che niuna cosa negò mai agl'uomini virtuosi. Erano allora in Roma infiniti giovani che attendevano alla pittura et emulando fra loro cercavano l'uno l'altro avanzare nel disegno, per venire in grazia di Raffaello e guadagnarsi nome fra i popoli, per che attendendo continuamente Pellegrino agli studi, divenne, oltre al disegno, di pratica maestrevole nell'ar-te. E quando Leone Decimo fece dipignere le logge a Raffaello, vi lavorò anch'egli in compagnia degl'altri giovani e riuscì tanto bene che Raffaello si servì poi di lui in molte altre cose. Fece Pellegrino in Santo Eustachio di Roma, entrando in chiesa, tre figure in fresco a uno altare, e nella chiesa de' Portughesi alla Scrofa la cappella dell'altare maggiore in fresco, insieme con la tavola. Dopo, avendo in San Iacopo della nazione spagnuola fatta fare il cardinale Alborense una cappella adorna di molti marmi, e da Iacopo Sansovino un San Iacopo di marmo alto quattro braccia e mezzo e molto lodato, Pellegrino vi dipinse in fresco le storie della vita di quello Apostolo, facendo alle figure gentilissima aria a immitazione di Raffaello suo maestro et avendo tanto bene accommodato tutto il componimento, che quell'opera fece conoscere Pellegrino per uomo desto e di bello e buono ingegno nella pittura. Finito questo lavoro, ne fece molti altri in Roma e da per sé et in compagnia. Ma venuto finalmente a morte Raffaello, egli se ne tornò a Modana, dove fece molte opere, et in fra l'altre per una Confraternita di Battuti fece in una tavola a olio San Giovanni che battezza Cristo, e nella chiesa de' Servi in un'altra tavola San Cosmo e Damiano con altre figure. Dopo, avendo preso moglie, ebbe un figliuolo che fu cagione delle sua morte; perché venuto a parole con alcuni suoi compagni, giovani modanesi, n'amazzò uno. Di che portata la nuova a Pellegrino, egli, per soccorrere al figliuolo, acciò non andasse in mano della giustizia, si mise in via per trafugarlo. Ma non essendo ancora molto lontano da casa, lo scontrarono i parenti del giovane morto, i quali andavano cercando l'omicida; costoro dunque, affrontando Pellegrino, che non ebbe tempo a fuggire, tutti infuriati poiché non avevano potuto giugnere il figliuolo, gli diedero tante ferite, che lo lasciarono in terra morto. Dolse molto ai Modanesi questo caso, conoscendo essi che per la morte di Pellegrino restavano privi di uno spirito veramente peregrino e raro. Fu coetaneo di costui Gaudenzio Milanese, pittore eccellente, pratico et espedito, il quale in fresco fece in Milano molte opere, e particularmente ai frati della Passione un Cenacolo bellissimo, che per la morte sua rimase imperfetto. Lavorò anco a olio eccellentemente, e di sua mano sono assai opere a Vercelli et a Veralla molto stimate.
VITA D'ANDREA DEL SARTO ECCELLENTISSIMO PITTORE FIORENTINO

Eccoci dopo le vite di molti artefici stati eccellenti chi per colorito, chi per disegno e chi per invenzione, pervenuti all'eccellentissimo Andrea del Sarto: nel quale uno mostrarono la natura e l'arte tutto quello che può far la pittura, mediante il disegno, il colorire e l'invenzione; in tanto che, se fusse stato Andrea d'animo alquanto più fiero et ardito, sì come era d'ingegno e giudizio profondissimo in questa arte, sarebbe stato senza dubitazione alcuna senza pari. Ma una certa timidità d'animo, et una sua certa natura dimessa e semplice, non lasciò mai vedere in lui un certo vivace ardore, né quella fierezza, che aggiunta all'altre sue parti l'arebbe fatto essere nella pittura veramente divino; perciò che egli mancò per questa cagione di quegli ornamenti, grandezza e copiosità di maniere, che in molti altri pittori si sono vedute. Sono non di meno le sue figure, se bene semplici e pure, bene intese, senza errori et in tutti i conti di somma perfezzione; l'arie delle teste, così di putti come di femmine, sono naturali e graziose, e quelle de' giovani e de' vecchi con vivacità e prontezza mirabile; i panni begli a maraviglia e gl'ignudi molto bene intesi. E se bene disegnò semplicemente, sono non di meno i coloriti suoi rari e veramente divini.
Nacque Andrea l'anno 1478 in Fiorenza di padre che esercitò sempre l'arte del sarto, onde egli fu sempre così chiamato da ognuno. E pervenuto all'età di sette anni, levato dalla scuola di leggere e scrivere, fu messo all'arte dell'orefice. Nella quale molto più volentieri si esercitò sempre (a ciò spinto da naturale inclinazzione) in disegnare che in maneggiando ferri per lavorare d'argento o d'oro; onde avvenne che Gian Barile, pittore fiorentino, ma grosso e plebeo, veduto il buon modo di disegnare del fanciullo, se lo tirò appresso e, fattogli abbandonare l'orefice, lo condusse all'arte della pittura. Nella quale cominciandosi ad esercitare Andrea con suo molto piacere, conobbe che la natura per quello esercizio l'aveva creato; onde cominciò in assai picciolo spazio di tempo a far cose con i colori, che Gian Barile e gl'altri artefici della città ne restavano maravigliati.
Ma avendo dopo tre anni fatto bonissima pratica nel lavorare e studiando continuamente, s'avvide Gian Barile che, attendendo il fanciullo a quello studio, egli era per fare una straordinaria riuscita, perché, parlatone con Piero di Cosimo, tenuto allora dei migliori pittori che fussero in Fiorenza, acconciò seco Andrea il quale, come desideroso d'impara-re, non restava mai di affaticarsi, né di studiare. E la natura, che l'aveva fatto nascere pittore, operava tanto in lui che nel maneggiare i colori lo faceva con tanta grazia, come se avesse lavorato cinquanta anni; onde Piero gli pose grandissimo amore e sentiva incredibile piacere nell'udire che quando aveva punto di tempo, e massimamente i giorni di festa, egli spendeva tutto il dì insieme con altri giovani disegnando alla sala del papa, dove era il cartone di Michelagnolo e quello di Lionardo da Vinci; e che superava, ancor che giovanetto, tutti gl'altri disegnatori che, terrazzani e forestieri, quasi senza fine vi concorrevano. In fra i quali piacque più che quella di tutti gl'altri ad Andrea la natura e conversazione del Francia Bigio pittore, e parimente al Francia quella d'Andrea; onde, fatti amici, Andrea disse al Francia che non poteva più sopportare la stranezza di Piero già vecchio e che voleva perciò torre una stanza da sé, la quale cosa udendo il Francia, che era forzato a fare il medesimo, perché Mariotto Albertinelli suo maestro aveva abbandonata l'arte della pittura, disse al suo compagno Andrea che anch'egli aveva bisogno di stanza e che sarebbe con comodo dell'uno e del-l'altro ridursi insieme. Avendo essi addunque tolta una stanza alla piazza del Grano, condussero molte opere di compagnia, una delle quali furono le cortine che cuoprono l'altar maggior delle tavole de' Servi, le quali furono allogate loro da un sagrestano, strettissimo parente del Francia. Nelle quali tele dipinsero, in quella che è volta verso il coro, una Nostra Donna Annunziata, e nell'altra, che è dinanzi, un Cristo diposto di croce, simile a quello che è nella tavola che quivi era di mano di Filippo e di Pietro Perugino.
Solevano ragunarsi in Fiorenza in capo della via Larga, sopra le case del Magnifico Ottaviano de' Medici, dirimpetto all'orto di San Marco, gli uomini della Compagnia che si dice dello Scalzo, intitolata in San Giovanni Battista; la quale era stata murata in que' giorni da molti artefici fiorentini, i quali fra l'altre cose vi avevano fatto di muraglia un cortile di prima giunta che posava sopra alcune colonne non molto grandi; onde, vedendo alcuni di loro che Andrea veniva in grado d'ottimo pittore, deliberarono, essendo più ricchi d'animo che di danari, che egli facesse intorno a detto chiostro in dodici quadri di chiaro scuro, cioè di terretta in fresco, dodici storie della vita di San Giovanbatista; per lo che egli, messovi mano, fece nella prima quando San Giovanni battezza Cristo, con molta diligenza e tanto buona maniera, che gl'acquistò credito, onore e fama per sì fatta maniera, che molte persone si voltarono a fargli fare opere, come a quello che stimavano dover col tempo a quello onorato fine che prometteva il principio del suo operare straordinario pervenire. E fra l'altre cose che egli allora fece di quella prima maniera, fece un quadro che oggi è in casa di Filippo Spini, tenuto per memoria di tanto artefice in molta venerazione. Né molto dopo in San Gallo, chiesa de' frati Eremitani osservanti dell'Ordine di Santo Agostino, fuor della porta a San Gallo, gli fu fatto fare per una capella una tavola d'un Cristo, quando in forma d'ortolano apparisce nell'orto a Maria Maddalena; la quale opera, per colorito e per una certa morbidezza et unione, è dolce per tutto e così ben condotta, che ella fu cagione che non molto poi ne fece due altre nella medesima chiesa, come si dirà di sotto. Questa tavola è oggi al Canto agl'Alberti in San Jacopo tra' Fossi, e similmente l'altre due. Dopo queste opere, partendosi Andrea et il Francia dalla piazza del Grano, presono nuove stanze vicino al convento della Nunziata, nella Sapienza; onde avvenne che Andrea et Iacopo Sansovino allora giovane, il quale nel medesimo luogo lavorava di scultura sotto Andrea Contucci suo maestro, feciono sì grande e stretta amicizia insieme che né giorno né notte si staccava l'uno dall'altro, e per lo più i loro ragionamenti erano delle difficultà dell'arte; onde non è maraviglia se l'uno e l'altro sono poi stati eccellentissimi, come si dice ora d'Andrea e come a suo luogo si dirà di Iacopo.
Stando in quel tempo medesimo nel detto convento de' Servi et al banco delle candele un frate sagrestano, chiamato fra' Mariano dal canto alle macine, egli sentiva molto lodare a ognuno Andrea e dire che egli andava facendo maraviglioso acquisto nella pittura, perché pensò di cavarsi una voglia con non molta spesa. E così, tentando Andrea (che dolce e buono uomo era) nelle cose dell'onore, cominciò a mostrargli sotto spezie di carità di volerlo aiutare in cosa che egli recarebbe onore et utile e lo farebbe conoscere per sì fatta maniera, che non sarebbe mai più povero. Aveva già molti anni innanzi, nel primo cortile de' Servi, fatto Alesso Baldovinetti nella facciata, che fa spalle alla Nunziata, una Natività di Cristo, come si è detto di sopra; e Cosimo Rosselli dall'altra parte aveva cominciato nel medesimo cortile una storia, dove San Filippo autore di quell'Ordine de' Servi piglia l'abito, la quale storia non aveva Cosimo condotta a fine per essere, mentre appunto la lavorava, venuto a morte. Il frate dunque, avendo volontà grande di seguitare il resto, pensò di fare con suo utile che Andrea et il Francia, i quali erano d'amici venuti concorrenti nell'arte, gareggiassino insieme e ne facessino ciascun di loro una parte; il che, oltre all'essere servito benissimo, averebbe fatto la spesa minore et a loro le fatiche più grandi. Laonde, aperto l'animo suo ad Andrea, lo persuase a pigliare quel carico, mostrandogli che per essere quel luogo publico e molto frequentato, egli sarebbe, mediante cotale opera, conosciuto non meno dai forestieri che dai fiorentini e che egli per ciò che doveva pensare a prezzo nessuno, anzi neanco di esserne pregato, ma più tosto di pregare altrui e che, quando egli a ciò che non volesse attendere, aveva il Francia, che, per farsi conoscere, aveva offerto di farle e del prezzo rimettersi in lui. Furono questi stimoli molto gagliardi a far che Andrea si risolvesse a pigliare quel carico, essendo egli massimamente di poco animo. Ma questo ultimo del Francia l'indusse a risolversi affatto et ad essere d'accordo, mediante una scritta, di tutta l'opera, perché niun altro v'entrasse. Così dunque avendolo il frate imbarcato e datogli danari, volle che per la prima cosa egli seguitasse la vita di San Filippo e non avesse per prezzo da lui altro che dieci ducati per ciascuna storia, dicendo che anco quelli gli dava di suo e che ciò faceva più per bene e commodo di lui, che per utile o bisogno del convento. Seguitando dunque quell'opera con grandissima diligenza, come quello che più pensava all'onore che all'utile, finì del tutto, in non molto tempo, le prime tre storie e le scoperse: cioè in una quando San Filippo già frate riveste quell'ignudo, nell'altra quando egli sgridando alcuni giuocatori che biastemmano Dio e si ridevano di S. Filippo, facendosi beffe del suo ammonirgli, viene in un tempo una saetta dal cielo, e percosso un albero dove eglino stavano sotto all'ombra, ne uccide due e mette negl'altri incredibile spavento: alcuni con le mani alla testa si gettano sbalorditi innanzi et altri si mettono gridando in fuga tutti spaventati; et una femmina, uscita di sé per lo tuono della saetta e per la paura et in fuga tanto naturale, che pare ch'ella veramente viva; et un cavallo scioltosi a tanto rumore e spavento, fa con i salti e con un orribile movimento vedere quanto le cose improvise e che non si aspettino rechino timore e spavento; nel che tutto si conosce quanto Andrea pensasse alla varietà delle cose ne' casi che avvengono, con avvertenze certamente belle e necessarie a chi esercita la pittura. Nella terza fece quando S. Filippo cava gli spiriti da dosso a una femmina, con tutte quelle considerazioni che migliori in sì fatta azzione possono immaginarsi. Onde recarono tutte queste storie ad Andrea onore grandissimo e fama; perché inanimito seguitò di fare due altre storie nel medesimo cortile: in una faccia è San Filippo morto e i suoi frati intorno che lo piangono, et oltre ciò, un putto morto che toccando la bara dove è S. Filippo, risuscita; onde vi si vede prima morto e poi risuscitato e vivo con molto bella considerazione e naturale e propria. Nell'ultima da quella banda figurò i frati che mettono la veste di San Filippo in capo a certi fanciulli; et in questa ritrasse Andrea della Robbia scultore in un vecchio vestito di rosso, che viene chinato e con una mazza in mano. Similmente vi ritrasse Luca suo figliuolo sì come nell'altra già detta, dove è morto San Filippo, ritrasse Girolamo pur figliuolo d'Andrea, scultore e suo amicissimo, il quale è morto, non è molto, in Francia. E così, dato fine al cortile di quella banda, parendogli il prezzo poco e l'onore troppo, si risolvé licenziare il rimanente dell'opera, quantunque il frate molto se ne dolesse, ma per l'obbligo fatto non volle disobligarlo, se Andrea non gli promisse prima fare due altre storie a suo commodo piacimento e crescendogli il frate il prezzo, e così furono d'accordo.
Per queste opere venuto Andrea in maggior cognizione, gli furono allogati molti quadri et opere d'importanza, e fra l'altre dal generale de' monaci di Vallombrosa, per il monasterio di San Salvi, fuor della porta alla Croce nel refettorio, l'arco d'una volta e la facciata, per farvi un Cenacolo. Nella quale volta fece in quattro tondi quattro figure: San Benedetto, San Giovanni Gualberto, San Salvi vescovo e San Bernardo degl'Uberti di Firenze loro frate e cardinale; e nel mezzo fece un tondo dentrovi tre faccie, che sono una medesima, per la Trinità, e fu questa opera, per cosa in fresco, molto ben lavorata e per ciò tenuto Andrea quello che egli era veramente nella pittura. Laonde per ordine di Baccio d'Agnolo gli fu dato a fare in fresco allo sdrucciolo d'Or San Michele, che va in Mercato Nuovo, in un biscanto, quella Nunziata di maniera minuta, che ancor vi si vede, la quale non gli fu molto lodata e ciò poté essere perché Andrea, il quale faceva bene senza affaticarsi o sforzare la natura, volle, come si crede, in questa opera sforzarsi e farla con troppo studio. Fra i molti quadri, che poi fece per Fiorenza, de' quali tutti sarei troppo lungo a volere ragionare, dirò che fra i più segnalati si può anoverare quello che oggi è in camera di Baccio Barbadori, nel quale è una Nostra Donna intera con un Putto in collo e Santa Anna e San Giuseppo, lavorati di bella maniera e tenuti carissimi da Baccio. Uno ne fece similmente molto lodevole, che è oggi appresso Lorenzo di Domenico Borghini, et un altro a Lionardo del Giocondo d'una Nostra Donna, che al presente è posseduto da Piero suo figliuolo. A Carlo Ginori ne fece due non molto grandi, che poi furono comperi dal Magnifico Ottaviano de' Medici, de' quali oggi n'è uno nella sua bellissima villa di Campi, e l'altro ha in camera, con molte altre pitture moderne fatte da eccellentissimi maestri, il signor Bernardetto, degno figliuolo di tanto padre, il quale come onora e stima l'opere de' famosi artefici, così è in tutte l'azzioni veramente magnifico e generoso signore. Aveva in questo mentre il frate de' Servi allogato al Francia Bigio una delle storie del sopradetto cortile, ma egli non aveva anco finito di fare la turata, quando Andrea, insospettito perché gli pareva che il Francia in maneggiare i colori a fresco fusse di sé più pratico e spedito maestro, fece, quasi per gara, i cartoni delle due storie, per mettergli in opera nel canto fra la porta del fianco di San Bastiano e la porta minore, che del cortile entra nella Nunziata; e fatto i cartoni, si mise a lavorare in fresco e fece nella prima la Natività di Nostra Donna, con un componimento di figure benissimo misurate et accommodate con grazia in una camera, dove alcune donne, come amiche e parenti, essendo venute a visitarla, sono intorno alla donna di parto, vestite di quegli abiti che in quel tempo si usavano, et alcune altre manco manco nobili, standosi intorno al fuoco, lavano la puttina pur allor nata, mentre alcune altre fanno le fascie et altri così fatti servigi; e fra gl'altri vi è un fanciullo che si scalda a quel fuoco, molto vivace, et un vecchio che si riposa sopra un lettuccio, molto naturale; et alcune donne similmente che portano da mangiare alla donna che è nel letto, con modi veramente proprii e naturalissimi. E tutte queste figure insieme con alcuni putti, che stando in aria gettano fiori, sono per l'aria, per i panni e per ogn'altra cosa consideratissimi e coloriti tanto morbidamente, che paiono di carne le figure e l'altre cose più tosto naturali che dipinte. Nell'altra Andrea fece i tre Magi d'Oriente, i quali guidati dalla stella andarono ad adorare il fanciullino Gesù Cristo; e gli finse scavalcati, quasi che fussero vicini al destinato luogo, e ciò per esser solo lo spazio delle due porte per vano fra loro e la Natività di Cristo, che di mano di Alesso Baldovinetti si vede; nella quale storia Andrea fece la corte di que' tre Re venire lor dietro con i cariaggi e molti arnesi e genti che gl'accompagnano, fra i quali sono in un cantone ritratti di naturale tre persone vestite d'abito fiorentino, l'uno è Iacopo Sansovino, che guarda in verso chi vede la storia tutto intero, l'altro appoggiato a esso, che ha un braccio in iscorto et accenna è Andrea, maestro dell'opera, et un'altra testa in mezzo occhio dietro a Iacopo è l'Aiolle musico. Vi sono, oltre ciò, alcuni putti che salgono su per le mura, per stare a vedere passare le magnificenze e le stravaganti bestie, che me-nano con esso loro que' tre Re. La quale istoria è tutta simile all'altra già detta di bontà, anzi nell'una e nell'altra superò se stesso, non che il Francia, che anch'egli la sua vi finì.
In questo medesimo tempo fece una tavola, per la Badia di San Godenzo, benefizio dei medesimi frati, che fu tenuta molto ben fatta; e per i frati di San Gallo fece in una tavola la Nostra Donna annunziata dall'Angelo, nella quale si vede un'unione di colorito molto piacevole et alcune teste d'Angeli che accompagnano Gabbriello, con dolcezza sfumate e di bellezza d'arie di teste condotte perfettamente, e sotto questa fece una predella Iacopo da Puntormo, allora discepolo d'Andrea, il quale diede saggio in quell'età giovenile d'avere a far poi le bell'opere che fece in Fiorenza di sua mano; prima che egli diventasse si può dire un altro, come si dirà nella sua vita. Dopo fece Andrea un quadro di figure non molto grandi a Zanobi Girolami, nel quale era dentro una storia di Giuseppo, figliuolo di Iacob, che fu da lui finita con una diligenza molto continuata e perciò tenuta una bellissima pittura. Prese, non molto dopo, a fare agl'uomini della Compagnia di Santa Maria della Neve, dietro alle monache di Santo Ambrogio, in una tavolina tre figure: la Nostra Donna, San Giovambatista e Santo Ambruogio, la quale opera finita fu col tempo posta in sull'altare di detta Compagnia. Aveva in questo mentre preso dimestichezza Andrea, mediante la sua virtù, con Giovanni Gaddi, che fu poi cherico di camera; il quale, perché si dilettò sempre dell'arti del disegno, faceva allora lavorare del continuo Iacopo Sansovino; onde, piacendo a costui la maniera d'Andrea, gli fece fare per sé un quadro d'una Nostra Donna bellissima; il quale, per avergli Andrea fatto intorno e modegli et altre fatiche ingegnose, fu stimato la più bella opera che insino allora Andrea avesse dipinto. Fece dopo questo un altro quadro di Nostra Donna a Giovanni di Paulo merciaio, che piacque a chiunque il vide infinitamente per essere veramente bellissimo. Et ad Andrea Santini ne fece un altro, dentrovi la Nostra Donna, Cristo, San Giovanni e San Giuseppo, lavorati con tanta diligenza, che sempre furono stimati in Fiorenza pittura molto lodevole. Le quali tutte opere diedero sì gran nome ad Andrea nella sua città, che fra molti giovani e vecchi, che allora dipignevano, era stimato dei più eccellenti che adoperassino colori e pennelli; laonde si trovava non solo essere onorato, ma in istato ancora, se bene si faceva poco affatto pagare le sue fatiche, che poteva in parte aiutare e sovvenire i suoi e difenderse dai fastidii e dalle noie che hanno coloro che ci vivono poveramente.
Ma essendosi d'una giovane innamorato e poco appresso, essendo rimasta vedova, toltala per moglie, ebbe più che fare il rimanente della sua vita e molto più da travagliare che per l'adietro fatto non aveva; perciò che, oltre le fatiche e fastidii che seco portano simili impacci comunemente, egli se ne prese alcuni da vantaggio, come quello che fu ora da gelosia et ora da una cosa et ora da un'altra combattuto. Ma per tornare all'opere che fece, le quali, come furono assai, così furono rarissime, egli fece, dopo quelle di che si è favellato di sopra, a un frate di Santa Croce dell'Ordine minore, il quale era governatore allora delle monache di San Francesco in via Pentolini e si dilettava molto della pittura, in una tavola per la chiesa di dette monache, la Nostra Donna ritta e rilevata sopra una basa in otto faccie; in sulle cantonate della quale sono alcune arpie che seggono quasi adorando la Vergine, la quale con una mano tiene in collo il Figliuolo, che con attitudine bellissima la strigne con le braccia tenerissimamente, e con l'altra un libro serrato, guardando due putti ignudi i quali, mentre l'aiutano a reggere, le fanno intorno ornamento. Ha questa Madonna, da man ritta, un San Francesco molto ben fatto, nella testa del quale si conosce la bontà e semplicità che fu veramente in quel santo uomo; oltre ciò sono i piedi bellissimi, e così i panni, perché Andrea con un girar di pieghe molto ricco e con alcune ammaccature dolci sempre contornava le figure in modo che si vedeva l'ignudo; a man destra ha un San Giovanni Evangelista, finto giovane et in atto di scrivere l'Evangelio, in molto bella maniera; si vede, oltre ciò, in questa opera un fumo di nuvoli trasparenti sopra il casamento e le figure che pare che si muovino. La quale opera è tenuta oggi fra le cose d'An-drea di singolare e veramente rara bellezza. Fece anco al Nizza legnaiuolo un quadro di Nostra Donna che fu non men bello stimato che l'altre opere sue.
Deliberando poi l'Arte de' Mercatanti che si facessero alcuni carri trionfali di legname, a guisa degl'antichi Romani, perché andassero la mattina di San Giovanni a processione in cambio di certi paliotti di drappo e ceri che le città e castella portano in segno di tributo, passando dinanzi al Duca e magistrati principali, di dieci che se ne fecero allora, ne dipinse Andrea alcuni a olio e di chiaro scuro, con alcune storie che furono molto lodate. E se bene si doveva seguitare di farne ogni anno qualcuno, per insino a che ogni città e terra avesse il suo (il che sarebbe stato magnificenza e pompa grandissima) fu nondimeno dismesso il ciò fare l'anno 1527. Mentre dunque che con queste et altre opere Andrea adornava la sua città et il suo nome ogni giorno maggiormente cresceva, deliberarono gl'uomini della Compagnia dello Scalzo che Andrea finisse l'opera del loro cortile, che già aveva cominciato e fattovi la storia del battesimo di Cristo; e così, avendo egli rimesso mano all'opera più volentieri, vi fece due storie, e per ornamento della porta che entra nella Compagnia, una Carità et una Iustizia bellissime. In una delle storie fece San Giovanni che predica alle turbe in attitudine pronta, con persona adulta e simile alla vita che faceva e con un'aria di testa che mostra tutto spirito e considerazione. Similmente la varietà e prontezza degl'ascoltatori è maravigliosa, vedendosi alcuni stare ammirati e tutti attoniti nell'udire nuove parole et una così rara e non mai più udita dottrina. Ma molto più si adoperò l'ingegno d'Andrea nel dipignere Giovanni che battezza in acqua una infinità di popoli, alcuni de' quali si spogliano, altri ricevono il battesimo et altri, essendo spogliati, aspettano che finisca di battezzare quelli che sono inanzi a loro; et in tutti mostrò un vivo affetto e molto ardente disiderio nell'attitudini di coloro che si affrettano per essere mondati dal peccato, senzaché tutte le figure sono tanto ben lavorate in quel chiaro scuro ch'elle rappresentano vive istorie di marmo e verissime. Non tacerò che, mentre Andrea in queste et in altre pitture si adoperava, uscirono fuori alcune stampe intagliate in rame d'Alberto Duro, e che egli se ne servì e ne cavò alcune figure, riducendole alla maniera sua. Il che ha fatto credere ad alcuni, non che sia male servirsi delle buone cose altrui destramente, ma che Andrea non avesse molta invenzione.
Venne in quel tempo disiderio a Baccio Bandinelli, allora disegnatore molto stimato, d'imparare a colorire a olio; onde, conoscendo che niuno in Fiorenza ciò meglio sapea fare di esso Andrea, gli fece fare un ritratto di sé, che somigliò molto in quell'età, come si può anco vedere. E così nel vedergli fare questa et altre opere, vide il suo modo di colorire, se ben poi o per la difficultà o per non se ne curare, non seguitò di colorire, tornandogli più a proposito la scultura. Fece Andrea un quadro ad Alessandro Corsini pieno di putti intorno et una Nostra Donna che siede in terra con un putto in collo; il quale quadro fu condotto con bell'arte e con un colorito molto piacevole. Et a un merciaio, che faceva bottega in Roma et era suo molto amico, fece una testa bellissima. Similmente Giovanbatista Puccini fiorentino, piacendogli straordinariamente il modo di fare d'Andrea, gli fece fare un quadro di Nostra Donna per mandare in Francia, ma riuscitogli bellissimo se lo tenne per sé e non lo mandò altrimenti. Ma nondimeno, facendo egli in Francia suoi traffichi e negozii e perciò essendogli commesso che facesse opera di mandar la pittura eccellente, diede a fare ad Andrea un quadro d'un Cristo morto e certi Angeli attorno che lo sostenevano e con atti mesti e pietosi contemplavano il loro Fattore in tanta miseria per i peccati degli uomini. Questa opera finita che fu, piacque di maniera universalmente, che Andrea, pregato da molti, la fece intagliare in Roma da Agostino Viniziano; ma non gli essendo riuscita molto bene, non volle mai più dare alcuna cosa alla stampa. Ma tornando al quadro, egli non piacque meno in Francia, dove fu mandato, che s'avesse fatto in Fiorenza, in tanto che il re, acceso di maggior disiderio d'avere dell'opere d'Andrea, diede ordine che ne facesse alcun'altre, la quale cosa fu cagione che Andrea, persuaso dagl'amici, si risolvé d'andare poco dopo in Francia. Ma intanto, intendendo i Fiorentini, il che fu l'anno 1515, che papa Leone Decimo voleva fare grazie alla patria di farsi in quella vedere, ordinarono per riceverlo feste grandissime et un magnifico e sontuoso apparato con tanti archi, facciate, tempii, colossi et altre statue et ornamenti, che infino allora non era mai stato fatto né il più sontuoso, né il più ricco e bello; perché allora fioriva in quella città maggior copia di begli et elevati ingegni, che in altri tempi fusse avvenuto già mai. All'entrata della porta di San Pier Gattolini, fece Iacopo di Sandro un arco tutto istoriato et insieme con esso lui Baccio da Monte Lupo; a San Felice in Piazza ne fece un altro Giuliano del Tasso, et a Santa Trinita alcune statue e la meta di Romolo; et in Mercato Nuovo la Colonna Traiana. In piazza de' Signori fece un tempio a otto faccie Antonio, fratello di Giuliano da San Gallo; e Baccio Bandinelli fece un gigante in sulla loggia. Fra la Badia et il palazzo del podestà fecero un arco il Granaccio et Aristotile da San Gallo, et al canto de' Bischeri ne fece un altro il Rosso, con molto bello ordine e varietà di figure. Ma quello che fu più di tutto stimato fu la facciata di Santa Maria del Fiore, fatta di legname e lavorata in diverse storie di chiaro scuro dal nostro Andrea, tanto bene che più non si sarebbe potuto disiderare; e perché l'architettura di questa opera fu di Jacopo Sansovino e similmente alcune storie di basso rilievo e di scultura molte figure tonde, fu giudicato dal Papa che non sarebbe potuto essere quell'edifizio più bello quando fusse stato di marmo, e ciò fu invenzione di Lorenzo de' Medici, padre di quel Papa, quando viveva. Fece il medesimo Iacopo in sulla piazza di Santa Maria Novella un cavallo simile a quello di Roma, che fu tenuto bello affatto. Furono anco fatti infiniti ornamenti alla sala del papa nella via della Scala, e la metà di quella strada piena di bellissime storie di mano di molti artefici; ma per la maggior parte disegnate da Baccio Bandinelli. Entrando dunque Leone in Fiorenza del medesimo anno, il terzo dì di settembre, fu giudicato questo apparato il maggiore che fusse stato fatto già mai et il più bello.
Ma tornando oggimai ad Andrea, essendo di nuovo ricerco di fare un altro quadro per lo re di Francia, ne finì in poco tempo uno, nel quale fece una Nostra Donna bellissima, che fu mandato subito e cavatone dai mercanti quattro volte più che non l'avevano essi pagato. Aveva a punto allora Pier Francesco Borgherini fatto fare a Baccio d'Agnolo di legnami intagliati spalliere, cassoni, sederi e letto di noce molto belli, per fornimento d'una camera; onde, perché corrispondessero le pitture all'eccellenza degl'altri lavori, fece in quelli fare una parte delle storie da Andrea, in figure non molto grandi, de' fatti di Giuseppo figliuolo di Iacob, a concorrenza d'alcune che n'aveva fatte il Granaccio e Iacopo da Pontorno, che sono molto belle. Andrea dunque si sforzò, con mettere in quel lavoro diligenza e tempo straordinario, di far sì che gli riuscissero più perfette che quelle degli altri sopra detti. Il che gli venne fatto benissimo, avendo egli nella varietà delle cose, che accaggiono in quelle storie, mostro quanto egli valesse nell'arte della pittura. Le quali storie per la bontà loro furono per l'assedio di Fiorenza volute scassare di dove erano confitte da Giovanbatista della Palla, per mandare al re di Francia; ma perché erano confitte di sorte che tutta l'opera si sarebbe guasta, restarono nel luogo medesimo con un quadro di Nostra Donna che è tenuto cosa rarissima. Fece dopo questo Andrea una testa d'un Cristo, tenuta oggi dai frati de' Servi in sull'altare della Nunziata, tanto bella, che io per me non so se può imaginare da umano intelletto, per una testa d'un Cristo, la più bella. Erano state fatte in San Gallo, fuor della porta nelle capelle della chiesa, oltre alle due tavole d'Andrea, molte altre, le quali non paragonano le sue; onde avendosene ad allogare un'altra, operarono que' frati col padrone della capella ch'ella si desse ad Andrea; il quale, cominciandola subito, fece in quella quattro figure ritte che disputano della Trinità, cioè un Santo Agostino, che con aria veramente africana et in abito di vescovo si muove con veemenzia verso un San Pier martire, che tiene un libro aperto in aria et atto fieramente terribile, la quale testa e figura è molto lodata. Allato a questo è un San Francesco che con una mano tiene un libro e l'altra ponendosi al petto pare che esprima con la bocca una certa caldezza di fervore che lo faccia quasi struggere in quel ragionamento. Èvvi anco un S. Lorenzo, che ascolta come giovane e pare che ceda all'autorità di coloro. Abbasso sono ginocchioni due figure, una Maddalena con bellissimi panni, il volto della quale è ritratto della moglie, perciò che non faceva aria di femine in nessun luogo che da lei non la ritraesse; se pur aveniva che da altre tallora la togliesse, per l'uso del continuo vederla e per tanto averla disegnata e, che è più, averla nell'animo impressa, veniva che quasi tutte le teste che faceva di femmine, la somigliavano. L'altra delle quattro figure fu un San Bastiano, il quale, essendo ignudo, mostra le schiene che non dipinte, ma paiono a chiunche le mira vivissime. E certamente questa fra tante opere a olio fu dagl'artefici tenuta la migliore, conciò sia che in essa si vede molta osservanza nella misura delle figure et un modo molto ordinato e la proprietà dell'aria ne' volti, perché hanno le teste de' giovani dolcezza, crudezza quelle de' vecchi, et un certo mescolato che tiene dell'une e dell'altre quelle di mezza età. Insomma questa tavola è in tutte le parti bellissima e si truova oggi in San Iacopo tra' Fossi al canto agl'Alberti insieme con l'altre di mano del medesimo.
Mentre che Andrea si andava trattenendo in Fiorenza dietro a queste opere, assai poveramente, senza punto sollevarsi, erano stati considerati in Francia i due quadri che vi aveva mandati dal re Francesco Primo; e fra molti altri stati mandati di Roma, di Vinezia e di Lombardia erano stati di gran lunga giudicati i migliori; lodandogli dunque straordinariamente quel re, gli fu detto che essere potrebbe agevolmente che Andrea si conducesse in Francia al servigio di Sua Maestà. La qual cosa fu carissima al re, onde data commessione di quanto si avea da fare e che in Fiorenza gli fussero pagati danari per il viaggio, Andrea si mise allegramente in camino per Francia conducendo seco Andrea Sguazzella suo creato. Arrivati poi finalmente alla corte, furono da quel re con molta amorevolezza et allegramente ricevuti, et Andrea, prima che passasse il primo giorno del suo arrivo, provò quanta fosse la liberalità e cortesia di quel magnanimo re, ricevendo in dono danari e vestimenti ricchi et onorati. Cominciando poco appresso a lavorare, si fece al re et a tutta la corte grato di maniera, che essendo da tutti carezzato, gli pareva che la sua partita l'avesse condotto da una estrema infelicità a una felicità grandissima. Ritrasse fra le prime cose, di naturale il Dalfino figliuolo del re, nato di pochi mesi, e così in fascie; e portatolo al re n'ebbe in dono trecento scudi d'oro. Dopo, seguitando di lavorare, fece al re una Carità che fu tenuta cosa rarissima e dal re tenuta in pregio, come cosa che lo meritava; ordinatogli appresso grossa provisione, faceva ogni opera perché volentieri stesse seco, promettendo che niuna cosa gli mancherebbe. E questo perché gli piaceva nell'operare d'Andrea la prestezza et il procedere di quell'uomo che si contentava d'ogni cosa; oltre ciò, sodisfacendo molto a tutta la corte, fece molti quadri e molte opere; e se egli avesse considerato donde si era partito e dove la sorte l'aveva condotto, non ha dubbio che sarebbe salito (lasciamo stare le ricchezze) a onoratissimo grado. Ma essendogli un giorno, che lavorava per la madre del re un San Girolamo in penitenza, venuto alcune lettere da Fiorenza, le quali gli scriveva la moglie, cominciò (qualunque si fusse la cagione) a pensare di partirsi. Chiese dunque licenza al re, dicendo di volere andare a Firenze e che, accommodate alcune sue faccende, tornerebbe a Sua Maestà per ogni modo e che per starvi più riposato menarebbe seco la moglie, et al ritorno suo porterebbe pitture e sculture di pregio. Il re, fidandosi di lui, gli diede per ciò danari, et Andrea giurò sopra il Vangelo di ritornare a lui fra pochi mesi. E così arrivato a Fiorenza felicemente, si godé la sua bella donna parecchi mesi e gl'amici e la città. Finalmente, passando il termine in fra 'l quale doveva ritornare al re, egli si trovò in ultimo, fra in murare e darsi piacere e non lavorare, aver consumati i suoi danari e quelli del re parimente. Ma nondimeno volendo egli tornare, potettero più in lui i pianti e i preghi della sua donna che il proprio bisogno e la fede promessa al re. Onde, non essendo (per compiacere alla donna) tornato, il re ne prese tanto sdegno, che mai più con diritto occhio non volle vedere per molto tempo pittori fiorentini; e giurò che se mai gli fusse capitato Andrea alle mani, più dispiacere che piacere gli arebbe fatto, senza avere punto di riguardo alla virtù di quello. Così Andrea restato in Fiorenza e da uno altissimo grado venuto a uno infimo, si tratteneva e passava tempo, come poteva il meglio.
Nella sua partita per Francia avevano gl'uomini dello Scalzo, pensando che non dovesse mai più tornare, allogato tutto il restante dell'opera del cortile al Francia Bigio, che già vi aveva fatto due storie; quando vedendo Andrea tornato in Firenze fecero che egli rimise mano all'opera, e seguitando vi fece quattro storie, l'una a canto all'altra. Nella prima è San Giovanni preso dinanzi a Erode; nell'altra è la cena et il ballo d'Erodiana, con figure molto accomodate et a proposito; nella terza è la decollazione di esso San Giovanni, nella quale il maestro della iustizia mezzo ignudo è figura molto eccellentemente disegnata, sì come sono anco tutte l'altre; nella quarta Erodiana presenta la testa, et in questa sono alcune figure che si maravigliano, fatte con bellissima considerazione; le quali storie sono state un tempo lo studio e la scuola di molti giovani che oggi sono eccellenti in queste arti. Fece in sul canto che fuor della porta a Pinti voltava per andare agl'Ingesuati, in un tabernacolo a fresco una Nostra Donna a sedere con un Putto in collo et un San Giovanni fanciullo che ride, fatto con arte grandissima e lavorato così perfettamente, che è molto stimato per la bellezza e vivezza sua; e la testa della Nostra Donna è il ritratto della sua moglie di naturale. Il quale tabernacolo, per la incredibile bellezza di questa pittura, che è veramente maravigliosa, fu lasciato in piedi, quando l'anno 1530 per l'assedio di Fiorenza fu rovinato il detto convento degl'Ingesuati et altri molti bellissimi edifizii. In que' medesimi tempi, facendo in Francia Bartolomeo Panciatichi il vecchio molte facende di mercanzia, come disideroso di lasciare memoria di sé in Lione, ordinò a Baccio d'Agnolo che gli facesse fare da Andrea una tavola e gliela mandasse là, dicendo che in quella voleva u-n'Assunta di Nostra Donna con gl'Apostoli intorno al sepolcro. Questa opera dunque condusse Andrea fin presso alla fine, ma perché il legname di quella parecchie volte s'aperse, or lavorandovi, or lasciandola stare, ella si rimase a dietro non finita del tutto alla morte sua e fu poi da Bartolomeo Panciatichi il giovane riposta nelle sue case, come opera veramente degna di lode, per le bellissime figure degl'Apostoli, oltre alla Nostra Donna che da un coro di putti ritti è circondata, mentre alcuni altri la reggono e portano con una grazia singularissima; et a sommo della tavola è ritratto fra gl'Apostoli Andrea tanto naturalmente che par vivo; è oggi questa nella villa de' Baroncelli, poco fuor di Fiorenza in una chiesetta stata murata da Piero Salviati vicina alla sua villa, per ornamento di detta tavola. Fece Andrea a sommo dell'orto de' Servi in due cantoni due storie della vigna di Cristo, cioè quando ella si pianta, lega e paleggia, et appresso quel padre di famiglia che chiama a lavorare coloro che si stavano oziosi, fra i quali è uno che mentre dimandato se vuole entrare in opera, sedendo si gratta le mani e sta pensando se vuole andare fra gl'altri operai, nella guisa a punto che certi infingardi si stanno con poca voglia di lavorare. Ma molto più bella è l'altra, dove il detto padre di famiglia gli fa pagare, mentre essi mormorando si dogliono; e fra questi uno che da sé annovera i danari, stando intento a quello che gli tocca, par vivo; sì come anco pare il castaldo che gli paga; le quali storie sono di chiaro scuro e lavorate in fresco con destrissima pratica.
Dopo queste fece nel noviziato del medesimo convento a sommo d'una scala, una Pietà colorita a fresco in una nicchia, che è molto bella. Dipinse anco in un quadretto a olio un'altra Pietà et insieme una Natività nella camera di quel convento, dove già stava il generale Angelo Aretino. Fece il medesimo a Zanobi Bracci, che molto disiderava avere opere di sua mano, in un quadro per una camera, una Nostra Donna che inginocchiata si appoggia a un masso contemplando Cristo che, posato sopra un viluppo di panni, la guarda sorridendo; mentre un San Giovanni, che vi è ritto, accenna alla Nostra Donna quasi mostrando quello essere il vero Figliuol di Dio. Dietro a questi è un Giuseppo appoggiato con la testa in su le mani posate sopra uno scoglio, che pare si beatifichi l'anima nel vedere la generazione umana essere diventata, per quella nascita, divina. Dovendo Giulio cardinale de' Medici per commessione di papa Leone far lavorare di stucco e di pittura la volta della sala grande del Poggio a Caiano, palazzo e villa della casa de' Medici, posta fra Pistoia e Fiorenza, fu data la cura di quest'opera e di pagar i danari al Magnifico Ottaviano de' Medici, come a persona che non tralignando dai suoi maggiori s'intendeva di quel mestiere et era amico et amorevole a tutti gl'artefici delle nostre arti, dilettandosi più che altri d'avere adorne le sue case dell'opere dei più eccellenti; ordinò dunque, essendosi dato carico di tutta l'opera al Francia Bigio, ch'egli n'avesse un terzo solo, un terzo Andrea e l'altro Iacopo da Pontormo, Né fu possibile per molto che il Magnifico Ottaviano sollecitasse costoro, né per danari che offerisse e pagasse loro, far sì che quell'opera si conducesse a fine; per che Andrea solamente finì con molta diligenza in una facciata una storia, dentrovi quando a Cesare sono presentati i tributi di tutti gl'animali: il disegno della quale opera è nel nostro libro insieme con molti altri di sua mano; et è il più finito, essendo di chiaro scuro, che Andrea facesse mai. In questa opera Andrea, per superare il Francia e Iacopo, si mise a fatiche non più usate, tirando in quella una magnifica prospettiva et un ordine di scale molto difficile, per le quali salendo si perviene alla sedia di Cesare; e queste adornò di statue molto ben considerate. Non gli bastando aver mostro il bell'ingegno suo nella varietà di quelle figure che portano addosso que' tanti diversi animali, come sono una figura indiana che ha una casacca gialla indosso e sopra le spalle una gabbia, tirata in prospettiva, con alcuni papagalli dentro e fuori, che sono cosa rarissima; e come sono ancora alcuni che guidano capre indiane, leoni, giraffi, leonze, lupi cervieri, scimie e mori et altre belle fantasie accommodate con bella maniera e lavorate in fresco divinissimamente, fece anco in su quelle scalee a sedere un nano che tiene in una scatola il camaleonte, tanto ben fatto, che non si può immaginare nella disformità della stranissima forma sua la più bella proporzione di quella che gli diede. Ma questa opera rimase, come s'è detto, imperfetta per la morte di papa Leone. E se bene il duca Alessandro de' Medici ebbe disiderio che Iacopo da Pontormo la finisse, non ebbe forza di far sì che vi mettessi mano. E nel vero ricevé torto grandissimo a restare imperfetta, essendo per cosa di villa la più bella sala del mondo. Ritornato in Fiorenza, Andrea fece in un quadro una mezza figura ignuda d'un S. Giovan Battista, che è molto bella, la quale gli fu fatta fare da Giovan Maria Benintendi, che poi la donò al signor duca Cosimo. Mentre le cose succedevano in questa maniera, ricordandosi alcuna volta Andrea delle cose di Francia, sospirava di cuore; e se avesse pensato trovar perdono del fallo commesso, non ha dubbio che egli vi sarebbe tornato. E per tentare la fortuna, volle provare se la virtù sua gli potesse a ciò essere giovevole. Fece addunque in un quadro un S. Giovanni Battista mezzo ignudo, per mandarlo al gran Maestro di Francia, acciò si adoperasse per farlo ritornare in grazia del re. Ma qualunche di ciò fusse la cagione, non glielo mandò altrimenti, ma lo vendé al magnifico Ottaviano de' Medici, il quale lo stimò sempre assai mentre vis-se, sì come fece anco due quadri di Nostre Donne, che gli fece d'una medesima maniera, i quali sono oggi nelle sue case. Né dopo molto gli fece fare Zanobi Bracci per monsignore di San Biause un quadro, il quale condusse con ogni diligenza, sperando che potesse esser cagione di fargli riavere la grazia del re Francesco, il quale desiderava di tornare a servire. Fece anco un quadro a Lorenzo Iacopi, di grandezza molto maggiore che l'usato, dentrovi una Nostra Donna a sedere con il Putto in braccio e due altre figure, che l'accompagnano, le quali seggono sopra certe scalee, che di disegno e colorito sono simili all'altre opere sue. Lavorò similmente un quadro di Nostra Donna bellissimo a Giovanni d'Ago-stino Dini, che è oggi per la sua bellezza molto stimato; e Cosimo Lapi ritrasse di naturale tanto bene, che pare vivissimo.
Essendo poi venuto l'anno 1523 in Fiorenza la peste et anco pel contado in qualche luogo, Andrea, per mezzo d'An-tonio Brancacci, per fuggire la peste et anco lavorare qualche cosa, andò in Mugello a fare per le monache di San Piero a Luco dell'ordine di Camaldoli una tavola. Là dove menò seco la moglie et una figliastra, e similmente la sorella di lei et un garzone. Quivi dunque standosi quietamente mise mano all'opera; e perché quelle venerande donne più l'un giorno che l'altro facevano carezze e cortesie alla moglie, a lui et a tutta la brigata, si pose con grandissimo amore a lavorare quella tavola. Nella quale fece un Cristo morto, pianto dalla Nostra Donna, S. Giovanni Evangelista e da una Madalena in figure tanto vive, che pare ch'elle abbiano veramente lo spirito e l'anima. Nel S. Giovanni si scorge la tenera dilezzione di quell'Apostolo e l'amore della Madalena nel pianto et un dolore estremo nel volto et attitudine della Madonna, la quale vedendo il Cristo, che pare veramente di rilievo in carne e morto, fa per la compassione stare tutto stupefatto e smarrito San Piero e San Paulo, che contemplano morto il Salvatore del mondo in grembo alla madre. Per le quali maravigliose considerazioni si conosce quanto Andrea si dilettasse delle fini e perfezzioni dell'arte; e per dire il vero questa tavola ha dato più nome a quel monasterio, che quante fabriche e quante altre spese vi sono state fatte, ancor che magnifiche e straordinarie. Finita la tavola, perché non era ancor passato il pericolo della peste, dimorò nel medesimo luogo, dove era benissimo veduto e carezzato, alcune settimane. Nel qual tempo, per non si stare, fece non solamente una Visitazione di Nostra Donna e S. Lisabetta, che è in chiesa a man ritta sopra il presepio, per finimento d'una tavoletta antica, ma ancora in una tela non molto grande una bellissima testa d'un Cristo, alquanto simile a quella che è sopra l'altare della Nunziata, ma non sì finita; la qual testa, che invero si può annoverare fra le buone cose che uscissero delle mani d'Andrea, è oggi nel monasterio de' monaci degl'Angeli di Firenze, appresso il molto reverendo padre don Antonio da Pisa, amator non solo degl'uomini eccellenti nelle nostre arti, ma generalmente di tutti i virtuosi. Da questo quadro ne sono stati ricavati alcuni; per che avendolo don Silvano Razzi fidato a Zanobi Poggini pittore, acciò uno ne ritraesse a Bartolomeo Gondi, che ne lo richiese, ne furono ricavati alcuni altri, che sono in Firenze tenuti in somma venerazione. In questo modo adunque passò Andrea senza pericolo il tempo della peste e quelle donne ebbero dalla virtù di tanto uomo quell'opera, che può stare al paragone delle più eccellenti pitture che siano state fatte a' tempi nostri; onde non è maraviglia se Ramazzotto, capo di parte a Scaricalasino, tentò per l'assedio di Firenze più volte d'averla, per mandarla a Bologna in San Michele in Bosco alla sua capella. Tornato Andrea a Firenze, lavorò a Becuccio Bicchieraio da Gambassi, amicissimo suo, in una tavola una Nostra Donna in aria col Figliuolo in collo, et abbasso quattro figure, San Giovanni Battista, S. Maria Madalena, S. Bastiano e San Rocco; e nella predella ritrasse di naturale esso Becuccio e la moglie, che sono vivissimi. La quale tavola è oggi a Gambassi, castello fra Volterra e Fiorenza nella Valdelsa. A Zanobi Bracci per una capella della sua villa di Rovezzano fece un bellissimo quadro di una Nostra Donna, che allatta un Putto, et un Giuseppo con tanta diligenza che si staccano, tanto hanno rilievo, dalla tavola. Il quale quadro è oggi in casa di Messer Antonio Bracci, figliuolo di detto Zanobi. Fece anco Andrea nel medesimo tempo e nel già detto cortile dello Scalzo, due altre storie; in una delle quali figurò Zacheria che sacrifica et ammutolisce nell'apparirgli l'Angelo; nell'altra è la Visitazione di Nostra Donna, bella a maraviglia.
Federigo Secondo duca di Mantoa, nel passare per Fiorenza, quando andò a far reverenza a Clemente Settimo, vide sopra una porta, in casa Medici, quel ritratto di papa Leone in mezzo al cardinale Giulio de' Medici et al cardinale de' Rossi, che già fece l'eccellentissimo Raffaello da Urbino; per che, piacendogli straordinariamente, pensò, come quello che si dilettava di così fatte pitture eccellenti, farlo suo. E così quando gli parve tempo, essendo in Roma, lo chiese in dono a papa Clemente, che gliene fece grazia cortesemente; onde fu ordinato in Fiorenza a Ottaviano de' Medici, sotto la cui cura e governo erano Ippolito et Alessandro, che incassatolo, lo facesse portare a Mantoa. La qual cosa dispiacendo molto al Magnifico Ottaviano, che non arebbe voluto privar Fiorenza d'una sì fatta pittura, si maravigliò che il Papa l'avesse corsa così a un tratto, pure rispose che non mancherebbe di servire il Duca, ma che essendo l'ornamento cattivo ne faceva fare un nuovo, il quale come fusse messo d'oro manderebbe sicurissimamente il quadro a Mantoa; e ciò fatto, Messer Ottaviano, per salvare, come si dice, la capra et i cavoli, mandò segretamente per Andrea e gli disse come il fatto stava, e che a ciò non era altro rimedio che contrafare quello con ogni diligenza; e mandandone un simile al Duca, ritenere, ma nascosamente, quello di mano di Raffaello. Avendo dunque promesso Andrea di fare quanto sapeva e poteva, fatto fare un quadro simile di grandezza et in tutte le parti, lo lavorò in casa di Messer Ottaviano segretamente. E vi si affaticò di maniera che esso Messer Ottaviano, intendentissimo delle cose dell'arti, quando fu finito non conosceva l'uno dall'altro, né il proprio e vero dal simile, avendo massimamente Andrea contrafatto insino alle macchie del sucido, come era il vero apunto. E così, nascosto che ebbero quello di Raffaello, mandarono quello di mano d'An-drea in un ornamento simile a Mantoa. Di che il Duca restò soddisfattissimo, avendoglielo massimamente lodato, senza essersi avveduto della cosa, Giulio Romano pittore e discepolo di Raffaello. Il quale Giulio si sarebbe stato sempre in quella openione e l'arebbe creduto di mano di Raffaello. Ma capitando a Mantoa Giorgio Vasari, il quale, essendo fanciullo e creatura di Messer Ottaviano, aveva veduto Andrea lavorare quel quadro, scoperse la cosa. Per che, facendo il detto Giulio molte carezze al Vasaro e mostrandogli, dopo molte anticaglie e pitture, quel quadro di Raffaello come la miglior cosa che vi fusse, disse Giorgio: “L'opera è bellissima, ma non è altrimenti di mano di Raffaello”. “Come no?”, disse Giulio, “non lo so io, che riconosco i colpi che vi lavorai su?”. “Voi ve gli sete dimenticati”, soggiunse Giorgio, “perché questo è di mano d'Andrea del Sarto; e per segno di ciò, eccovi un segno (e glielo mostrò) che fu fatto in Fiorenza, perché quando erano insieme si scambiavano.” Ciò udito fece rivoltar Giulio il quadro, e visto il contrasegno, si strinse nelle spalle, dicendo queste parole: “Io non lo stimo meno che s'ella fusse di mano di Raffaello, anzi molto più, perché è cosa fuor di natura che un uomo eccellente imiti sì bene la maniera d'un altro e la faccia così simile”. Basta, che si conosce che così valse la virtù d'Andrea accompagnata, come sola. E così fu col giudizio e consiglio di Messer Ottaviano sodisfatto al Duca e non privata Fiorenza d'una sì degna opera. La quale essendogli poi donata dal duca Alessandro, tenne molti anni appresso di sé. E finalmente ne fece dono al duca Cosimo, che l'ha in guardaroba con molte altre pitture famose. Mentre che Andrea faceva questo ritratto, fece anco per il detto Messer Ottaviano in un quadro, solo la testa di Giulio cardinal de' Medici, che fu poi papa Clemente, simile a quella di Raffaello, che fu molto bella. La quale testa fu poi donata da esso Messer Ottaviano al vescovo vecchio de' Marzi. Non molto dopo, disiderando Messer Baldo Magni da Prato fare alla Madonna della Carcere nella sua terra una tavola di pittura bellissima, dove aveva fatto fare prima un ornamento di marmo molto onorato, gli fu, fra molti altri pittori, messo inanzi Andrea; onde avendo Mes-ser Baldo, ancor che di ciò non s'intendesse molto, più inchinato l'animo a lui che a niun altro, gli aveva quasi dato intenzione di volere che egli e non altri facesse; quando un Niccolò Soggi sansovino, che aveva qualche amicizia in Prato, fu messo inanzi a Messer Baldo per quest'opera, e di maniera aiutato, dicendo che non si poteva avere miglior maestro di lui, che gli fu allogata quell'opera. Intanto, mandando per Andrea chi l'aiutava, egli con Domenico Puligo et altri pittori amici suoi, pensando al fermo che il lavoro fusse suo, se n'andò a Prato. Ma giunto trovò che Niccolò non solo aveva rivolto l'animo di Messer Baldo, ma anco era tanto ardito e sfacciato, che in presenza di Messer Baldo disse ad Andrea che giocherebbe seco ogni somma di danari a far qualche cosa di pittura e chi facesse meglio tirasse. Andrea, che sapea quanto Niccolò valesse, rispose, ancor che per ordinario fusse di poco animo: “Io ho qui meco questo mio garzone che non è stato molto all'arte, se tu vuoi giocar seco, io metterò i danari per lui, ma meco non voglio che tu ciò faccia per niente: perciò che, se io ti vincessi, non mi sarebbe onore, e se io perdessi, mi sarebbe grandissima vergogna”. E detto a Messer Baldo che desse l'opera a Niccolò, perché egli la farebbe di maniera che ella piacerebbe a chi andasse al mercato, se ne tornò a Fiorenza, dove gli fu allogata una tavola per Pisa, divisa in cinque quadri, che poi fu posta alla Madonna di S. Agnesa lungo le mura di quella città, fra la cittadella vecchia et il Duomo. Facendo dunque in ciascun quadro una figura, fece S. Giovanni Battista e S. Piero, che mettono in mezzo quella Madonna che fa miracoli; negl'altri è S. Caterina martire, S. Agnesa e S. Margherita; figure, ciascuna per sé, che fanno maravigliare per la loro bellezza chiunche le guarda e sono tenute le più leggiadre e belle femmine che egli facesse mai. Aveva Messer Iacopo, frate de' Servi, nell'assolvere e permutar un voto d'una donna, ordinatole ch'ella facesse fare sopra la porta del fianco della Nunziata che va nel chiostro, dalla parte di fuori, una figura d'una Nostra Donna; per che trovato Andrea, gli disse che aveva a fare spendere questi danari e che, se bene non erano molti, gli pareva ben fatto, avendogli tanto nome acquistato le altre opere fatte in quel luogo, che egli e non altri facesse anco questa. Andrea, che era anzi dolce uomo che altrimenti, spinto dalle persuasioni di quel padre, dall'utile e dal desiderio della gloria, rispose che la farebbe volentieri; e poco appresso, messovi mano, fece in fresco una Nostra Donna che siede, bellissima, con il Figliuolo in collo et un San Giuseppo, che appoggiato a un sacco, tien gl'occhi fissi a un libro aperto. E fu si fatta quest'opera, che per disegno, grazia e bontà di colorito e per vivezza e rilievo, mostrò egli avere di gran lunga superati et avanzati tutti i pittori che avevano insino a quel tempo lavorato. Et invero è questa pittura così fatta che apertamente da se stessa, senza che altri la lodi, si fa conoscere per stupenda e rarissima.
Mancava al cortile dello Scalzo solamente una storia a restare finito del tutto; per il che Andrea, che aveva ringrandito la maniera per aver visto le figure che Michelagnolo aveva cominciate e parte finite per la sagrestia di San Lorenzo, mise mano a fare quest'ultima storia; et in essa, dando l'ultimo saggio del suo miglioramento, fece il nascer di San Giovanni Battista in figure bellissime e molto migliori e di maggior rilievo che l'altre da lui state fatte per l'adietro nel medesimo luogo. Sono bellissime in questa opera fra l'altre, una femmina che porta il putto nato al letto, dove è S. Lisabetta, che anch'ella è bellissima figura; e Zacheria che scrive sopra una carta, la quale ha posata sopra un ginocchio, tenendola con una mano e con l'altra scrivendo il nome del figliuolo, tanto vivamente che non gli manca altro che il fiato stesso. È bellissima similmente una vecchia che siede in su una predella, ridendosi del parto di quell'altra vecchia e mostra nell'attitudine e nell'affetto quel tanto che in simile cosa farebbe la natura. Finita quell'opera, che certamente è dignissima di ogni lode, fece per il generale di Vallombrosa in una tavola quattro bellissime figure, San Giovanni Battista, S. Giovangualberto, institutor di quell'Ordine, S. Michelagnolo e S. Bernardo, cardinale e loro monaco; e nel mezzo alcuni putti che non possono esser né più vivaci, né più belli. Questa tavola è a Vallombrosa sopra l'altezza d'un sasso, dove stanno certi monaci separati dagl'altri, in alcune stanze, dette le celle, quasi menando vita da romiti. Dopo que-sta, gli fece fare Giuliano Scala, per mandare a Serrezzana, in una tavola una Nostra Donna a sedere col Figlio in collo e due mezze figure dalle ginocchia in su, San Celso e S. Iulia, S. Onofrio, S. Caterina, San Benedetto, S. Antonio da Padoa, San Piero e San Marco. La quale tavola fu tenuta simile all'altre cose d'Andrea et al detto Giuliano Scala rimase per un resto, che coloro gli dovevano di danari pagati per loro, un mezzo tondo, dentro al quale è una Nunziata, che andava sopra per finimento della tavola; il quale è nella chiesa de' Servi a una sua capella intorno al coro nella tribuna maggiore. Erano stati i monaci di San Salvi molti anni senza pensare che si mettesse mano al loro Cenacolo, che ave-vano dato a fare ad Andrea, allora che fece l'arco con le quattro figure; quando un abbate galantuomo e di giudizio, deliberò che egli finisse quell'opera; onde Andrea, che già si era a ciò altra volta obligato, non fece alcuna resistenza, anzi messovi mano in non molti mesi, lavorandone a suo piacere un pezzo per volta, lo finì e di maniera che quest'opera fu tenuta, ed è certamente, la più facile, la più vivace di colorito e di disegno che facesse già mai, anzi che fare si possa: avendo, oltre all'altre cose, dato grandezza, maestà e grazia infinita a tutte quelle figure; intanto che io non so che mi dire di questo Cenacolo che non sia poco, essendo tale che chiunche lo vede resta stupefatto; onde non è maraviglia se la sua bontà fu cagione che nelle rovine dell'assedio di Firenze l'anno 1529 egli fusse lasciato stare in piedi, allora che i soldati e guastatori, per comandamento di chi reggeva, rovinarono tutti i borghi fuor della città, i monasteri, spedali e tutti altri edifizii. Costoro dico, avendo rovinato la chiesa et il campanile di San Salvi e cominciando a mandar giù parte del convento, giunti che furono al refettorio, dove è questo Cenacolo, vedendo chi gli guidava e forse avendone udito ragionare sì maravigliosa pittura, abbandonando l'impresa, non lasciò rovinar altro di quel luogo, serbandosi a ciò fare quando non avessero potuto fare altro.
Dopo fece Andrea alla Compagnia di San Iacopo detta il Nicchio, in un segno da portare a processione, un San Iacopo che fa carezze, toccandolo sotto il mento, a un putto vestito da Battuto et un altro putto, che ha un libro in mano, fatto con bella grazia e naturale. Ritrasse di naturale un commesso de' monaci di Vallonbrosa, che per bisogni del suo monasterio si stava sempre in villa e fu messo sotto un pergolato, dove aveva fatto suoi acconcimi e pergole con varie fantasie e dove percuoteva assai l'acqua et il vento, sì come volle quel commesso amico d'Andrea. E perché finita l'ope-ra avanzò de' colori e della calcina, Andrea, preso un tegolo, chiamò la Lucrezia sua donna e le disse: “Vien qua, poiché ci sono avanzati questi colori, io ti voglio ritrarre, acciò si veggia in questa tua età come ti sei ben conservata, e si conosca nondimeno quanto hai mutato effigie e sia per esser questo diverso dai primi ritratti”. Ma non volendo la donna, che forse aveva altra fantasia, star ferma, Andrea, quasi indovinando esser vicino al suo fine, tolta una spera, ritrasse se medesimo in quel tegolo, tanto bene che par vivo e naturalissimo. Il qual ritratto è appresso alla detta Madonna Lucrezia sua donna, che ancor vive. Ritrasse similmente un canonico pisano suo amicissimo, et il ritratto, che è naturale e molto bello, è anco in Pisa. Cominciò poi, per la Signoria, i cartoni che si avevano a colorire, per far le spalliere della ringhiera di piazza con molte belle fantasie sopra i quartieri della città, con le bandiere delle capitudini tenute da certi putti, con ornamenti ancora dei simulacri di tutte le virtù, e parimente i monti e' fiumi più famosi del dominio di Fiorenza. Ma quest'opera così cominciata rimase imperfetta per la morte d'Andrea; come rimase anco, ma poco meno che finita, una tavola che fece per i monaci di Vallombrosa alla loro badia di Poppi in Casentino; nella quale tavola fece una Nostra Donna Assunta con molti putti intorno, San Giovanni Gualberto, San Bernardo cardinale loro monaco, come s'è detto, S. Caterina e San Fedele. La quale tavola così imperfetta è oggi in detta Badia di Poppi. Il simile avvenne d'una tavola non molto grande, che finita doveva andar a Pisa. Lasciò bene finito del tutto un molto bel quadro, che oggi è in casa di Filippo Salviati, et alcuni altri. Quasi ne' medesimi tempi Giovanbattista della Palla, avendo compere quante sculture e pitture notabili aveva potuto, facendo ritrarre quelle che non poteva avere, aveva spogliato Fiorenza d'una infinità di cose elette, senza alcun rispetto, per ordinare al re di Francia un appartamento di stanze, che fusse il più ricco di così fatti ornamenti che ritrovare si potesse. Costui dunque, desiderando che Andrea tornasse in grazia et al servigio del re, gli fece fare due quadri: in uno dipinse Andrea Abramo in atto di volere sacrificare il figliuolo; e ciò con tanta diligenza, che fu giudicato che insino allora non avesse mai fatto meglio. Si vedeva nella figura del vecchio espressa divinamente quella viva fede e constanza che senza punto spaventarlo, lo faceva di buonissima voglia pronto a uccidere il proprio figliuolo. Si vedeva anco il medesimo volgere la testa verso un bellissimo putto, il quale parea gli dicesse che fermasse il colpo. Non dirò quali fussero l'attitudini, l'abito, i calzari et altre cose di quel vecchio, perché non è possibile dirne a bastanza. Dirò bene che si vedeva il bellissimo e tenero putto Isaac tutto nudo tremare per timo-re della morte e quasi morto senza esser ferito. Il medesimo aveva, non che altro, il collo tinto dal calor del sole e candidissime quelle parti che nel viaggio di tre giorni avevano ricoperto i panni. Similmente il montone fra le spine pareva vivo et i panni di Isaac in terra più tosto veri e naturali che dipinti. Vi erano, oltre ciò, certi servi ignudi che guardavano un asino che pasceva et un paese tanto ben fatto che quel proprio dove fu il fatto non poteva esser più bello né altrimenti. La qual pittura, avendo dopo la morte d'Andrea e la cattura di Battista compera Filippo Strozzi, ne fece dono al signor Alfonso Davalos marchese del Vasto, il quale la fece portar nell'isola d'Ischia, vicina a Napoli, e porre in alcune stanze in compagnia d'altre dignissime pitture. Nell'altro quadro fece una Carità bellissima con tre putti, e questo comperò poi dalla donna d'Andrea, essendo egli morto, Domenico Conti pittore, che poi lo vendé a Niccolò Antinori, che lo tiene come cosa rara, che ell'è veramente. Venne in questo mentre desiderio al Magnifico Ottaviano de' Medici, veden-do quanto Andrea aveva in quest'ultimo migliorata la maniera, d'avere un quadro di sua mano; onde Andrea, che desiderava servirlo, per esser molto obligato a quel signore, che sempre aveva favorito i begli ingegni e particolarmente i pittori, gli fece in un quadro una Nostra Donna, che siede in terra con un putto in su le gambe a cavalcione, che volge la testa a un San Giovannino, sostenuto da una S. Elisabetta vecchia, tanto ben fatta e naturale, che par viva, sì come anco ogni altra cosa è lavorata con arte, disegno e diligenza incredibile. Finito che ebbe questo quadro, Andrea lo portò a Messer Ottaviano; ma perché, essendo allora l'assedio attorno a Firenze, aveva quel signore altri pensieri, gli rispose che lo desse a chi voleva, scusandosi e ringraziandolo sommamente. Al che Andrea non rispose altro se non: “La fatica è durata per voi e vostro sarà sempre”. “Vendilo”, rispose Messer Ottaviano “e serveti de' danari, perciò che io so quel che io mi dico.” Partitosi dunque Andrea, se ne tornò a casa, né per chieste che gli fussino fatte volle mai dare il quadro a nessuno, anzi, fornito che fu l'assedio et i Medici tornati in Firenze, riportò Andrea il quadro a Messer Ottaviano, il quale presolo ben volentieri e ringraziandolo, glielo pagò doppiamente. La qual opera è oggi in camera di Madonna Francesca, sua donna, e sorella del reverendissimo Salviati; la quale non tiene men conto delle belle pitture lasciateli dal Magnifico suo consorte che ella si faccia del conservare e tener conto degl'amici di lui. Fece un altro quadro Andrea, quasi simile a quello della Carità già detta, a Giovanni Borgherini, dentrovi una Nostra Donna, un S. Giovanni putto che porge a Cristo una palla, figurata per il mondo, et una testa di S. Giuseppo molto bella. Venne voglia a Pavolo da Terra Rossa, veduta la bozza del sopra detto Abramo, d'avere qualche cosa di mano d'Andrea, come amico universalmente di tutti i pittori. Per che richiestolo d'un ritratto di quello Abramo, Andrea volentieri lo servì, e glielo fece tale che nella sua piccolezza non fu punto inferiore alla grandezza dell'originale. Laonde, piacendo molto a Pavolo, gli domandò del prezzo per pagarlo, stimando che dovesse costarli quello che veramente valeva; ma chiedendoli Andrea una miseria, Pavolo quasi si vergognò e strettosi nelle spalle gli diede tutto quello che chiese. Il quadro fu poi mandato da lui a Napoli... et in quel luogo è la più bella et onorata pittura che vi sia. Erano per l'assedio di Firenze fuggitisi con le paghe alcuni capitani della città, onde essendo richiesto Andrea di dipignere nella facciata del palazzo del podestà et in piazza non solo detti capitani, ma ancora alcuni cittadini fuggiti e fatti ribelli, disse che gli farebbe; ma per non si acquistare, come Andrea dal Castagno, il cognome degli Impiccati, diede nome di fargli fare a un suo garzone, chiamato Bernardo del Buda. Ma fatta una turata grande, dove egli stesso entrava e usciva di notte, condusse quelle figure di maniera che parevano coloro stessi vivi e naturali. I soldati che furon dipinti in piazza nella facciata della Mercatanzia Vecchia vicino alla condotta furono, già sono molt'anni, coperti di bianco perché non si vedesseno. E similmente i cittadini che egli finì tutti di sua mano nel palazzo del podestà guasti.
Essendo dopo Andrea in questi suoi ultimi anni molto familiare d'alcuni che governavano la Compagnia di San Bastiano che è dietro a' Servi, fece loro di sua mano un San Bastiano dal bellico in su tanto bello, che ben parve che quelle avessero a essere l'ultime pennellate che egli avesse a dare. Finito l'assedio se ne stava Andrea aspettando che le cose si allargassino, se bene con poca speranza, che il disegno di Francia gli dovesse riuscire, essendo stato preso Giovambatista della Palla, quando Fiorenza si riempié dei soldati del campo e di vettovaglie. Fra i quali soldati essendo alcuni Lanzi appestati, diedero non piccolo spavento alla città e poco appresso la lasciarono infetta. Laonde, o fusse per questo sospetto o pure perché avesse disordinato nel mangiare, dopo aver molto in quello assedio patito, si ammalò un giorno Andrea gravemente. E postosi nel letto giudicatissimo senza trovar rimedio al suo male e senza molto governo, standoli più lontana che poteva la moglie, per timor della peste, si morì (dicono) che quasi nissuno se n'avide; e così con assai poche cirimonie gli fu nella chiesa de' Servi vicino a casa sua dato sepoltura dagli uomini dello Scalzo, dove sogliono sepellirsi tutti quelli di quella Compagnia. Fu la morte d'Andrea di grandissimo danno alla sua città et all'arte, perché insino all'età di quarantadue anni che visse, andò sempre di cosa in cosa migliorando di sorte, che quanto più fusse vivuto, sempre averebbe accresciuto miglioramento all'arte; perciò che meglio si va acquistando a poco a poco, andandosi col piede più sicuro e fermo nelle difficultà dell'arte, che non si fa in volere sforzare la natura e l'ingegno a un tratto. Né è dubbio che se Andrea si fusse fermo a Roma, quando egli vi andò per vedere l'opere di Raffaello e di Michelagnolo, e parimente le statue e le rovine di quella città, che egli averebbe molto arrichita la maniera ne' componimenti delle storie et averebbe dato un giorno più finezza e maggior forza alle sue figure. Il che non è venuto fatto interamente, se non a chi è stato qualche tempo in Roma a praticarle e considerarle minutamente. Avendo egli dunque dalla natura una dolce e graziosa maniera nel disegno et un colorito facile e vivace molto, così nel lavorare in fresco, come a olio, si crede senza dubbio, se si fusse fermo in Roma, che egli averebbe avanzati tutti gl'artefici del tempo suo. Ma credono alcuni che da ciò lo ritraesse l'abondanza dell'opere che vidde in quella città di scultura e pittura, e così antiche come moderne, et il vedere molti giovani discepoli di Raffaello e d'altri essere fieri nel disegno e lavorare sicuri e senza stento; i quali, come timido che egli era, non gli diede il cuore di passare. E così, facendosi paura da sé, si risolvé per lo meglio tornarsene a Firenze, dove, considerando a poco a poco quello che avea veduto, fece tanto profitto che l'opere sue sono state tenute in pregio et amirate, e, che è più, imitate più dopo la morte che mentre visse. E chi n'ha le tien care, e chi l'ha volute vendere n'ha cavato tre volte più che non furono pagate a lui, atteso che delle sue cose ebbe sempre poco prezzo, sì perché era, come si è detto, timido di natura, e sì perché certi maestri di legname, che allora lavoravano le migliori cose in casa de' cittadini, non gli facevano mai allogare alcun'opera, per servire gl'amici loro, se non quando sapevano che Andrea avesse gran bisogno, nel qual tempo si contentava d'ogni pregio. Ma questo non toglie che l'opere sue non siano rarissime e che non ne sia tenuto grandissimo conto e meritamente, per essere egli stato de' maggiori e migliori maestri, che siano stati insin qui.
Sono nel nostro libro molti disegni di sua mano, e tutti buoni, ma particolarmente è bello affatto quello della storia che fece al Poggio, quando a Cesare è presentato il tributo di tutti gl'animali orientali; il quale disegno, che è fatto di chiaro scuro, è cosa rara et il più finito che Andrea facesse mai; avenga che quando egli disegnava le cose di naturale per metterle in opera faceva certi schizzi così abbozzati, bastandogli vedere quello che faceva il naturale. Quando poi gli metteva in opera gli conduceva a perfezzione. Onde i disegni gli servivano più per memoria di quello che aveva visto che per copiare a punto da quelli le sue pitture.
Furono i discepoli d'Andrea infiniti, ma non tutti fecero il medesimo studio sotto la disciplina di lui, perché vi dimorarono chi poco e chi assai, non per colpa d'Andrea, ma della donna sua, che senza aver rispetto a nessuno, comandando a tutti imperiosamente gli teneva tribolati. Furono dunque suoi discepoli Iacopo da Puntormo, Andrea Sguazzella, che tenendo la maniera d'Andrea, ha lavorato in Francia un palazzo fuor di Parigi, che è cosa molto lodata; il Solosmeo, Pierfrancesco di Iacopo di Sandro, il qual ha fatto in Santo Spirito tre tavole, e Francesco Salviati e Giorgio Vasari are-tino, che fu compagno del detto Salviati, ancor che poco dimorasse con Andrea; Iacopo del Conte fiorentino e Nannoccio, ch'oggi è in Francia col cardinale Tornone in bonissimo credito. Similmente Iacopo, detto Iacone fu discepolo d'Andrea e molto amico suo et imitatore della sua maniera. Il quale Iacone, mentre visse Andrea si valse assai di lui, come appare in tutte le sue opere e massimamente nella facciata del cavalier Buondelmonti in sulla piazza di S. Trinità. Restò dopo la sua morte erede dei disegni d'Andrea e dell'altre cose dell'arte Domenico Conti, che fece poco profitto nella pittura, al quale furono da alcuni (come si crede) dell'arte rubati una notte tutti i disegni e cartoni et altre cose che aveva d'Andrea. Né mai si è potuto sapere chi que' tali fussero. Domenico Conti adunque, come non ingrato de' benefizii ricevuti dal suo maestro e disideroso di dargli dopo la morte quelli onori che meritava, fece sì che la cortesia di Raffaello da Montelupo gli fece un quadro assai ornato di marmo, il quale fu nella chiesa de' Servi murato in un pilastro, con questo epitaffio fattogli dal dottissimo Messer Pier Vettori, allora giovane:
ANDREAE SARTIO
Admirabilis ingenii pictori, ac veteribus illis omnium
iudicio comparando.
Dominicus Contes, discipulus, pro laboribus,
in se instituendo susceptis, grato animo posuit.
Vixit annos XLII. Obiit Anno MDXXX.
Dopo non molto tempo alcuni cittadini Operai della detta chiesa, più tosto ignoranti che nemici delle memorie onorate, sdegnandosi che quel quadro fusse in quel luogo stato messo senza loro licenza, operarono di maniera che ne fu levato, né per ancora è stato rimurato in altro luogo. Nel che volle forse mostrarci la fortuna che non solo gl'influssi de' fati possono in vita, ma ancora nelle memorie dopo la morte. Ma a dispetto loro sono per vivere l'opere et il nome d'Andrea lunghissimo tempo e per tenerne, spero, questi miei scritti, molti secoli, memoria. Conchiudiamo adunque che se Andrea fu d'animo basso nell'azzioni della vita, contentandosi di poco, egli non è perciò che nell'arte non fusse d'in-gegno elevato e speditissimo e pratico in ogni lavoro; avendo con l'opere sue, oltre l'ornamento ch'elle fanno a' luoghi dove elle sono, fatto grandissimo giovamento ai suoi artefici nella maniera, nel disegno e nel colorito; et il tutto con manco errori che altro pittor fiorentino; per avere egli, come si è detto inanzi, inteso benissimo l'ombre et i lumi e lo sfuggire delle cose negli scuri e dipinte le sue cose con una dolcezza molto viva, senzaché egli mostrò il modo di lavorare in fresco con perfetta unione e senza ritoccare molto a secco: il che fa parer fatta ciascuna opera sua tutta in un medesimo giorno. Onde può agli artefici toscani stare per essempio in ogni luogo et avere fra i più celebrati ingegni loro lode grandissima et onorata palma.
IL FINE DELLA VITA D'ANDREA DEL SARTO, PITTOR FIORENTINO
VITA DI MADONNA PROPERZIA DE' ROSSI
SCULTRICE BOLOGNESE

È gran cosa che in tutte quelle virtù et in tutti quelli esercizii ne' quali, in qualunque tempo, hanno voluto le donne intromettersi con qualche studio, elle siano sempre riuscite eccellentissime e più che famose, come con una infinità di esempli agevolmente potrebbe dimostrarsi. E certamente ognun sa quanto elleno universalmente tutte nelle cose economiche vagliono, oltra che nelle cose della guerra, medesimamente si sa chi fu Camilla, Arpalice, Valasca, Tomiri, Pantasilea, Molpadia, Orizia, Antiope, Ippolita, Semiramide, Zenobia; chi finalmente Fulvia di Marcantonio che, come dice Dione istorico, tante volte s'armò per defender il marito e se medesima. Ma nella poesia ancora sono state maravigliosissime: come racconta Pausania, Corinna fu molto celebre nel versificare, et Eustachio, nel catalogo delle navi d'Omero, fa menzione di Safo, onoratissima giovane; il medesimo fa Eusebio nel libro de' tempi, la quale invero se ben fu donna, ella fu però tale che superò di gran lunga tutti gli eccellenti scrittori di quella età. E Varrone loda anch'egli fuor di modo, ma meritamente Erinna, che con trecento versi s'oppose alla gloriosa fama del primo lume della Grecia, e con un suo picciol volume, chiamato Elecate, equiperò la numerosa Iliade del grand'Omero. Aristofane celebra Carissena, nella medesima professione, per dottissima et eccellentissima femina; e similmente Teano, Merone, Polla, Elpe, Cornificia e Telisilla, alla quale fu posta nel tempio di Venere per maraviglia delle sue tante virtù, una bellissima statua. E per lassar tant'altre versificatrici, non leggiamo noi che Arete nelle difficultà di filosofia fu maestra del dotto Aristippo? E Lastenia et Assiotea discepole del divinissimo Platone? E nell'arte oratoria Sempronia et Ortensia, femmine ro-mane, furono molto famose. Nella grammatica, Agallide (come dice Ateneo) fu rarissima, e nel predir delle cose future,
o diasi questo all'astrologia, o alla magica, basta che Temi e Cassandra e Manto ebbero ne' tempi loro grandissimo no-me. Come ancora Iside e Cerere nelle necessità dell'agricultura. Et in tutte le scienze universalmente, le figliuole di Tespio. Ma certo in nessun'altra età s'è ciò meglio potuto conoscere che nella nostra; dove le donne hanno acquistato grandissima fama, non solamente nello studio delle lettere, com'ha fatto la signora Vittoria del Vasto, la signora Veronica Gambara, la signora Caterina Anguisola, la Schioppa, la Nugarola, Madonna Laura Battiferra e cent'altre, sì nella volgare, come nella latina e nella greca lingua, dottissime; ma eziandio in tutte l'altre facultà. Né si son vergognate, quasi per torci il vanto della superiorità, di mettersi con le tenere e bianchissime mani nelle cose mecaniche e fra la ruvidezza de' marmi e l'asprezza del ferro, per conseguir il desiderio loro e riportarsene fama, come fece ne' nostri dì Properzia de' Rossi da Bologna, giovane virtuosa, non solamente nelle cose di casa, come l'altre, ma in infinite scienze che non che le donne, ma tutti gli uomini gl'ebbero invidia. Costei fu del corpo bellissima e sonò e cantò ne' suoi tempi meglio che femmina della sua città. E perciò ch'era di capriccioso e destrissimo ingegno, si mise ad intagliar noccioli di pesche, i quali sì bene e con tanta pazienza lavorò, che fu cosa singulare e maravigliosa il vederli. Non solamente per la sottilità del lavoro, ma per la sveltezza delle figurine che in quegli faceva e per la delicatissima maniera del compartirle. E certamente era un miracolo veder in su un nocciolo così piccolo tutta la Passione di Cristo, fatta con bellissimo intaglio, con una infinità di persone, oltre i crucifissori e gli Apostoli. Questa cosa le diede animo, dovendosi far l'or-namento delle tre porte della prima facciata di San Petronio, tutta a figure di marmo, che ella per mezzo del marito, chiedesse agli Operai una parte di quel lavoro, i quali di ciò furon contentissimi, ogni volta ch'ella facesse veder loro qualche opera di marmo condotta di sua mano. Onde ella subito fece al conte Alessandro de' Peppoli un ritratto di finissimo marmo, dov'era il conte Guido suo padre di naturale. La qual cosa piacque infinitamente, non solo a coloro, ma a tutta quella città, e perciò gl'Operai non mancarono di allogarle una parte di quel lavoro. Nel quale ella finì, con grandissima maraviglia di tutta Bologna, un leggiadrissimo quadro, dove (perciò che in quel tempo la misera donna era innamoratissima d'un bel giovane, il quale parea che poco di lei si curasse) fece la moglie del maestro di casa di Faraone, che innamoratasi di Giosep, quasi disperata del tanto pregarlo, all'ultimo gli toglie la veste d'attorno con una donnesca grazia e più che mirabile. Fu questa opera da tutti riputata bellissima et a lei di gran sodisfazzione, parendole con questa figura del Vecchio Testamento avere isfogato in parte l'ardentissima sua passione. Né volse far altro mai per conto di detta fabbrica, né fu persona che non la pregasse ch'ella seguitar volesse, eccetto maestro Amico, che per l'invidia sempre la sconfortò e sempre ne disse male agli Operai, e fece tanto il maligno, che il suo lavoro le fu pagato un vilissimo prezzo. Fece ancor ella due Agnoli di grandissimo rilievo e di bella proporzione, ch'oggi si veggono, contra sua voglia però, nella medesima fabbrica. All'ultimo costei si diede ad intagliar stampe di rame e ciò fece fuor d'ogni biasimo e con grandissima lode. Finalmente alla povera innamorata giovane ogni cosa riuscì perfettissimamente, eccetto il suo infelicissimo amore.
Andò la fama di così nobile et elevato ingegno per tutt'Italia, et all'ultimo pervenne agli orecchi di papa Clemente VII, il quale, subito che coronato ebbe l'imperatore in Bologna, domandato di lei, trovò la misera donna esser morta quella medesima settimana et esser stata sepolta nello spedale della Morte, che così avea lasciato nel suo ultimo testamento. Onde al Papa, ch'era volenteroso di vederla, spiacque grandissimamente la morte di quella, ma molto più a' suoi cittadini, li quali mentre ella visse, la tennero per un grandissimo miracolo della natura ne' nostri tempi. Sono nel nostro libro alcuni disegni di mano di costei fatti di penna e ritratti dalle cose di Raffaello da Urbino, molto buoni, et il suo ritratto si è avuto da alcuni pittori che furono suoi amicissimi.
Ma non è mancato, ancor che ella disegnasse molto bene, chi abbia paragonato Properzia non solamente nel disegno, ma fatto così bene in pittura, com'ella di scultura. Di queste la prima è suor Plautilla, monaca et oggi priora nel monasterio di S. Caterina da Siena in Fiorenza in sulla piazza di San Marco. La quale cominciando a poco a poco a disegnare et ad imitar coi colori quadri e pitture di maestri eccellenti ha con tanta diligenza condotte alcune cose, che ha fatto maravigliare gl'artefici. Di mano di costei sono due tavole nella chiesa del detto monasterio di S. Caterina. Ma quella è molto lodata dove sono i Magi che adorano Gesù. Nel monasterio di S. Lucia di Pistoia è una tavola grande nel coro, nella quale è la Madonna col Bambino in braccio, San Tommaso, S. Agostino, S. Maria Maddalena, S. Caterina da Siena, S. Agnese, S. Caterina martire e S. Lucia. Et un'altra tavola grande di mano della medesima mandò di fuori lo spedalingo di Lemo. Nel reffettorio del detto monasterio di S. Caterina è un Cenacolo grande e nella sala del lavoro una tavola di mano della detta. E per le case de' gentiluomini di Firenze tanti quadri che troppo sarei lungo a volere di tutti ragionare. Una Nunziata in un gran quadro ha la moglie del signor Mondragone spagnuolo et un'altra simile ne ha Madonna Marietta de Fedini. Un quadretto di Nostra Donna è in S. Giovannino di Firenze. Et una predella d'altare è in S. Maria del Fiore, nella quale sono istorie della vita di S. Zanobi molto belle. E perché questa veneranda e virtuosa suora, inanzi che lavorasse tavole et opere d'importanza, attese a far di minio, sono di sua mano molti quadretti belli affatto in mano di diversi, dei quali non accade far menzione. Ma quelle cose di mano di costei sono migliori che ella ha ricavato da altri, nelle quali mostra che arebbe fatto cose maravigliose se, come fanno gl'uomini, avesse avuto commodo di studiare et attendere al disegno e ritrarre cose vive e naturali. E che ciò sia vero, si vede manifestamente in un quadro d'u-na Natività di Cristo, ritratto da uno che già fece il Bronzino a Filippo Salviati. Similmente, il vero di ciò si dimostra in questo: che nelle sue opere i volti e fattezze delle donne, per averne veduto a suo piacimento, sono assai migliori che le teste degli uomini non sono e più simili al vero. Ha ritratto in alcuna delle sue opere in volti di donne Madonna Gostanza de' Doni, stata ne' tempi nostri essempio d'incredibile bellezza et onestà, tanto bene, che da donna, in ciò per le dette cagioni non molto pratica, non si può più oltre desiderare.
Similmente ha con molta sua lode atteso al disegno et alla pittura et attende ancora, avendo imparato da Alessandro Allori allievo del Bronzino, Madonna Lucrezia figliuola di Messer Alfonso Quistelli dalla Mirandola e donna oggi del conte Clemente Pietra; come si può vedere in molti quadri e ritratti che ha lavorati di sua mano, degni d'esser lodati da ognuno. Ma Soffonisba Cremonese figliuola di Messer Amilcaro Angusciuola, ha con più studio e con miglior grazia che altra donna de' tempi nostri faticato dietro alle cose del disegno, perciò che ha saputo non pure disegnare, colorire e ritrarre di naturale e copiare eccellentemente cose d'altri, ma da sé sola ha fatto cose rarissime e bellissime di pittura. Onde ha meritato che Filippo re di Spagna, avendo inteso dal signor Duca d'Alba le virtù e meriti suoi, abbia mandato per lei e fattala condurre onoratissimamente in Ispagna, dove la tiene appresso la reina con grossa provisione e con stupor di tutta quella corte che ammira, come cosa maravigliosa, l'eccellenza di Soffonisba. E non è molto, che Messer Tommaso Cavalieri, gentiluomo romano, mandò al signor duca Cosimo (oltre una carta di mano del divino Michelagnolo dove è una Cleopatra) un'altra carta di mano di Sofonisba, nella quale è una fanciullina che si ride di un putto che piagne, perché avendogli ella messo inanzi un canestrino pieno di gambari, uno d'essi gli morde un dito. Del quale disegno non si può veder cosa più graziosa, né più simile al vero. Onde io in memoria della virtù di Sofonisba, poiché vi-vendo ella in Ispagna non ha l'Italia copia delle sue opere, l'ho messo nel nostro libro de' disegni. Possiamo dunque dire col divino Ariosto e con verità che:
Le donne son venute in eccellenza
di ciascun'arte ov'hanno posto cura.
E questo sia il fine della vita di Properzia, scultrice bolognese.
VITE D'ALFONSO LOMBARDI FERRARESE DI MICHELAGNOLO DA SIENA E DI GIROLAMO S. CROCE NAPOLETANO SCULTORI E DI DOSSO E BATTISTA PITTORI FERRARESI

Alfonso Ferrarese, lavorando nella sua prima giovanezza di stucchi e di cera, fece infiniti ritratti di naturale in medagliette piccole a molti signori e gentiluomini della sua patria; alcuni de' quali, che ancora si veggiono di cera e stucco bianchi, fanno fede del buon ingegno e giudizio ch'egli ebbe, come sono quello del principe Doria, d'Alfonso duca di Ferrara, di Clemente Settimo, di Carlo Quinto imperatore, del cardinale Ippolito de' Medici, del Bembo, dell'Ariosto e d'altri simili personaggi. Costui trovandosi in Bologna per la incoronazione di Carlo Quinto, dove aveva fatto per quello apparato gl'ornamenti della porta di S. Petronio, fu in tanta considerazione, per essere il primo che introducesse il buon modo di fare ritratti di naturale, in forma di medaglie, come si è detto, che non fu alcun grande uomo in quelle corti per lo quale egli non lavorasse alcuna cosa, con suo molto utile et onore. Ma non si contentando della gloria et utile che gli veniva dal fare opere di terra, di cera e di stucco, si mise a lavorar di marmo et acquistò tanto in alcune cose di non molta importanza che fece, che gli fu dato a lavorare in San Michele in Bosco fuori di Bologna la sepoltura di Ramazzotto, la quale gli acquistò grandissimo onore e fama. Dopo la quale opera, fece nella medesima città alcune storiette di marmo di mezzo rilievo all'arca di San Domenico nella predella dell'altare. Fece similmente per la porta di San Petronio in alcune storiette di marmo a man sinistra, entrando in chiesa, la Resurrezzione di Cristo, molto bella. Ma quello che ai Bolognesi piacque sommamente fu la morte di Nostra Donna in figure tonde di mistura e di stucco molto forte, nello spedale della Vita, nella stanza di sopra. Nella quale opera è fra l'altre cose maraviglioso il giudeo, che lascia appiccate le mani al cataletto della Madonna. Fece anco della medesima mistura nel palazzo publico di quella città, nella sala di sopra del governatore, un Ercole grande che ha sotto l'Idra morta. La quale statua fu fatta a concorrenza di Zacheria da Volterra, il quale fu di molto superato dalla virtù et eccellenza d'Alfonso. Alla Madonna del Baracane fece il medesimo due Angeli di stucco, che tengono un padiglione di mezzo rilievo; et in San Giuseppo nella nave di mezzo fra un arco e l'altro fece di terra in alcuni tondi i dodici Apostoli dal mezzo in su di tondo rilievo. Di terra parimente fece nella medesima città nei cantoni della volta della Madonna del Popolo, quattro figure maggiori del vivo; cioè S. Petronio, San Procolo, San Francesco e San Domenico, che sono figure bellissime e di gran maniera. Di mano del medesimo sono alcune cose pur di stucco a Castel Bolognese, et alcune altre in Cesena nella Compagnia di San Giovanni. Né si maravigli alcuno se in sin qui non si è ragionato che costui lavorasse quasi altro che terra, cera e stucchi e pochissimo di marmo, perché oltre che Alfonso fu sempre in questa maniera di lavori inclinato, passata una certa età, essendo assai bello di persona e d'aspetto giovinile, esercitò l'arte più per piacere e per una certa vanagloria, che per voglia di mettersi a scarpellare sassi. Usò sempre di portare alle braccia et al collo e ne' vestimenti, ornamenti d'oro et altre frascherie, che lo dimostravano più tosto uomo di corte lascivo e vano che artefice desideroso di gloria. E nel vero quanto risplendono cotali ornamenti in coloro ai quali per ricchezze, stati e nobiltà di sangue non disconvengono, tanto sono degni di biasimo negl'artefici et altre persone, che non deono, chi per un rispetto e chi per un altro, agguagliarsi a gl'uomini ricchissimi; perciò che in cambio d'esserne questi cotali lodati, sono dagl'uomini di giudizio meno stimati e molte volte scherniti. Alfonso dunque invaghito di se medesimo et usando termini e lascivie poco convenienti a virtuoso artefice, si levò con sì fatti costumi alcuna volta, tutta quella gloria che gl'aveva acquistato l'affaticarsi nel suo mestiero; perciò che trovandosi una sera a certe nozze in casa d'un conte in Bologna et avendo buona pezza fatto all'amore con una onoratissima gentildonna, fu per avventura invitato da lei al ballo della torcia: perché aggirandosi con essa, vinto da smania d'amore, disse con un profondissimo sospiro e con voce tremante, guardando la sua donna con occhi pieni di dolcezza:
“S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento?”
Il che udendo la gentildonna, che accortissima era, per mostrargli l'error suo, rispose: “È sarà qualche pidocchio”. La qual risposta, essendo udita da molti, fu cagione che s'empiesse di questo motto tutta Bologna e ch'egli ne rimanesse sempre scornato. E veramente se Alfonso avesse dato opera non alle vanità del mondo, ma alle fatiche dell'arte, egli avrebbe senza dubbio fatto cose maravigliose. Perché se ciò faceva in parte, non si essercitando molto, che averebbe fatto se avesse durato fatica?
Essendo il detto imperador Carlo Quinto in Bologna e venendo l'eccellentissimo Tiziano da Cadór a ritrarre Sua Maestà, venne in desiderio Alfonso di ritrarre anch'egli quel signore; né avendo altro commodo di potere ciò fare, pregò Tiziano senza scoprirgli quello che aveva in animo di fare, che gli facesse grazia di condurlo, in cambio d'un di coloro che gli portavano i colori, alla presenza di Sua Maestà. Onde Tiziano, che molto l'amava, come cortesissimo che è sempre stato veramente, condusse seco Alfonso nelle stanze dell'imperatore. Alfonso dunque, posto che si fu Tiziano a lavorare, se gl'accommodò dietro in guisa che non poteva da lui, che attentissimo badava al suo lavoro, esser veduto. E messo mano a una sua scatoleta in forma di medaglia, ritrasse in quella di stucco l'istesso imperadore e l'ebbe condotto a fine, quando appunto Tiziano ebbe finito anch'egli il suo ritratto. Nel rizzarsi dunque l'imperatore, Alfonso chiusa la scatola, se l'aveva, acciò Tiziano non la vedesse, già messa nella manica, quando dicendogli Sua Maestà: “Mostra quello che tu hai fatto”, fu forzato a dare umilmente quel ritratto in mano dell'imperatore, il quale avendo considerato e molto lodato l'opera, gli disse: “Bastarebbeti l'animo di farla di marmo?”. “Sacra Maestà, sì”, rispose Alfonso. “Falla dunque”, soggiunse l'imperatore, “e portamela a Genova.” Quanto paresse nuovo questo fatto a Tiziano, se lo può ciascuno per se stesso imaginare. Io per me credo che gli paresse avere messo la sua virtù in compromesso. Ma quello che più gli dovette parer strano, si fu che mandando Sua Maestà a donare mille scudi a Tiziano, gli commise che ne desse la metà, cioè cinquecento, ad Alfonso, e gl'altri cinquecento si tenesse per sé. Di che è da credere, che seco medesimo si dolesse Tiziano. Alfonso dunque messosi con quel maggiore studio che gli fu possibile a lavorare, condusse con tanta diligenza a fine la testa di marmo, che fu giudicata cosa rarissima. Onde meritò, portandola all'imperatore, che Sua Maestà gli facesse donare altri trecento scudi. Venuto Alfonso per i doni e per le lodi dategli da Cesare in riputazione, Ippolito cardinal de' Medici lo condusse a Roma, dove aveva appresso di sé, oltre agl'altri infiniti virtuosi, molti scultori e pittori; e gli fece da una testa antica molto lodata ritrarre in marmo Vitellio imperatore. Nella quale opera, avendo confirmata l'openione che di lui aveva il cardinale e tutta Roma, gli fu dato a fare dal medesimo in una testa di marmo il ritratto naturale di papa Clemente Settimo; e poco appresso quello di Giuliano de' Medici padre di detto cardinale; ma questa non restò del tutto finita. Le quali teste furono poi vendute in Roma e da me comperate a requisizione del Magnifico Ottaviano de' Medici, con alcune pitture. Et oggi dal signor duca Cosimo de' Medici sono state poste nelle stanze nuove del suo palazzo, nella sala dove sono state fatte da me nel palco e nelle facciate, di pittura, tutte le storie di papa Leone Decimo; sono state poste dico in detta sala sopra le porte fatte di quel mischio rosso che si truova vicino a Fiorenza, in compagnia d'altre teste d'uomini illustri della casa de' Medici.
Ma tornando ad Alfonso, egli seguitò poi di fare di scultura al detto cardinale molte cose, che per essere state piccole si sono smarrite. Venendo poi la morte di Clemente e dovendosi fare la sepoltura di lui e di Leone, fu ad Alfonso allogata quell'opera dal cardinale de' Medici. Per che avendo egli fatto sopra alcuni schizzi di Michelagnolo Buonarroti un modello con figure di cera, che fu tenuta cosa bellissima, se n'andò con danari a Carrara per cavare i marmi. Ma essendo non molto dopo morto il cardinale a Itri, essendo partito di Roma per andar in Africa, uscì di mano ad Alfonso quell'opera, perché da' cardinali Salviati, Ridolfi, Pucci, Cibò e Gaddi commessarii di quella, fu ributtato. E dal favore di Madonna Lucrezia Salviati, figliuola del gran Lorenzo Vecchio de' Medici e sorella di Leone, allogata a Baccio Bandinelli scultor fiorentino, che ne aveva, vivendo Clemente, fatto i modelli; per la qual cosa Alfonso mezzo fuor di sé, posta giù l'alterezza, deliberò tornarsene a Bologna, et arrivato a Fiorenza, donò al duca Alessandro una bellissima testa di marmo d'un Carlo Quinto imperatore, la quale è oggi in Carrara, dove fu mandata dal cardinale Cibò, che la cavò alla morte del duca Alessandro della guardaroba di quel signore. Era in umore il detto Duca, quando arrivò Alfonso in Fiorenza, di farsi ritrarre: perché, avendolo fatto Domenico di Polo, intagliatore di ruote, e Francesco di Girolamo dal Prato in medaglia, Benvenuto Cellini per le monete, e di pittura Giorgio Vasari aretino e Iacopo da Puntormo, volle che anco Alfonso lo ritraesse; perché, avendone egli fatto uno di rilievo molto bello e miglior assai di quello che avea fatto il Danese da Carrara, gli fu dato commodità, poiché ad ogni modo voleva andar a Bologna, di farne là un di marmo simile al modello. Avendo dunque Alfonso ricevuto molti doni e cortesie dal duca Alessandro, se ne tornò a Bologna; dove, essendo anco per la morte del cardinale poco contento e per la perdita delle sepolture molto dolente, gli venne una rogna pestifera et incurabile, che a poco a poco l'andò consumando fin che, condottosi a 49 anni della sua età, passò a miglior vita, continuamente dolendosi della fortuna che gl'avesse tolto un signore dal quale poteva sperare tutto quel bene che poteva farlo in questa vita felice; e che ella doveva pur prima chiuder gl'occhi a lui condottosi a tanta miseria,
che al cardinale Ippolito de' Medici.
Morì Alfonso l'anno 1536.
Michelagnolo scultore sanese, poi che ebbe consumato i suoi migliori anni in Schiavonia con altri eccellenti scultori, si condusse a Roma con questa occasione. Morto papa Adriano, il cardinale Hincfort, il quale era stato dimestico e creato di quel Pontefice, non ingrato de' benefizii da lui ricevuti deliberò di fargli una sepoltura di marmo e ne diede cura a Baldassarre Petrucci pittor sanese, il quale fattone il modello, volle che Michelagnolo scultore suo amico e compatriota ne pigliasse carico sopra di sé. Michelagnolo dunque fece in detta sepoltura esso papa Adriano grande quanto il vivo, disteso in sulla cassa e ritratto di naturale, e sotto a quello in una storia pur di marmo, la sua venuta a Roma et il popolo romano, che va a incontrarlo e l'adora. Intorno poi sono in quattro nicchie, quattro Virtù di marmo: la Giustizia, la Fortezza, la Pace e la Prudenza, tutte condotte con molta diligenza dalla mano di Michelagnolo e dal consiglio di Baldassarre; bene è vero che alcune delle cose che sono in quell'opera, furono lavorate dal Tribolo scultore fiorentino allora giovanetto, e queste fra tutte furono stimate le migliori. E perché Michelagnolo con sottilissima diligenza lavorò le cose minori di quell'opera, le figure piccole che vi sono meritano di essere più che tutte l'altre lodate. Ma fra l'altre cose vi sono alcuni mischi con molta pulitezza lavorati e commessi tanto bene, che più non si può desiderare. Per le quali fatiche fu a Michelagnolo dal detto cardinale donato giusto et onorato premio e poi sempre carezzato mentre che visse; e nel vero a gran ragione, perciò che questa sepoltura e gratitudine non ha dato minor fama al cardinale che a Michelagnolo si facesse nome in vita e fama dopo la morte. La quale opera finita non andò molto che Michelagnolo passò da questa all'altra vita d'anni cinquanta in circa.
Girolamo Santa Croce napolitano, ancor che nel più bel corso della sua vita, e quando di lui maggior cose si speravano, ci fusse dalla morte rapito, mostrò nell'opere di scultura, che in que' pochi anni fece in Napoli, quello che arebbe fatto se fusse più lungamente vivuto. L'opere, adunque, che costui lavorò di scultura in Napoli, furono con quell'amore condotte e finite, che maggiore si può desiderare in un giovane che voglia di gran lunga avanzar gl'altri che abbiano inanzi a lui tenuto in qualche nobile esercizio molti anni il principato. Lavorò costui in San Giovanni Carbonaro di Napoli la capella del marchese di Vico, la quale è un tempio tondo, partito in colonne e nicchie, con alcune sepolture intagliate con molta diligenza. E perché la tavola di questa capella, nella quale sono di mezzo rilievo in marmo i Magi che offeriscono a Cristo, è di mano d'uno Spagnuolo, Girolamo fece a concorrenza di quella un San Giovanni di tondo rilievo in una nicchia così bello che mostrò non esser inferiore allo Spagnuolo né d'animo, né di giudizio; onde si acquistò tanto nome, che ancor che in Napoli fusse tenuto scultore maraviglioso, e di tutti migliore Giovanni da Nola, egli nondimeno lavorò mentre Giovanni visse a sua concorrenza, ancor che Giovanni fusse già vecchio et avesse in quella città, dove molto si costuma fare le capelle e le tavole di marmo, lavorato moltissime cose. Prese dunque Girolamo per concorrenza di Giovanni a fare una capella in Monte Oliveto di Napoli dentro la porta della chiesa a man manca, dirimpetto alla quale ne fece un'altra dall'altra banda Giovanni del medesimo componimento. Fece Girolamo nella sua una Nostra Donna quanto il vivo tutta tonda, che è tenuta bellissima figura. E perché misse infinita diligenza nel fare i panni, le mani e spiccare con straforamenti il marmo, la condusse a tanta perfezzione che fu openione che egli avesse passato tutti coloro che in Napoli avevano adoperato al suo tempo ferri per lavorare di marmo. La qual Madonna pose in mezzo a un S. Giovanni et un San Piero, figure molto bene intese e con bella maniera lavorate e finite, come sono anco alcuni fanciulli che sono sopra queste collocati. Fece oltre ciò nella chiesa di Capella, luogo de' monaci di Monte Oliveto, due statue grandi di tutto rilievo, bellissime. Dopo cominciò una statua di Carlo Quinto imperatore, quando tornò da Tunisi, e quella abbozzata e subbiata in alcuni luoghi, rimase gradinata; perché la fortuna e la morte invidiando al mondo tanto bene, ce lo tolsero d'anni trentacinque. E certo se Girolamo vivea, si sperava che sì come aveva nella sua professione avanzati tutti quelli della sua patria, così avesse a superare tutti gl'artefici del tempo suo. Onde dolse a' Napoletani infinitamente la morte di lui e tanto più, quanto egli era stato dalla natura dotato, non pure di bellissimo ingegno, ma di tanta modestia, umanità e gentilezza, quanto più non si può in uomo desiderare; per che non è maraviglia, se tutti coloro che lo conobbono quando di lui ragionano non possono tenere le lacrime. L'ultime sue sculture furono l'anno 1537, nel quale anno fu sotterrato in Napoli con onoratissime essequie, rimanendo anco vivo il detto Giovanni da Nola vecchio et assai pratico scultore, come si vede in molte opere fatte in Napoli con buona pratica, ma con non molto disegno. A costui fece lavorare don Petro di Tolledo marchese di Villafranca et allora vece re di Napoli, una sepoltura di marmo per sé e per la sua donna; nella quale opera fece Giovanni una infinità di storie delle vittorie ottenute da quel signore contra i Turchi, con molte statue, che sono in quell'opera tutta isolata, e condotta con molta diligenza. Doveva questo sepolcro esser portato in Ispagna, ma non avendo ciò fatto mentre visse quel signore, si rimase in Napoli.
Morì Giovanni d'anni settanta e fu sotterrato in Napoli l'anno 1558.
Quasi ne' medesimi tempi che il cielo fece dono a Ferrara, anzi al mondo, del divino Lodovico Ariosto, nacque il Dosso pittore nella medesima città, il quale, se bene non fu così raro tra i pittori come l'Ariosto tra i poeti, si portò non di meno per sì fatta maniera nell'arte, che oltre all'essere state in gran pregio le sue opere in Ferrara, meritò anco che il dotto poeta amico e dimestico suo facesse di lui onorata memoria ne' suoi celebratissimi scritti. Onde al nome del Dos-so ha dato maggior fama la penna di Messer Lodovico, che non fecero tutti i pennelli e colori che consumò in tutta sua vita. Onde io per me confesso che grandissima ventura è quella di coloro che sono da così grandi uomini celebrati; perché il valor della penna sforza infiniti a dar credenza alle lodi di quelli, ancor che interamente non le meritino.
Fu il Dosso molto amato dal duca Alfonso di Ferrara, prima per le sue qualità nell'arte della pittura e poi per essere uomo affabile molto e piacevole, della quale maniera d'uomini molto si dilettava quel Duca. Ebbe in Lombardia nome il Dosso di far meglio i paesi che alcun altro che di quella pratica operasse, o in muro o a olio o a guazzo; massimamente da poi che si è veduta la maniera tedesca. Fece in Ferrara nella chiesa catedrale una tavola con figure a olio, tenuta assai bella, e lavorò nel palazzo del Duca molte stanze in compagnia d'un suo fratello detto Battista, i quali sempre furono nimici l'uno dell'altro, ancor che per voler del Duca lavorassero insieme. Fecero di chiaro scuro nel cortile di detto palazzo istorie d'Ercole et una infinità di nudi per quelle mura. Similmente per tutta Ferrara lavorarono molte cose in tavola et in fresco. E di lor mano è una tavola del Duomo di Modena. Et in Trento nel palazzo del cardinale in compagnia d'altri pittori fecero molte cose di lor mano. Ne' medesimi tempi, facendo Girolamo Genga pittore et architettore, per il duca Francesco Maria d'Urbino sopra Pesero al palazzo dell'imperiale molti ornamenti, come al suo luogo si dirà, fra molti pittori, che a quell'opera furono condotti per ordine del detto signor Francesco Maria, vi furono chiamati Dos-so e Battista ferraresi, massimamente per far paesi, avendo molto innanzi fatto in quel palazzo molte pitture Francesco di Mirozzo da Forlì, Raffaello dal Colle del Borgo a Sansepolcro e molti altri. Arrivati dunque il Dosso e Battista al-l'imperiale, come è usanza di certi uomini così fatti, biasimarono la maggior parte di quelle cose che videro e promessero a quel signore di voler essi fare cose molto migliori; per che il Genga, che era persona accorta, vedendo dove la cosa doveva riuscire, diede loro a dipignere una camera da per loro. Onde essi messesi a lavorare si sforzarono con ogni fati-ca e studio di mostrare la virtù loro. Ma qualunque si fusse di ciò la cagione, non fecero mai in tutto il tempo di lor vita alcuna cosa meno lodevole, anzi peggio di quella. E pare che spesso avvenga che gl'uomini nei maggior bisogni e quando sono in maggior aspettazione, abagliandosi et acecandosi il giudizio, facciano peggio che mai: il che può forse avvenire dalla loro malignità e cattiva natura di biasimare sempre le cose altrui o dal troppo volere sforzare l'ingegno; essendo che nell'andar di passo e come porge la natura, senza mancar però di studio e diligenza, pare che sia miglior modo che il voler cavar le cose quasi per forza dell'ingegno, dove non sono; donde è vero che anco nell'altre arti e massimamente negli scritti, troppo bene si conosce l'affettazione e per dir così il troppo studio in ogni cosa. Scopertasi dunque l'opera dei Dossi, ella fu di maniera ridicola che si partirono con vergogna da quel signore; il quale fu forzato a buttar in terra tutto quello che avevano lavorato e farlo da altri ridipignere con il disegno del Genga. In ultimo fecero costoro nel duomo di Faenza per Messer Giovambattista cavaliere de' Buosi una molto bella tavola d'un Cristo che disputa nel tempio, nella quale opera vinsero se stessi, per la nuova maniera che vi usarono e massimamente nel ritratto di detto cavaliere e d'altri. La qual tavola fu posta in quel luogo l'anno 1536. Finalmente divenuto Dosso già vecchio, consumò gl'ultimi anni senza lavorare, essendo insino all'ultimo della vita provisionato dal duca Alfonso. Finalmente dopo lui rimase Battista, che lavorò molte cose da per sé, mantenendosi in buono stato. E Dosso fu sepellito in Ferrara sua patria.
Visse ne' tempi medesimi il Bernazzano Milanese, eccellentissimo per far paesi, erbe, animali et altre cose terrestri, volatili et acquatici. E perché non diede molta opera alle figure, come quello che si conosceva imperfetto, fece compagnia con Cesare da Sesto, che le faceva molto bene e di bella maniera. Dicesi che il Bernazzano fece in un cortile a fresco certi paesi molto belli e tanto bene imitati, che essendovi dipinto un fragoleto pieno di fragole mature, acerbe e fiorite, alcuni pavoni ingannati dalla falsa apparenza di quelle, tanto spesso tornarono a beccarle che bucarono la calcina dell'intonaco.
VITA DI GIOVANNI ANTONIO LICINIO DA PORDENONE E D'ALTRI PITTORI DEL FRIULI

Pare, sì come si è altra volta a questo proposito ragionato, che la natura benigna, madre di tutti, faccia alcuna fiata dono di cose rarissime ad alcuni luoghi, che non ebbero mai di cotali cose alcuna conoscenza; e ch'ella faccia anco talora nascere in un paese di maniera gl'uomini inclinati al disegno et alla pittura, che senza altri maestri, solo imitando le cose vive e naturali, divengono eccellentissimi. Ed adiviene ancora bene spesso che, cominciando un solo, molti si mettono a far a concorrenza di quello, e tanto si affaticano senza veder Roma, Fiorenza o altri luoghi pieni di notabili pitture, per emulazione l'un dell'altro, che si veggiono da loro uscir opere maravigliose. Le quali cose si veggiono essere avvenute nel Friuli particularmente, dove sono stati a' tempi nostri, (il che non si era veduto in que' paesi per molti secoli), infiniti pittori eccellenti mediante un così fatto principio.
Lavorando in Vinezia, come si è detto, Giovan Bellino, et insegnando l'arte a molti, furono suoi discepoli, et emuli fra loro, Pellegrino da Udine, che fu poi chiamato, come si dirà, da San Daniello, e Giovanni Martini da Udine. Per ragionar dunque primieramente di Giovanni, costui imitò sempre la maniera del Bellini, la quale era crudetta, tagliente e secca tanto, che non poté mai addolcirla, né far morbida, per pulito e diligente che fusse; e ciò poté avvenire perché andava dietro a certi riflessi barlumi et ombre che, dividendo in sul mezzo de' rilievi, venivano a terminare l'ombre coi lumi a un tratto, in modo che il colorito di tutte l'opere sue fu sempre crudo e spiacevole, se bene si affaticò per imitar con lo studio e con l'arte la natura.
Sono di mano di costui molte opere nel Friuli in più luoghi, e particularmente nella città d'Udine, dove nel Duomo è in una tavola lavorata a olio un San Marco che siede con molte figure attorno, e questa è tenuta di quante mai ne fece la migliore. Un'altra n'è nella chiesa de' frati di S. Pier martire all'altare di S. Orsola, nella quale è la detta Santa in piedi con alcune delle sue vergini intorno, fatte con bella grazia et arie di volti. Costui, oltre all'esser stato ragionevole dipintore, fu dotato dalla natura di bellezza e grazia di volto e d'ottimi costumi e, che è da stimare assai, di sì fatta prudenza e governo, che lasciò dopo la sua morte erede di molte facultà la sua donna per non aver figliuoli maschi; la quale, essendo non meno prudente, secondo che ho inteso, che bella donna, seppe in modo vivere dopo la morte del marito, che maritò due sue bellissime figliuole nelle più ricche e nobili case di Udine.
Pellegrino da S. Daniello, il quale, come si è detto, fu concorrente di Giovanni e fu di maggior eccellenza nella pittura, ebbe nome al battesimo Martino. Ma facendo giudizio Giovan Bellino che dovesse riuscir quello che poi fu, nel-l'arte veramente raro, gli cambiò il nome di Martino in Pellegrino. E come gli fu mutato il nome, così gli fu dal caso quasi assegnata altra patria: perché stando volentieri a San Daniello, castello lontano da Udine dieci miglia, et avendo in quello preso moglie e dimorandovi il più del tempo, fu non Martino da Udine, ma Pellegrino da San Daniello poi sempre chiamato. Fece costui in Udine molte pitture, delle quali ancora si veggiono i portegli dell'organo vecchio, nelle facce de' quali, dalla banda di fuori, è finito uno sfondato d'un arco in prospettiva, dentro al quale è San Piero che siede fra una moltitudine di figure e porge un pasturale a Santo Ermacora vescovo. Fece parimente nel didentro di detti sportelli, in alcuni sfondati, i quattro Dottori della Chiesa in atto di studiare. Nella capella di S. Gioseffo fece una tavola a olio disegnata e colorita con molta diligenza, dentro la quale è nel mezzo detto San Giuseppo in piedi con bell'attitudine e posar grave; et appresso a lui il Nostro Signor piccol fanciullo, et a basso San Giovanni Battista in abito di pastorello et intentissimo nel suo Signore. E perché questa tavola è molto lodata, si può credere quello che si dice, cioè che egli la facesse a concorrenza del detto Giovanni e che vi mettesse ogni studio per farla, come fu, più bella che quella che esso Giovanni fece del San Marco, come si è detto di sopra. Fece anco Pellegrino in Udine in casa Messer Pré Giovanni, agente degl'illustri signori della Torre, una Giuditta dal mezzo in su in un quadro, con la testa di Oloferne in una mano, che è cosa bellissima. Vedesi di mano del medesimo nella terra di Civitale, lontano a Udine otto miglia, nella chiesa di
S. Maria, sopra l'altare maggiore, una tavola grande a olio compartita in più quadri, dove sono alcune teste di vergini et altre figure con molta bell'aria. E nel suo castello di San Daniello dipinse a S. Antonio, in una capella a fresco, istorie della Passione di Gesù Cristo molto eccellentemente; onde meritò che gli fusse pagata quell'opera più di mille scudi. Fu costui per le sue virtù molto amato dai duchi di Ferrara, et oltre agl'altri favori e molti doni, ebbe per lor mezzo due canonicati nel Duomo d'Udine per alcuni suoi parenti.
Fra gl'allievi di costui, che furono molti e de' quali si servì pur assai ristorandogli largamente, fu assai valente uno di nazione greco, che ebbe bellissima maniera e fu molto imitatore di Pellegrino. Ma sarebbe stato a costui superiore Luca Monverde da Udine, che fu molto amato da Pellegrino, se non fusse stato levato dal mondo troppo presto e giovanetto affatto. Pure rimase di sua mano una tavola a olio, che fu la prima e l'ultima, sopra l'altare maggiore di S. Maria delle Grazie in Udine, dentro la quale, in uno sfondato in prospettiva, siede in alto una Nostra Donna col Figliuolo in collo, la quale fece dolcemente sfuggire, e nel piano da basso sono due figure per parte, tanto belle, che ne dimostrano che se più lungamente fusse vivuto sarebbe stato eccellentissimo.
Fu discepolo del medesimo Pellegrino, Bastianello Florigorio, il quale fece in Udine sopra l'altar maggiore di S. Giorgio, in una tavola, una Nostra Donna in aria con infinito numero di putti, che in varii gesti la circondano adorando il Figliuolo, ch'ella tiene in braccio sotto un paese molto ben fatto. Vi è anco un S. Giovanni molto bello e S. Giorgio armato sopra un cavallo che, scortando in attitudine fiera, amazza con la lancia il serpente mentre la donzella, che è là da canto, pare che ringrazii Dio e la gloriosa Vergine del soccorso mandatogli. Nella testa del San Giorgio, dicono che Bastianello ritrasse se medesimo. Dipinse anco a fresco nel reffettorio de' frati di San Pier Martire due quadri: in uno è Cristo che, essendo in Emaus a tavola con i due discepoli, parte con la benedizzione il pane; nell'altro è la morte di S. Piero Martire. Fece il medesimo sopra un canto del palazzo di Messer Marguando eccellente dottore, in un nicchio a fresco, uno ignudo in iscorto per un San Giovanni, che è tenuto buona pittura. Finalmente costui per certe quistioni fu forzato, per viver in pace, partirsi di Udine, e come fuoriuscito starsi in Civitale. Ebbe Bastiano la maniera cruda e tagliente, perché si dilettò assai di ritrarre rilievi e cose naturali a lume di candela; fu assai bello inventore e si dilettò molto di fare ritratti di naturale, belli in vero e molto simili. Et in Udine fra gl'altri fece quello di Messer Raffaello Belgrado, e quello del padre di Messer Giovambattista Grassi pittore et architettore eccellente, dalla cortesia et amorevolezza del quale avemo avuto molti particolari avisi delle cose che scriviamo del Friuli. Visse Bastianello circa anni quaranta.
Fu ancora discepolo di Pellegrino, Francesco Floreani da Udine, che vive et è bonissimo pittore et architetto; sì come è anco Antonio Floriani suo fratello più giovane, il quale per le sue rare qualità in questa professione, serve oggi la cesarea maestà di Massimiano imperatore. Delle pitture del qual Francesco Floriani si videro alcune due anni sono nelle mani del detto imperatore allora re; cioè una Giuditta che ha tagliato il capo a Oloferne, fatta con mirabile giudizio e diligenza. Et appresso del detto, è di mano del medesimo un libro disegnato di penna, pieno di belle invenzioni, di fabriche, teatri, archi, portici, ponti, palazzi et altre molte cose d'architettura utili e bellissime. Gensio Liberale fu anch'e-gli discepolo di Pellegrino, e fra l'altre cose imitò nelle sue pitture ogni sorte di pesci eccellentemente. Costui è oggi al servizio di Ferdinando arciduca d'Austria in bonissimo grado e meritamente, per essere ottimo pittore.
Ma fra i più chiari e famosi pittori del paese del Friuli, il più raro e celebre è stato ai giorni nostri, per avere passato di gran lunga i sopra detti nell'invenzione delle storie, nel disegno, nella bravura, nella pratica de' colori, nel lavoro a fresco, nella velocità, nel rilievo grande et in ogni altra cosa delle nostre arti, Giovanni Antonio Licinio da altri chiamato Cuticello. Costui nacque in Pordenone, castello del Friuli, lontano da Udine 25 miglia. E perché fu dotato dalla natura di bello ingegno et inclinato alla pittura, si diede senza altro maestro a studiare le cose naturali, imitando il fare di Giorgione da Castelfranco, per essergli piaciuta assai quella maniera da lui veduta molte volte in Venezia. Avendo dunque costui apparato i principii dell'arte, fu forzato, per campare la vita da una mortalità venuta nella sua patria, cansarsi. E così, trattenendosi molti mesi in contado, lavorò per molti contadini diverse opere in fresco, facendo a spese loro esperimento del colorire sopra la calcina; onde avvenne, perché il più sicuro e miglior modo d'imparar è nella pratica e nel far assai, che si fece in quella sorte di lavoro pratico e giudizioso; et imparò a fare che i colori, quando si lavorano molli, per amor del bianco, che secca la calcina e rischiara tanto che guasta ogni dolcezza, facessero quello effetto che altri vuole. E così conosciuta la natura de' colori, et imparato con lunga pratica a lavorar benissimo in fresco, si ritornò a Udine, dove nel convento di S. Pier Martire fece all'altar della Nunziata una tavola a olio, dentrovi la Nostra Donna quando è salutata dall'angelo Gabriello; e nell'aria fece un Dio Padre, che circondato da molti putti, manda lo Spirito Santo. Questa opera, che è lavorata con disegno, grazia, vivezza e rilievo, è da gl'artefici intendenti tenuti la miglior opera che mai facesse costui. Nel Duomo della detta città fece pur a olio nel pergamo dell'organo sotto i portegli già dipinti da Pellegrino, una storia di S. Ermacora e Fortunato piena di leggiadria e disegno. Nella città medesima, per farsi amici i signori Tinghi, dipinse a fresco la facciata del palazzo loro. Nella quale opera, per farsi conoscere e mostrare quanto valesse nell'invenzioni d'architettura e nel lavorar a fresco, fece alcuni spartimenti et ordini di varii ornamenti pieni di figure in nicchie; et in tre vani grandi, posti in mezzo di quello, fece storie di figure colorite, cioè due stretti et alti dalle bande, et uno di forma quadra nel mezzo. Et in questo fece una colonna corinta, posata col suo basamento in mare, alla destra della quale è una sirena, che tiene in piedi ritta la colonna, et alla sinistra Nettuno ignudo, che la regge dall'altra parte. E sopra il capitello di detta colonna è un capello da cardinali, impresa, per quanto si dice, di Pompeo Colonna, che era amicissimo dei signori di quel palazzo. Negl'altri due quadri sono i giganti fulminati da Giove, con alcuni corpi morti in terra molto ben fatti et in iscorti bellissimi. Dall'altra parte è un cielo pieno di dèi, et in terra due giganti che con bastoni in mano stanno in atto di ferir Diana; la quale, con atto vivace e fiero difendendosi, con una face accesa mostra di voler accender le braccia a un di loro.
In Spelimbergo, castel grosso sopra Udine quindici miglia, è dipinto nella chiesa grande di mano del medesimo il pulpito dell'organo et i portigli, cioè nella facciata dinanzi in uno l'assunta di Nostra Donna, e nel didentro San Piero e San Paulo innanzi a Nerone guardanti Simon Mago in aria. Nell'altro è la conversione di S. Paulo, e nel pulpito la natività di Cristo. Per questa opera, che è bellissima, e molte altre, venuto il Pordenone in credito e fama, fu condotto a Piacenza, donde, poi che vi ebbe lavorate alcune cose, se n'andò a Mantoa, dove a Messer Paris gentiluomo di quella città colorì a fresco una facciata di muro con grazia maravigliosa. E fra l'altre belle invenzioni che sono in questa opera è molto lodevole, a sommo sotto la cornice, un fregio di lettere antiche alte un braccio e mezzo, fra le quali è un numero di fanciulli che passano fra esse in varie attitudini, e tutti bellissimi. Finita quest'opera con suo molto onore ritornò a Piacenza, e quivi, oltre molti altri lavori, dipinse in S. Maria di Campagna tutta la tribuna, se bene una parte ne rimase imperfetta per la sua partita; che fu poi con diligenza finita da maestro Bernardo da Vercelli. Fece in detta chiesa due capelle a fresco: in una storie di S. Caterina, e nell'altra la natività di Cristo et adorazione de' Magi, ambedue lodatissime. Dipinse poi nel bellissimo giardino di Messer Bernaba dal Pozzo dottore alcuni quadri di poesia, e nella detta chiesa di Campagna la tavola di Sant'Agostino, entrando in chiesa, a man sinistra. Le quali tutte bellissime opere furono cagione che i gentiluomini di quella città gli facessero in essa pigliar donna e l'avessero sempre in somma venerazione. Andando poi a Vinezia, dove aveva prima fatto alcun'opere, fece in San Geremia sul canal grande una facciata; nella Madonna dell'Orto una tavola a olio con molte figure. Ma particularmente in S. Giovanni Battista si sforzò di mostrare quanto valesse. Fece anco, in sul detto canal grande, nella facciata della casa di Martin d'Anna molte storie a fresco, et in particolare un Curzio a cavallo in iscorto, che pare tutto tondo e di rilievo; sì come è anco un Mercurio, che vola in aria per ogni lato, oltre a molte altre cose tutte ingegnose. La quale opera piacque sopra modo a tutta la città di Vinezia, e fu perciò Pordenone più lodato che altro uomo mai in quella città avesse insino allora lavorato. Ma fra l'altre cose che fecero a costui mettere incredibile studio in tutte le sue opere, fu la concorrenza dell'eccellentissimo Tiziano; perché mettendosi a garreggiare seco, si prometteva mediante un continuo studio e fiero modo di lavorare a fresco con prestezza, levargli di mano quella grandezza che Tiziano con tante belle opere si avea acquistato, aggiugnendo alle cose del-l'arte anco modi straordinarii mediante l'esser affabile e cortese, e praticar continuamente a bella posta con uomini grandi, col suo essere universale e mettere mano in ogni cosa. E di vero questa concorrenza gli fu di giovamento, perché ella gli fece mettere in tutte l'opere quel maggiore studio e diligenza che potette, onde riuscirono degne d'eterna lo-de. Per queste cagioni adunque gli fu dai soprastanti di S. Rocco data a dipignere in fresco la capella di quella chiesa con tutta la tribuna. Perché messovi mano, fece in quest'opera un Dio Padre nella tribuna et una infinità di fanciulli che da esso si partono con belle e variate attitudini. Nel fregio della detta tribuna, fece otto figure del Testamento Vecchio, e negl'angoli i quattro Evangelisti, e sopra l'altar maggiore la Trasfigurazione di Cristo, e ne' due mezzi tondi dalle bande sono i quattro Dottori della Chiesa. Di mano del medesimo sono a mezza la chiesa due quadri grandi: in uno è Cristo che risana una infinità d'infermi, molto ben fatti, e nell'altra è un San Cristoforo che ha Gesù Cristo sopra le spalle. Nel tabernacolo di legno di detta chiesa, dove si conservano l'argenterie, fece un S. Martino a cavallo con molti poveri che porgono voti sotto una prospettiva. Questa opera, che fu lodatissima, e gli acquistò onore et utile, fu cagione che Mes-ser Iacopo Soranzo, fattosi amico e dimestico suo, gli fece allogare a concorrenza di Tiziano la sala de' Pregai, nella quale fece molti quadri di figure che scortano al disotto in su, che sono bellissime; e similmente un fregio di mostri marini lavorati a olio intorno a detta sala. Le quali cose lo renderono tanto caro a quel Senato, che mentre visse ebbe sempre da loro onorata provisione. E perché gareggiando cercò sempre di far opere in luoghi dove avesse lavorato Tiziano, fece in S. Giovanni di Rialto un S. Giovanni elemosinario che a' poveri dona danari; et a un altare pose un quadro di S. Bastiano e S. Rocco et altri santi che fu cosa bella, ma non però eguale all'opera di Tiziano; se bene molti, più per malignità che per dire il vero, lodarono quella di Giovan Antonio. Fece il medesimo nel chiostro di S. Stefano molte storie in fresco del Testamento Vecchio et una del Nuovo, tramezzate da diverse Virtù, nelle quali mostrò scorti terribili di figure; del qual modo di fare si dilettò sempre e cercò di porne in ogni suo componimento, e difficilissime, adornandole meglio che alcun'altro pittore.
Avendo il prencipe Doria in Genova fatto un palazzo su la marina, et a Perin del Vaga pittor celebratissimo fatto far sale, camere et anticamere a olio et a fresco, che per la ricchezza e per la bellezza delle pitture sono maravigliosissime, perché in quel tempo Perino non frequentava molto il lavoro, acciò che per isprone e per concorrenza facesse quel che non faceva per se medesimo, fece venire il Pordenone, il quale cominciò uno terrazzo scoperto dove lavorò un fregio di fanciulli con la sua solita maniera, i quali votano una barca piena di cose maritime, che girando fanno bellissime attitudini. Fece ancora una storia grande quando Giasone chiede licenza al zio per andare per il vello d'oro. Ma il Prencipe, vedendo il cambio che faceva dall'opera di Perino a quella del Pordenone, licenziatolo, fece venir in suo luogo Domenico Beccafumi sanese, eccellente e più raro maestro di lui. Il quale, per servire tanto Prencipe, non si curò d'abbando-nare Siena sua patria dove sono tante opere maravigliose di sua mano. Ma in quel luogo non fece se non una storia sola e non più, perché Perino condusse ogni cosa da sé ad ultimo fine.
A Giovanni Antonio dunque, ritornato a Vinegia, fu fatto intendere come Ercole, duca di Ferrara, aveva condotto di Alemagna un numero infinito di maestri, et a quegli fatto cominciare a far panni di seta, d'oro, di filaticci e di lana, secondo l'uso e voglia sua, ma che non avendo in Ferrara disegnatori buoni di figure (perché Girolamo da Ferrara era più atto a' ritratti et a cose appartate, che a storie terribili dove bisognasse la forza dell'arte e del disegno) che andasse a ser-vire quel signore; ond'egli, non meno desideroso d'acquistare fama che facultà, partì da Vinegia, e nel suo giugner a Ferrara dal Duca fu ricevuto con molte carezze. Ma poco dopo la sua venuta, assalito da gravissimo affanno di petto, si pose nel letto per mezzo morto; dove, aggravando del continuo, in tre giorni o poco più, senza potervisi rimediare, d'anni 56 finì il corso della sua vita. Parve ciò cosa strana al Duca e similmente agli amici di lui. E non mancò chi per molti mesi credesse lui di veleno esser morto. Fu sepolto il corpo di Giovan Antonio onorevolmente, e della morte sua n'increbbe a molti, et in Vinegia specialmente. Perciò che Giovanni Antonio aveva prontezza nel dire, era amico e compagno di molti e si dilettava della musica, e perché aveva dato opera alle lettere latine, aveva prontezza e grazia nel dire. Costui fece sempre le sue figure grandi, fu ricchissimo d'invenzioni et universale in fingere bene ogni cosa; ma sopratutto fu risoluto e prontissimo nei lavori a fresco.
Fu suo discepolo Pomponio Amalteo da S. Vito, il quale per le sue buone qualità meritò d'esser genero del Pordenone. Il quale Pomponio, seguitando sempre il suo maestro nelle cose dell'arte, si è portato molto bene in tutte le sue opere, come si può vedere in Udine nei portigli degl'organi nuovi, dipinti a olio. Sopra i quali nella faccia di fuori è Cristo che caccia i negozianti del tempio, e dentro è la storia della probatica piscina con la resurrezione di Lazzero. Nella chiesa di S. Francesco della medesima città è di mano del medesimo in una tavola a olio un S. Francesco che riceve le stimmate, con alcuni paesi bellissimi, et un levare di sole che manda fuori di mezzo a certi razzi lucidissimi il serafico lume, che passa le mani, i piedi et il costato a San Francesco; il quale, stando ginocchioni divotamente e pieno d'amore, lo riceve, mentre il compagno si sta posato in terra in iscorto tutto pieno di stupore. Dipinse ancora in fresco Pomponio ai frati della Vigna, in testa del reffettorio, Gesù Cristo in mezzo ai due discepoli in Emaus. Nel castello di S. Vito sua patria, lontano da Udine venti miglia, dipinse a fresco nella chiesa di S. Maria la capella di detta Madonna, con tanto bella maniera e sodisfazzione d'ognuno, che ha meritato dal reverendissimo cardinale Maria Grimani, patriarca d'Aqui-leia e signor di S. Vito, esser fatto de' nobili di quel luogo.
Ho voluto in questa vita del Pordenone far memoria di questi eccellenti artefici del Friuli, perché così mi pare che meriti la virtù loro; e perché si conosca nelle cose che si diranno, quanto, dopo questo principio, siano coloro che sono stati poi molto più eccellenti, come si dirà nella vita di Giovanni Ricamatori da Udine, al quale ha l'età nostra, per gli stucchi e per le grottesche, obligo grandissimo.
Ma tornando al Pordenone, dopo le cose che si sono dette di sopra state da lui lavorate in Vinezia al tempo del serenissimo Gritti, si morì, come è detto, l'anno 1540. E perché costui è stato de' valenti uomini che abbia avuto l'età nostra, apparendo massimamente le sue figure tonde e spiccate dal muro e quasi di rilievo, si può fra quelli annoverare, che hanno fatto augumento all'arte e benefizio all'universale.
VITA DI GIOVANNI ANTONIO SOGLIANI
PITTOR FIORENTINO

Spesse volte veggiamo negl'esercizii delle lettere e nell'arti ingegnose manuali, quelli che sono maninconici essere più assidui agli studii e con maggior pacienza sopportare i pesi delle fatiche; onde rari sono coloro di questo umore, che in cotali professioni non rieschino eccellenti; come fece Giovanni Antonio Sogliani pittor fiorentino. Il quale era tanto nell'aspetto freddo e malinconico, che parea la stessa malinconia; e poté quell'umore talmente in lui, che dalle cose del-l'arte in fuori pochi altri pensieri si diede, eccetto che delle cure famigliari, nelle quali egli sopportava gravissima passione, quantunche avesse assai comodamente da ripararsi.
Stette costui con Lorenzo di Credi all'arte della pittura ventiquattro anni, e con esso lui visse onorandolo sempre et osservandolo con ogni qualità d'ufficii. Nel qual tempo fattosi bonissimo pittore, mostrò poi in tutte l'opere essere fidelissimo discepolo di quello et imitatore della sua maniera: come si conobbe nelle sue prime pitture, nella chiesa dell'Os-servanza sul poggio di S. Miniato fuor di Firenze. Nella quale fece una tavola di ritratto, simile a quella che Lorenzo avea fatto nelle monache di S. Chiara, dentrovi la natività di Cristo, non manco buona che quella di Lorenzo.
Partito poi dal detto suo maestro, fece nella chiesa di San Michele in Orto, per l'Arte de' vinattieri, un S. Martino a olio in abito di vescovo, il quale gli diede nome di bonissimo maestro. E perché ebbe Gioanni Antonio in somma venerazione l'opere e la maniera di fra' Bartolomeo di S. Marco, e fortemente a essa cercò nel colorito d'accostarsi, si vede in una tavola, che egli abbozzò e non finì, non gli piacendo, che egli lo imitò molto. La quale tavola si tenne in casa mentre visse, come inutile. Ma dopo la morte di lui, essendo venduta per cosa vecchia a Sinibaldo Gaddi, egli la fece finire a Santi Tidi dal Borgo, allora giovinetto, e la pose in una sua cappella nella chiesa di S. Domenico da Fiesole. Nella quale tavola sono i Magi che adorano Gesù Cristo in grembo alla madre, et in un canto è il suo ritratto di naturale, che lo somiglia assai.
Fece poi per madonna Alfonsina, moglie di Pietro de' Medici, una tavola che fu posta per voto sopra l'altar della capella de' Martiri nella chiesa di Camaldoli di Firenze. Nella qual tavola fece S. Arcadio crucifisso et altri martiri con le croci in braccio, e due figure mezze coperte di panni et il resto nudo e ginocchioni con le croci in terra, et in aria sono alcuni puttini con palme in mano. La quale tavola, che fu fatta con molta diligenza e condotta con buon giudizio nel colorito e nelle teste, che sono vivaci molto, fu posta in detta chiesa di Camaldoli. Ma essendo quel monasterio, per l'assedio di Firenze, tolto a que' padri romiti, che santamente in quella chiesa celebravano i divini ufficii, e poi data alle monache di S. Giovannino dell'Ordine de' Cavalieri Ierosolimitani, et ultimamente stato rovinato, fu la detta tavola per ordine del signor duca Cosimo posta in San Lorenzo a una delle cappelle della famiglia de' Medici, come quella che si può mettere fra le migliori cose che facesse il Sogliano.
Fece il medesimo, per le monache della Crocetta, un cenacolo colorito a olio, che fu allora molto lodato. E nella via de' Ginori, a Taddeo Taddei dipinse in un tabernacolo a fresco un Crucifisso con la Nostra Donna e San Giovanni a' piedi, et alcuni Angeli in aria che lo piangono molto vivamente. La quale opera certo è molto lodata, e ben condotta per lavoro a fresco. Di mano di costui è anco nel reffettorio della badia de' monaci Neri in Firenze un Crucifisso con Angeli che volano e piangono con molta grazia, et a basso è la Nostra Donna, S. Giovanni, S. Benedetto, S. Scolastica et altre figure. Alle monache dello Spirito Santo, sopra la costa a S. Giorgio, dipinse in due quadri, che sono in chiesa, S. Francesco e S. Lisabetta reina d'Ungheria e suora di quell'Ordine. Per la Compagnia del Ceppo dipinse il segno da portare a processione che è molto bello: nella parte dinanzi del quale fece la visitazione di Nostra Donna, e dall'altra parte S. Niccolò vescovo e due fanciulli vestiti da Battuti, uno de' quali gli tiene il libro e l'altro le tre palle d'oro. Lavorò in una tavola in S. Iacopo sopr'Arno, la Trinità con infinito numero di putti e S. Maria Maddalena ginocchioni, S. Caterina e S. Iacopo, e dagli lati in fresco due figure ritte, un S. Girolamo in penitenza e S. Giovanni. E nella predella fece fare tre storie a Sandrino del Calzolaio suo creato, che furono assai lodate. Nel castello d'Anghiari fece in testa d'una Compagnia in tavola un cenacolo a olio con figure di grandezza quanto il vivo, e nelle due rivolte del muro, cioè dalle bande, in una Cristo che lava i piedi a gl'Apostoli, e nell'altra un servo che reca due idrie d'acqua; la quale opera in quel luogo è tenuta in gran venerazione, perché invero è cosa rara, e che gli acquistò onore et utile. Un quadro che lavorò d'una Giuditta, che avea spiccato il capo a Oloferne, come cosa molto bella fu mandata in Ungheria; e similmente un altro, dove era la decollazione di S. Giovanni Battista con una prospettiva nella quale ritrasse il difuori del capitolo de' Pazzi che è nel primo chiostro di S. Croce, fu mandato da Paulo da Terrarossa, che lo fece fare, a Napoli per cosa bellissima. Lavorò anco per uno de' Bernardi altri due quadri, che furono posti nella chiesa dell'Osservanza di S. Miniato in una cappella, dove sono due figure a olio grandi quanto il vivo, cioè S. Giovanni Battista e S. Antonio da Padoa. Ma la tavola, che vi andava nel mezzo, per essere Giovanni Antonio di natura lunghetto et agiato nel lavorare, penò tanto, che chi la faceva fare si morì. Onde essa tavola, nella quale andava un Cristo in grembo alla madre, si rimase imperfetta. Dopo queste cose, quando Perino del Vaga, partito da Genoa, per aver avuto sdegno col prencipe Doria, lavorava in Pisa, avendo Stagio scultore da Pietrasanta cominciato l'ordine delle nuove cappelle di marmo nell'ultima navata del Duomo, e quella apparato che è dietro l'altare maggiore, il quale serve per sagrestia, fu ordinato che il detto Perino, come si dirà nella sua vita, et altri maestri cominciassero a empier quegli ornamenti di marmo di pitture. Ma essendo richiamato Perino a Genoa, fu ordinato a Giovanni Antonio che mettesse mano ai quadri che andavano in detta nicchia dietro l'altar maggiore e che nell'opere trattasse de' sacrifizii del Testamento Vecchio, per figurare il sacrifizio del Santissimo Sagramento, quivi posto in mezzo, sopra l'altar maggiore. Il Sogliano adunque nel primo quadro dipinse il sacrifizio che fece Noè et i figliuoli, uscito che fu dell'Arca, et appresso quel di Caino e quello d'Abel, che furono molto lodati, e massimamente quello di Noè, per esservi teste e pezzi di figure bellissime. Il qual quadro d'Abel è vago per i paesi, che sono molto ben fatti, e per la testa di lui che pare la stessa bontà; sì come è tutta il contrario quella di Caino, che ha cera di tristo da dovero. E se il Sogliano avesse così seguitato il lavorar gagliardo come se la tranquillò, arebbe per l'Operaio, che lo faceva lavorare, al quale piaceva molto la sua maniera e bontà, finite tutte l'opere di quel Duomo; là dove, oltre ai detti quadri, per allora non fece se non una tavola che andava alla cappella, dove aveva cominciato a lavorare Perino e quella finì in Firenze: ma di sorte che ella piacque assai ai Pisani e fu tenuta molto bella. Dentro vi è la Nostra Donna, S. Giovanni Battista, S. Giorgio, S. Maria Madalena, S. Margherita et altri Santi. Per essere dunque piacciuta gli furono allogate dall'Operaio altre tre tavole, alle quali mise mano, ma non le finì, vivente quell'Operaio: in luogo del quale essendo stato eletto Bastiano della Seta, vedendo le cose andar a lungo, fece allogazione di quattro quadri, per la detta sagrestia, dietro l'altar maggiore, a Domenico Beccafumi sanese, pittor eccellente, il quale se ne spedì in un tratto, come si dirà a suo luogo, e vi fece una tavola, et il rimanente fecero altri pittori. Giovan Antonio dunque finì, avendo agio, l'altre due tavole con molta diligenza, et in ciascuna fece una Nostra Donna con molti Santi attorno. Et ultimamente, condottosi in Pisa, vi fece la quarta et ultima, nella quale si portò peggio che in alcun'altra, o fusse la vecchiezza o la concorrenza del Beccafumi o l'altra cagione. Ma perché Bastiano Operaio vedeva la lunghezza di quell'uomo, per venirne a fine allogò l'altre tre tavole a Giorgio Vasari aretino, il quale ne finì due che sono a lato alla porta della facciata dinanzi. In quella che è verso Camposanto è la Nostra Donna col Figliuolo in collo, al quale S. Marta fa carezze. Sonovi poi ginocchioni S. Cecilia, S. Agostino, S. Gioseffo e S. Guido romito, et innanzi San Girolamo nudo e S. Luca Evangelista con alcuni putti che alzano un panno et altri che tengono fiori. Nell'altra fece, come volle l'Operaio, un'altra Nostra Donna col Figliuolo in collo, S. Giacopo interciso, S. Matteo, S. Silvestro papa e S. Turpè cavaliere; e per non fare il medesimo nell'invenzioni che gl'altri, ancor che in altro avesse variato molto, dovendovi pur far la Madonna, la fece con Cristo morto in braccio e que' Santi, come intorno a un Deposto di croce. E nelle croci, che sono in alto, fatte a guisa di tronchi, sono confitti due ladroni nudi, et intorno cavalli, i crucifissori con Giuseppo e Nicodemo e le Marie, per sodisfare all'Operaio che, fra tutte le dette tavole, volle che si ponessero tutti i Santi, che erano già stati in diverse cappelle vecchie disfatte, per rinovar la memoria loro alle nuove. Mancava alle dette una tavola, la quale fece il Bronzino, con un Cristo nudo et otto Santi. Et in questa maniera fu dato fine alle dette cappelle, le quali arebbe potuto far tutte di sua mano Giovan Antonio, se non fusse stato tanto lungo. E perché egli si era acquistato molta grazia fra i Pisani, gli fu, dopo la morte d'Andrea del Sarto, data a finire una tavola per la Compagnia di S. Francesco, che il detto Andrea lasciò abbozzata; la quale tavola è oggi nella detta Compagnia in sulla piazza di S. Francesco di Pisa.
Fece il medesimo, per l'Opera del detto Duomo, alcune filze di drappelloni, et in Firenze molti altri, perché gli lavorava volentieri e massimamente in compagnia di Tommaso di Stefano pittor fiorentino amico suo. Essendo Giovanni Antonio chiamato da' frati di S. Marco di Firenze a fare in testa del loro reffettorio in fresco un'opera a spese d'un loro frate converso de' Molletti, ch'aveva avuto buone facultà di patrimonio al secolo, voleva farvi quando Gesù Cristo con cinque pani e due pesci diede mangiar a cinquemila persone, per far lo sforzo di quello che sapeva fare; e già n'aveva fatto il disegno con molte donne, putti et altra turba e confusione di persone, ma i frati non vollono quella storia, dicen-do voler cose positive, ordinarie e semplici. Laonde, come piacque loro, vi fece quando San Domenico, essendo in reffettorio con i suoi frati e non avendo pane, fatta orazione a Dio, fu miracolosamente quella tavola piena di pane, portato da due Angeli in forma umana. Nella qual opera ritrasse molti frati che allora erano in quel convento, i quali paiono vivi, e particolarmente quel converso de' Molletti che serve a tavola. Fece poi nel mezzo tondo sopra la mensa S. Domenico a piè d'un Crucifisso, la Nostra Donna e S. Giovanni Evangelista che piangono, e dalle bande S. Caterina da Siena e S. Antonino arcivescovo di Firenze e di quell'Ordine, la quale fu condotta, per lavoro a fresco, molto pulitamente e con diligenza. Ma molto meglio sarebbe riuscito al Sogliano se avesse fatto quello ch'aveva disegnato, perché i pittori esprimono meglio i concetti dell'animo loro che gl'altrui. Ma dall'altro lato è onesto che chi spende il suo si contenti. Il quale disegno del pane e del pesce è in mano di Bartolomeo Gondi, il quale, oltre un gran quadro che ha di mano del Sogliano, ha anco molti disegni e teste colorite dal vivo, sopra fogli mesticati, le quali ebbe dalla moglie del Sogliano, poi che fu morto, essendo stato suo amicissimo. E noi ancora avemo alcuni disegni del medesimo nel nostro libro che sono belli affatto. Cominciò il Sogliano a Giovanni Serristori una tavola grande, che s'aveva a porre in S. Francesco dell'Osservanza, fuor della porta a S. Miniato, con un numero infinito di figure, dove sono alcune teste miracolose e le migliori che facesse mai, ma ella rimase imperfetta alla morte del detto Giovanni Serristori. Ma nondimeno, perché Giovanni Antonio era stato pagato del tutto, la finì poi a poco a poco e la diede a Messer Alamanno di Iacopo Salviati, genero et erede di Giovanni Serristori, et egli insieme con l'ornamento la diede alle monache di S. Luca, che l'hanno in via di S. Gallo posta sopra l'altar maggiore. Fece Giovanni Antonio molte altre cose in Firenze, che parte sono per le case de' cittadini e parte furono mandate in diversi paesi, delle quali non accade far menzione, essendosi parlato delle principali.
Fu il Sogliano persona onesta e religiosa molto, e sempre attese ai fatti suoi senza esser molesto a niuno dell'arte. Fu suo discepolo Sandrino del Calzolaio, che fece il tabernacolo ch'è in sul canto delle Murate, et allo spedale del Tempio un San Giovanni Battista che insegna il raccetto ai poveri. E più opere arebbe fatto e bene, se non fusse morto, come fece, giovane. Fu anco discepolo di costui Michele, che andò poi a stare con Ridolfo Ghirlandai, dal quale prese il no-me. E Benedetto similmente, che andò con Antonio Mini discepolo di Michelagnolo Buonarroti in Francia, dove ha fatto molte bell'opere. E finalmente Zanobi di Poggino, che ha fatto molte opere per la città. In ultimo, essendo Giovanni Antonio già stanco e male complessionato, dopo essere molto stato tormentato dal male della pietra, rendé l'anima a Dio d'anni cinquantadue.
Dolse molto la sua morte per essere stato uomo da bene e perché molto piaceva la sua maniera, facendo l'arie pietose et in quel modo che piacciono a coloro che senza dilettarsi della fatiche dell'arte e di certe bravure, amano e cose oneste, facili, dolci e graziose. Fu aperto dopo la morte, e trovatogli tre pietre grosse ciascuna quanto un uovo, le quali non volle mai acconsentire che se gli cavassino, né udirne ragionar mentre che visse.
FINE DELLA VITA DI GIOVANNI ANTONIO SOGLIANI, PITTOR FIORENTINO
VITA DI GIROLAMO DA TREVIGI
PITTORE

Rare volte avviene che coloro che nascono in una patria, et in quella lavorando perseverano, dalla fortuna siano esaltati a quelle felicità che meritano le virtù loro; dove, cercandone molte, finalmente in una si viene riconosciuto, o tardi o per tempo. E molte volte nasce che chi tardi perviene a' ristori delle fatiche, per il tossico della morte poco tempo quelli si gode; nel medesimo modo che vedremo nella vita di Girolamo da Trevigi pittore, il quale fu tenuto bonissimo maestro. E quantunque egli non avesse un grandissimo disegno, fu coloritor vago nell'olio e nel fresco, et imitava grandemente gli andari di Raffaello da Urbino. Lavorò in Trevigi sua patria assai, et in Vinegia ancora fece molte opere, e particolarmente la facciata della casa d'Andrea Udone in fresco, e dentro nel cortile alcuni fregi di fanciulli et una stanza di sopra. Le quali cose fece di colorito, e non di chiaro scuro, perché a Vinezia piace più il colorito che altro. Nel mezzo di questa facciata è in una storia grande Giunone che vola con la luna in testa sopra certe nuvole, dalle cosce in su e con le braccia alte sopra la testa, una delle quali tiene un vaso e l'altra una tazza. Vi fece similmente un Bacco grasso e rosso, e con un vaso, il quale rovescia, tenendo in braccio una Cerere, che ha in mano molte spighe. Vi sono le Grazie e cinque putti, che volando abbasso le ricevono per farne, come accennano, abondantissima quella casa degl'U-doni. La quale per mostrare il Trevisi che fusse amica et un albergo di virtuosi, vi fece da un lato Apollo e dall'altro Pallade. E questo lavoro fu condotto molto frescamente, onde ne riportò Girolamo onore et utile. Fece il medesimo un quadro alla cappella della Madonna di S. Petronio a concorrenza d'alcuni pittori bolognesi, come si dirà al suo luogo. E così dimorando poi in Bologna, vi lavorò molte pitture; et in S. Petronio nella cappella di S. Antonio da Padoa di marmo, a olio, contrafece tutte le storie della vita sua, nelle quali certamente si conosce gudizio, bontà, grazia et una grandissima pulitezza. Fece una tavola a San Salvatore di una Nostra Donna che saglie i gradi con alcuni Santi, et un'altra con la Nostra Donna in aria con alcuni fanciulli, et a' piè S. Ieronimo e S. Caterina, che fu veramente la più debole che di suo si vegga in Bologna. Fece ancora, sopra un portone in Bologna, un Crucifisso, la Nostra Donna e San Giovanni in fresco, che sono lodatissimi. Fece in San Domenico di Bologna una tavola a olio di una Madonna et alcuni Santi, la quale è la migliore delle cose sue, vicino al coro nel salire all'arca di San Domenico, dentrovi ritratto il padrone che la fece fare. Similmente colorì un quadro al conte Giovanni Battista Bentivogli, che aveva un cartone di mano di Baldassarre Sanese de la storia de' Magi, cosa che molto bene condusse a perfezzione, ancora che vi fussero più di cento figure. Similmente sono in Bologna di man d'esso molte altre pitture, e per le case e per le chiese; et in Galiera una facciata di chiaro e scuro alla facciata de' Teofamini, et una facciata dietro alle case de' Dolfi, che secondo il giudizio di molti artifici è giudicata la miglior cosa che e' facesse mai in quella città.
Andò a Trento e dipinse al cardinal vecchio il suo palazzo insieme con altri pittori, di che n'acquistò grandissima fama; e ritornato a Bologna attese all'opere da lui cominciate. Avvenne che per Bologna si diede nome di fare una tavola per lo spedale de la Morte; onde a concorrenza furono fatti varii disegni, chi disegnati e chi coloriti; e parendo a molti essere innanzi, chi per amicizia e chi per merito, di dovere avere tal cosa, restò indietro Girolamo; e parendoli che gli fosse fatto ingiuria, di là a poco tempo si partì di Bologna, onde l'invidia altrui lo pose in quel grado di felicità, che egli non pensò mai; atteso che, se passava innanzi, tale opera gl'impediva il bene che la buona fortuna gli aveva apparecchiato. Per che condottosi in Inghilterra, da alcuni amici suoi, che lo favorivano, fu preposto al re Arrigo; e giuntogli innanzi, non più per pittore, ma per ingegniere s'accommodò a' servigi suoi. Quivi mostrando alcune prove d'edifici ingegnosi, cavati da altri in Toscana e per l'Italia, e quel re giudicandoli miracolosi, lo premiò con doni continui e gli ordinò provisione di quattrocento scudi l'anno. E gli diede commodità ch'e' fabbricasse una abitazione onorata alle spese proprie del re. Per il che Girolamo da una estrema calamità a una grandissima grandezza condotto, viveva lietissimo e contento, ringraziando Iddio e la fortuna, che lo aveva fatto arrivare in un paese, dove gli uomini erano sì propizii alle sue virtù. Ma perché poco doveva durargli questa insolita felicità, avvenne che continuandosi la guerra tra Francesi e gli Inglesi, e Girolamo provedendo a tutte l'imprese de' bastioni e delle fortificazioni per le artiglierie e ripari del campo, un giorno faccendosi la batteria intorno alla città di Bologna in Piccardia, venne un mezzo cannone con violentissima furia, e da cavallo per mezzo lo divise. Onde in un medesimo tempo la vita e gli onori del mondo insieme con le grandezze sue rimasero estinte, essendo egli nella età d'anni trentasei, l'anno MDXLIIII.
FINE DELLA VITA DI GIROLAMO DA TREVIGI, PITTORE
VITA DI PULIDORO DA CARAVAGGIO E MATURINO FIORENTINO
PITTORI

Nell'ultima età dell'oro, che così si poté chiamare per gl'uomini virtuosi et artefici nobili la felice età di Leone Decimo, fra gl'altri spiriti nobilissimi ebbe luogo onorato Pulidoro da Caravaggio di Lombardia, non fattosi per lungo studio, ma stato prodotto e creato dalla natura pittore. Costui, venuto a Roma nel tempo che per Leone si fabbricavano le logge del palazzo del papa con ordine di Raffaello da Urbino, portò lo schifo, o vogliam dir vassoio pieno di calce, ai maestri che muravano, infino a che fu di età di diciotto anni. Ma cominciando Giovanni da Udine a dipignerle, e murandosi e dipignendosi, la volontà e l'inclinazione di Polidoro molto volta alla pittura, non restò di far sì ch'egli prese dimestichezza con tutti quei giovani che erano valenti, per veder i tratti et i modi dell'arte e mettersi a disegnar. Ma fra gl'altri, s'elesse per compagno Maturino fiorentino, allora nella cappella del papa, et alle anticaglie tenuto bonissimo disegnatore. Col quale praticando, talmente di quest'arte invaghì, che in pochi mesi fé cose (fatta prova del suo ingegno) che ne stupì ogni persona che lo aveva già conosciuto in quell'altro stato. Per la qual cosa, seguitandosi le logge, egli sì gagliardamente si essercitò con quei giovani pittori; che erano pratichi e dotti nella pittura, e sì divinamente apprese quella arte, che egli non si partì di su quel lavoro senza portarsene la vera gloria del più bello e più nobile ingegno, che fra tanti si ritrovasse. Per il che crebbe talmente l'amor di Maturino a Polidoro e di Polidoro a Maturino, che deliberarono come fratelli e veri compagni, vivere insieme e morire. E rimescolato le volontà, i danari e l'opere, di comune concordia si misero unitamente a lavorare insieme.
E perché erano in Roma pur molti che di grado, d'opere e di nome i coloriti loro conducevano più vivaci et allegri, e di favori più degni e più sortiti, cominciò a entrargli nell'animo, avendo Baldassarre Sanese fatto alcune facce di case di chiaro scuro, d'imitar quell'andare et a quelle, già venute in usanza, attendere da indi innanzi. Per che ne cominciarono una a Monte Cavallo dirimpetto a S. Salvestro in compagnia di Pellegrino da Modena, la quale diede loro animo di po-ter tentare se quello dovesse essere il loro essercizio; e ne seguitarono dirimpetto alla porta del fianco di S. Salvatore del Lauro un'altra; e similmente fecero da la porta del fianco della Minerva un'istoria, e di sopra S. Rocco a Ripetta u-n'altra, che è uno fregio di mostri marini. E ne dipinsero infinite in questo principio, manco buone dell'altre, per tutta Roma, che non accade qui raccontarle per avere eglino poi in tal cosa operato meglio. Laonde, inanimiti di ciò, cominciarono sì a studiare le cose dell'antichità di Roma, ch'eglino contraffacendo le cose di marmo antiche ne' chiari e scuri loro, non restò vaso, statue, pili, storie né cosa intera o rotta, ch'eglino non disegnassero e di quella non si servissero. E tanto con frequentazione e voglia, a tal cosa posero il pensiero, che unitamente presero la maniera antica e tanto l'una simile all'altra, che sì come gl'animi loro erano d'uno istesso volere, così le mani ancora esprimevano il medesimo sapere. E benché Maturino non fosse quanto Polidoro aiutato dalla natura, poté tanto l'osservanza dello stile nella compagnia, che l'uno e l'altro pareva il medesimo, dove poneva ciascuno la mano, di componimenti, d'aria e di maniera. Fecero su la piazza di Capranica per andar in Colonna, una facciata con le virtù teologiche et un fregio sotto le finestre, con bellissima invenzione, una Roma vestita, e per la fede figurata col calice e con l'ostia in mano aver prigione tutte le nazioni del mondo, e concorrere tutti i popoli a portarle i tributi, et i Turchi all'ultima fine distrutti, saetare l'arca di Macometto, conchiudendo finalmente col detto della scrittura, che sarà un ovile et un pastore. E nel vero eglino d'inven-zione non ebbero pari; di che ne fanno fede tutte le cose loro, cariche di abbigliamenti, vesti, calzari, strane bizzarrie, e con infinita maraviglia condotte. Et ancora ne rendono testimonio le cose loro, da tutti i forestieri pittori disegnate sì di continuo, che per utilità hanno essi fatto all'arte della pittura, per la bella maniera che avevano e per la bella facilità, che tutti gli altri da Cimabue in qua insieme non hanno fatto. Laonde si è veduto di continuo, et ancor si vede per Roma, tutti i disegnatori essere più volti alle cose di Polidoro e di Maturino, che a tutte l'altre pitture moderne. Fecero in Borgo Nuovo una facciata di graffito, e sul canto della Pace un'altra di graffito similmente; e poco lontano a questa, nella casa degli Spinoli per andar in Parione, una facciata, dentrovi le lotte antiche, come si costumavano, et i sacrifizii e la morte di Tarpea. Vicino a Torre di Nona verso il ponte S. Angelo si vede una facciata piccola col trionfo di Camillo et un sacrifizio antico. Nella via, che camina, all'imagine di Ponte è una facciata bellissima con la storia di Perillo, quando egli è messo nel toro di bronzo da lui fabbricato, nella quale si vede la forza di coloro che lo mettono in esso toro, et il terrore di chi aspetta vedere tal morte inusitata. Oltra che vi è a sedere Falari (come io credo) che comanda con imperiosità bellissima che e' si punisca il troppo feroce ingegno che aveva trovato crudeltà nuova per ammazzar gli uomini con maggior pena. Et in questa si vede un fregio bellissimo di fanciulli figurati di bronzo, et altre figure. Sopra questa fece poi un'altra facciata di quella casa stessa, dove è la imagine che si dice di Ponte, ove con l'ordine senatorio vestito nello abito antico romano più storie da loro figurate si veggono. Et alla piazza della Dogana allato a S. Eustachio una facciata di battaglie. E dentro in chiesa a man destra entrando si conosce una cappellina con le figure dipinte da Polidoro. Fecero ancora sopra Farnese un'altra de' Cepperelli, et una facciata dietro alla Minerva, nella strada che va a' Maddaleni, dentrovi storie romane, nella quale, fra l'altre cose belle si vede un fregio di fanciulli di bronzo contrafatti che trionfano, condotto con grandissima grazia e somma bellezza. Nella faccia de' Buoni Auguri, vicino alla Minerva, sono alcune storie di Romolo bellissime, cioè quando egli con l'aratro disegna il luogo per la città, e quando gli avoltoi gli volano sopra; dove, imitando gli abiti, le cere e le persone antiche, pare veramente che gli uomini siano quelli istessi. E nel ve-ro che di tal magisterio nessuno ebbe mai in quest'arte né tanto disegno, né più bella maniera, né sì gran pratica o maggior prestezza. E ne resta ogni artefice sì maravigliato, ogni volta che quelle vede, ch'è forza stupire che la natura abbia in questo secolo potuto avere forza di farci per tali uomini veder i miracoli suoi.
Fecero ancora, sotto Corte Savella, nella casa che comperò la signora Gostanza, quando le Sabine son rapite; la qual istoria fa conoscere non meno la sete et il bisogno del rapirle, che la fuga e la miseria delle meschine portate via da diversi soldati, et a cavallo et in diversi modi. E non sono in questa sola simili avvertimenti, ma anco e molto più nelle istorie di Muzio e d'Orazio, e la fuga di Porsena re di Toscana. Lavorarono nel giardino di Messer Stefano dal Bufalo, vicino alla fontana di Trevi, storie bellissime del fonte di Parnaso. E vi fecero grottesche e figure piccole, colorite molto bene. Similmente nella casa del Baldassino, da S. Agostino, fecero graffiti e storie, e nel cortile alcune teste d'imperato-ri sopra le finestre. Lavorarono in Monte Cavallo vicino a S. Agata una facciata dentrovi infinite e diverse storie, come quando Tuzia vestale porta dal Tevere al tempio l'acqua nel crivello, e quando Claudia tira la nave con la cintura. E così lo sbaraglio che fa Camillo, mentre che Brenno pesa l'oro. E nella altra facciata doppo il cantone, Romolo et il fratello alle poppe della lupa, e la terribilissima pugna d'Orazio, che mentre solo fra mille spade difende la bocca del ponte, ha dietro a sé molte figure bellissime, che in diverse attitudini con grandissima sollecitudine, co' picconi tagliano il ponte. Èvvi ancora Muzio Scevola, che nel cospetto di Porsena abbrucia la sua stessa mano che aveva errato nell'uccidere il ministro in cambio del re; dove si conosce il disprezzo del re et il desiderio della vendetta. E dentro in quella casa fecero molti paesi. Lavorarono la facciata di S. Pietro in Vincola e le storie di S. Pietro in quella con alcuni profeti grandi. E fu tanto nota per tutto la fama di questi maestri, per l'abbondanza del lavoro, che furono cagione le publiche pitture da loro con tanta bellezza lavorate, che meritarono lode grandissima in vita, et infinita et eterna, per l'imitazione, l'hanno avuta dopo la morte. Fecero ancora su la piazza, dove è il palazzo de' Medici, dietro a Naona, una faccia coi trionfi di Paulo Emilio, et infinite altre storie romane. Et a S. Salvestro di Monte Cavallo, per fra Mariano, per casa e per il giardino alcune cosette; et in chiesa li dipinsero la sua cappella e due storie colorite di S. Maria Maddalena, nelle quali so-no i macchiati de' paesi fatti con somma grazia e discrezione, perché Polidoro veramente lavorò i paesi e macchie d'al-beri e sassi, meglio d'ogni pittore. Et egli nell'arte è stato cagione di quella facilità, che oggi usano gl'artefici nelle cose loro.
Fecero ancora molte camere e fregi per molte case di Roma, coi colori a fresco et a tempera lavorati, le quali opere erano da essi esercitate per pruova, perché mai a' colori non poterono dare quella bellezza, che di continuo diedero alle cose di chiaro e scuro, o in bronzo, o in terretta, come si vede ancora nella casa che era del cardinale di Volterra da Torre Sanguigna. Nella faccia della quale fecero un ornamento di chiaro scuro bellissimo, e dentro alcune figure colorite, le quali son tanto mal lavorate e condotte, che hanno deviato dal primo essere il disegno buono ch'eglino avevano. E ciò tanto parve più strano per esservi appresso un'arme di papa Leone, di ignudi, di mano di Giovan Francesco Vetraio, il quale se la morte non avesse tolto di mezzo arebbe fatto cose grandissime. E non isgannati per questo della folle credenza loro, fecero ancora in S. Agostino di Roma, all'altare de' Martelli, certi fanciulli coloriti, dove Giacopo Sansovino per fine dell'opera, fece una Nostra Donna di marmo; i quali fanciulli non paiono di mano di persone illustri, ma d'i-dioti che comincino allora a imparare. Per il che nella banda dove la tovaglia cuopre l'altare, fece Polidoro una storietta d'un Cristo morto con le Marie, ch'è cosa bellissima, mostrando nel vero essere più quella la professione loro che i colori. Onde, ritornati al sotto loro, fecero in Campo Marzio due facciate bellissime: nell'una le storie di Anco Marzio, e nell'altra le feste de' Saturnali celebrati in tal luogo, con tutte le bighe e quadrighe de' cavalli ch'agli obelischi aggirano intorno, che sono tenute bellissime per esser elleno talmente condotte di disegno e bella maniera, che espressissimamente rappresentano quegli stessi spettacoli per i quali elle sono dipinte. Sul canto della Chiavica, per andare a Corte Savella, fecero una facciata la quale è cosa divina, e delle belle che facessero, giudicata bellissima; perché oltra l'istoria delle fanciulle che passano il Tevere, abbasso vicino alla porta è un sacrifizio fatto con industria et arte maravigliosa, par vedersi osservato quivi tutti gli instrumenti e tutti quegli antichi costumi, che a' sacrifizii di quella sorte si solevano osservare. Vicino al Popolo, sotto S. Iacopo degli Incurabili, fecero una facciata con le storie d'Alessandro Magno ch'è tenute bellissima, nella quale figurarono il Nilo e 'l Tebro di Belvedere antichi. A San Simeone fecero la facciata de' Gaddi, ch'è cosa di maraviglia e di stupore nel considerarvi dentro i belli e tanti varii abiti, l'infinità delle celate antiche, de' soccinti, de' calzari e delle barche, ornate con tanta leggiadria e copia d'ogni cosa, che imaginar si possa un sofistico ingegno. Quivi la memoria si carica di una infinità di cose bellissime, e quivi si rappresentano i modi antichi, l'effigie de' savi e bellissime femmine, Perché vi sono tutte le spezie de' sacrifizii antichi, come si costumavano, e da che s'im-barca uno essercito, a che combatte con variatissima foggia di strumenti e d'armi, lavorate con tanta grazia e condotte con tanta pratica, che l'occhio si smarrisce nella copia di tante belle invenzioni. Dirimpetto a questa è un'altra facciata minore, che di bellezza e di copia non potria migliorare, dov'è nel fregio la storia di Niobe quando si fa adorare e le genti che portano tributi e vasi e diverse sorti di doni; le quali cose con tanta novità, leggiadria, arte, ingegno e rilievo espresse egli in tutta questa opera, che troppo sarebbe certo narrarne il tutto. Seguitò appresso lo sdegno di Latona e la miserabile vendetta ne' figliuoli della superbissima Niobe, e che i sette maschi da Febo e le sette femmine da Diana le sono ammazzati, con un'infinità di figure di bronzo che non di pittura, ma paiono di mettallo. E sopra, altre storie lavorate con alcuni vasi d'oro contrafatti con tante bizzarrie dentro, che occhio mortale non potrebbe imaginarsi altro, né più bello, né più nuovo, con alcuni elmi etrusci da rimaner confuso per la moltiplicazione e copia di sì belle e capricciose fantasie ch'uscivano loro de la mente. Le quali opere sono state imitate da infiniti che lavorano di sì fatt'opere. Fecero ancora il cortile di questa casa, e similmente la loggia, colorita di grotteschine picciole, che sono stimate divine. Insomma ciò che eglino toccarono, con grazia e bellezza infinita assoluto renderono. E s'io volessi nominare tutte l'opere loro, farei un libro intero de' fatti di questi due soli, perché non è stanza, palazzo, giardino, né vigna, dove non siano opere di Polidoro e di Maturino.
Ora, mentre che Roma ridendo s'abbelliva delle fatiche loro et essi aspettavano premio de' proprii sudori, l'invidia e la fortuna mandarono a Roma Borbone, l'anno 1527, che quella città mise a sacco. Laonde fu divisa la compagnia non solo di Polidoro e di Maturino, ma di tanti migliaia d'amici e di parenti, che a un sol pane tanti anni erano stati in Roma. Perché Maturino si mise in fuga, né molto andò, che da' disagi patiti per tale sacco, si stima a Roma che morisse di peste, e fu sepolto in S. Eustachio. Polidoro verso Napoli prese il camino, dove arivato, essendo quei gentiluomini poco curiosi delle cose eccellenti di pittura, fu per morirvisi di fame. Onde egli lavorando a opere per alcuni pittori, fece in S. Maria della Grazia un San Pietro nella maggior cappella; e così aiutò in molte cose que' pittori, più per campare la vita, che per altro. Ma pure essendo predicato le virtù sue, fece al conte di... una volta dipinta a tempera, con alcune facciate, ch'è tenuta cosa bellissima. E così fece il cortile di chiaro e scuro al signor... et insieme alcune logge, le quali sono molte piene d'ornamento e di bellezza, e ben lavorate. Fece ancora in S. Angelo, allato alla pescheria di Napoli, una tavolina a olio, nella quale è una Nostra Donna et alcuni ignudi d'anime cruciate, la quale di disegno, più che di colorito, è tenuta bellissima. Similmente alcuni quadri, in quella dell'altar maggiore, di figure intere sole, nel medesimo modo lavorate.
Avvenne che stando egli in Napoli, e veggendo poco stimata la sua virtù, deliberò partire da coloro che più conto tenevano d'un cavallo che saltasse, che di chi facesse con le mani le figure dipinte parer vive. Per il che, montato su le galee, si trasferì a Messina, e quivi trovato più pietà e più onore, si diede ad operare; e così lavorando di continuo prese ne' colori buona e destra pratica. Onde egli vi fece di molte opere, che sono sparse in molti luoghi. Et all'architettura attendendo, diede saggio di sé in molte cose ch'e' fece. Appresso nel ritorno di Carlo V dalla vittoria di Tunisi, passando egli per Messina, Polidoro gli fece archi trionfali bellissimi, onde n'acquistò nome e premio infinito. Laonde egli, che sempre ardeva di desiderio di rivedere quella Roma, la quale di continuo strugge coloro che stati ci sono molti anni nel provare gli altri paesi, vi fece per ultimo una tavola d'un Cristo che porta la croce, lavorata a olio, di bontà e di colo-rito vaghissimo; nella quale fece un numero di figure che accompagnano Cristo alla morte, soldati, farisei, cavagli, donne, putti et i ladroni innanzi, col tenere ferma l'intenzione, come poteva essere ordinata una giustizia simile: che ben pareva che la natura si fusse sforzata a far l'ultime pruove sue in questa opera veramente eccellentissima. Doppo la qua-le cercò egli molte volte svilupparsi di quel paese, ancora ch'egli ben veduto vi fosse; ma la cagione della sua dimora era una donna, da lui molti anni amata, che con sue dolci parole e lusinghe lo riteneva. Ma pure tanto poté in lui la volontà di rivedere Roma e gli amici, che levò dal banco una buona quantità di danari ch'egli aveva, e risoluto al tutto, si partì.
Aveva Polidoro tenuto molto tempo un garzone di quel paese, il quale portava maggiore amore a' danari di Polidoro, che a lui, ma per averli così sul banco, non poté mai porvi su le mani e con essi partirsi. Per il che caduto in un pensiero malvagio e crudele, deliberò la notte seguente, mentre che dormiva, con alcuni suoi congiurati amici, dargli la morte e poi partire i danari fra loro. E così in sul primo sonno assalitolo, mentre dormiva forte, aiutato da coloro, con una fascia lo strangolò. E poi datogli alcune ferite, lo lasciarono morto. E per mostrare ch'essi non l'avessero fatto, lo portarono su la porta della donna da Polidoro amata, fingendo che, o parenti, o altri in casa l'avessero amazzato. Diede dunque il garzone buona parte de' danari a que' ribaldi, che sì brutto eccesso avevan commesso; e quindi fatteli partire, la mattina piangendo andò a casa un Conte, amico del morto maestro, e raccontogli il caso; ma per diligenza che si facesse in cercar molti di chi avesse cotal tradimento commesso, non venne alcuna cosa a luce. Ma pure come Dio volle, avendo la natura e la virtù a sdegno d'essere per mano della fortuna percosse, fecero a uno, che interesso non ci aveva, dire che impossibil era che altri che tal garzone l'avesse assassinato. Per il che il Conte gli fece por le mani addosso, et alla tortura messolo, senza che altro martorio gli dessero, confessò il delitto, e fu dalla giustizia condannato alle forche, ma prima con tanaglie affocate per la strada tormentato et ultimamente squartato.
Ma non per questo tornò la vita a Polidoro, né alla pittura si rese quello ingegno pellegrino e veloce, che per tanti secoli non era più stato al mondo. Per il che se allora che morì, avesse potuto morire con lui, sarebbe morta l'invenzio-ne, la grazia e la bravura nelle figure dell'arte. Felicità della natura e della virtù nel formare in un corpo così nobile spirto; et invidia et odio crudele di così strana morte nel fato e nella fortuna sua, la quale, se bene gli tolse la vita, non gli torrà per alcun tempo il nome. Furono fatte l'essequie sue solennissime, e con doglia infinita di tutta Messina nella chiesa catedrale datogli sepoltura l'anno 1543.
Grande obligo hanno veramente gl'artefici a Polidoro per averla arrichita di gran copia di diversi abiti, e stranissimi e varii ornamenti, e dato a tutte le sue cose grazia et ornamento; similmente per avere fatto figure d'ogni sorte, animali, casamenti, grottesche e paesi così belli, che dopo lui chiunche ha cercato d'essere universale l'ha imitato. Ma è gran cosa e da temerne, il vedere, per l'esempio di costui, la instabilità della fortuna e quello che ella sa fare, facendo divenire eccellenti in una professione, uomini da chi si sarebbe ogn'altra cosa aspettato, con non piccola passione di chi ha nella medesima arte molti anni in vano faticato. È gran cosa, dico, vedere i medesimi, dopo molti travagli e fatiche, essere condotti dalla stessa fortuna a misero et infelicissimo fine, allora che aspettavano di goder il premio delle loro fatiche: e ciò con sì terribili e mostruosi casi, che la stessa pietà se ne fugge, la virtù s'ingiuria, et i beneficii d'una incredibile e straordinaria ingratitudine si ristorano. Quanto dunque può lodarsi la pittura della virtuosa vita di Polidoro, tanto può egli dolersi della fortuna, che se gli mostrò un tempo amica, per condurlo poi, quando meno ciò si aspettava, a dolorosa morte.
VITA DEL ROSSO
PITTOR FIORENTINO

Gli uomini pregiati che si danno alle virtù, e quelle con tutte le forze loro abbracciano, sono pur qualche volta, quando manco ciò si aspettava, esaltati et onorati eccessivamente nel cospetto di tutto il mondo; come apertamente si può vedere nelle fatiche che il Rosso pittor fiorentino pose nell'arte della pittura. Le quali, se in Roma et in Fiorenza non furono da quei che le potevano rimunerare sodisfatte, trovò egli pure in Francia chi per quelle lo riconobbe di sorte, che la gloria di lui poté spegnere la sete in ogni grado d'ambizione che possa 'l petto di qual si voglia artefice occupare. Né poteva egli in quell'essere conseguir dignità, onore, o grado maggiore, poi che sopra ogn'altro del suo mestiero, da sì gran re, come è quello di Francia, fu ben visto e pregiato molto. E nel vero i meriti d'esso erano tali, che se la fortuna gli avesse procacciato manco, ella gli avrebbe fatto torto grandissimo. Con ciò fusse che il Rosso era, oltra la pittura, dotato di bellissima presenza; il modo del parlar suo era molto grazioso e grave; era bonissimo musico et aveva ottimi termini di filosofia, e quel che importava più che tutte l'altre sue bonissime qualità, fu che egli del continuo nelle composizione delle figure sue era molto poetico, e nel disegno fiero e fondato, con leggiadra maniera e terribilità di cose stravaganti, et un bellissimo compositore di figure. Nella architettura fu eccellentissimo e straordinario, e sempre, per povero ch'egli fosse, fu ricco d'animo e di grandezza. Per il che coloro che nelle fatiche della pittura terranno l'ordine che 'l Rosso tenne, saranno di continuo celebrati come son l'opre di lui. Le quali di bravura non hanno pari, e senza fatiche di stento son fatte, levato via da quelle un certo tisicume e tedio, che infiniti patiscono per fare le loro cose di niente parere qualche cosa. Disegnò il Rosso nella sua giovanezza al cartone di Michele Agnolo, e con pochi maestri volle sta-re all'arte, avendo egli una certa sua opinione contraria alle maniere di quegli, come si vede fuor della porta a S. Pier Gattolini di Fiorenza, a Marignolle, in un tabernacolo lavorato a fresco per Piero Bartoli con un Cristo morto, dove cominciò a mostrare quanto egli desiderasse la maniera gagliarda e di grandezza più degl'altri, leggiadra e maravigliosa. Lavorò sopra la porta di San Sebastiano de' Servi, essendo ancor sbarbato, quando Lorenzo Pucci fu da papa Leone fatto cardinale, l'arme de' Pucci con due figure che in quel tempo fece maravigliare gli artefici, non si aspettando di lui quello che riuscì. Onde gli crebbe l'animo talmente, che avendo egli a maestro Giacopo frate de' Servi, che attendeva alle poesie, fatto un quadro d'una Nostra Donna con la testa di S. Giovanni Evangelista mezza figura, persuaso da lui fece nel cortile de' detti Servi, allato alla storia della Visitazione che lavorò Giacopo da Pontormo, l'assunzione di Nostra Donna, nella quale fece un cielo d'Angeli tutti fanciulli ignudi, che ballano intorno alla Nostra Donna acerchiati, che scortano con bellissimo andare di contorni e con graziosissimo modo girati per quell'aria; di maniera che, se il colo-rito fatto da lui fosse con quella maturità d'arte che egli ebbe poi col tempo, avrebbe, come di grandezza e di buon disegno paragonò l'altre storie, di gran lunga ancora trapassate. Fecevi gli Apostoli carichi molto di panni e di troppa dovizia di essi pieni, ma le attitudini et alcune teste sono più che bellissime. Fecegli far lo Spedalingo di S. Maria Nuova una tavola, la quale, vedendola abbozzata, gli parvero, come colui ch'era poco intendente di questa arte, tutti quei Santi diavoli, avendo il Rosso costume, nelle sue bozze a olio, di fare certe arie crudeli e disperate, e nel finirle poi addolciva l'aria e riducevale al buono. Per che se li fuggì di casa e non volle la tavola, dicendo che lo aveva giuntato. Dipinse medesimamente sopra un'altra porta che entra nel chiostro del convento de' Servi, l'arme di papa Leone con due fanciulli, oggi guasta. E per le case de' cittadini si veggono più quadri e molti ritratti. Fece per la venuta di papa Leone a Fiorenza sul canto de' Bischeri un arco bellissimo. Poi lavorò al signor di Piombino una tavola con un Cristo morto bellissimo, e gli fece ancora una cappelluccia. E similmente a Volterra dipinse un bellissimo Deposto di croce. Perché cresciuto in pregio e fama, fece in S. Spirito di Fiorenza la tavola de' Dei, la quale già avevano allogato a Raffaello da Urbino, che la lasciò per le cure dell'opera che aveva preso a Roma. La quale il Rosso lavorò con bellissima grazia e disegno e vivacità di colori. Né pensi alcuno che nessuna opera abbia più forza o mostra più bella di lontano, di quella, la quale, per la bravura nelle figure e per l'astrattezza delle attitudini, non più usata per gli altri, fu tenuta cosa stravagante. E se bene non gli fu allora molto lodata, hanno poi a poco a poco conosciuto i popoli la bontà di quella, e gli hanno dato lode mirabili; perché nell'unione de' colori non è possibile far più, essendo che i chiari, che sono sopra dove batte il maggior lume, con i men chiari vanno a poco a poco con tanta dolcezza et unione a trovar gli scuri con artifizio di sbattimenti d'ombre, che le figure fanno addosso l'una all'altra figura, perché vanno per via di chiari scuri facendo rilievo l'una al-l'altra. E tanta fierezza ha quest'opera, che si può dire ch'ella sia intesa e fatta con più giudizio e maestria, che nessun'al-tra che sia stata dipinta da qual si voglia più giudizioso maestro. Fece in San Lorenzo la tavola di Carlo Ginori dello sponsalizio di Nostra Donna, tenuto cosa bellissima. Et in vero in quella sua facilità del fare non è mai stato chi di pratica o di destrezza l'abbi potuto vincere, né a gran lunga accostarseli; per esser egli stato nel colorito sì dolce, e con tanta grazia cangiato i panni, che il diletto, che per tale arte prese, lo fé sempre tenere lodatissimo e mirabile, come chi guarderà tale opera conoscerà tutto questo ch'io scrivo esser verissimo, considerando gl'ignudi, che sono benissimo intesi, e con tutte l'avvertenze della notomia. Sono le femmine graziosissime e l'acconciature de' panni bizarre e capricciose. Similmente ebbe le considerazioni, che si deono avere, sì nelle teste de' vecchi con cere bizarre, come in quelle delle donne e dei putti, con arie dolci e piacevoli. Era anco tanto ricco d'invenzioni, che non gl'avanzava mai niente di campo nelle tavole, e tutto conduceva con tanta facilità e grazia, che era una maraviglia. Fece ancora a Giovanni Bandini un quadro d'alcuni ignudi bellissimi, in una storia di Mosè quando ammazza l'Egizzio, nel quale erano cose lodatissime; e credo che in Francia fosse mandato. Similmente un altro ne fece a Giovanni Cavalcanti, che andò in Inghilterra, quando Iacob piglia il bere da quelle donne alla fonte, che fu tenuto divino, atteso che vi erano ignudi e femmine lavorate con somma grazia, alle quali egli di continuo si dilettò far panniccini sottili, acconciature di capo con trecce et abbigliamenti per il dosso.
Stava il Rosso, quando questa opera faceva, nel Borgo de' Tintori, che risponde con le stanze negli orti de' frati di S. Croce, e si pigliava piacere d'un bertuccione, il quale aveva spirto più d'uomo che d'animale; per la qual cosa carissimo se lo teneva e come se medesimo l'amava, e perciò ch'egli aveva un intelletto maraviglioso, gli faceva fare di molti servigi. Avvenne che questo animale s'innamorò d'un suo garzone, chiamato Batistino, il quale era di bellissimo aspetto, et indovinava tutto quel che dir voleva, ai cenni, che 'l suo Batistin gli faceva. Per il che, essendo da la banda delle stanze di dietro, che nell'orto de' frati rispondevano, una pergola del guardiano piena di uve grossissime S. Colombane, quei giovani mandavano giù il bertuccione per quella che dalla finestra era lontana, e con la fune su tiravano l'animale con le mani piene d'uve. Il guardiano, trovando scaricarsi la pergola e non sapendo da chi, dubitando de' topi, mise l'aguato a essa, e visto che il bertuccione del Rosso giù scendeva, tutto s'accese d'ira, e presa una pertica per bastonarlo, si recò verso lui a due mani. Il bertuccione, visto che se saliva ne toccherebbe, e se stava fermo il medesimo, cominciò salticchiando a ruinargli la pergola, e fatto animo di volersi gettare addosso al frate, con ambedue le mani prese l'ultime traverse che cingevano la pergola; in tanto menando il frate la pertica, il bertuccione scosse la pergola per la paura, di sor-te e con tal forza, che fece uscire delle buche le pertiche e le canne: onde la pergola et il bertuccione ruinarono addosso al frate, il quale gridando misericordia, fu da Batistino e da gl'altri tirata la fune, et il bertuccion salvo rimesso in camera, perché discostatosi il guardiano et a un suo terrazzo fattosi, disse cose fuor della messa; e con còlora e mal animo e n'andò all'ufficio degli Otto, magistrato in Fiorenza molto temuto. Quivi posta la sua querela e mandato per il Rosso, fu per motteggio condannato il bertuccione a dovere un contrapeso tener al culo, acciò che non potesse saltare come prima faceva su per le pergole. Così il Rosso fatto un rullo che girava con un ferro, quello gli teneva, acciò che per casa potes-se andare, ma non saltare per l'altrui come prima faceva. Per che, vistosi a tal supplizio condennato, il bertuccione par-ve che s'indovinasse il frate essere stato di ciò cagione, onde ogni dì s'essercitava saltando di passo in passo con le gambe e tenendo con le mani il contrapeso, e così posandosi spesso al suo disegno pervenne. Perché, sendo un dì sciolto per casa, saltò a poco a poco di tetto in tetto, su l'ora che il guardiano era a cantare il vespro, e pervenne sopra il tetto della camera sua. E quivi lasciato andare il contrapeso, vi fece per mezza ora un sì amorevole ballo, che né tegolo né coppo vi restò che non rompesse. E tornatosi in casa, si sentì fra tre dì per una pioggia le querele del guardiano.
Avendo il Rosso finito l'opere sue, con Batistino et il bertuccione s'inviò a Roma, et essendo in grandissima aspettazione l'opre sue, erano oltre modo desiderate, essendosi veduti alcuni disegni fatti per lui, i quali erano tenuti maravigliosi, atteso che il Rosso divinissimamente e con gran pulitezza disegnava. Quivi fece nella Pace sopra le cose di Raffaello un'opera, della quale non dipinse mai peggio a' suoi giorni, né posso imaginare onde ciò procedesse, se non da questo, che non pure in lui, ma si è veduto anco in molti altri. E questo (il che pare cosa mirabile et occulta di natura) è che chi muta paese o luogo, pare che muti natura, virtù, costumi et abito di persona, in tanto che tallora non pare quel medesimo, ma un altro e tutto stordito e stupefatto. Il che poté intervenire al Rosso nell'aria di Roma, e per le stupende cose che egli vi vide d'architettura e scultura, e per le pitture e statue di Michelagnolo, che forse lo cavarono di sé. Le quali cose fecero anco fuggire, senza lasciar loro alcuna cosa operare in Roma, fra' Bartolomeo di S. Marco et Andrea del Sarto. Tuttavia, qualunche si fusse di ciò la cagione, il Rosso non fece mai peggio; e da vantaggio è quest'opera [a] paragone di quelle di Raffaello da Urbino.
In questo tempo fece al vescovo Tornabuoni amico suo un quadro d'un Cristo morto, sostenuto da due Angeli, che oggi è appresso agli eredi di monsignor Della Casa, il quale fu una bellissima impresa. Fece al Baviera, in disegni di stampe, tutti gli dèi, intagliati poi da Giacopo Caraglio, quando Saturno si muta in cavallo, e particularmente quando Plutone rapisce Proserpina. Lavorò una bozza della decollazione di S. Giovanni Batista, che oggi è in una chiesiuola su la piazza de' Salviati in Roma. Succedendo in tanto il sacco di Roma, fu il povero Rosso fatto prigione de' Tedeschi e molto mal trattato. Perciò che oltra lo spogliarlo de' vestimenti, scalzo e senza nulla in testa, gli fecero portare addosso pesi, e sgombrare quasi tutta la bottega d'un pizzicagnolo. Per il che da quelli mal condotto, si condusse appena in Perugia, dove da Domenico di Paris pittore fu molto accarezzato e rivestito; et egli disegnò per lui un cartone di una tavola de' Magi, il quale appresso lui si vede, cosa bellissima. Né molto restò in tal luogo, perché intendendo ch'al Borgo era venuto il vescovo de' Tornabuoni, fuggito egli ancora dal sacco, si trasferì quivi, perché gli era amicissimo. Era in quel tempo al Borgo Raffaello dal Colle pittore, creato di Giulio Romano, che nella sua patria aveva preso a fare, per S. Croce, Compagnia di Battuti, una tavola per poco prezzo, della quale come amorevole si spogliò, e la diede al Rosso, acciò che in quella città rimanesse qualche reliquia di suo. Per il che la Compagnia si risentì, ma il vescovo gli fece molte comodità. Onde finita la tavola, che gl'acquistò nome, ella fu messa in S. Croce: perché il Deposto che vi è di croce è cosa molto rara e bella, per avere osservato ne' colori un certo che, tenebroso per l'eclisse, che fu nella morte di Cristo, e per essere stata lavorata con grandissima diligenza. Gli fu dopo fatto in Città di Castello allogazione d'una tavola, la quale volendo lavorare mentre che s'ingessava, le ruinò un tetto addosso che l'infranse tutta, et a lui venne un mal di febbre sì bestiale, che ne fu quasi per morire: per il che da Castello si fé portare al Borgo. Seguitando quel male con la quartana, si trasferì poi alla Pieve a S. Stefano a pigliare aria, et ultimamente in Arezzo, dove fu tenuto in casa da Benedetto Spadari; il quale adoperò di maniera col mezzo di Giovanni Antonio Lappoli aretino e di quanti amici e parenti essi avevano, che gli fu dato a lavorare in fresco alla Madonna delle Lagrime una volta, allogata già a Niccolò Soggi pittore. E perché tal memoria si lasciasse in quella città, gliele allogarono per prezzo di trecento scudi d'oro. Onde il Rosso cominciò cartoni in una stanza che gli avevano consegnata in un luogo detto Murello, e quivi ne finì quattro. In uno fece i primi parenti legati allo albero del peccato, e la Nostra Donna che cava loro il peccato di bocca, figurato per quel pomo, e sotto i piedi il serpente, e nell'aria (volendo figurare ch'era vestita del sole e della luna) fece Febo e Diana ignudi. Nell'altra quando l'arca federes è portata da Mosè, figurata per la Nostra Donna da cinque Virtù circondata. In un'altra è il trono di Salamone, pure figurato per la medesima a cui si porgono voti per significare quei che ricorrono a lei per grazia, con altre bizzarrie che dal bello ingegno di Messer Giovanni Polastra, canonico aretino et amico del Rosso, furono trovate; a compiacenza del quale fece il Rosso un bellissimo modello di tutta l'opera, che è oggi nelle nostre case d'Arezzo. Disegnò anco uno studio d'ignudi per quell'opera, che è cosa rarissima: onde fu un peccato ch'ella non si finisse, perché se egli l'avesse messa in opera, e fattala a olio come aveva a farla in fresco, ella sarebbe stata veramente un miracolo. Ma egli fu sempre nemico del lavorare in fresco, e però si andò temporeggiando in fare i cartoni, per farla finire a Raffaello dal Borgo et altri, tanto ch'ella non si fece.
In quel medesimo tempo, essendo persona cortese, fece molti disegni in Arezzo e fuori, per pitture e fabriche: come ai rettori della fraternita quello della cappella che è a' piè di piazza, dove è oggi il volto santo, per i quali aveva disegnato una tavola che s'aveva a porre di sua mano nel medesimo luogo, dentro una Nostra Donna che ha sotto il manto un popolo. Il quale disegno, che non fu messo in opera, è nel nostro libro insieme con molti altri bellissimi di mano del medesimo. Ma tornando all'opera ch'egli doveva fare alla Madonna delle Lacrime, gl'entrò mallevadore di questa opera Giovanni Antonio Lappoli aretino et amico suo fidatissimo, che con ogni modo di servitù gli usò termini di amorevolezza. Ma l'anno 1530, essendo l'assedio intorno a Fiorenza, et essendo gli Aretini, per la poca prudenza di papa Altoviti, rimasi in libertà, essi combatterono la cittadella e la mandarono a terra. E perché que' popoli mal volentieri vedevano i Fiorentini, il Rosso non si volle fidar di essi e se n'andò al Borgo San Sepolcro, lasciando i cartoni et i disegni dell'o-pera serrati in Cittadella: perché quelli che a Castello gli aveva allogato la tavola, volsero che la finisse; e per il male che avea avuto a Castello, non volle ritornarvi, e così al Borgo finì la tavola loro. Né mai a essi volse dare allegrezza di poterla vedere: dove figurò un popolo et un Cristo in aria adorato da quattro figure, e quivi fece Mori, Zingani e le più strane cose del mondo; e da le figure in fuori, che di bontà son perfette, il componimento attende a ogni altra cosa, che all'animo di coloro che gli chiesero tale pittura. In quel medesimo tempo, che tal cosa faceva, disotterrò de' morti nel vescovado ove stava, e fece una bellissima notomia. E nel vero era il Rosso studiosissimo delle cose dell'arte, e pochi giorni passavano che non disegnasse qualche nudo di naturale.
Ora, avendo egli sempre avuto capriccio di finire la sua vita in Francia e torsi, come diceva egli, a una certa miseria e povertà nella quale si stanno gli uomini che lavorano in Toscana e ne' paesi dove sono nati, deliberò di partirsi. Et a-vendo a punto, per comparire più pratico in tutte le cose et essere universale, apparata la lingua latina, gli venne occasione d'affrettare maggiormente la sua partita, perciò che, essendo un giovedì santo, quando si dice matutino la sera, un giovinetto aretino suo creato in chiesa, e facendo con un moccolo acceso e con pece greca alcune vampe e fiamme di fuoco, mentre si facevano, come si dice, le tenebre, fu il putto da alcuni preti sgridato et alquanto percosso. Di che avedutosi il Rosso, al quale sedeva il fanciullo a canto, si rizzò con mal animo alla volta del prete. Perché levatosi il rumore, né sapendo alcuno onde la cosa venisse, fu cacciato mano alle spade contra il povero Rosso, il quale era alle mani con i preti. Onde egli datosi a fuggire, con destrezza si ricoverò nelle stanze sue, senza essere stato offeso o raggiunto da nessuno. Ma tenendosi per ciò vituperato, finita la tavola di Castello, senza curarsi del lavoro d'Arezzo, o del danno che faceva a Gioan Antonio suo mallevadore, avendo avuto più di centocinquanta scudi, si partì di notte, e facendo la via di Pesaro, se n'andò a Vinezia. Dove essendo da Messer Pietro Aretino trattenuto, gli disegnò in una carta, che poi fu stampata, un Marte che dorme con Venere e gl'Amori, e le Grazie che lo spogliano e gli traggono la corazza. Da Vinezia partito, se n'andò in Francia, dove fu con molte carezze dalla nazione fiorentina ricevuto. Quivi fatti alcuni quadri, che poi furono posti in Fontanableò nella galleria, gli donò al re Francesco, al quale piacquero infinitamente, ma molto più la presenza, il parlare e la maniera del Rosso, il quale era grande di persona, di pelo rosso conforme al nome, et in tutte le sue azzioni grave, considerato e di molto giudizio. Il re, adunque, avendogli subito ordinato una provisione di quattrocento scudi, e donatogli una casa in Parigi, la quale abitò poco per starsi il più del tempo a Fontanableò, dove aveva stanze e vivea da signore, lo fece capo generale sopra tutte le fabriche, pitture et altri ornamenti di quel luogo. Nel quale primieramente diede il Rosso principio a una galleria sopra la bassa corte, facendo di sopra non volta, ma un palco, o vero soffittato di legname con bellissimo spartimento; le facciate dalle bande fece tutte lavorate di stucchi, con partimenti bizzarri e stravaganti e di più sorti cornici intagliate, con figure ne' reggimenti grandi quanto il naturale, adornando ogni cosa sotto le cornici, fra l'un reggimento e l'altro, di festoni di stucco ricchissimi, e d'altri di pittura con frutti bellissimi e verzure d'ogni sorte. E dopo, in un vano grande, fece dipignere col suo disegno (se bene ho inteso il vero) circa ventiquattro storie, a fresco, credo, dei fatti d'Alessandro Magno; facendo esso come ho detto tutti i disegni, che furono d'acquerello e di chiaro scuro. Nelle due testate di questa galleria sono due tavole a olio di sua mano disegnate e dipinte, di tanta perfezzione, che di pittura si può vedere poco meglio. Nell'una delle quali è un Bacco et una Venere, fatti con arte maravigliosa e con giudizio. È il Bacco un giovinetto nudo, tanto tenero, delicato e dolce, che par di carne veramente e palpabile, e più tosto vivo che dipinto. Et intorno a esso sono alcuni vasi finti d'oro, d'argento, di cristallo e di diverse pietre finissime, tanto stravaganti e con tante bizzarrie attorno, che resta pieno di stupore chiunche vede quest'opera con tante invenzioni. Vi è anco fra l'altre cose, un satiro, che lieva una parte d'un padiglione, la testa del quale è di maravigliosa bellezza in quella sua strana cera caprina, e massimamente, che par che rida e tutto sia festoso in veder così bel giovinetto. Èvvi anco un putto a cavallo sopra un orso bellissimo, e molti altri graziosi e belli ornamenti a torno. Nell'altro è un Cupido e Venere con altre belle figure. Ma quello in che pose il Rosso grandissimo studio fu il Cupido: perché finse un putto di dodici anni, ma cresciuto e di maggiori fattezze che di quella età non si richiede, et in tutte le parti bellissimo. Le quali opere vedendo il re, e piacendogli sommamente, pose al Rosso incredibile affezione, onde non passò molto, che gli diede un canonicato nella santa capella della Madonna di Parigi, et altre tan-te entrate et utili, che il Rosso con buon numero di servidori e di cavalli viveva da signore e facea banchetti e cortesie straordinarie a tutti i conoscenti et amici, e massimamente ai forestieri italiani, che in quelle parti capitavano. Fece poi un'altra sala, chiamata il Padiglione, perché è sopra il primo piano delle stanze di sopra, che viene a essere l'ultima sopra tutte l'altre et in forma di padiglione, la quale stanza condusse dal piano del pavimento fino agl'arcibanchi, con varii e belli ornamenti di stucchi, e figure tutte tonde spartite con egual distanza, con putti, festoni e varie sorti d'animali. E negli spartimenti de' piani n'è una figura a fresco a sedere, in sì gran numero, che in essi si veggiono figurati tutti gli dèi e dee degl'antichi e gentili; e nel fine sopra le finestre è un fregio tutto ornato di stucchi e ricchissimo, ma senza pitture. Fece poi in molte camere, stufe et altre stanze, infinite opere pur di stucchi e di pitture, delle quali si veggiono alcune ritratte e mandate fuora in stampe, che sono molto belle e graziose; sì come sono ancora infiniti disegni che il Rosso fece di saliere, vasi, conche et altre bizzarrie, che poi fece fare quel re tutti d'argento, le quali furono tante che troppo sarebbe di tutte voler far menzione. E però basti dire che fece disegni per tutti i vasi d'una credenza da re, e per tutte quelle cose, che per abigliamenti di cavalli, di mascherate, di trionfi e di tutte l'altre cose che si possono immaginare; e con sì strane e bizzarre fantasie, che non è possibile far meglio. Fece quando Carlo Quinto imperadore andò l'anno 1540 sotto la fede del re Francesco in Francia, avendo seco non più che dodici uomini, a Fontanableò la metà di tutti gl'ornamenti, che fece il re fare per onorare un tanto imperadore; e l'altra metà fece Francesco Primaticcio bolognese. Ma le cose che fece il Rosso d'archi, di colossi, altre cose simili, furono, per quanto si disse allora, le più stupende che da altri insino allora fussero state fatte mai. Ma una gran parte delle stanze, che il Rosso fece al detto luogo di Fontanableò, sono state disfatte dopo la sua morte dal detto Francesco Primaticcio, che in quel luogo ha fatto nuova e maggior fabrica.
Lavorarono con il Rosso le cose sopradette di stucco e di rilievo, e furono da lui sopra tutti gl'altri amati, Lorenzo Naldino fiorentino, maestro Francesco d'Orliens, maestro Simone da Parigi e maestro Claudio similmente parigino, maestro Lorenzo Piccardo et altri molti. Ma il migliore di tutti fu Domenico del Barbieri, che è pittore e maestro di stucchi eccellentissimo e disegnatore straordinario, come ne dimostrano le sue opere stampate, che si possono annoverare fra le migliori che vadano a torno. I pittori parimenti, che egli adoperò nelle dette opere di Fontanableò, furono Luca Penni fratello di Giovan Francesco detto il Fattore, il quale fu discepolo di Raffaello da Urbino; Lionardo fiamingo, pittore molto valente, il quale conduceva bene affatto con i colori i disegni del Rosso; Bartolomeo Miniati fiorentino; Francesco Caccianimici e Giovambatista da Bagnacavallo, i quali ultimi lo servirono mentre Francesco Primaticcio andò per ordine del re a Roma a formare il Laoconte, l'Apollo e molte altre anticaglie rare, per gettarle di bronzo. Tacerò gl'intagliatori, i maestri di legname et altri infiniti di quali si servì il Rosso in queste opere, perché non fa di bisogno ragionare di tutti, come che molti di loro facessero opere degne di molta lode. Lavorò di sua mano il Rosso, oltre le cose dette, un S. Michele che è cosa rara. Et al connestabile fece una tavola d'un Cristo morto, cosa rara che è a un suo luogo chiamato Ceuan, e fece anco di minio a quel re cose rarissime. Fece appresso un libro di notomie per farlo stampare in Francia, del quale sono alcuni pezzi di sua mano nel nostro libro de' disegni; si trovarono anco fra le sue cose, dopo che fu morto, due bellissimi cartoni: in uno de' quali è una Leda che è cosa singolare, e nell'altro la Sibilla Tiburtina che mostra a Ottaviano imperadore la Vergine gloriosa con Cristo nato in collo. Et in questo fece il re Francesco, la reina, la guardia et il popolo con tanto numero di figure, e sì ben fatte, che si può dire con verità che questa fusse una delle belle cose che mai facesse il Rosso. Il quale fu per queste opere, et altre molte che non si sanno, così grato al re, che egli si trovava poco avanti la sua morte avere più di mille scudi d'entrata, senza le provisioni dell'opera, che erano grossissime. Di maniera che non più da pittore, ma da principe vivendo, teneva servitori assai, cavalcature, et aveva la casa fornita di tapezzerie e d'argenti, et altri fornimenti e masserizie di valore; quando la fortuna, che non lascia mai o rarissime volte lungo tempo in alto grado chi troppo si fida di lei, lo fece nel più strano modo del mondo capitar male: perché, praticando con esso lui, come dimestico e familiare, Francesco di Pellegrino fiorentino, il quale della pittura si dilettava et al Rosso era amicissimo, gli furono rubate alcune centinaia di ducati. Onde il Rosso, non sospettando d'altri che di detto Francesco, lo fece pigliare dalla corte, e con esamine rigorose tormentarlo molto. Ma colui, che si trovava innocente, non confessando altro che il vero, finalmente relassato, fu sforzato, mosso da giusto sdegno, a risentirsi contra il Rosso del vituperoso carico che da lui gli era stato falsamente apposto. Perché datogli un libello d'ingiuria, lo strinse in tal maniera, che il Rosso, non se ne potendo aiutare, né difendere, si vide a mal partito, parendogli non solo avere falsamente vituperato l'amico, ma ancora machiato il proprio onore, et il disdirsi, o tenere altri vituperosi modi, lo dichiarava similmente uomo disleale e cattivo. Per che deliberato di uccidersi da se stesso, più tosto che esser castigato da altri, prese questo partito: un giorno che il re si trovava a Fontanableò mandò un contadino a Parigi per certo velenosissimo liquore, mostrando voler servirsene per far colori o vernici, con animo, come fece, d'avelenarsi. Il contadino dunque tornandosene con esso (tanta era la malignità di quel veleno) per tenere solamente il dito grosso sopra la bocca dell'ampolla turata diligentemente con la cera, rimase poco meno che senza quel dito, avendoglielo consumato e quasi mangiato la mortifera virtù di quel veleno, che poco appresso uccise il Rosso, avendolo egli, che sanissimo era, preso, perché gli togliesse, come in poche ore fece, la vita. La qual nuova essendo portata al re senza fine gli dispiacque, parendogli aver fatto nella morte del Rosso perdita del più eccellente artefice de' tempi suoi. Ma perché l'opera non patisse, la fece seguitare a Francesco Primaticcio bolognese, che già gl'aveva fatto, come s'è detto, molte opere, donandogli una buona badia, sì come al Rosso avea fatto un canonicato.
Morì il Rosso l'anno 1541, lasciando di sé gran disiderio agl'amici et agl'artefici, i quali hanno mediante lui conosciuto quanto acquisti appresso a un prencipe uno che sia universale, et in tutte l'azzioni manieroso e gentile, come fu egli, il quale per molte cagioni ha meritato e merita di essere ammirato come veramente eccellentissimo.
VITA DI BARTOLOMEO DA BAGNACAVALLO ET ALTRI PITTORI ROMAGNUOLI

Certamente che il fine delle concorrenzie nelle arti, per la ambizione della gloria, si vede il più delle volte esser lo-dato; ma s'egli avviene che da superbia e da presumersi chi concorre meni alcuna volta troppa vampa di sé, si scorge in ispazio di tempo quella virtù che cerca, in fumo e nebbia risolversi; atteso che mal può crescere in perfezzione chi non conosce il proprio difetto e chi non teme l'operare altrui; però meglio si conduce ad augumento la speranza degli studiosi timidi, che sotto colore d'onesta vita onorano l'opere de' rari maestri, e con ogni studio quelle imitano, che quella di coloro che hanno il capo pieno di superbia e di fumo, come ebbero Bartolomeo da Bagnacavallo, Amico Bolognese, Girolamo da Codignuola et Innocenzio da Imola pittori: perché essendo costoro in Bologna in un medesimo tempo, s'ebbero l'uno all'altro quell'invidia, che si può maggiore imaginare. E, che è più, la superbia loro e la vanagloria, che non era sopra il fondamento della virtù collocata, li deviò dalla via buona; la quale all'eternità conduce coloro che più per bene operare che per gara combattono. Fu dunque questa cosa cagione che a' buoni principii che avevano costoro non diedero quello ottimo fine che s'aspettava. Conciò sia che il presumersi d'essere maestri li fece troppo discostarsi dal buono.
Era Bartolomeo da Bagnacavallo venuto a Roma, ne' tempi di Raffaello, per aggiugnere con l'opere, dove con l'a-nimo gli pareva arrivare di perfezzione. E come giovane, ch'aveva fama in Bologna per l'aspettazione di lui, fu messo a fare un lavoro nella chiesa della Pace di Roma, nella cappella prima a man destra entrando in chiesa, sopra la cappella di Baldassar Perucci sanese. Ma non gli parendo riuscire quel tanto, che di sé aveva promesso, se ne tornò a Bologna, dove egli et i sopra detti fecero a concorrenza l'un dell'altro in San Petronio, ciascuno una storia della vita di Cristo e della madre alla capella della Madonna, alla porta della facciata dinanzi a man destra entrando in chiesa, fra le quali poca differenza di perfezzione si vede dall'una all'altra. Per che Bartolomeo acquistò in tal cosa fama di avere la maniera più dolce e più sicura. Et avvenga che nella storia di maestro Amico sia una infinità di cose strane, per aver figurato nella Resurression di Cristo gl'armati con attitudini torte e rannicchiate, e dalla lapida del sepolcro, che rovina loro addosso, stiacciati molti soldati; nondimeno per essere quella di Bartolomeo più unita di disegno e di colorito, fu più lodata dagli artefici. Il che fu cagione ch'egli facesse poi compagnia con Biagio Bolognese, persona molto più pratica nella arte che eccellente, e che lavorassino in compagnia in San Salvatore a' frati Scopetini, un refettorio, il quale dipinsero parte a fresco parte a secco; dentrovi quando Cristo sazia coi cinque pani e due pesci, cinquemila persone. Lavorarono ancora in una facciata della libreria la disputa di Santo Agostino, nella quale fecero una prospettiva assai ragionevole. Avevano questi maestri, per avere veduto l'opere di Raffaello e praticato con esso, un certo che d'un tutto, che pareva di dovere esser buono; ma nel vero non attesero all'ingegnose particolarità dell'arte, come si debbe. Ma perché in Bologna in que' tempi non erano pittori che sapessero più di loro, erano tenuti da chi governava e dai popoli di quella città i migliori maestri d'Italia. Sono di mano di Bartolomeo sotto la volta del palagio del podestà alcuni tondi in fresco, e dirimpetto al palazzo de' Fantucci in San Vitale una storia della visitazione di Santa Elisabetta. E ne' Servi di Bologna intorno a una tavola d'una Nunziata dipinta a olio, alcuni Santi lavorati a fresco da Innocenzio da Imola. Et in San Michele in Bosco dipinse Bartolomeo a fresco la capella di Ramazzotto, capo di parte in Romagna. Dipinse il medesimo in Santo Stefano in una capella due Santi a fresco con certi putti in aria assai begli. Et in San Iacopo una capella a Messer Aniballe del Corello, nella quale fece la Circoncisione di Nostro Signore, con assai figure; e nel mezzo tondo disopra fece Abramo, che sacrifica il figliuolo a Dio. E questa opera invero fu fatta con buona pratica e maniera. A tempera dipinse nella Misericordia fuor di Bologna in una tavoletta la Nostra Donna et alcuni Santi, e per tutta la città molti quadri et altre opere, che sono in mano di diversi. E nel vero fu costui nella bontà della vita e nell'opere più che ragionevole, et ebbe miglior disegno et invenzione che gl'altri, come si può vedere nel nostro libro in un disegno, nel quale è Gesù Cristo fanciullo che disputa con i Dottori nel tempio, con un casamento molto ben fatto e con giudizio. Finalmente finì costui la vita d'anni cinquantotto, essendo sempre stato molto invidiato da Amico Bolognese, uomo capriccioso e di bizzarro cervello: come sono anco pazze, per dir così, e capricciose, le figure da lui fatte per tutta Italia e particolarmente in Bologna, dove dimorò il più del tempo. E nel vero, se le molte fatiche che fece et i disegni, fussero state dura-te per buona via e non a caso, egli averebbe per aventura passato molti, che tenghiamo rari e valent'uomini. Ma può tanto, dall'altro lato, il fare assai, che è impossibile non ritrovarne infra molte alcuna buona e lodevole opera, come è fra le infinite che fece costui una facciata di chiaro scuro in sulla piazza de' Marsigli, nella quale sono molti quadri di storie, et un fregio d'animali che combattono insieme, molto fiero e ben fatto, e quasi delle migliori cose che dipignesse mai. Un'altra facciata dipinse alla porta di San Mammolo, et a San Salvadore un fregio intorno alla capella maggiore, tanto stravagante e pieno di pazzie, che farebbe ridere chi ha più voglia di piagnere. Insomma non è chiesa, né strada in Bologna, che non abbia qualche imbratto di mano di costui. In Roma ancora dipinse assai; et a Lucca in San Friano una capella con strane e bizzarre fantasie, e con alcune cose degne di lode come sono le storie della Croce et alcune di Santo Agostino, nelle quali sono infiniti ritratti di persone segnalate in quella città. E per vero dire questa fu delle migliori opere, che maestro Amico facesse mai a fresco, di colori. Et anco in San Iacopo di Bologna, all'altare di San Nicola, alcune storie di quel Santo, et un fregio da basso con prospettive, che meritan di esser lodate. Quando Carlo Quinto imperador andò a Bologna, fece Amico alla porta del palazzo un arco trionfale, nel quale fece Alfonso Lombardi le statue di rilievo. Né è maraviglia che quella d'Amico fusse più pratica che altro, perché si dice che, come persona astratta che egli era e fuor di squadra dall'altre, andò per tutta Italia disegnando e ritraendo ogni cosa di pittura e di rilievo, e così le buone come le cattive; il che fu cagione, che egli diventò un praticaccio inventore. E quando poteva aver cose da servirsene vi metteva su volentieri le mani; e poi, perché altri non se ne servissi, le guastava. Le quali fatiche furono cagione, che egli fece quella maniera così pazza e strana. Costui venuto finalmente in vecchiezza di settanta anni, fra per l'arte e la stranezza della vita, bestialissimamente impazzò; onde Messer Francesco Guicciardino, nobilissimo fiorentino e veracissimo scrittore delle storie de' tempi suoi, il quale era allora governatore di Bologna, ne pigliava non piccolo piacere insieme con tutta la città. Nondimeno credono alcuni, che questa sua pazzia fusse mescolata di tristizia, perché avendo venduto per piccol prezzo alcuni beni mentre era pazzo et in estremo bisogno, gli rivolle, essendo tornato in cervello, e gli riebbe con certe condizioni, per avergli venduto, diceva egli, “quando ero pazzo”; tuttavia, perché può anco essere altrimenti, non affermo che fusse così, ma ben dico che così ho molte volte udito raccontare. Attese costui anco alla scultura, e come seppe il meglio fece di marmo in San Petronio, entrando in chiesa a man ritta, un Cristo morto e Nicodemo, che lo tiene, della maniera che sono le sue pitture. Dipigneva Amico con amendue le mani a un tratto, tenendo in una il pennello del chiaro e nell'altra quello dello scuro; ma quello che era più bello e da ridere si è che, stando cinto, aveva intorno intorno piena la coreggia di pignatti pieni di colori temperati, di modo che pareva il diavolo di San Macario con quelle sue tante ampolle. E quando lavorava con gl'occhiali al naso arebbe fatto ridere i sassi, e massimamente se si metteva a cicalare, perché chiacchierando per venti, e dicendo le più strane cose del mondo, era uno spasso il fatto suo. Vero è che non usò mai di dir bene di persona alcuna, per virtuosa o buona ch'ella fusse, o per bontà che vedesse in lei di natura o di fortuna. E come si è detto fu tanto vago di gracchiare e dir novelle, che avendo una sera un pittor bolognese in sull'Ave Maria compero cavoli in piazza, si scontrò in Amico, il quale con sue novelle, non si potendo il povero uomo spiccare da lui, lo tenne sotto la loggia del podestà a ragionamento con sì fatte piacevoli novelle tanto che, condottisi fin presso a giorno, disse Amico all'altro pittore: “Or va, cuoci il cavolo, che l'ora passa”.
Fece altre infinite burle e pazzie, delle quali non farò menzione, per essere oggimai tempo che si dica alcuna cosa di Girolamo da Cotignuola, il quale fece in Bologna molti quadri e ritratti di naturale, ma fra gl'altri, due che sono molto belli, in casa de' Vinacci. Ritrasse dal morto monsignor de Fois, che morì nella rotta di Ravenna, e non molto dopo fece il ritratto di Massimiliano Sforza. Fece una tavola in San Giuseppe, che gli fu molto lodata; et a San Michele in Bosco la tavola a olio che è alla cappella di San Benedetto, la quale fu cagione che con Biagio Bolognese egli facesse tutte le storie che sono intorno alla chiesa, a fresco imposte et a secco lavorate; nelle quali si vede pratica assai, come nel ragionare della maniera di Biagio si è detto. Dipinse il medesimo Girolamo in Santa Colomba di Rimini, a concorrenza di Benedetto da Ferrara e di Lattanzio, un'ancona, nella quale fece una Santa Lucia più tosto lasciva, che bella; e nella tribuna maggiore una coronazione di Nostra Donna con i dodici Apostoli e quattro Evangelisti, con teste tanto grosse e contrafatte, che è una vergogna vederle. Tornato poi a Bologna, non vi dimorò molto che andò a Roma, dove ritrasse di naturale molti signori, e particolarmente papa Paulo Terzo. Ma vedendo che quel paese non faceva per lui, e che male poteva acquistare onore, utile, o nome fra tanti pittori nobilissimi, se n'andò a Napoli, dove trovati alcuni amici suoi che lo favorirono, e particolarmente Messer Tommaso Cambi mercatante fiorentino, delle antiquità de' marmi antichi e del-le pitture molto amatore, fu da lui accomodato di tutto quello che ebbe di bisogno. Perché messosi a lavorare, fece in Monte Oliveto la tavola de' Magi a olio, nella capella di un Messer Antonello vescovo di non so che luogo; et in Santo Aniello in un'altra tavola a olio la Nostra Donna, San Paulo e San Giovambatista; et a molti signori, ritratti di naturale. E perché vivendo con miseria, cercava di avanzare, essendo già bene in là con gl'anni, dopo non molto tempo, non a-vendo quasi più che fare in Napoli, se ne tornò a Roma. Per che avendo alcuni amici suoi inteso che aveva avanzato qualche scudo, gli persuasero che per governo della propria vita, dovesse tor moglie. E così egli, che si credette far be-ne, tanto si lasciò aggirare, che dai detti, per commodità loro, gli fu messa a canto per moglie una puttana che essi si tenevano. Onde sposata che l'ebbe, e giaciuto che si fu con esso lei, si scoperse la cosa con tanto dolore di quel povero vecchio, che egli in poche settimane se ne morì d'età d'anni 69.
Per dir ora alcuna cosa di Innocenzio da Immola, stette costui molti anni in Fiorenza con Mariotto Albertinelli, e dopo, ritornato a Immola, fece in quella terra molte opere. Ma persuaso finalmente dal conte Giovambattista Bentivogli, andò a stare a Bologna; dove fra le prime opere contrafece un quadro di Raffaello da Urbino già stato fatto al signor Lionello da Carpi. Et ai monaci di San Michele in Bosco lavorò nel capitolo a fresco la morte di Nostra Donna e la Ressurrezzione di Cristo, la quale opera certo fu condotta con grandissima diligenza e pulitezza. Fece anco nella chiesa del medesimo luogo la tavola dell'altar maggiore, la parte disopra della quale è lavorata con buona maniera. Ne' Servi di Bologna fece in tavola una Nunziata, et in San Salvadore un Crucifisso e molti quadri et altre pitture per tutta la città. Alla Viola fece per lo cardinale Ivrea tre logge in fresco, cioè in ciascuna due storie colorite con disegni d'altri pittori, ma fatte con diligenza. In San Iacopo fece una capella in fresco et una tavola a olio per madonna Benozza, che non fu se non ragionevole. Ritrasse anco oltre molti altri Francesco Alidosio cardinale, che l'ho veduto io in Imola insieme col ritratto del cardinale Bernardino Carniale, che ammendue sono assai begli. Fu Innocenzio persona assai modesta e buona, onde fuggì sempre la pratica e conversazione di que' pittori bolognesi, che erano di contraria natura. E perché si affaticava più di quello che potevano le forze sue, amalandosi di anni cinquantasei di febre pestilenziale, ella lo trovò sì debole et affaticato, che in pochi giorni l'uccise. Per che essendo rimaso imperfetto, anzi quasi non ben ben cominciato, un lavoro che avea preso a fare fuor di Bologna, lo condusse a ottima fine, secondo che Innocenzio ordinò avanti la sua morte, Prospero Fontana pittore bolognese. Furono l'opere di tutti i sopradetti pittori dal MDVI infino al MDXLII. E di mano di tutti sono disegni nel nostro libro.
VITA
DEL FRANCIA BIGIO
PITTOR FIORENTINO

Le fatiche che si patiscono nella vita per levarsi da terra e ripararsi da la povertà, soccorrendo non pure sé ma i prossimi suoi, fanno che il sudor e disagi diventano dolcissimi, et il nutrimento di ciò talmente pasce l'animo altrui, che la bontà del cielo, veggendo alcun volto a buona vita et ottimi costumi e pronto et inclinato agli studi delle scienze, è sforzato sopra l'usanza sua essergli nel genio favorevole e benigno. Come fu veramente al Francia pittor fiorentino; il quale da ottima e giusta cagione posto all'arte della pittura, s'esercitò in quella, non tanto desideroso di fama, quanto per porgere aiuto ai poveri parenti suoi. Et essendo egli nato di umilissimi artefici e persone basse, cercava svilupparsi da questo, al che fare lo spronò molto la concorrenza di Andrea del Sarto allora suo compagno, co 'l quale molto tempo tenne e bottega e la vita del dipignere. La qual vita fu cagione ch'eglino grande acquisto fecero l'un per l'altro all'arte della pittura.
Imparò il Francia nella sua giovanezza, dimorando alcuni mesi con Mariotto Albertinelli, i principii dell'arte. Et essendo molto inclinato alle cose di prospettiva e quella imparando di continuo per lo diletto di essa, fu in Fiorenza riputato molto valente nella sua giovanezza. Le prime opere da lui dipinte furono in San Brancazio, chiesa dirimpetto alle case sue, cioè un San Bernardo lavorato in fresco, e nella cappella de' Rucellai in un pilastro una Santa Caterina da Siena lavorata similmente in fresco: le quali diedero saggio delle sue buone qualità, che in tale arte mostrò per le sue fatiche. Ma molto più lo fé tenere valente un quadro di Nostra Donna con il Putto in collo ch'è a una capellina in San Piero Maggiore, dove un San Giovanni fanciullo fa festa a Gesù Cristo. Si dimostrò anco eccellente a San Giobbe dietro a' Servi in Fiorenza in un cantone della chiesa di detto Santo, in un tabernacolo lavorato a fresco, nel quale fece la visitazione della Madonna. Nella quale figura si scorge la benignità della Madonna, e nella vecchia una reverenza grandissima; e dipinse il San Giobbe povero e lebbroso, et il medesimo ricco e sano. La quale opera diè tal saggio di lui, che pervenne in credito et in fama. Laonde gli uomini, che di quella chiesa e Compagnia erano capitani, gli allogarono la tavola dello altar maggiore, nella quale il Francia si portò molto meglio; et in tale opera, in un San Giovanni Batista si ritrasse nel viso; e fece in quella una Nostra Donna e San Giobbe povero.
Edificossi allora in Santo Spirito di Fiorenza, la cappella di San Niccola, nella quale di legno col modello di Iacopo Sansovino fu intagliato esso Santo tutto tondo, et il Francia due Agnoletti, che in mezzo lo mettono, dipinse a olio in duo quadri che furono lodati, et in due tondi fece una Nunziata; e lavorò la predella di figure piccole dei miracoli di San Niccola con tanta diligenza, che merita perciò molte lodi. Fece in San Pier Maggiore alla porta a man destra entrando in chiesa, una Nunziata, dove ha fatto l'Angelo che ancora vola per aria, et essa che ginocchioni, con una graziosissima attitudine, riceve il saluto. E vi ha tirato un casamento in prospettiva, il quale fu cosa molto lodata et ingegnosa. E nel vero ancor che 'l Francia avesse la maniera un poco gentile, per essere egli molto faticoso e duro nel suo operare, nientedimeno egli era molto riservato e diligente nelle misure dell'arte nelle figure. Gli fu allogato a dipignere nei Servi, per concorrenza d'Andrea del Sarto, nel cortile dinanzi alla chiesa, una storia: nella quale fece lo sposalizio di Nostra Donna, dove apertamente si conosce la grandissima fede che aveva Giuseppo, il quale sposandola non meno mostra nel viso il timore che l'allegrezza. Oltra che egli vi fece uno che gli dà certe pugna, come si usa ne' tempi nostri per ricordanza delle nozze. Et in uno ignudo espresse felicemente l'ira et il desio, inducendolo a rompere la verga sua che non era fiorita, e di questo, con molti altri, è il disegno nel nostro libro. In compagnia ancora della Nostra Donna fece alcune femmine con bellissime arie et acconciature di teste, de le quali egli si dilettò sempre. Et in tutta questa istoria, non fece cosa che non fusse benissimo considerata: come è una femmina con un putto in collo che va in casa, et ha dato de le busse ad un altro putto che postosi a sedere non vuole andare e piagne e sta con una mano al viso molto graziatamente. E certamente che in ogni cosa, e grande e piccola, mise in quella istoria molta diligenza et amore, per lo sprone et animo che aveva di mostrare in tal cosa agli artefici et agli altri intendenti, quanto egli le difficultà dell'arte sempre avesse in venerazione, e quelle imitando a buon termine riducesse.
Volendo non molto dopo i frati per la solennità d'una festa, che le storie d'Andrea si scoprissero e quelle del Francia similmente, la notte che il Francia aveva finita la sua dal basamento in fuori, come temerari e prosontuosi gliela scopersero, pensando, come ignoranti di tale arte, che il Francia ritoccare o fare altra cosa nelle figure non dovesse. La mattina, scoperta così quella del Francia come quelle d'Andrea, fu portato la nuova al Francia che l'opere d'Andrea e la sua erano scoperte: di che ne sentì tanto dolore, che ne fu per morire. E venutagli stizza contra a' frati per la presunzione loro, che così poco rispetto gli avevano usato, di buon passo caminando pervenne all'opera. E salito su 'l ponte, che ancora non era disfatto se bene era scoperta la storia, con una martellina da muratori, che era quivi, percosse alcune teste di femmine e guastò quella della Madonna, e così uno ignudo che rompe una mazza, quasi tutto lo scalcinò dal muro. Per il che i frati corsi al rumore, et alcuni secolari gli tennero le mani, ché non la guastasse tutta. E benché poi co 'l tempo gli volessero dar doppio pagamento, egli però non volle mai, per l'odio che contra di loro aveva concetto, racconciarla. E per la riverenza avuta a tale opera et a lui, gli altri pittori non l'hanno voluta finire. E così si resta fino a ora, per quella memoria. La quale opera è lavorata in fresco con tanto amore e con tanta diligenza e con sì bella freschezza, che si può dire che 'l Francia in fresco lavorasse meglio che uomo del tempo suo; e meglio con i colori sicuri da 'l ritoccare, in fresco le sue cose unisse et isfumasse. Onde per questa e per l'altre sue opere merita molto d'esser celebrato. Fece ancor fuor della porta alla Croce di Fiorenza, a Rovezzano, un tabernacolo d'un Crocifisso et altri Santi, et a San Giovannino alla porta di San Pier Gattolino un cenacolo di Appostoli lavorò a fresco. Non molto dopo nell'andare in Francia Andrea del Sarto pittore, il quale aveva incominciato alla Compagnia dello Scalzo di Fiorenza un cortile di chiaro e scuro, dentrovi le storie di San Giovanni Batista, gli uomini di quella avendo desiderio dar fine a tal cosa presero il Francia, acciò, come imitatore della maniera di Andrea, l'opera cominciata da lui, seguitasse. Laonde in quel luogo fece il Francia intorno intorno gli ornamenti a una parte; e condusse a fine due storie di quelle lavorate con diligenza. Le quali sono quando San Giovanni Batista piglia licenzia dal padre suo Zacheria, per andare al deserto; e l'altra lo incontrare che si fecero per viaggio Cristo e San Giovanni con Giuseppo e Maria, ch'ivi stanno a vederli abbracciare. Né seguì più innanzi per lo ritorno d'Andrea, il quale continuò poi di dar fine al resto dell'opere. Fece con Ridolfo Ghirlandai uno apparato bellissimo per le nozze del duca Lorenzo, con due prospettive per le comedie che si fecero, lavorate molto con ordine e maestrevole gudicio e grazia; per le quali acquistò nome e favore appresso a qual Principe. La qual servitù fu cagione ch'egli ebbe l'opera della volta della sala del Poggio a Caiano a mettersi d'oro, in compagnia d'Andrea di Cosimo; e poi cominciò per concorrenza di Andrea del Sarto e di Iacopo da Puntormo una facciata di detta: quando Cicerone dai cittadini romani è portato per gloria sua. La quale opera aveva fatto cominciare la liberalità di papa Leone per memoria di Lorenzo suo padre, che tale edifizio aveva fatto fabbricare, e di ornamenti e di storie antiche a suo proposito fatto dipignere. Le quali dal dottissimo istorico Messer Paolo Giovio vescovo di Nocera, allora primo appresso a Giulio cardinale de' Medici, erano state date ad Andrea del Sarto et Iacopo da Puntormo et al Francia Bigio, che il valore e la perfezzione di tale arte in quella mostrassero; et avevano il Magnifico Ottaviano de' Medici che ogni mese dava loro trenta scudi per ciascuno. Laonde il Francia fece nella parte sua, oltra la bellezza della storia, alcuni casamenti misurati molto bene in prospettiva. Ma questa opera per la morte di Leone rimase imperfetta, e poi fu di commissione del Duca Alessandro de' Medici l'anno 1532 ricominciata da Iacopo da Puntormo, il quale la mandò tanto per la lunga, che il Duca si morì et il lavoro restò a dietro.
Ma per tornare al Francia, egli ardeva tanto vago delle cose dell'arte, che non era giorno di stare, che e' non ritraesse di naturale per istudio uno ignudo in bottega sua, tenendo del continuo per ciò uomini salariati. Fece in Santa Maria Nuova una notomia a requisizione di maestro Andrea Pasquali medico fiorentino eccellentissimo, il che fu cagione ch'egli migliorò molto nell'arte della pittura e la seguitò poi sempre con più amore. Lavorò poi nel convento di Santa Maria Novella sopra la porta della libreria nel mezzo tondo un San Tommaso, che confonde gli eretici con la dottrina, la quale opera è molto lavorata con diligenza e buona maniera. E fra gli altri particulari vi son due fanciulli, che servono a tenere nell'ornamento un'arme, i quali sono di molta bontà e di bellissima grazia ripieni, e di maniera vaghissimi lavorati. Fece ancora un quadro di figure piccole a Giovanni Maria Benintendi, a concorrenza di Iacopo da Puntormo che glie ne fece un altro d'una simil grandezza, con la storia de' Magi; e due altri Francesco d'Albertino. Fece il Francia nel suo quando David vede Bersabè lavarsi in un bagno, dove lavorò alcune femmine con troppo leccata e saporita maniera, e tirovvi un casamento in prospettiva, nel quale fa David che dà lettere a' corrieri, che le portino in campo perché Uria Eteo sia morto. E sotto una loggia fece in pittura un pasto regio bellissimo. La quale storia fu di molto utile alla fama et onore del Francia, il quale se molto valse nelle figure grandi, valse molto più nelle piccole. Fece anco il Francia molti e bellissimi ritratti di naturale; uno particolarmente a Matteo Sofferroni suo amicissimo, et un altro a un lavoratore e fattore di Pierfrancesco de' Medici al palazzo di San Girolamo da Fiesole, che par vivo, e molti altri. E perché lavorò universalmente d'ogni cosa, senza vergognarsi di far l'arte sua, mise mano a qualunque lavoro gli fu dato da fare; onde oltre a molti lavori di cose bassissime, fece per Arcangelo tessitore di drappi in porta Rossa, sopra una torre che ser-ve per terrazzo, un Noli me tangere, bellissimo, et altre infinite simile minuzie delle quali non fa bisogno dirne altro, per essere stato il Francia persona di buona e dolce natura, e molto servente. Amò costui di starsi in pace, e per questa cagione non volle mai prender donna, usando di dire quel trito proverbio, che chi ha moglie ha pene e doglie. Non volle mai uscir di Firenze, perché avendo vedute alcune opere di Raffaello da Urbino e parendogli non esser pari a tanto uomo, né a molti altri di grandissimo nome, non si volle mettere a paragone d'artefici così eccellenti e rarissimi. E nel ve-ro la maggior prudenza e saviezza, che possa essere in un uomo, è conoscersi, e non presumere di sé più di quello che sia il valore. Finalmente avendo molto acquistato nel lavorare assai, come che non avesse dalla natura molto fiera invenzione, né altro che quello che s'aveva acquistato con lungo studio, si morì l'anno 1524, d'età d'anni 42.
Fu discepolo del Francia Agnolo suo fratello, che avendo fatto un fregio che è nel chiostro di San Brancazio e poche altre cose, si morì. Fece il medesimo Agnolo a Ciano profumiero, uomo capriccioso et onorato par suo, in un'insegna da botega una zingana che dà con molta grazia la ventura a una donna. La quale invenzione di Ciano non fu senza misterio. Imparò la pittura dal medesimo Antonio di Donnino Mazzieri, che fu fiero disegnatore et ebbe molta invenzione in far cavalli e paesi; et il quale dipinse di chiaro scuro il chiostro di Santo Agostino al Monte San Savino, nel quale fece istorie del Testamento Vecchio, che furono molto lodate. Nel Vescovado d'Arezzo fece la capella di San Matteo, e fra l'altre cose quando battezza un re, dove ritrasse tanto bene un tedesco, che par vivo. A Francesco del Giocondo fece dietro al coro della chiesa de' Servi di Fiorenza in una capella la storia de' martiri, ma si portò tanto male, che avendo oltre modo perso il credito, si condusse a lavorare d'ogni cosa. Insegnò anco il Francia l'arte a un giovane detto Visino, il quale sarebbe riuscito eccellente, per quello che si vide, se non fusse, come avvenne, morto giovane, et a molti altri de' quali non si farà altra menzione. Fu sepolto il Francia dalla compagnia di San Giobbe in S. Brancazio, dirimpetto alla sua casa, l'anno 1525, e certo con molto dispiacere de' buoni artefici, essendo egli stato ingegnoso e pratico maestro, e modestissimo in tutte le sue azzioni.
VITA DEL MORTO DA FELTRO PITTORE E DI ANDREA DI COSIMO FELTRINI

Morto, pittore da Feltro, il quale fu astratto nella vita come era nel cervello e nelle novità nelle grottesche ch'egli faceva, le quali furono cagione di farlo molto stimare, si condusse a Roma nella sua giovanezza in quel tempo che il Pinturicchio per Alessandro VI dipigneva le camere papali, et in Castel Sant'Angelo, le logge e stanze da basso nel torrione e sopra altre camere. Per che egli, che era maninconica persona, di continuo alle anticaglie studiava, dove spartimenti di volte et ordini di facce alla grottesca vedendo e piacendogli, quelle sempre studiò. E sì i modi del girar le foglie all'anti-ca prese, che di quella professione a nessuno fu al suo tempo secondo. Per il che non restò di vedere sotto terra ciò che poté in Roma di grotte antiche et infinitissime volte. Stette a Tivoli molti mesi nella villa Adriana disegnando tutti i pavimenti e grotte, che sono in quella sotto e sopra terra. E sentendo che a Pozzuolo, nel Regno, vicino a Napoli dieci miglia, erano insieme muraglie piene di grottesche, di rilievo, di stucchi e dipinte, antiche, tenute bellissime, attese parecchi mesi in quel luogo a cotale studio. Né restò che in Campana, strada antica in quel luogo, piena di sepolture antiche, ogni minima cosa non disegnasse; et ancora al Trullo, vicino alla marina, molti di quei tempii e grotte sopra e sotto ritrasse. Andò a Baia et a Mercato di Sabato, tutti luoghi pieni d'edificii guasti e storiati, cercando di maniera che con lunga et amorevole fatica in quella virtù crebbe infinitamente di valore e di sapere. Ritornato poi a Roma, quivi lavorò molti mesi et attese alle figure, parendogli che di quella professione egli non fosse tale, quale nel magisterio delle grottesche era tenuto. E poi che era venuto in questo desiderio, sentendo i romori che in tale arte avevano Lionardo e Michelagnolo per li loro cartoni fatti in Fiorenza, subito si mise per andare a Fiorenza; e vedute l'opere, non gli parve po-ter fare il medesimo miglioramento, che nella prima professione aveva fatto. Laonde egli ritornò a lavorare alle sue grottesche.
Era allora in Fiorenza Andrea di Cosimo de' Feltrini pittor fiorentino, giovane diligente, il quale raccolse in casa il Morto, e lo trattenne con molto amorevoli accoglienze. E piaciutoli i modi di tal professione, volto egli ancora l'animo a quello esercizio, riuscì molto valente, e più del Morto fu col tempo raro et in Fiorenza molto stimato come si dirà di sotto. Per ch'egli fu cagione che il Morto dipignesse a Pier Soderini, allora gonfaloniere, la camera del palazzo a quadri di grottesche, le quali bellissime furono tenute; ma oggi, per racconciar le stanze del duca Cosimo, sono state ruinate e rifatte. Fece a maestro Valerio frate de' Servi, un vano d'una spalliera che fu cosa bellissima; e similmente per Agnolo Doni in una camera molti quadri, di variate e bizzarre grottesche. E perché si dilettava ancora di figure, lavorò alcuni tondi di Madonne, tentando se poteva in quelle divenir famoso, come era tenuto. Perché venutogli a noia lo stare a Fiorenza, si trasferì a Vinegia. E con Giorgione da Castelfranco, ch'allora lavorava il Fondaco de' tedeschi, si mise ad aiutarlo, facendo gli ornamenti di quella opera. E così in quella città dimorò molti mesi, tirato dai piaceri e dai diletti che per il corpo vi trovava. Poi se ne andò nel Friuli a fare opere, né molto vi stette, che faccendo i signori viniziani soldati, egli prese danari; e senza avere molto esercitato quel mestiero, fu fatta capitano di dugento soldati. Era allora lo essercito de' Viniziani condottosi a Zara di Schiavonia, dove appiccandosi un giorno una grossa scaramuccia, il Morto desideroso d'acquistar maggior nome in quella professione, che nella pittura non aveva fatto, andando valorosamente innanzi e combattendo in quella baruffa, rimase morto, come nel nome era stato sempre, d'età d'anni 45. Ma non sarà già mai nella fama morto, perché coloro che l'opere della eternità nelle arti manovali esercitano e di loro lasciano memoria do-po la morte, non possono per alcun tempo già mai sentire la morte delle fatiche loro. Perciò che gli scrittori grati fanno fede delle virtù di essi. Però molto deverebbono gli artefici nostri spronar se stessi con la frequenza degli studi, per venire a quel fine che rimanesse ricordo di loro per opere e per scritti, perché ciò facendo darebbono anima e vita a loro et all'opere ch'essi lasciano dopo la morte. Ritrovò il Morto le grottesche più simili alla maniera antica, ch'alcuno altro pittore, e per questo merita infinite lodi, da che per il principio di lui sono oggi ridotte dalle mani di Giovanni da Udine e di altri artefici a tanta bellezza e bontà, quanto si vede. Ma se bene il detto Giovanni et altri l'hanno ridotte a estrema perfezzione, non è però che la prima lode non sia del Morto, che fu il primo a ritrovarle e mettere tutto il suo studio in questa sorte di pitture, chiamate grottesche per essere elleno state trovate, per la maggior parte, nelle grotte delle rovine di Roma, senza che ognun sa che è facile aggiugnere alle cose trovate.
Seguitò nella professione delle grottesche in Fiorenza Andrea Feltrini detto di Cosimo, perché fu discepolo di Cosimo Rossegli per le figure, che le faceva acconciamente; e poi dal Morto per le grottesche, come s'è ragionato, il quale ebbe dalla natura in questo genere Andrea tanta invenzione e grazia, che trovò il far le fregiature maggiori e più copiose e piene, e che hanno un'altra maniera che le antiche, rilegandole con più ordine insieme, l'accompagnò con figure che né in Roma, né in altro luogo che in Fiorenza non se ne vede. Dove egli, se ne lavorò gran quantità, non fu nessuno che lo passassi mai di eccellenzia in questa parte. Come si vede in Santa Croce di Fiorenza l'ornamento dipinto, la predella a grottesche piccole e colorite intorno alla Pietà che fecie Pietro Perugino allo altare de' Seristori, le quali son campite prima di rosso e nero mescolato insieme, e sopra rilevato di varii colori, che son fatte facilmente e con una grazia e fierezza grandissima. Costui cominciò a dar principio di far le facciate delle case e palazzi sullo intonaco della calcina mescolata con nero di carbon pesto o vero paglia abrucciata, che poi sopra questo intonaco fresco dandovi di bianco, e disegnato le grottesche con que' partimenti che e' voleva sopra alcuni cartoni, spolverandogli sopra lo 'ntonaco veniva con un ferro a graffiare sopra quello talmente, che quelle facciate venivan disegnate tutte da quel ferro, e poi raschiato il bianco de' campi di queste grottesche che rimaneva scuro, le veniva ombrando, o col ferro medesimo trattegiando con buon disegno. Tutta quella opera poi, con un acquerello liquido come acqua tinta di nero, l'andava ombrando: che ciò mostra una cosa bella, vaga e rica da vedere, che, di ciò s'è trattato di questo modo nelle teoriche al capitolo 26 degli sgraffiti. Le prime facciate che fecie Andrea di questa maniera fu, in Borgo Ogni Santi, la facciata de' Gondi, che è molto leggiadra e graziosa, Lungarno fra 'l ponte Santa Trinita e quello della Carraia, di verso Santo Spirito, quella di Lanfredino Lanfredini, ch'è ornatissima e con varietà di spartimenti. Da San Michele di piazza Padella, lavorò pur di graffito la casa di Andrea e Tomaso Sertini, varia e con maggior maniera che l'altre due. Fece di chiaro scuro la facciata della chiesa de' frati de' Servi, dove fece fare in dua nichie a Tomaso di Stefano pittore l'Angelo che annunzia la Vergine, e nel cortile dove son le storie di San Filippo e della Nostra Donna fatte da Andrea del Sarto. Fra le dua porte fecie un'arme bellissima di papa Leone X, e per la venuta di quel pontefice in Fiorenza, fece alla facciata di Santa Maria del Fiore molti begli ornamenti di grottesche per Iacopo Sansovino, che gli piede per donna una sua sorella; fece il balda-chino dove andò sotto il Papa con un cielo pien di grottesche bellissimo, e drapelloni a torno con arme di quel Papa et altre imprese della chiesa, che fu poi donato alla chiesa di San Lorenzo di Fiorenza, dove ancora oggi si vede, e così molti stendardi e bandiere per, quella entrata, e nella onoranza di molti cavalieri fatti da quel pontefice e da altri principi, che ne sono in diverse chiese appiccate in quella città. Servì Andrea del continuo la casa de' Medici nelle nozze del duca Giuliano et in quelle del duca Lorenzo per gli aparati di quelle, empiendole di vari ornamenti di grottesche, così nelle essequie di que' principi, dove fu adoperato grandemente e dal Francia Bigio e da Andrea del Sarto, dal Puntormo e Ridolfo Grillandaio, e ne' trionfi et altri aparati dal Granaccio, che non si poteva far cosa di buono senza lui. Era Andrea il migliore uomo che tocassi mai pennello e di natura timido, e non volse mai sopra di sé far lavoro alcuno perché temeva a riscuotere i danari delle opere, e si dilettava lavorar tutto il giorno, né voleva inpacci di nessuna sorte; là dove si accompagnò con Mariotto di Francesco Mettidoro, persona nel suo mestiero de' più valenti e pratichi che avessi mai tutta l'arte, et accortissimo nel pigliare opere, e molto destro nel riscuotere e far facende; il quale aveva anche messo Raffaello di Biagio Mettidoro in compagnia loro, e tre lavoravano insieme col partire in terzo tutto il guadagno dell'o-pere che facevano, che così durò quella compagnia fino alla morte di ciascuno, che Mariotto a morire fu l'ultimo. E tornando all'opere di Andrea, dico che e' fece a Giovan Maria Benintendi tutti e palchi di casa sua e gli ornamenti delle anticamere, dove son le storie colorite dal Francia Bigio e da Iacopo da Puntormo. Andò col Francia al Poggio, e gli ornamenti di quelle storie condusse di terretta che non è possibile veder meglio. Lavorò per il cavaliere Guidotti nella via Larga di sgraffito la sua facciata, e parimente a Bartolomeo Panciatichi un'altra della casa che e' murò sulla piazza degl'Agli, oggi di Ruberto de' Ricci, bellissima. Né si può dire le fregiature, i cassoni, i forzieri e la quantità de' palchi che Andrea di sua mano lavorò, che per esserne tutta questa città piena, lasserò il commemorarlo; né anche tacerò i tondi delle arme di diverse sorte fatte da lui, che non si faceva nozze che non avessi or di questo or di quello cittadino la bottega piena; né si fece mai opere di fogliature di broccati vari e di tele e drappi d'oro tessuti, che lui non ne facessi disegno e con tanta grazia, varietà e bellezza, che diede spirito e vita a tutte queste cose. E se Andrea avessi conosciuto la virtù sua, arebbe fatto una ricchezza grandissima, ma gli bastò vivere et avere amore all'arte.
Né tacerò che nella gioventù mia servendo il duca Alessandro de' Medici quando venne Carlo Quinto a Fiorenza, mi fu dato a fare le bandiere del Castello o vero Cittadella, che si chiami oggi, dove ci fu uno stendardo che era diciotto braccia in aste e quaranta lungo, di drappo chermisi, dove andò a torno fregiature d'oro con l'imprese di Carlo V imperadore e di casa Medici, e nel mezzo l'arme di Sua Maestà, nel quale andò dentro quarantacinque migliaia d'oro in fogli, dove io chiamai per aiuto Andrea per le fregiature e Mariotto per metter d'oro, che molte cose imparai da quello uomo pien di amore e di bontà verso coloro che studiano l'arte, dove fu tale la pratica di Andrea, che oltre che me ne servii in molte cose per gli archi che si feciono nella entrata di Sua Maestà, me lo volsi in compagnia insieme col Tribolo, venendo madama Margherita figliuola di Carlo V a marito al duca Alessandro, per l'apparato che io feci nella casa del Magnifico Ottaviano de' Medici da San Marco, che si ornò di grottesche per man sua, di statue per le mani del Tribolo, e per figure e storie di mia mano. Ultimamente nelle essequie del duca Alessandro si adoperò assai, e molto più nelle nozze del duca Cosimo, ché tutte le imprese del cortile scritte da Messer Francesco Giambullari, che scrisse l'apparato di quelle nozze, furono dipinte da Andrea con varii e diversi ornamenti, là dove Andrea, che molte volte per uno umor malinconico che spesso lo tormentava si fu per tor la vita, ma era da Mariotto suo compagno osservato molto e guardato talmente, che già venuto vecchio di 64 anni finì il corso della vita sua lassando di sé fama di buono e di eccellente e raro maestro nelle grottesche de' tempi nostri, dove ogni artefice di mano ha sempre imitato quella maniera non solo in Fiorenza, ma altrove ancora.
VITA DI MARCO CALAVRESE
PITTORE

Quando il mondo ha un lume in una scienza che sia grande, universalmente ne risplende ogni parte, e dove maggior fiamma e dove minore; e secondo i siti e l'arie sono i miracoli ancora maggiori e minori; e nel vero di continuo certi ingegni in certe provincie sono a certe cose atti, ch'altri non possono essere. Né per fatiche, che eglino durino, arrivano però mai al segno di grandissima eccellenza. Ma se quando noi veggiamo in qualche provincia nascere un frutto che usato non sia a nascerci, ce ne maravigliamo, tanto più d'uno ingegno buono possiamo rallegrarci, quando lo troviamo in un paese dove non nascano uomini di simile professione. Come fu Marco Calavrese pittore, il quale uscito della sua patria, elesse come ameno e pieno di dolcezza per sua abitazione Napoli, se bene indrizzato aveva il camino per venirsene a Roma et in quella ultimare il fine che si cava dallo studio della pittura. Ma sì gli fu dolce il canto della Serena, dilettandosi egli massimamente di sonare di liuto, e sì le molli onde del Sebeto lo liquefecero, che restò prigione col corpo di quel sito fin che rese lo spirito al cielo, et alla terra il mortale. Fece Marco infiniti lavori, in olio et in fresco, et in quella patria mostrò valere più di alcuno altro che tale arte in suo tempo esercitasse. Come ne fece fede quello che lavorò in Aversa, dieci miglia lontano da Napoli, e particularmente nella chiesa di Santo Agostino allo altar maggiore una tavola a olio, con grandissimo ornamento; e diversi quadri con istorie e figure lavorate, nelle quali figurò Santo Agostino disputare con gli eretici e di sopra e dalle bande storie di Cristo e santi in varie attitudini. Nella quale opera si vede una maniera molto continuata e che tira al buono delle cose della maniera moderna, et un bellissimo e pratico colorito in essa si comprende. Questa fu una delle sue tante fatiche che in quella città e per diversi luoghi del regno fece. Visse di continuo allegramente, e bellissimo tempo si diede. Però che non avendo emulazione, né contrasto degl'artefici nella pittura, fu da que' signori sempre adorato, e delle cose sue si fece con bonissimi pagamenti sodisfare. Così, pervenuto a gli anni 56 di sua età, d'uno ordinario male finì la sua vita. Lasciò suo creato Giovanni Filippo Crescione pittor napolitano, il quale in compagnia di Lionardo Castellani suo cognato, fece molte pitture e tuttavia fanno: dei quali per esser vivi et in continuo essercizio, non accade far menzione alcuna.
Furono le pitture di maestro Marco da lui lavorate dal 1508 fino al 1542.
Fu compagno di Marco un altro calavrese, del quale non so il nome, il quale in Roma lavorò con Giovanni, da Udine lungo tempo e fece da per sé molte opere in Roma, e particolarmente facciate di chiaro scuro. Fece anche nella chiesa della Trinità la capella della Concezzione a fresco, con molta pratica e diligenza.
Fu ne' medesimi tempi Nicola, detto comunemente da ognuno maestro Cola dalla Matrice, il quale fece in Ascoli, in Calavria et a Norcia molte opere che sono notissime, che gl'acquistarono fama di maestro raro e del migliore che fusse mai stato in que' paesi. E perché attese anco all'architettura, tutti gl'edificii che ne' suoi tempi si fecero ad Ascoli et in tutta quella provincia, furono architettati da lui; il quale senza curarsi di veder Roma o mutar paese, si stette sempre in Ascoli vivendo un tempo allegramente con una sua moglie di buona et onorata famiglia e dotata di singolar virtù d'ani-mo, come si vide quanto, al tempo di papa Paulo Terzo, si levarono in Ascoli le parti; perciò che fuggendo costei col marito, il quale era seguitato da molti soldati, più per cagione di lei, che bellissima giovane era, che per altro, ella si risolvé, non vedendo di potere in altro modo salvare a sé l'onore et al marito la vita, a precipitarsi da un'altissima balza in un fondo; il che fatto, pensarono tutti che ella si fusse, come fu invero, tutta stritolata non che percossa a morte; per che lasciato il marito senza fargli alcuna ingiuria, se ne tornarono in Ascoli. Morta dunque questa singolar donna, degna d'eterna lode, visse maestro Cola il rimanente della sua vita poco lieto. Non molto dopo, essendo il signor Alessandro Vitelli fatto signore della Matrice, condusse maestro Cola già vecchio a Città di Castello dove, in un suo palazzo, gli fece dipignere molte cose a fresco e molti altri lavori, le quali opere finite, tornò maestro Cola a finire la sua vita alla Matrice. Costui non arebbe fatto se non ragionevolmente, se egli avesse la sua arte esercitato in luoghi dove la concorrenza e l'emulazione l'avesse fatto attendere con più studio alla pittura, et esercitare il bello ingegno di cui si vide che era stato dalla natura dotato.
VITA DI FRANCESCO MAZZUOLI
PITTORE PARMIGIANO

Fra molti che sono stati dotati in Lombardia della graziosa virtù del disegno e d'una certa vivezza di spirito nell'in-venzioni, e d'una particolar maniera di far in pittura bellissimi paesi, non è da posporre a nessuno, anzi da preporre a tutti gl'altri, Francesco Mazzuoli parmigiano, il quale fu dal cielo largamente dotato di tutte quelle parti che a un eccellente pittore sono richieste, poiché diede alle sue figure, oltre quello che si è detto di molti altri, una certa venustà, dolcezza e leggiadria nell'attitudini, che fu sua propria e particolare. Nelle teste parimente si vede che egli ebbe tutte quelle avvertenze che si dee, intanto che la sua maniera è stata da infiniti pittori immitata et osservata, per aver'egli dato all'ar-te un lume di grazia tanto piacevole, che saranno sempre le sue cose tenute in pregio, et egli da tutti gli studiosi del disegno onorato. Et avesse voluto Dio ch'egli avesse seguitato gli studii della pittura e non fusse andato dietro ai ghiribizzi di congelare mercurio per farsi più ricco di quello che l'aveva dotato la natura et il cielo, perciò che sarebbe stato sanza pari e veramente unico nella pittura; dove cercando di quello che non poté mai trovare, perdé il tempo, spregiò l'arte sua e fecesi danno nella propria vita e nel nome.
Nacque Francesco in Parma l'anno 1504, e perché gli mancò il padre essendo egli ancor fanciullo di poca età, restò a custodia di due suoi zii, fratelli del padre e pittori ammendue, i quali l'allevarono con grandissimo amore, insegnandogli tutti quei lodevoli costumi che ad uomo cristiano e civile si convengono. Dopo, essendo alquanto cresciuto, tosto che ebbe la penna in mano per imparare a scrivere, cominciò, spinto dalla natura che l'avea fatto nascere al disegno, a far cose in quello maravigliose; di che accortosi il maestro che gl'insegnava a scrivere, persuase, vedendo dove col tempo poteva arrivare lo spirito del fanciullo, ai zii di quello, che lo facessero attendere al disegno et alla pittura. Laonde, ancor che essi fusssero vecchi e pittori di non molta fama, essendo però di buon giudizio nelle cose dell'arte, conosciuto Dio e la natura essere i primi maestri di quel giovinetto, non mancarono con ogni acuratezza di farlo attendere a disegnare sotto la disciplina d'eccellenti maestri, acciò pigliasse buona maniera. E parendo loro nel continuare che fusse nato, si può dire, con i pennelli in mano, da un canto lo sollecitavano e dall'altro, dubitando non forse i troppi studii gli guastassero la complessione, alcuna volta lo ritiravano. Ma finalmente, essendo all'età di sedici anni pervenuto, dopo aver fatto miracoli nel disegno, fece in una tavola di suo capriccio, un San Giovanni che battezza Cristo, il quale condusse di maniera, che ancora chi la vede resta maravigliato che da un putto fusse condotta sì bene una simil cosa. Fu posta questa tavola in Parma alla Nunziata, dove stanno i frati de' Zoccoli. Ma non contento di questo, si volle provare Francesco a lavorare in fresco, per che fatta in San Giovanni Evangelista, luogo de' monaci neri di San Benedetto, una capella, perché quella sorte di lavoro gli riusciva, ne fece insino in sette. Ma in quel tempo, mandando papa Leon Decimo il signor Prospero Colonna col campo a Parma, i zii di Francesco, dubitando non forse perdesse tempo o si sviasse, lo mandarono in compagnia di Ieronimo Mazzuoli suo cugino, anch'egli putto e pittore, in Viadana, luogo del Duca di Mantoa, dove stando tutto il tempo che durò quella guerra, vi dipinse Francesco due tavole a tempera, una delle quali, dove è San Francesco che riceve le stimite e Santa Chiara, fu posta nella chiesa de' frati de' Zoccoli, e l'altra, nella quale è uno sposalizio di Santa Caterina, con molte figure, fu posta in S. Piero. Né creda niuno che queste siano opere da principiante e giovane, ma da maestro e vecchio. Finita la guerra e tornato Francesco col cugino a Parma, primamente finì alcuni quadri che alla sua partita aveva lasciati imperfetti, che sono appresso varie persone, e dopo fece in una tavola a olio la Nostra Donna col Figliuolo in collo, San Ieronimo da un lato e il beato Bernardino da Feltro nell'altro. E nella testa d'uno dei detti ritrasse il padrone della tavola tanto bene, che non gli manca se non lo spirito. E tutte quest'o-pere condusse inanzi che fusse di età d'anni dicianove. Dopo, venuto in desiderio di veder Roma, come quello che era in sull'acquistare e sentiva molto lodar l'opere de' maestri buoni, e particolarmente quelle di Raffaello e di Michelagnolo, disse l'animo e disiderio suo ai vecchi zii, ai quali parendo che non fusse cotal desiderio se non lodevole, dissero es-ser contenti, ma che sarebbe ben fatto che egli avesse portato seco qualche cosa di sua mano che gli facesse entratura a que' signori et agl'artefici della professione; il qual consiglio non dispiacendo a Francesco, fece tre quadri, due piccoli et uno assai grande, nel quale fece la Nostra Donna col Figliuolo in collo che toglie di grembo a un Angelo alcuni frutti et un vecchio con le braccia piene di peli, fatto con arte e giudizio e vagamente colorito. Oltra ciò, per investigare le sottigliezze dell'arte, si mise un giorno a ritrarre se stesso, guardandosi in uno specchio da barbieri, di que' mezzo tondi. Nel che fare, vedendo quelle bizzarrie che fa la ritondità dello specchio, nel girare che fanno le travi de' palchi, che torcono e le porte e tutti gl'edifizi che sfuggono stranamente, gli venne voglia di contrafare per suo capriccio ogni cosa. Laonde, fatta fare una palla di legno al tornio, e quella divisa per farla mezza tonda e di grandezza simile allo specchio, in quella si mise con grande arte a contrafare tutto quello che vedeva nello specchio e particolarmente se stesso tanto simile al naturale, che non si potrebbero stimare, né credere. E perché tutte le cose che s'appressano allo specchio crescono, e quelle che si allontanano diminuiscono, vi fece una mano che disegnava un poco grande, come mostrava lo specchio, tanto bella che pareva verissima; e perché Francesco era di bellissima aria et aveva il volto e l'aspetto grazioso molto e più tosto d'Angelo che d'uomo, pareva la sua effigie in quella palla una cosa divina. Anzi gli successe così felicemente tutta quell'opera, che il vero non istava altrimenti che il dipinto, essendo in quella il lustro del vetro, ogni segno di riflessione, l'ombre et i lumi sì propri e veri, che più non si sarebbe potuto sperare da umano ingegno.
Finite queste opere, che furono non pure dai suo' vecchi tenute rare, ma da molti altri che s'intendevano dell'arte, stupende e maravigliose, et incassato i quadri et il ritratto, accompagnato da uno de' suoi zii, si condusse a Roma. Dove, avendo il datario veduti i quadri e stimatigli quello che erano, furono subito il giovane et il zio introdotti a papa Clemente, il quale vedute l'opere e Francesco così giovane, restò stupefatto e con esso tutta la corte. Appresso, Sua Santità, dopo avergli fatto molti favori, disse che voleva dare a dipignere a Francesco la sala de' pontefici, della quale aveva già fatto Giovanni da Udine di stucchi e di pitture tutte le volte. Così dunque, avendo donato Francesco i quadri al Papa et avute, oltre alle promesse, alcune cortesie e doni, stimolato dalla gloria, dalle lodi che si sentiva dare e dall'utile che poteva sperare da tanto pontefice, fece un bellissimo quadro d'una Circoncisione, del quale fu tenuta cosa rarissima la invenzione, per tre lumi fantastichi che a quella pittura, servivano perché le prime figure erano alluminate dalla vampa del volto di Cristo, le seconde ricevevano lume da certi che, portando doni al sacrifizio, caminavano per certe scale con torce accese in mano, e l'ultime erano scoperte et illuminate dall'aurora, che mostrava un leggiadrissimo paese con infiniti casamenti. Il quale quadro finito, lo donò al Papa, che non fece di questo come degl'altri, perché avendo donato il quadro di Nostra Donna a Ipolito cardinale de' Medici suo nipote, et il ritratto nello specchio a Messer Pietro Aretino poeta e suo servitore, e quello della Circoncisione ritenne per sé, e si stima che poi col tempo l'avesse l'imperatore; ma il ritratto dello specchio mi ricordo, io essendo giovinetto, aver veduto in Arezzo nelle case di esso Messer Pietro Are-tino, dove era veduto dai forestieri, che per quella città passavano, come cosa rara. Questo capitò poi, non so come, alle mani di Valerio Vicentino intagliatore di cristallo, et oggi è appresso Alessandro Vittoria, scultore in Vinezia e creato di Iacopo Sansovino.
Ma tornando a Francesco, egli studiando in Roma volle vedere tutte le cose antiche e moderne, così di scultura come di pittura, che erano in quella città; ma in somma venerazzione ebbe particolarmente quelle di Michelagnolo Buonarroti e di Raffaello da Urbino; lo spirito del qual Raffaello si diceva poi esser passato nel corpo di Francesco, per vedersi quel giovane nell'arte raro e ne' costumi gentile e grazioso, come fu Raffaello, e, che è più, sentendosi quanto egli s'ingegnava d'immitarlo in tutte le cose, ma sopra tutto nella pittura; il quale studio non fu invano, perché molti quadretti che fece in Roma, la maggior parte de' quali vennero poi in mano del cardinal Ipolito de' Medici, erano veramente maravigliosi, sì come è un tondo d'una bellissima Nunziata che egli fece a Messer Agnolo Cesis, il quale è oggi nelle case loro come cosa rara stimato. Dipinse similmente in un quadro la Madonna con Cristo, alcuni Angioletti et un San Giuseppo, che sono belli in estremo per l'aria delle teste, pel colorito e per la grazia e diligenza con che si vede esser stati dipinti. La quale opera era già appresso Luigi Gaddi et oggi dee essere appresso gl'eredi. Sentendo la fama di costui, il signor Lorenzo Cibo, capitano della guardia del papa e bellissimo uomo, si fece ritrarre da Francesco; il quale si può dire che non lo ritraesse, ma lo facesse di carne e vivo. Essendogli poi dato a fare per madonna Maria Bufolina da Città di Castello, una tavola che dovea porsi in San Salvatore del Lauro, in una capella vicina alla porta, fece in essa Francesco una Nostra Donna in aria che legge et ha un Fanciullo fra le gambe, et in terra con straordinaria e bella attitudine ginocchioni con un piè, fece un San Giovanni che torcendo il torso accenna Cristo fanciullo, et in terra a giacere in scorto è un San Girolamo in penitenza che dorme. Ma quest'opera non gli lasciò condurre a perfezzione la rovina et il sacco di Roma del 1527, la quale non solo fu cagione che all'arti per un tempo si diede bando, ma ancora che la vita a molti artefici fu tolta; e mancò poco che Francesco non la perdesse ancor egli; perciò che in sul principio del sacco era egli sì intento a lavorare, che quando i soldati entravano per le case, e già nella sua erano alcuni tedeschi, egli per rumore che facessero non si moveva dal lavoro; per che sopragiugnendogli essi e vedendolo lavorare, restarono in modo stupefatti di quell'opera, che come galantuomini che doveano essere, lo lasciarono seguitare. E così mentre che l'impiissi-ma crudeltà di quelle genti barbare rovinava la povera città, e parimente le profane e sacre cose, senza aver rispetto né a Dio, né agl'uomini, egli fu da que' tedeschi proveduto e grandemente stimato, e da ogni ingiuria difeso. Quanto disagio ebbe per allora si fu che, essendo un di loro molto amatore delle cose di pittura, fu forzato a fare un numero infinito di disegni d'acquerello e di penna, i quali furono il pagamento della sua taglia. Ma nel mutarsi poi i soldati, fu Francesco vicino a capitar male perché, andando a cercare d'alcuni amici, fu da altri soldati fatto prigione, e bisognò che pagasse certi pochi scudi, che aveva, di taglia. Onde il zio, dolendosi di ciò e della speranza che quella rovina avea tronca a Francesco di acquistarsi scienza, onore e roba, deliberò, vedendo Roma poco meno che rovinata et il papa prigione degli Spagnuoli, ricondurlo a Parma. E così, inviatolo verso la patria, si rimase egli per alcuni giorni in Roma, dove dipositò la tavola fatta per madonna Maria Bufolina ne' frati della Pace; nel refettorio de' quali, essendo stata molti anni, fu poi da Messer Giulio Bufolini condotta nella lor chiesa a Città di Castello.
Arrivato Francesco a Bologna, e trattenendosi con molti amici, e particolarmente in casa d'un sellaio parmigiano suo amicissimo, dimorò, perché la stanza gli piaceva, alcuni mesi in quella città; nel qual tempo fece intagliare alcune stampe di chiaro scuro, e fra l'altre la decollazione di San Piero e S. Paulo et un Diogene grande. Ne mise anco a ordine molte altre per farle intagliare in rame e stamparle, avendo appresso di sé per questo effetto un maestro, Antonio da Trento, ma non diede per allora a cotal pensiero effetto, perché gli fu forza metter mano a lavorare molti quadri et altre opere per gentiluomini bolognesi. E la prima pittura che fusse in Bologna veduta di sua mano, fu in San Petronio alla capella de' Monsignori un San Rocco di molta grandezza, al quale diede bellissima aria e fecelo in tutte le parti bellissimo, imaginandoselo alquanto sollevato dal dolore che gli dava la peste nella coscia, il che dimostra guardando con la testa alta il cielo in atto di ringraziarne Dio, come i buoni fanno eziandio dell'avversità che loro adivengono. La quale opera fece per un Fabrizio da Milano, il quale ritrasse dal mezzo in su in quel quadro a man giunte, che par vivo; come pare anche naturale un cane che vi è, e certi paesi che sono bellissimi, essendo in ciò particolarmente Francesco eccellente. Fece poi per l'Albio, medico parmigiano, una conversione di San Paulo con molte figure e con un paese, che fu cosa rarissima. Et al suo amico sellaio ne fece un altro di straordinaria bellezza, dentrovi una Nostra Donna volta per fianco con bell'attitudine, e parecchie altre figure. Dipinse al conte Giorgio Manzuoli un altro quadro, e due tele a guazzo per maestro Luca dai Leuti con certe figurette tutte ben fatte e graziose.
In questo tempo il detto Antonio da Trento, che stava seco per intagliare, una mattina che Francesco era ancora in letto, apertogli un forziere, gli furò tutte le stampe di rame e di legno e quanti disegni avea, et andatosene col diavolo, non mai più se ne seppe nuova. Tuttavia riebbe Francesco le stampe, avendole colui lasciate in Bologna a un suo amico, con animo forse di riaverle con qualche comodo, ma i disegni non poté già mai riavere; per che mezzo disperato, tornando a dipignere, ritrasse per aver danari non so che conte bolognese, e dopo fece un quadro di Nostra Donna con un Cristo che tiene una palla di mappamondo; ha la Madonna bellissima aria, et il putto è similmente molto naturale, perciò che egli usò di far sempre nel volto de' putti una vivacità propriamente puerile, che fa conoscere certi spiriti acuti e maliziosi che hanno bene spesso i fanciulli; abbigliò ancora la Nostra Donna con modi straordinarii, vestendola d'un abito che avea le maniche di veli gialletti e quasi vergati d'oro, che nel vero avea bellissima grazia, facendo parere le carni vere e delicatissime, oltra che non si possono vedere capegli dipinti meglio lavorati. Questo quadro fu dipinto per Messer Pietro Aretino, ma venendo in quel tempo papa Clemente a Bologna, Francesco glielo donò; poi, comunche s'andasse la cosa, egli capitò alle mani di Messer Dionigi Gianni, et oggi l'ha Messer Bartolomeo suo figliuolo, che l'ha tanto accommodato, che ne sono state fatte (cotanto è stimato) cinquanta copie. Fece il medesimo alle monache di Santa Margherita in Bologna, in una tavola, una Nostra Donna, Santa Margherita, San Petronio, San Girolamo e San Michele, tenuta in somma venerazione sì come merita, per essere nell'aria delle teste et in tutte l'altre parti, come le cose di questo pittore sono tutte quante. Fece ancora molti disegni, e particolarmente alcuni per Girolamo del Lino, et a Girolamo Fagiuoli orefice et intagliatore, che gli cercò per intagliargli in rame, i quali disegni sono tenuti graziosissimi. Fece a Bonifazio Gozadino il suo ritratto di naturale e quello della moglie, che rimase imperfetto. Abbozzò anco un quadro d'una Madonna, il quale fu poi venduto in Bologna a Giorgio Vasari aretino, che l'ha in Arezzo nelle sue case nuove e da lui fabricate, con molte altre nobili pitture, sculture e marmi antichi, Quando l'imperadore Carlo Quinto fu a Bologna perché l'incoronasse Clemente Settimo, Francesco, andando talora a vederlo mangiare, fece senza ritrarlo l'ima-gine di esso Cesare a olio in un quadro grandissimo, et in quello dipinse la Fama che lo coronava di lauro, et un fanciullo in forma d'un Ercole piccolino che gli porgeva il mondo quasi dandogliene il dominio. La quale opera, finita che fu, la fece vedere a papa Clemente, al quale piacque tanto che mandò quella e Francesco insieme, accompagnati dal vescovo di Vasona, allora datario, all'imperadore. Onde essendo molto piaciuta a Sua Maestà, fece intendere che si lasciasse; ma Francesco, come mal consigliato da un suo poco fedele o poco saputo amico, dicendo che non era finita, non la vol-le lasciare; e così Sua Maestà non l'ebbe et egli non fu, come sarebbe stato senza dubbio, premiato. Questo quadro, essendo poi capitato alle mani del cardinale Ipolito de' Medici, fu donato da lui al cardinale di Mantoa, et oggi è in guardaroba di quel Duca, con molte altre belle e nobilissime pitture.
Dopo essere stato Francesco, come si è detto, tanti anni fuor della patria e molto esperimentatosi nell'arte, senza a-ver fatto però acquisto nessuno di facultà, ma solo d'amici, se ne tornò finalmente, per sodisfare a molti amici e parenti, a Parma; dove, arrivato, gli fu subito dato a lavorare in fresco nella chiesa di Santa Maria della Steccata, una volta assai grande; ma perché inanzi alla volta era un arco piano che girava secondo la volta a uso di faccia, si mise a lavorare prima quello come più facile, e vi fece sei figure, due colorite e quattro di chiaro scuro molto belle; e fra l'una e l'altra alcuni molto belli ornamenti, che mettevano in mezzo rosoni di rilievo. I quali egli da sé, come capriccioso, si mise a lavorare di rame, facendo in essi grandissime fatiche. In questo medesimo tempo fece al cavalier Baiardo, gentiluomo parmigiano e suo molto familiare amico, in un quadro un Cupido che fabrica di sua mano un arco: a' piè del quale fece due putti, che sedendo uno piglia l'altro per un braccio e ridendo vuol che tocchi Cupido con un dito, e quegli, che non vuol toccarlo, piange mostrando aver paura di non cuocersi al fuoco d'amore. Questa pittura, che è vaga per colorito, ingegnosa per invenzione e graziosa per quella sua maniera che è stata et è dagl'artefici e da chi si diletta dell'arte imitata et osservata molto, è oggi nello studio del signor Marcantonio Cavalca, erede del cavalier Baiardo, con molti disegni che ha raccolti, di mano del medesimo, bellissimi e ben finiti d'ogni sorte, sì come sono ancora quelli che pur di mano di Francesco sono nel nostro libro in molte carte, e particolarmente quello della decollazione di San Piero e San Paulo che, come si è detto, mandò poi fuori in stampe di legno e di rame stando in Bologna. Alla chiesa di Santa Maria de' Servi fece in una tavola la Nostra Donna col Figliuolo in braccio che dorme, e da un lato certi Angeli, uno de' quali ha in braccio un'urna di cristallo, dentro la quale riluce una croce contemplata dalla Nostra Donna. La quale opera, perché non se ne contentava molto, rimase imperfetta; ma nondimeno è cosa molto lodata in quella sua maniera piena di grazia e di bellezza.
Intanto cominciò Francesco a dismettere l'opera della Steccata, o almeno a fare tanto adagio, che si conosceva che v'andava di male gambe. E questo avveniva perché, avendo cominciato a studiare le cose dell'alchimia, aveva tralasciato del tutto le cose della pittura, pensando di dover tosto aricchire congelando mercurio. Per che stillandosi il cervello, non con pensare belle invenzioni, né con i pennelli o mestiche, perdeva tutto il giorno in tramenare carboni, legne, bocce di vetro et altre simili bazicature che gli facevano spendere più in un giorno, che non guadagnava a lavorare una settimana alla capella della Steccata; e non avendo altra entrata, e pur bisognandogli anco vivere, si veniva così consumando con questi suoi fornelli a poco a poco. E, che fu peggio, gl'uomini della Compagnia della Steccata, vedendo che egli avea del tutto tralasciato il lavoro, avendolo per aventura, come si fa, soprapagato, gli messero lite; onde egli per lo migliore si ritirò, fuggendosi una notte con alcuni amici suoi a Casalmaggiore; dove, uscitogli alquanto di capo l'alchi-mie, fece per la chiesa di Santo Stefano, in una tavola, la Nostra Donna in aria, e da basso San Giovambatista e Santo Stefano. E dopo fece (e questa fu l'ultima pittura che facesse) un quadro d'una Lucrezia romana, che fu cosa divina e delle migliori che mai fusse veduta di sua mano; ma come si sia è stato trafugato che non si sa dove sia. È di sua mano anco un quadro di certe ninfe, che oggi è in casa di Messer Niccolò Buffolini a Città di Castello; et una culla di putti, che fu fatta per la signora Angiola de' Rossi da Parma, moglie del signor Alessandro Vitelli, la quale è similmente in Città di Castello.
Francesco finalmente, avendo pur sempre l'animo a quella sua alchimia, come gl'altri che le impazzano dietro una volta, et essendo di delicato e gentile, fatto con la barba e chiome lunghe e mal conce, quasi un uomo sabatico et un altro da quello che era stato, fu assalito, essendo mal condotto e fatto malinconico e strano, da una febre grave e da un flusso crudele, che lo fecero in pochi giorni passare a miglior vita. Et a questo modo pose fine ai travagli di questo mondo, che non fu mai conosciuto da lui se non pieno di fastidii e di noie. Volle essere sepolto nella chiesa de' frati de' Servi, chiamata la Fontana, lontana un miglio da Casalmaggiore; e, come lasciò, fu sepolto nudo con una croce d'arci-presso sul petto in alto. Finì il corso della sua vita a dì 24 d'agosto 1540, con gran perdita dell'arte per la singolar grazia che le sue mani diedero alle pitture che fece. Si dilettò Francesco di sonar di liuto et ebbe in ciò tanto la mano e l'inge-gno accomodato, che non fu in quello manco eccellente che nella pittura. Ma è ben vero che se non avesse lavorato a capriccio et avesse messo da canto le sciocchezze degl'alchimisti, sarebbe veramente stato dei più rari et eccellenti pittori dell'età nostra. Non niego che il lavorare a furori e quando se n'ha voglia non sia il miglior tempo, ma biasimo bene il non voler lavorare mai, o poco, et andar perdendo il tempo in considerazioni; atteso che il voler truffare e dove non si può aggiugnere pervenire, è spesso cagione che si smarrisce quello che si sa, per volere quello che non si può. Se Francesco, il quale ebbe dalla natura bella e graziosa maniera e spirito vivacissimo, avesse seguitato di fare giornalmente, arebbe acquistato di mano in mano tanto nell'arte, che sì come diede bella e graziosa aria alle teste e molta leggiadria, così arebbe di perfezzione, di fondamento e bontà nel disegno, avanzato se stesso e gl'altri.
Rimase dopo lui Ieronimo Mazzuoli suo cugino, che imitò sempre la maniera di lui con suo molto onore, come ne dimostrano l'opere che sono di sua mano in Parma. A Viadana ancora, dove egli si fuggì con Francesco per la guerra, fece in San Francesco, luogo de' Zoccoli, così giovanetto come era, in una tavolina, una bellissima Nunziata. Et un'altra ne fece in Santa Maria ne' Borghi. In Parma ai frati di San Francesco conventuali fece la tavola dell'altar maggiore, dentrovi Giovacchino cacciato del tempio, con molte figure. Et in Santo Alessandro, monasterio di monache in quella città, fece in una tavola la Madonna in alto con Cristo fanciullo che porge una palma a Santa Iustina, et alcuni Angeli che scuoprono un panno, e Santo Alessandro papa e San Benedetto. Nella chiesa de' frati Carmelitani fece la tavola del-l'altar maggiore che è molto bella; et in San Sepolcro un'altra tavola assai grande. In San Giovanni Evangelista, chiesa di monache nella detta città, sono due tavole di mano di Girolamo assai belle, ma non quanto i portegli dell'organo, ne quanto la tavola dell'altar maggiore, nella quale è una Trasfigurazione bellissima e lavorata con molta diligenza. Ha di-pinto il medesimo, nel refettorio di queste donne, una prospettiva in fresco, et in un quadro a olio la Cena di Cristo con gl'Apostoli; e nel Duomo a fresco la capella dell'altar maggiore. Ha ritratto, per madama Margherita d'Austria duchessa di Parma, il principe don Alessandro, suo figliuolo, tutto armato con la spada sopra un mappamondo, et una Parma ginocchioni et armata dinanzi a lui. Alla Steccata di Parma ha fatto in una capella a fresco gl'Apostoli che ricevono lo Spirito Santo; et in un arco, simile a quello che dipinse Francesco suo parente, ha fatto sei sibille, due colorite e quattro di chiaro scuro. Et in una nicchia al dirimpetto di detto arco, dipinse, ma non restò del tutto perfetta, la Natività di Cristo et i pastori che adorano, che è molto bella pittura. Alla Certosa fuor di Parma ha fatto i tre Magi nella tavola dell'al-tar maggiore; et a Pavia in San Piero, badia de' monaci di San Bernardo, una tavola; et in Mantoa, nel Duomo, un'altra al cardinale; et in San Giovanni della medesima città un'altra tavola, dentrovi un Cristo in uno splendore, et intorno gl'Apostoli e S. Giovanni, del quale par che dica: “Sic eum volo manere”, etc.; et intorno a questa tavola sono, in sei quadri grandi, miracoli del detto S. Giovanni Evangelista. Nella chiesa de' frati zoccolanti, a man sinistra, è di mano del medesimo, in una tavola grande, la conversione di San Paulo, opera bellissima. Et in San Benedetto in Pollirone, luogo lontano dodici miglia da Mantoa, ha fatto nella tavola dell'altar maggiore Cristo nel presepio adorato dai pastori con Angeli che cantano. Ha fatto ancora, ma non so già in che tempo a punto, in un quadro bellissimo, cinque amori, il primo de' quali dorme e gl'altri lo spogliano, togliendogli chi l'arco, chi le saette et altri la face. Il qual quadro ha il signor duca Ottavio, che lo tiene in gran conto per la virtù di Ieronimo, il quale non ha punto degenerato dal suo parente Francesco nell'essere eccellente pittore e cortese e gentile oltre modo, e perché ancor vive si vedano anco uscire di lui altre opere bellissime che ha tuttavia fra mano. Fu amicissimo del detto Francesco Messer Vincenzio Caccianimici gentiluomo bolognese, il quale dipinse e s'ingegnò d'imitare quanto poté il più la maniera di esso Francesco Mazzuoli. Costui coloriva benissimo, onde quelle cose che lavorò per suo piacere e per donare a diversi signori et amici suoi sono invero dignissime di lode; ma particolarmente una tavola a olio, che è in San Petronio alla capella della sua famiglia, dentro la quale è la decollazione di San Giovanni Battista.
Morì questo virtuoso gentiluomo, di mano del quale sono alcuni disegni nel nostro libro molto belli, l'anno 1542.
VITA DI IACOMO PALMA E LORENZO LOTTO
PITTORI VINIZIANI

Può tanto l'artifizio e la bontà d'una sola o due opere, che perfette si facciano in quell'arte che l'uomo esercita, che per piccole che elle siano, sono sforzati gl'artefici et intendenti a lodarle, e gli scrittori a celebrarle e dar lode all'artefice che l'ha fatte, nella maniera che facciamo or noi al Palma viniziano, il quale, se bene non fu eccellente né raro nella perfezzione della pittura, fu non di meno sì pulito e diligente e sommesso alle fatiche dell'arte, che le cose sue, se non tutte, almeno una parte hanno del buono; perché contrafanno molto il vivo et il naturale degl'uomini. Fu il Palma molto più nei colori unito, sfumato e paziente, che gagliardo nel disegno, e quegli maneggiò con grazia, pulitezza grandissima, come si vede in Venegia in molti quadri e ritratti che fece a diversi gentiluomini, de' quali non dirò altro perché voglio che mi basti far menzione di alcune tavole e d'una testa che tenghiamo divina e maravigliosa. L'una delle quali tavole dipinse in Santo Antonio di Vinezia vicino a Castello, e l'altra in Santa Elena presso al Lio, dove i monaci di Monte Oliveto hanno il loro monasterio. Et in questa, che è all'altar maggiore di detta chiesa, fece i Magi che offeriscono a Cristo con buon numero di figure, fra le quali sono alcune teste veramente degne di lode, come anco sono i panni che vestono le figure, condotti con bello andar di pieghe. Fece anco il Palma, nella chiesa di Santa Maria Formosa all'altare de' Bombardieri, una Santa Barbara grande quanto il naturale con due minori figure dalle bande, cioè San Sebastiano e Santo Antonio. Ma la Santa Barbara è delle migliori figure che mai facesse questo pittore; il quale fece anco nella chiesa di San Moisè, appresso alla piazza di San Marco, un'altra tavola, nella quale è una Nostra Donna in aria e San Giovanni a' piedi. Fece oltre ciò il Palma, per la stanza dove si ragunano gl'uomini della scuola di San Marco, in sulla piazza di San Giovanni e Paulo, a concorrenza di quelle che già fecero Gian Bellino, Giovanni Mansuchi et altri pittori, una bellissima storia, nella quale è dipinta una nave che conduce il corpo di San Marco a Vinezia: nella quale si vede finto dal Palma una orribile tempesta di mare et alcune barche combattute dalla furia de' venti, fatte con molto giudicio e con belle considerazioni, sì come è anco un gruppo di figure in aria e diverse forme di demoni, che soffiano a guisa di venti nelle barche che, andando a remi e sforzandosi con varii modi di rompere l'inimiche et altissime onde, stanno per somergersi. Insomma quest'opera, per vero dire, è tale e sì bella per invenzione e per altro, che pare quasi impossibile che colore o pennello adoperati da mani anco eccellenti, possino esprimere alcuna cosa più simile al vero o più naturale, atteso che in essa si vede la furia de' venti, la forza e destrezza degl'uomini, il moversi dell'onde, i lampi e baleni del cielo, l'acqua rotta dai remi e i remi piegati dall'onde e dalla forza de' vogadori. Che più? Io per me non mi ricordo aver mai veduto la più orrenda pittura di quella, essendo talmente condotta, e con tanta osservanza nel disegno, nell'inven-zione e nel colorito, che pare che tremi la tavola, come tutto quello che vi è dipinto fusse vero. Per la quale opera merita Iacopo Palma grandissima lode, e di essere annoverato fra quegli che posseggono l'arte et hanno in poter loro facultà d'esprimere nelle pitture le difficultà dei loro concetti. Conciò sia che, in simili cose difficili, a molti pittori vien fatto nel primo abbozzare l'opera, come guidati da un certo forore, qualche cosa di buono e qualche fierezza, che vien poi levata nel finire e tolto via quel buono che vi aveva posto il furore. E questo avviene perché molte volte chi finisce considera le parti e non il tutto di quello che fa, e va (rafreddandosi gli spiriti) perdendo la vena della fierezza. Là dove costui stette sempre saldo nel medesimo proposito, e condusse a perfezzione il suo concetto, che gli fu allora, e sarà sempre, infinitamente lodato.
Ma senza dubbio, come che molte siano e molto stimate tutte l'opere di costui, quella di tutte l'altre è migliore e certo stupendissima, dove ritrasse, guardandosi in una spera, se stesso di naturale, con alcune pelli di camello intorno a certi ciuffi di capegli tanto vivamente che non si può meglio immaginare; perciò che poté tanto lo spirito del Palma in questa cosa particolare, che egli la fece miracolosissima e fuor di modo bella, come afferma ognuno, vedendosi ella quasi ogni anno nella mostra dell'Ascensione. Et invero ella merita di essere celebrata per disegno, per artificio e per colorito, et insomma per essere di tutta perfezzione, più che qual si voglia altra opera che da pittore viniziano fusse stata insino a quel tempo lavorata; perché, oltre all'altre cose, vi si vede dentro un girar d'occhi sì fatto che Lionardo da Vinci e Michelagnolo Buonarroti non averebbono altrimenti operato. Ma è meglio tacere la grazia, la gravità e l'altre parti che in questo ritratto si veggono, perché non si può tanto dire della sua perfezzione, che più non meriti. E se la sorte avessi voluto che il Palma, dopo quest'opera, si fusse morto, egli solo portava il vanto d'aver passato tutti coloro che noi celebriamo per ingegni rari e divini; là dove la vita, che durando lo fece operare, fu cagione che non mantenendo il principio che avea preso, venne a diminuire tutto quello che infiniti pensarono che dovesse accrescere. Finalmente, bastandogli che una o due opere perfette gli levassero il biasimo in parte che gli averebbono l'altre acquistato, si morì d'anni quarantotto in Vinezia.
Fu compagno et amico del Palma, Lorenzo Lotto pittor vineziano, il quale avendo imitato un tempo la maniera de' Bellini, s'appiccò poi a quella di Giorgione, come ne dimostrano molti quadri e ritratti che in Vinezia sono per le case de' gentiluomini. In casa d'Andrea Odoni è il suo ritratto di mano di Lorenzo, che è molto bello. Et in casa Tommaso da Empoli fiorentino è un quadro d'una Natività di Cristo, finta in una notte, che è bellissimo, massimamente perché vi si vede che lo splendore di Cristo con bella maniera illumina quella pittura, dove è la Madonna ginocchioni, et in una figura intera, che adora Cristo, ritratto Messer Marco Loredano. Ne' frati carmelitani fece il medesimo in una tavola San Niccolò sospeso in aria et in abito pontificale con tre Angeli, et a piedi Santa Lucia e San Giovanni, in alto certe nuvole et abbasso un paese bellissimo con molte figurette et animali in varii luoghi. Da un lato è San Giorgio a cavallo che amazza il serpente, e poco lontana la donzella, con una città appresso et un pezzo di mare. In San Giovanni e Paulo, alla capella di Santo Antonio arcivescovo di Firenze, fece Lorenzo in una tavola esso Santo a sedere con due ministri preti, e da basso molta gente.
Essendo anco questo pittore giovane et imitando parte la maniera de' Bellini e parte quella di Giorgione, fece in San Domenico di Ricanati la tavola dell'altar maggiore partita in sei quadri. In quello del mezzo è la Nostra Donna col Figliuolo in braccio che mette, per le mani d'un Angelo, l'abito a San Domenico, il quale sta ginocchioni dinanzi alla Vergine. Et in questo sono anche due putti che suonano uno un liuto e l'altro un ribechino. In un altro quadro è San Gregorio e Santo Urbano papi, e nel terzo San Tommaso d'Aquino et un altro Santo, che fu vescovo di Ricanati. Sopra questi sono gl'altri tre quadri: nel mezzo, sopra, la Madonna e Cristo morto sostenuto da un Angelo, e la madre che gli bacia un braccio, e Santa Madalena; sopra quello di San Gregorio è Santa Maria Madalena e San Vincenzio; e nell'al-tro, cioè sopra San Tommaso d'Aquino, è San Gismondo e Santa Caterina da Siena. Nella predella, che è di figure piccole e cosa rara, è nel mezzo quando Santa Maria di Loreto fu portata dagl'Angeli dalle parti di Schiavonia, là dove ora è posta. Delle due storie, che la mettono in mezzo, in una è San Domenico che predica, con le più graziose figurine del mondo, e nell'altra papa Onorio che conferma a San Domenico la Regola. È di mano del medesimo in mezzo a questa chiesa un San Vincenzio frate lavorato a fresco. Et una tavola a olio è nella chiesa di Santa Maria di Castelnuovo con una Trasfigurazione di Cristo e con tre storie di figure piccole nella predella: quando Cristo mena gl'Apostoli al Monte Tabor, quando ora nell'orto, e quando ascende in cielo. Dopo queste opere, andando Lorenzo in Ancona quando a punto Mariano da Perugia avea fatto in Santo Agostino la tavola dell'altar maggiore con un ornamento grande, la quale non sodisfece molto, gli fu fatto fare, per la medesima chiesa, in una tavola che è posta a mezzo, la Nostra Donna col Figliuolo in grembo e due Angeli in aria che scortando le figure incoronano la Vergine.
Finalmente, essendo Lorenzo vecchio et avendo quasi perduta la voce, dopo aver fatto alcune altre opere di non molta importanza in Ancona, se n'andò alla Madonna di Loreto, dove già avea fatto una favola a olio, che è in una ca-pella a man ritta entrando in chiesa, e quivi, risoluto di voler finire la vita in servigio della Madonna et abitare quella santa casa, mise mano a fare istorie di figure alte un braccio e minori intorno al coro sopra le sedie de' sacerdoti. Fecevi il Nascere di Gesù Cristo in una storia, e quando i Magi l'adorano in un'altra; il presentarlo a Simeone seguitava, e, do-po questa, quando è batezzato da Giovanni nel Giordano. Eravi la adultera condotta inanzi a Cristo, condotte con grazia. Così vi fece dua altre storie copiose di figure: una era Davit quando faceva sagrificare, et in l'altra San Michele Arcangelo che combatte con Lucifero avendolo cacciato di cielo. E quelle finite, non passò molto che, come era vivuto costumatamente e buon cristiano, così morì, rendendo l'anima al Signore Dio. I quali ultimi anni della sua vita provò egli felicissimi e pieni di tranquillità d'animo e, che è più, gli fecero, per quello che si crede, far acquisto dei beni di vita eterna. Il che non gli sarebbe forse avenuto se fusse stato, nel fine della sua vita, oltre modo inviluppato nelle cose del mondo, le quali, come troppo gravi a chi pone in loro il suo fine, non lasciano mai levar la mente ai veri beni dell'altra vita et alla somma beatitudine e felicità.
Fiorì in questo tempo, ancora in Romagna, il Rondinello pittore eccellente, del quale nella vita di Giovan Bellino, per essere stato suo discepolo e servitosene assai nell'opere sue, ne facemmo un poco di memoria. Costui dopo che si partì da Giovan Bellino si affaticò nell'arte di maniera che, per esser diligentissimo, fé molte opere degne di lode, come in Furlì nel Duomo fa fede la tavola dello altar maggiore, che egli vi dipinse di suo mano, dove Cristo comunica gli Apostoli, che è molto ben condotta. Fecevi sopra, nel mezzo tondo di quella, un Cristo morto, e nella predella alcune storie di figure piccole coi fatti di Santa Elena, madre di Gostantino imperadore, quando ella ritruova la croce, condotte con gran diligenza. Fecevi ancora un San Bastiano che è molto bella figura, sola in un quadro, nella chiesa medesima.
Nel Duomo di Ravenna, allo altar di Santa Maria Madalena, dipinse una tavola a olio dentrovi la figura sola di quella Santa, e sotto vi fece di figure piccole, in una predella, molto graziose, tre storie: Cristo che appare a Maria Madalena in forma d'ortolano; et in un'altra quando San Pietro uscendo di nave camina sopra l'acque verso Cristo; e nel mezz'a queste el battesimo di Gesù Cristo, molto belle. Fece in San Giovanni Evangelista nella medesima città dua tavole: in una è San Giovanni quando consacra la chiesa, nell'altra è tre martiri dentro, San Cancio e San Conciano e Santa Cancionila bellissime figure. In Santo Appollinare nella medesima città duo quadri con due figure, in ciascuno la sua, San Giovanni Batista e San Bastiano, molto lodate. Nella chiesa dello Spirito Santo è una tavola, pur di sua mano, dentrovi la Nostra Donna in mezzo con Santa Caterina vergine e martire e San Ieronimo. Dipinse parimente in San Francesco dua tavole: in una è Santa Caterina e San Francesco, e nell'altra dipinse la Nostra Donna con molte figure e San Iacopo Apostolo e S. Francesco. Du' altre tavole fé medesimamente in San Domenico, che n'è una a man manca dello altar maggiore, dentrovi la Nostra Donna con molte figure, e l'altra è in una facciata della chiesa, assai bella. Nella chiesa di San Niccolò, convento de' frati di Santo Agostino, dipinse un'altra tavola con San Lorenzo e San Francesco; che ne fu commendato tanto di quest'opere, che mentre che visse fu tenuto non solo in Ravenna, ma per tutta la Romagna in gran conto. Visse Rondinello fino alla età di 60 anni e fu sepolto in San Francesco di Ravenna.
Costui dopo di lui lassò Francesco da Cotignuola, pittore anch'egli stimato in quella città, il quale dipinse molte opere, e particolarmente nella chiesa della Badia di Classi dentro in Ravenna una tavola allo altar maggiore assai grande, dentrovi la resurrezione di Lazzaro, con molte figure, dove l'anno 1548 Giorgio Vasari dirimpetto a questa fece per don Romualdo da Verona, abate di quel luogo, un'altra tavola con Cristo deposto di croce, dentrovi gran numero di figure. Fece Francesco ancora una tavola in San Niccolò con la Natività di Cristo, che è una gran tavola; in San Sebastiano parimente dua tavole con varie figure. Nello spedale di Santa Caterina dipinse una tavola con la Nostra Donna e Santa Caterina con molte altre figure; et in Santa Agata dipinse una tavola con Cristo in croce e la Nostra Donna a' piedi con altre figure assai, che ne fu lodato. Dipinse in Santo Apollinari di quella città tre tavole, una allo altar maggiore, dentrovi la Nostra Donna, San Giovanni Batista e Santo Apollinari con San Ieronimo et altri Santi. Nell'altra fé pur la Madonna con San Piero e Santa Caterina; nella terza et ultima, Gesù Cristo quando e' porta la croce, la quale egli non poté finire intervenendo la morte. Colorì assai vagamente, ma non ebbe tanto disegno quanto aveva Rondinello, ma ne fu tenuto da' Ravennati conto assai. Costui volse essere, doppo la morte sua, sepolto in Santo Apollinari, dove egli aveva fatto queste figure, contentandosi dove egli avea faticato e vissuto, essere in riposo con l'ossa dopo la morte.
VITE DI FRA' IOCONDO E DI LIBERALE E D'ALTRI VERONESI

Se gli scrittori delle storie vivesseno qualche anno più di quello che è comunemente conceduto al corso dell'umana vita, io per me non dubito punto che arebbono, per un pezzo, che aggiugnere alle passate cose già scritte da loro; perciò che, come non è possibile che un solo, per diligentissimo che sia, sappia a un tratto così a punto il vero, e in picciol tempo, i particolari delle cose che scrive, così è chiaro come il sole che il tempo, il quale si dice padre della verità, va giornalmente scoprendo agli studiosi cose nuove. Se quando io scrissi, già molti anni sono, quelle vite de' pittori et altri, che allora furono publicate, io avesse avuto quella piena notizia di fra' Iocondo Veronese, uomo rarissimo et universale in tutte le più lodate facultà, che n'ho avuto poi, io averei senza dubbio fatta di lui quella onorata memoria che m'appa-recchio di farne ora a benefizio degl'artefici, anzi del mondo. E non solamente di lui, ma di molti altri Veronesi stati veramente eccellentissimi. Né si maravigli alcuno se io gli porrò tutti sotto l'effigie d'un solo di loro, perché non avendo io potuto avere il ritratto di tutti, sono forzato a così fare; ma non per questo sarà defraudata, per quanto potrò io, la virtù di niuno di quello che se le deve.
E perché l'ordine de' tempi et i meriti così richieggiono, parlerò prima di fra' Iocondo, il quale, quando si vestì l'abi-to di San Domenico, non fra' Iocondo semplicemente, ma fra' Giovan Iocondo fu nominato. Ma come gli cascasse quel Giovanni non so, so bene che egli fu sempre fra' Iocondo chiamato da ognuno. E se bene la sua principal professione furono le lettere, essendo stato non pur filosofo e teologo eccellente, ma bonissimo greco, il che in quel tempo era cosa rara cominciando a punto allora a risorgere le buone lettere in Italia, egli nondimeno fu anco come quello che di ciò si dilettò sempre sommamente, eccellentissimo architetto: sì come racconta lo Scaligero contra il Cardano, et il dottissimo Budeo ne' suoi libri de Asse e nell'osservazioni che fece sopra le pandette. Costui, dunque, essendo gran literato, intendente dell'architettura e bonissimo prospettivo, stette molti anni appresso Massimiliano imperatore, e fu maestro nella lingua greca e latina del dottissimo Scaligero, il quale scrive aver udito dottamente disputar fra' Iocondo innanzi al detto Massimiliano di cose sottilissime.
Raccontano alcuni, che ancor vivono e di ciò benissimo si ricordano, che rifaccendosi in Verona il ponte detto della Pietra nel tempo che quella città era sotto Massimiliano imperatore, e dovendosi rifondare la pila di mezzo, la quale molte volte per avanti era rovinata, fra' Iocondo diede il modo di fondarla e di conservarla ancora per sì fatta maniera che per l'avenire non rovinasse. Il qual modo di conservarla fu questo, che egli ordinò che detta pila si tenesse sempre fasciata intorno di doppie travi lunghe e fitte nell'acqua d'ogn'intorno, acciò la difendessino in modo che il fiume non la potesse cavare sotto, essendo che in quel luogo, dove è fondata, è il principal corso del fiume che ha il fondo tanto molle che non vi si truova sodezza di terreno da potere altrimenti fondarla. Et invero fu ottimo, per quello che si è veduto, il consiglio di fra' Iocondo, perciò che da quel tempo in qua è durata e dura, senza avere mai mostrato un pelo, e si spera, osservandosi quanto diede in ricordo quel buon padre, che durerà perpetuamente.
Stette fra' Iocondo in Roma nella sua giovinezza molti anni, e dando opera alla cognizione delle cose antique, cioè non solo alle fabriche, ma anco all'inscrizzioni antiche che sono nei sepolcri et all'altre anticaglie, e non solo in Roma, ma ne' paesi all'intorno et in tutti i luoghi d'Italia, raccolse in un bellissimo libro tutte le dette inscrizzioni e memorie e lo mandò a donare, secondo ch'affermano i Veronesi medesimi, al Magnifico Lorenzo Vecchio de' Medici, con il quale, come amicissimo e fautor di tutti i virtuosi, egli e Domizio Calderino, suo compagno e della medesima patria, tenne sempre grandissima servitù. E di questo libro fa menzione il Poliziano nelle sue Mugillane, nelle quali si serve d'alcune autorità del detto libro, chiamando fra' Iocondo peritissimo in tutte l'antiquità. Scrisse il medesimo sopra i Comentarii di Cesare, alcune osservazioni che sono in stampa. E fu il primo che mise in disegno il ponte fatto da Cesare sopra il fiume Rodano, descritto da lui nei detti suoi Comentarii e male inteso ai tempi di fra' Iocondo, il quale confessa il detto Budeo avere avuto per suo maestro nelle cose d'architettura; ringraziando Dio d'avere avuto un sì dotto e sì diligente precettore sopra Vitruvio, come fu esso frate, il quale ricorresse in quello autore infiniti errori non stati infino allora conosciuti. E questo poté fare agevolmente per essere stato pratico in tutte le dottrine, e per la cognizione che ebbe della lingua greca e della latina. E queste et altre cose afferma esso Budeo, lodando fra' Iocondo per ottimo architettore, aggiungendo che per opera del medesimo furono ritrovate la maggior parte delle Pistole di Plinio in una vecchia libreria in Parigi; le quali, non essendo state più in mano degl'uomini, furono stampate da Aldo Manuzio, come si legge, in una sua pistola latina stampata con le dette. Fece fra' Iocondo, stando in Parigi al servizio del re Lodovico Duodecimo, due superbissimi ponti sopra la Senna carichi di botteghe; opera degna veramente del grand'animo di quel re e del maraviglioso ingegno di fra' Iocondo. Onde meritò, oltre la inscrizione che ancor oggi si vede in queste opere in lode sua, che il Sanazzaro, poeta rarissimo, l'onorasse con questo bellissimo distico:
Iocundus geminum imposuit tibi Sequana pontem;
hunc tu iure potes dicere Pontificem.
Fece, oltre ciò, altre infinite opere per quel re in tutto il regno, ma essendo stato solamente fatto memoria di queste come maggiori, non ne dirò altro.
Trovandosi poi in Roma alla morte di Bramante, gli fu data la cura del tempio di San Piero, in compagnia di Raffaello da Urbino e Giuliano da S. Gallo, acciò continuasse quella fabrica cominciata da esso Bramante; per che minacciando ella rovina in molte parti, per essere stata lavorata in fretta e per le cagioni dette in altro luogo, fu per consiglio di fra' Iocondo, di Raffaello e di Giuliano per la maggior parte rifondata; nel che fare, dicono alcuni che ancor vivono e furono presenti, si tenne questo moda: furono cavate, con giusto spazio dall'una all'altra, molte buche grandi a uso di pozzi, ma quadre, sotto i fondamenti, e quelle ripiene di muro fatto a mano furono fra l'uno e l'altro pilastro, o vero ripieno di quelle, gettati archi fortissimi sopra il terreno, in modo che tutta la fabrica venne a esser posta, senza che si rovinasse, sopra nuove fondamenta, e senza pericolo di fare mai più risentimento alcuno.
Ma quello in che mi pare che meriti somma lode fra' Iocondo, si fu un'opera di che gli deveno avere obligo eterno non pur i viniziani, ma con essi tutto il mondo; perché considerando egli che l'eternità della Republica di Vinizia pende in gran parte dal conservarsi nel sito inespugnabile di quelle lagune, nelle quali è quasi miracolosamente edificata quella città, e che ogni volta che le dette lagune atterrassero, o sarebbe l'aria infetta e pestilente, e per conseguente la città inabitabile, o che per lo meno ella sarebbe sottoposta a tutti quei pericoli a che sono le città di terraferma, si mise a pensare in che modo si potesse provedere alla conservazione delle lagune e del sito in che fu da principio la città edificata. E trovato il modo, disse fra' Iocondo a que' signori che, se non si veniva a presta resoluzione di riparare a tanto danno, fra pochi anni, per quello che si vedeva essere avenuto in parte, s'accorgerebbono dell'errore loro senza essere a tempo a potervi rimediare. Per lo quale avvertimento svegliati que' signori e udite le vive ragioni di fra' Iocondo, e fatta una congregazione de' più rari ingegnieri et architetti che fussero in Italia, furono dati molti pareri e fatti molti disegni, ma quello di fra' Iocondo fu tenuto il migliore e messo in essecuzione. E così si diede principio a divertire con un cavamento grande i duoi terzi, o almeno la metà dell'acque che mena il fiume della Brenta, le quali acque con lungo giro condussero a sboccare nelle lagune di Chioggia. E così, non mettendo quel fiume in quelle di Vinezia, non vi ha portato terreno che abbia potuto riempire, come ha fatto a Chioggia, dove ha in modo munito e ripieno, che si sono fatte, dove erano l'acque, molte possessioni e ville, con grande utile della città di Venezia. Onde affermano molti e massimamente il Magnifico Messer Luigi Cornaro, gentiluomo di Vinezia, e per lunga esperienza e dottrina prudentissimo, che, se non fusse stato l'avertimento di fra' Iocondo, tutto quello atterramento fatto nelle dette lagune di Chioggia, si sarebbe fatto, e forse maggiore, in quelle di Vinezia, con incredibile danno e quasi rovina di quella città. Afferma ancora il medesimo, il quale fu amicissimo di fra' Iocondo, come fu sempre et è di tutti i virtuosi, che la sua patria Vinezia avea sempre per ciò obligo immortale alla memoria di fra' Iocondo, e che egli si potrebbe in questa parte ragionevolmente chiamare secondo edificatore di Vinezia, e che quasi merita più lode, per avere conservata l'ampiezza e nobiltà di sì maravigliosa e potente città mediante questo riparo, che coloro che l'edificarono da principio debile e di poca considerazione. Perché questo benefizio, sì come è stato, così sarà eternamente d'incredibile giovamento et utile a Vinezia.
Essendosi, non molti anni dopo che ebbe fatto questa sant'opera fra' Iocondo, con molto danno de' viniziani abruciato il Rialto di Vinezia, nel quale luogo sono i raccetti delle più preciose merci e quasi il tesoro di quella città, et essendo ciò avenuto in tempo a punto che quella Republica, per lunghe e continue guerre e perdita della maggior parte, anzi di quasi tutto lo stato di terra ferma, era ridotta in stato travagliatissimo, stavano i signori del governo in dubbio e sospesi di quello dovessero fare. Pure, essendo la riedificazione di quel luogo di grandissima importanza, fu risoluto che ad ogni modo si rifacesse. E per farla più onorevole e secondo la grandezza e magnificenza di quella Republica, avendo prima conosciuto la virtù di fra' Iocondo e quanto valesse nell'architettura, gli diedero ordine di fare un disegno di quella fabrica. Laonde ne disegnò uno di questa maniera: voleva occupare tutto lo spazio che è fra il canale delle Beccherie di Rialto et il rio del Fondaco delle Farine, pigliando tanto terreno fra l'uno e l'altro rio, che facesse quadro perfetto, cioè che tanta fusse la lunghezza delle facciate di questa fabrica, quanto di spazio al presente si trova, caminando, dallo sbucare di questi due rivi nel Canal Grande. Disegnava, poi, che li detti due rivi sboccassero dall'altra parte in un canal comune che andasse dall'uno all'altro, tal che questa fabrica rimanesse d'ogni intorno cinta dall'acqua, cioè che avesse il Canal Grande da una parte, li due rivi da due, et il rio, che s'avea a far di nuovo, dalla quarta parte. Voleva, poi, che fra l'acqua e la fabrica intorno intorno al quadro fusse, o vero rimanesse, una spiaggia o fondamento assai largo che servisse per piazza, e vi si vendessero, secondo che fusseno deputati i luoghi, erbaggi, frutte, pesci et altre cose che vengono da molti luoghi alla città. Era di parere, appresso, che si fabricassero, intorno intorno dalla parte di fuori, boteghe che riguardassero le dette piazze, le quali boteghe servissero solamente a cose da mangiare d'ogni sorte. In queste quattro facciate aveva il disegno di fra' Iocondo quattro porte principali, cioè una per facciata posta nel mezzo e dirimpetto a corda all'altra. Ma prima che s'entrasse nella piazza di mezzo, entrando dentro, da ogni parte si trovava a man destra et a man sinistra una strada, la quale, girando intorno il quadro, aveva botteghe di qua e di là, on fabriche sopra bellissime e magazzini per servigio di dette botteghe, le quali tutte erano deputate alla drapperia, cioè panni di lana fini, et alla seta; le quali due sono le principali arti di quella città. Et insomma in questa entravano tutte le botteghe che sono dette de' toscani e de' setaiuoli. Da queste strade doppie di botteghe che sboccavano alle quattro porte, si doveva entrare nel mezzo di detta fabbrica, cioè in una grandissima piazza con belle e gran logge intorno intorno per commodo de' mercanti e servizio de' popoli infiniti, che in quella città, la quale è la dogana d'Italia, anzi d'Europa, per lor mercanzie e traffichi concorrono. Sotto le quali logge doveva essere intorno intorno le botteghe de' banchieri, orefici e gioiellieri, e nel mezzo aveva a essere un bellissimo tempio dedicato a San Matteo, nel quale potessero la mattina i gentiluomini udire i divini uffizii: nondimeno dicono alcuni che, quanto a questo tempio, aveva fra' Iocondo mutato proposito e che voleva farne due, ma sotto le logge perché non impedissero la piazza. Doveva oltre ciò questo superbissimo edifizio avere tanti altri comodi e bellezze et ornamenti particolari, che chi vede oggi il bellissimo disegno che di quello fece fra' Iocondo, afferma che non si può imaginare, né rappresentar da qual si voglia più felice ingegno, o eccellentissimo artefice, alcuna cosa né più bella, né più magnifica, né più ordinata di questa. Si doveva anche, col parere del medesimo, per compimento di quest'opera, fare il ponte di Rialto di pietre e carico di botteghe, che sarebbe stato cosa maravigliosa. Ma che quest'opera non avesse effetto, due furono le cagioni: l'una il trovarsi la Republica, per le gravissime spese fatte in quella guerra, esausta di danari; e l'altra perché un gentiluomo, si dica di Ca' Valereso grande in quel tempo e di molta autorità, forse per qualche interesse particolar, tolse a favorire, come uomo in questo di poco giudizio, un maestro Zamfragnino che, secondo mi vien detto, vive ancora, il quale l'aveva in sue particolari fabriche servito, il quale Zamfragnino (degno e conveniente nome dell'eccellenza del maestro) fece il disegno di quella marmaglia che fu poi messo in opera, e la quale oggi si vede. Della quale stolta elezzione molti che ancor vivono e benissimo se ne ricordano ancora si dogliono senza fine. Fra' Iocondo, veduto quanto più possono molte volte appresso ai signori e grandi uomini i favori che i meriti, ebbe del veder preporre così sgangherato disegno al suo bellissimo tanto sdegno, che si partì di Vinezia, né mai più vi volle, ancor che molto ne fusse pregato, ritornare. Questo, con altri disegni di questo padre, rimase-ro in casa i Bragadini riscontro a Santa Marina et a frate Angelo di detta famiglia, frate di San Domenico, che poi fu, secondo i molti meriti suoi, vescovo di Vicenza.
Fu fra' Iocondo universale, e si dilettò, oltre le cose dette, de' semplici e dell'agricoltura; onde racconta Messer Do-nato Giannotti fiorentino, che molti anni fu suo amicissimo in Francia, che avendo il frate allevato una volta un pesco in un vaso di terra, mentre dimorava in Francia, vide quel piccolissimo arbore carico di tanti frutti che era a guardarlo una maraviglia, e che avendolo, per consiglio d'alcuni amici, messo una volta in luogo dove avendo a passare il re, po-tea vederlo, certi cortigiani che prima vi passarono, come usano di fare così fatte genti, colsero, con gran dispiacere di fra' Iocondo, tutti i frutti di quell'arbuscello, e quelli che non mangiarono, scherzando fra loro, se le trassero dietro per tutta quella contrada. La quale cosa, avendo risaputa il re, dopo essersi preso spasso della burla con i cortigiani, ringraziò il frate di quanto, per piacere a lui, avea fatto, facendogli appresso sì fatto dono, che restò consolato.
Fu uomo fra' Iocondo di santa e bonissima vita, e molto amato da tutti i grandi uomini di lettere dell'età sua, e particolarmente da Domizio Calderino, Matteo Basso e Paulo Emilio, che scrisse l'istorie franzese, e tutti e tre suoi compatrioti. Fu similmente suo amicissimo il Sanazzaro, il Budeo et Aldo Manuzio e tutta l'Accademia di Roma, e fu suo discepolo Iulio Cesare Scaligero, uomo litteratissimo de' tempi nostri. Morì finalmente vecchissimo, ma non si sa in che tempo a punto, né in che luogo, e per consequenza né dove fusse sotterrato.
Sì come è vero che la città di Verona, per sito, costumi et altre parti, è molto simile a Firenze, così è vero che in es-sa, come in questa, sono fioriti sempre bellissimi ingegni in tutte le professioni più rare e lodevoli. E per non dire dei litterati, non essendo questa mia cura, e seguitando il parlare degl'uomini dell'arti nostre che hanno sempre avuto in quella nobilissima città onorato albergo, dico che Liberale veronese, discepolo di Vincenzio di Stefano della medesima patria, del quale si è in altro luogo ragionato, et il quale fece l'anno 1463 a Mantoa, nella chiesa d'Ogni Santi de' monaci di S. Benedetto, una Madonna, che fu, secondo que' tempi, molto lodata; immitò la maniera di Iacopo Bellini per che, essendo giovanetto, mentre lavorò il detto Iacopo la capella di S. Nicolò di Verona, attese sotto di lui per sì fatta guisa agli studii del disegno che, scordatosi quello che imparato avea da Vincenzio di Stefano, prese la maniera del Bellini, e quella si tenne sempre.
Le prime pitture di Liberale furono nella sua città in S. Bernardino alla capella del Monte della Pietà, dove fece nel quadro principale un Deposto di croce e certi Angeli, alcuni de' quali hanno in mano i misterii, come si dice, della Passione, e tutti in volto mostrano pianto e mestizia per la morte del Salvatore. E nel vero hanno molto del vivo, sì come hanno l'altre cose simili di costui, il quale volle mostrare in più luoghi che sapea fare piangere le figure; come che si vide in Santa Nastasia pur di Verona, e chiesa de' frati di S. Domenico, dove, nel frontespizio della capella de' Buonaveri, fece un Cristo morto e pianto dalle Marie. E della medesima maniera e pittura che è l'altra opera sopra detta, fece molti quadri che sono sparsi per Verona in casa di diversi gentiluomini. Nella medesima capella fece un Dio Padre con molti Angeli attorno che suonano e cantano, e dagli lati fece tre figure per parte: da una S. Piero, San Domenico e San Tommaso d'Aquino; e dall'altra Santa Lucia, Santa Agnesa et un'altra Santa; ma le prime tre son migliori, meglio condotte e con più rilievo. Nella facciata di detta capella fece la Nostra Donna e Cristo fanciullo che sposa Santa Caterina vergine e martire; et in questa opera ritrasse Messer Piero Buonanni, padrone della capella; et intorno sono alcuni Angeli che presentano fiori e certe teste che ridono, e sono fatte allegre con tanta grazia, che mostrò così sapere fare il riso come il pianto avea fatto in altre figure. Dipinse nella tavola della detta capella Santa Maria Madalena in aria, sostenuta da certi Angeli, et a basso Santa Caterina, che fu tenuta bell'opera.
Nella chiesa di Santa Maria della Scala de' frati de' Servi, all'altare della Madonna, fece la storia de' Magi in due portegli, che chiuggono quella Madonna tenuta in detta città in somma venerazione. Ma non vi stettero molto che, essendo guasti dal fumo delle candele, fu levata e posta in sagrestia, dove è molto stimata dai pittori veronesi. Dipinse a fresco nella chiesa di San Bernardino, sopra la capella della Compagnia della Madalena, nel tramezzo, la storia della purificazione, dove è assai lodata la figura di Simeone et il Cristo puttino che bacia con molto affetto quel vecchio che lo tiene in braccio. È molto bello anco un sacerdote che vi è da canto, il quale levato il viso al cielo et aperte le braccia, pare che ringrazii Dio della salute del mondo. A canto a questa capella è di mano del medesimo Liberale la storia de' Magi e la morte della Madonna nel frontespizio della tavola, di figurine piccole molto lodate. E nel vero si dilettò molto di far cose piccole, e vi mise sempre tanta diligenza che paiono miniate, non dipinte; come si può vedere nel Duomo di quella città, dove è in un quadro di sua mano la storia de' Magi, con un numero infinito di figure piccole e di cavalli, cani et altri diversi animali, et appresso un gruppo di Cherubini di color rosso, che fanno appoggiatoio alla madre di Gesù; nella quale opera sono le teste finite et ogni cosa condotta con tanta diligenza che, come ho detto, paiono miniate. Fece ancora per la capella della detta Madonna, in Duomo, in una predelletta pure a uso di minio, storie di Nostra Donna. Ma questa fu poi fatta levar di quel luogo da monsignor Messer Giovan Matteo Giberti, vescovo di Verona, e posta in Vescovado alla capella del palazzo, dove è la residenza de' vescovi e dove odono messa ogni mattina. La quale predella in detto luogo è accompagnata da un Crucifisso di rilievo bellissimo, fatto da Giovanbatista scultore veronese che oggi abita in Mantoa. Dipinse Liberale una tavola in San Vitale alla capella degl'Allegni, dentrovi San Mastro confessore e veronese, uomo di molta santità, posto in mezzo da un San Francesco e San Domenico. Nella Vittoria, chiesa e convento di certi frati eremiti, dipinse nella capella di San Girolamo, in una tavola per la famiglia de' Scaltritegli, un San Girolamo in abito di cardinale et un San Francesco e San Paulo molto lodati. Nel tramezzo della chiesa di San Giovanni in Monte dipinse la Circoncisione di Cristo et altre cose, che furono, non ha molto, rovinate, perché pareva che quel tramezzo impedisse la bellezza della chiesa.
Essendo poi condotto Liberale dal generale de' monaci di Monte Oliveto a Siena, miniò per quella Relligione molti libri, i quali gli riuscirono in modo ben fatti, che furono cagione che egli ne finì di miniar alcuni rimasi imperfetti, cioè solamente scritti, nella libreria de' Piccolomini. Miniò anco per il Duomo di quella città alcuni libri di canto fermo; e vi sarebbe dimorato più e fatto molte opere che aveva per le mani, ma cacciato dall'invidie e dalle persecuzioni se ne partì per tornare a Verona con ottocento scudi, che egli avea guadagnati, i quali prestò poi ai monaci di Santa Maria in Organo di Monte Oliveto, traendone alcune entrate per vivere giornalmente. Tornato dunque a Verona, diede più che ad altro opera al miniare tutto il rimanente della sua vita.
Dipinse a Bardolino, castello sopra il lago di Garda, una tavola che è nella Pieve; et un'altra per la chiesa di San Tommaso Apostolo; et una similmente nella chiesa di S. Fermo, convento de' frati di San Francesco, alla capella di San Bernardo, il quale Santo dipinse nella tavola, e nella predella fece alcune istorie della sua vita. Fece anco nel medesimo luogo et in altri, molti quadri da spose, de' quali n'è uno in casa di Messer Vincenzio de' Medici in Verona, dentrovi la Nostra Donna et il Figliuolo in collo che sposa Santa Caterina. Dipinse a fresco in Verona una Nostra Donna e San Giuseppo sopra il cantone della casa de' Cartai, per andare dal ponte nuovo a Santa Maria in Organo, la quale opera fu molto lodata. Arebbe voluto Liberale dipignere in Santa Eufemia la capella della famiglia de' Rivi, la quale fu fatta per onorare la memoria di Giovanni Riva, capitano d'uomini d'arme nella giornata del Taro, ma non l'ebbe; perché essendo allogata ad alcuni forestieri, fu detto a lui che per essere già molto vecchio, non lo serviva la vista. Onde scoperta que-sta capella, nella quale erano infiniti errori, disse Liberale che chi l'aveva allogata aveva avuto peggior vista di lui.
Finalmente essendo Liberale d'anni ottantaquattro o meglio, si lasciava governare dai parenti, e particolarmente da una sua figliuola maritata, la quale lo trattava insieme con gl'altri malissimamente; per che sdegnatosi con esso lei e con gl'altri parenti, e trovandosi sotto la sua custodia Francesco Torbido detto il Moro, allora giovane e suo affezionatissimo e diligente pittore, lo instituì erede della casa e giardino che aveva a San Giovanni in Valle, luogo in quella città amenissimo; e con lui si ridusse, dicendo volere che anzi godesse il suo uno che amasse la virtù, che chi disprezzava il prossimo. Ma non passò molto che si morì nel dì di Santa Chiara l'anno 1536, e fu sepolto in San Giovanni in Valle, d'anni 85. Furono suoi discepoli Giovan Francesco e Giovanni Caroti, Francesco Torbido detto il Moro, e Paulo Cavazzuola, de' quali, perché invero sono bonissimi maestri, si farà menzione a suo luogo.
Giovanfrancesco Caroto nacque in Verona l'anno 1470, e dopo avere apparato i primi principii delle lettere, essendo inclinato alla pittura, levatosi dagli studii della grammatica, si pose a imparare la pittura con Liberale veronese, promettendogli ristorarlo delle sue fatiche. Così giovinetto, dunque, attese Giovanfrancesco con tanto amore e diligenza al disegno, che con esso e col colorito fu nei primi anni di grande aiuto a Liberale. Non molti anni dopo, essendo con gl'anni cresciuto il giudizio, vide in Verona l'opere d'Andrea Mantegna e parendogli, sì come era in effetto, che elle fussero d'altra maniera e migliori che quelle del suo maestro, fece sì col padre che gli fu conceduto, con buona grazia di Liberale, acconciarsi col Mantegna. E così andato a Mantoa e postosi con esso lui, acquistò in poco tempo tanto che Andrea mandava fuori dell'opere di lui per di sua mano. Insomma non andarono molti anni che riuscì valente uomo.
Le prime opere che facesse, uscito che fu di sotto al Mantegna, furono in Verona nella chiesa dello spedale di S. Cosimo all'altare de' tre Magi, cioè i portegli che chiuggono il detto altare, ne' quali fece la Circoncisione di Cristo et il suo fuggire in Egitto, con altre figure. Nella chiesa de' frati Ingesuati, detta San Girolamo, in due angoli d'una capella fece la Madonna e l'Angelo che l'annunzia. Al priore de' frati di San Giorgio lavorò in una tavola piccola un presepio, nel quale si vede che aveva assai migliorata la maniera, perché le teste de' pastori e di tutte l'altre figure hanno così bella e dolce aria, che questa opera gli fu molto e meritamente lodata. E se non fusse che il gesso di quest'opera, per essere stato male stemperato, si scrosta e la pittura si va consumando, questa sola sarebbe cagione di mantenerlo vivo sempre nella memoria de' suoi cittadini. Essendogli poi allogato dagl'uomini che governavano la Compagnia dell'Agnol Raffaello una loro capella nella chiesa di Santa Eufemia, vi fece dentro a fresco due storie dell'Agnolo Raffaello, e nella tavola a olio tre Agnoli grandi, Raffaello in mezzo e Gabriello e Michele dagli lati, e tutti con buon disegno e ben coloriti, ma nondimeno le gambe di detti Angeli gli furono riprese come troppo sottili e poco morbide; a che egli, con piacevole grazia rispondendo, diceva che poi che si fanno gl'Angeli con l'ale e con i corpi quasi celesti et aerei, sì come fussero uccegli, che ben si può far loro le gambe sottili e secche, acciò possano volare et andare in alto con più agevolezza. Dipinse nella chiesa di San Giorgio all'altare, dove è un Cristo che porta la croce, San Rocco e San Bastiano, con alcune storie nella predella di figure piccole e bellissime. Alla Compagnia della Madonna, in San Bernardino, dipinse nella predella dell'altar di detta Compagnia la natività della Madonna e gl'innocenti, con varie attitudini negl'ucisori e ne' gruppi de' putti difesi vivamente dalle lor madri; la quale opera è tenuta in venerazione e coperta, perché meglio si conservi. E questa fu cagione che gl'uomini della Fraternita di Santo Stefano nel Duomo antico di Verona, gli facesseno fare al loro altare, in tre quadri di figure simili, tre storiette della Nostra Donna, cioè lo sposalizio, la Natività di Cristo e la storia de' Magi.
Dopo quest'opere, parendogli essersi acquistato assai credito in Verona, disegnava Giovanfrancesco di partirsi e cercare altri paesi, ma gli furono in modo addosso gl'amici e parenti, che gli fecero pigliar per donna una giovane nobile e figliuola di Messer Braliassarti Grandoni, la quale, poi che si ebbe menata l'anno 1505 et avutone indi a non molto un figliuolo, ella si morì sopra parto. E così rimaso libero si partì Giovanfrancesco di Verona, et andossene a Milano, dove il signor Antonmaria Visconte, tiratoselo in casa, gli fece molte opere, per ornamento delle sue case, lavorare. In-tanto essendo portata da un fiamingo in Milano una testa d'un giovane ritratta di naturale e dipinta a olio, la quale era da ognuno in quella città ammirata, nel vederla Giovanfrancesco se ne rise, dicendo: “A me basta l'animo di farne una migliore”. Di che facendosi beffe il fiamingo, si venne dopo molte parole a questo: che Giovanfrancesco facesse la pruova, e perdendo, perdesse il quadro fatto e 25 scudi, e vincendo, guadagnasse la testa del fiamingo e similmente 25 scudi. Messosi dunque Giovanfrancesco a lavorare con tutto il suo sapere, ritrasse un gentiluomo vecchio e raso con un sparviere in mano, ma ancora che molto somigliasse, fu giudicata migliore la testa del fiamingo. Ma Giovanfrancesco non fece buona elezzione, nel fare il suo ritratto, d'una testa che gli potesse fare onore, perché se pigliava un giovane bello e l'avesse bene immitato, come fece il vecchio, se non avesse passata la pittura dell'avversario, l'arebbe almanco paragonata. Ma non per questo fu se non lodata la testa di Giovanfrancesco, al quale il fiamingo fece cortesia, perché contentandosi della testa sola del vecchio raso, non volle altrimenti (come nobile e gentile) i venticinque ducati. Questo quadro venne poi col tempo nelle mani di madonna Isabella da Este, Marchesana di Mantoa, che lo pagò benissimo al fiamingo e lo pose per cosa singolare nel suo studio, nel quale aveva infinite cose di marmo, di conio, di pittura e di getto bellissime.
Dopo aver servito il Visconte, essendo Giovanfrancesco chiamato da Guglielmo, Marchese di Monferrato, andò volentieri a servirlo essendo di ciò molto pregato dal Visconte, e così arivato gli fu assegnata bonissima provisione, et egli, messo mano a lavorare, fece in Casale a quel signore in una cappella dove egli udiva messa, tanti quadri quanti bisognarono a empierla et adornarla da tutte le bande di storie del Testamento Vecchio e Nuovo, lavorate con estrema diligenza, sì come anco fu la tavola principale. Lavorò poi per le camere di quel castello molte cose che gli acquistarono grandissima fama. E dipinse in San Domenico, per ordine di detto marchese, tutta la capella maggiore, per ornamento d'una sepoltura dove dovea essere posto; nella quale opera si portò talmente Giovanfrancesco, che meritò dalla liberalità del Marchese essere con onorati premi riconosciuto; il quale Marchese per privilegio lo fece uno de' suoi camerieri, come per uno instrumento, che è in Verona appresso gl'eredi, si vede. Fece il ritratto di detto signore e della moglie, e molti quadri che mandarono in Francia, et il ritratto parimente di Guglielmo lor primogenito ancor fanciullo, e così quegli delle figliuole e di tutte le dame che erano al servigio della Marchesana.
Morto il marchese Guglielmo, si partì Giovanfrancesco da Casale, avendo prima venduto ciò che in quelle parti aveva, e si condusse a Verona, dove accomodò di maniera le cose sue e del figliuolo, al quale diede moglie, che in poco tempo si trovò esser ricco di più di settemila ducati. Ma non per questo abandonò la pittura, anzi vi attese più che mai, avendo l'animo quieto e non avendo a stillarsi il cervello per guadagnarsi il pane. Vero è che, o fusse per invidia o per altra cagione, gli fu dato nome di pittore che non sapesse fare se non figure piccole. Per che egli, nel fare la tavola della capella della Madonna in San Fermo, convento de' frati di San Francesco, per mostrare che era calonniato a torto, fece le figure maggiori del vivo e tanto bene, ch'elle furono le migliore che avesse mai fatto. In aria è la Nostra Donna, che siede in grembo a Santa Anna, con alcuni Angeli che posano sopra le nuvole, e a' piedi sono San Piero, San Giovanbattista, San Roco e San Bastiano, e non lontano è in un paese bellissimo San Francesco che riceve le stimite. Et invero quest'opera non è tenuta dagl'artefici se non buona.
Fece in San Bernardino, luogo de' frati Zoccolanti, alla capella de la croce, Cristo che inginocchiato con una gamba chiede licenza alla madre. Nella quale opera, per concorrenza di molte notabili pitture che in quel luogo sono di mano d'altri maestri, si sforzò di passargli tutti; onde certo si portò benissimo, per che fu lodato da chiunche la vide, eccetto che dal guardiano di quel luogo; il quale con parole mordaci, come sciocco e goffo solenne che egli era, biasimò Giovanfrancesco con dire che aveva fatto Cristo sì poco reverente alla madre, che non s'inginocchiava se non con un ginocchio. A che rispondendo Giovanfrancesco disse: “Padre, fatemi prima grazia d'inginocchiarvi e rizzarvi, et io poi vi dirà per quale cagione ho così dipinto Cristo”. Il guardiano, dopo molti preghi inginocchiandosi, mise prima in terra il ginocchio destro e poi il sinistro, e nel rizzarsi alzò prima il sinistro e poi il destro. Il che fatto disse Giovanfrancesco: “Avete voi visto, padre guardiano, che non vi siate mosso a un tratto con due ginocchi, né così levato? Vi dico dunque che questo mio Cristo sta bene, perché si può dire o che s'inginocchi alla madre, o che, essendo stato ginocchioni un pezzo, cominci a levar una gamba per rizzarsi”. Di che mostrò rimanere assai quieto il guardiano, pure se n'andò in là così borbottando sotto voce.
Fu Giovanfrancesco molto arguto nelle risposte, onde si racconta ancora che, essendogli una volta detto da un prete che troppo erano lascive le sue figure degl'altari, rispose: “Voi state fresco, se le cose dipinte vi comuovono, pensate come è da fidarsi di voi dove siano persone vive e palpabili”.
A Isola, luogo in sul lago di Garda, dipinse due tavole nella chiesa de' Zoccolanti, et in Malsessino, terra sopra il detto lago, fece, sopra la porta d'una chiesa, una Nostra Donna bellissima, et in chiesa alcuni Santi a requisizione del Fracastoro, poeta famosissimo, del quale era amicissimo. Al conte Giovanfrancesco Giusti dipinse, secondo la invenzione di quel signore, un giovane tutto nudo, eccetto le parti vergognose, il quale stando in fra due, et in atto di levarsi o non levarsi, aveva da un lato una giovane bellissima finta per Minerva, che con una mano gli mostrava la fama in alto, e con l'altra lo eccitava a seguitarla; ma l'ozio e la pigrizia che erano dietro al giovane, si affaticavano per ritenerlo. A basso era una figura con viso mastinotto, e più di servo e d'uomo plebeo che di nobile, la quale aveva alle gomita attaccate due lumache grosse e si stava a sedere sopra un granchio; et appresso aveva un'altra figura con le mani piene di papaveri. Questa invenzione, nella quale sono altre belle fantasie e particolari, e la quale fu condotta da Giovanfrancesco con estremo amore e diligenza, serve per testiera d'una lettiera di quel signore in un suo amenissimo luogo detto Santa Maria Stella, presso a Verona. Dipinse il medesimo al conte Raimondo della Torre tutto un camerino di diverse storie in figure piccole. E perché si dilettò di far di rilievo, e non solamente modegli per quelle cose che gli bisognavano e per acconciar panni addosso, ma altre cose ancora per suo capriccio, se ne veggiono alcune in casa degl'eredi suoi, e particolarmente una storia di mezzo rilievo che non è se non ragionevole. Lavorò di ritratti in medaglie, e se ne veggiono ancora alcuni come quello di Guglielmo marchese di Monferrato, il quale ha per rovescio un Ercole che amazza... con un motto che dice: “Monstra domat”.
Ritrasse di pittura il conte Raimondo della Torre, Messer Giulio suo fratello e Messer Girolamo Fracastoro. Ma fatto Giovanfrancesco vecchio, cominciò a ire perdendo nelle cose dell'arte, come si può vedere in Santa Maria della Scala ne' portegli degl'organi, e nella tavola della famiglia de' Movi, dove è un Deposto di croce, et in Santa Nastasia nella capella di San Martino. Ebbe sempre Giovanfrancesco grande opinione di sé, onde non arebbe messo in opera per cosa del mondo cosa ritratta da altri, perché volendogli il vescovo Giovan Matteo Giberti far dipignere in Duomo nella ca-pella grande alcune storie della Madonna, ne fece fare a Roma a Giulio Romano suo amicissimo i disegni, essendo datario di papa Clemente Settimo. Ma Giovanfrancesco, tornato il vescovo a Verona, non volle mai mettere que' disegni in opera. Là dove il vescovo sdegnato gli fece fare a Francesco detto il Moro. Costui era d'openione, né in ciò si discostava dal vero, che il vernicare le tavole le guastasse e le facesse, più tosto che non farieno, divenir vecchie; e perciò adoperava, lavorando, la vernice negli scuri e certi olii purgati. E così fu il primo che in Verona facesse bene i paesi, perché se ne vede in quella città di sua mano che sono bellissimi. Finalmente, essendo Giovanfrancesco di 76 anni, si morì come buon cristiano, lasciando assai bene agiati i nipoti e Giovanni Caroti suo fratello, il quale, essendo stato un tempo a Vinezia, dopo avere atteso all'arte sotto di lui, se n'era a punto tornato a Verona quando Giovanfrancesco passò all'altra vita; e così si trovò con i nipoti a vedere le cose che loro rimasero dell'arte, fra le quali trovarono un ritratto d'un vecchio armato, benissimo fatto e colorito, il quale fu la miglior cosa che mai fusse veduta di mano di Giovanfrancesco, e così un quadretto, dentrovi un Deposto di croce, che fu donato al signor Spitech, uomo di grande autorità appresso al re di Pollonia, il quale allora era venuto a certi bagni che sono in sul Veronese. Fu sepolto Giovanfrancesco nella sua capella di San Niccolò nella Madonna dell'Organo, che egli aveva delle sue pitture adornata.
Giovanni Caroti fratello del detto Giovanfrancesco, se bene seguitò la maniera del fratello, egli nondimeno esercitò la pittura con manco reputazione. Dipinse costui la su detta tavola della capella di San Niccolò, dove è la Madonna sopra le nuvole, e da basso fece il suo ritratto di naturale e quello della Placida sua moglie. Fece anco nella chiesa di San Bartolomeo, all'altare degli Schioppi, alcune figurette di Sante, e vi fece il ritratto di madonna Laura delli Schioppi, che fece fare quella capella, e la quale fu non meno per le sue virtù che per le bellezze celebrata molto dagli scrittori di que' tempi. Fece anco Giovanni a canto al Duomo in San Giovanni in Fonte, in una tavoletta piccola un San Martino, e fece il ritratto di Messer Marcantonio della Torre quando era giovane, il quale riuscì poi persona litterata et ebbe publiche letture in Padova et in Pavia, e così anco Messer Giulio, le quali teste sono in Verona appresso degl'eredi loro. Al priore di San Giorgio dipinse un quadro d'una Nostra Donna, che come buona pittura è stato poi sempre e sta nella camera de' priori. In un quadro dipinse la trasformazione d'Ateone in cervio, per Brunetto maestro d'organi, il quale la donò poi a Girolamo Cicogna, eccellente ricamatore et ingegnere del vescovo Giberti, et oggi l'ha Messer Vincenzio Cicogna suo figliuolo.
Disegnò Giovanni tutte le piante dell'anticaglie di Verona, e gl'archi trionfali et il Colosseo, riviste dal Falconetto, architettore veronese, per adornarne il libro dell'antichità di Verona, il quale avea scritte e cavate da quelle proprie Messer Torello Saraina, che poi mise in stampa il detto libro, che da Giovanni Caroto mi fu mandato a Bologna, dove io allora faceva l'opera del refettorio di San Michele in Bosco, insieme col ritratto del reverendo padre don Cipriano da Verona, che due volte fu generale de' monaci di Monte Oliveto, acciò io me ne servissi, come feci, in una di quelle tavole. Il quale ritratto mandatomi da Giovanni è oggi in casa mia in Fiorenza con altre pitture di mano di diversi maestri.
Giovanni finalmente d'anni sessanta in circa, essendo vivuto senza figliuoli e senza ambizione e con buone facultà, si morì, essendo molto lieto per vedere alcuni suoi discepoli in buona reputazione, cioè Anselmo Canneri e Paulo Veronese, che oggi lavora in Vinezia et è tenuto buon maestro. Anselmo ha lavorato molte opere a olio et in fresco, e particolarmente alla Soranza in sul Tesino, et a Castel Franco nel palazzo de' Soranzi et in altri molti luoghi, e più che altrove in Vicenza. Ma per tornare a Giovanni, fu sepolto in Santa Maria dell'Organo, dove aveva dipinto di sua mano la capella.
Francesco Torbido detto il Moro, pittore veronese, imparò i primi principii dell'arte, essendo ancor giovinetto, da Giorgione da Castel Franco, il quale immitò poi sempre nel colorito e nella morbidezza. Ma essendo il Moro a punto in sull'acquistare venuto a parole con non so chi, lo conciò di maniera che fu forzato partirsi di Vinezia e tornare a Verona, dove, dismessa la pittura, per essere alquanto manesco e praticare con giovani nobili, sì come colui che era di bonissime creanze, stette senza essercitarsi un tempo. E così praticando fra gl'altri con i conti Sanbonifazii e' conti Giusti, famiglie illustri di Verona, si fece tanto loro domestico, che non solo abitava le case loro come se in quelle fusse nato, ma non andò molto che il conte Zenoello Giusti gli diede una sua naturale figliuola per moglie, dandogli nelle proprie case un apparamento commodo per lui, per la moglie e per i figli che gli nacquero.
Dicono che Francesco, stando ai servigi di que' signori, portava sempre il lapis nella scarsella, et in ogni luogo dove andava, pur che n'avesse agio, dipignea qualche testa o altro sopra le mura. Per che il detto conte Zenovello. vedendolo tanto inclinato alla pittura, alleggeritolo d'altri negozii, fece, come generoso signore, ch'egli si diede tutto all'arte, e perché egli si era poco meno che scordato ogni cosa, si mise, col favor di detto signore, sotto Liberale, allora famoso dipintore e miniatore. E così non lasciando mai di praticare col maestro, andò tanto di giorno in giorno acquistando, che non solo si risvegliarono in lui le cose dimenticate, ma n'ebbe in poco tempo acquistate tanto dell'altre, quante bastarono a farlo valentuomo. Ma è ben vero che, se bene tenne sempre la maniera di Liberale, immitò nondimeno nella morbidezza e colorire sfumato Giorgione suo primo precettore, parendogli che le cose di Liberale, buone per altro, avessero un poco del secco.
Liberale, adunque, avendo conosciuto il bello spirito di Francesco, gli pose tanto amore, che venendo a morte lo lasciò erede del tutto e l'amò sempre come figliuolo; e così morto Liberale e rimaso Francesco nell'aviamento, fece molte cose che sono per le case private. Ma quelle che sopra l'altre meritano essere comendate, e sono in Verona, sono primieramente la capella maggiore del Duomo, colorita a fresco, nella volta della quale sono, in quattro gran quadri, la natività della Madonna, la presentazione al tempio, et in quello di mezzo, che pare che sfondi, sono tre Angeli in aria che scortano all'insù e tengono una corona di stelle per coronar la Madonna, la quale è poi nella nicchia accompagnata da molti Angeli mentre è assunta in cielo, e gl'Apostoli in diverse maniere et attitudini guardano in su, i quali Apostoli so-no figure il doppio più che il naturale. E tutte queste pitture furono fatte dal Moro col disegno di Giulio Romano, come volle il vescovo Giovan Matteo Giberti, che fece far quest'opera, e fu come si detto amicissimo del detto Giulio. Appresso dipinse il Moro la facciata della casa de' Manuelli, fondata sopra la spalla del ponte nuovo, e la facciata di Torello Saraina dottore, il quale fece il sopra detto libro dell'antichità di Verona.
Nel Friuli dipinse similmente a fresco la capella maggiore della badia di Rosazzo per lo vescovo Giovan Matteo, che l'aveva in comenda e riedificò, come signor da bene e veramente relligioso, essendo stata empiamente lasciata, come le più si ritrovano essere, in rovina da chi avanti a lui l'aveva tenuta in comenda et atteso a trarne l'entrate senza spendere un picciolo in servigio di Dio e della chiesa. A olio poi dipinse il Moro in Verona e Vinezia molte cose; et in Santa Maria in Organo fece, nella facciata prima, le figure che vi sono a fresco, eccetto l'Angelo Michele e l'Angiolo Raffaello, che sono di mano di Paulo Cavazzuola, et a olio fece la tavola della detta capella, dove nella figura d'un San Iacopo ritrasse Messer Iacopo Fontani che la fece fare, oltre la Nostra Donna et altre bellissime figure; e sopra la detta tavola, in un semicirculo grande quanto il foro della capella, fece la Trasfigurazione del Signore e gl'Apostoli a basso, che furono tenute delle migliori figure che mai facesse. In Santa Eufemia alla capella de' Bombardieri fece in una tavola Santa Barbara in aria, e nel mezzo e da basso un Santo Antonio che la mano alla barba, che è una bellissima testa, e dall'altro lato un San Rocco similmente tenuto bonissima figura, onde meritamente è tenuta quest'opera per lavorata con estrema diligenza et unione di colori. Nella Madonna della Scala all'altare della santificazione fece un San Bastiano in un quadro a concorrenza di Paulo Cavazzuola, che in un altro fece un San Rocco, e dopo fece una tavola, che fu portata a Bagolino, terra nelle montagne di Brescia.
Fece il Moro molti ritratti, e nel vero le sue teste sono belle a maraviglia, e molto somigliano coloro per cui son fatte. In Verona ritrasse il conte Francesco San Bonifazio detto, per la grandezza del corpo, il conte Lungo, et uno de' Franchi, che fu una testa stupenda. Ritrasse anco Messer Girolamo Verità, ma perché il Moro era anzi lungo nelle sue cose che no, questo si rimase imperfetto. Ma nondimeno così imperfetto è appresso i figliuoli di quel buon signore. Ritrasse anco, oltre molti altri, monsignor de' Martini viniziano, cavalier di Rodi, et al medesimo vendé una testa maravigliosa per bellezza e bontà, la quale aveva fatta molti anni prima per ritratto d'un gentiluomo viniziano, figliuolo d'uno allora capitano in Verona. La quale testa, per avarizia di colui che mai non la pagò, si rimase in mano del Moro, che n'accomodò detto monsignor Martini, il quale fece quello del viniziano mutare in abito di pecoraio o pastore, la quale testa, che è così rara, come qual si voglia uscita da altro artefice, è oggi in casa gl'eredi di detto monsignore tenuta, e meritamente, in somma venerazione. Ritrasse in Vinezia Messer Alessandro Contarino, procuratore di S. Marco e provveditore dell'armata; e Messer Michele San Michele per un suo carissimo amico, che portò quel ritratto ad Orvieto; et un altro, si dice, che ne fece del medesimo Messer Michele architetto, che è ora appresso Messer Paulo Ramusio figliuolo di Messer Giovambatista. Ritrasse il Fracastoro celebratissimo poeta ad instanza di monsignor Giberti, che lo mandò al Giovio, il quale lo pose nel suo museo. Fece il Moro molte altre cose, delle quali non accade far menzione, come che tutte sieno dignissime di memoria, per essere stato così diligente coloritore quanto altro che visse a' tempi suoi, e per avere messo nelle sue opere molto tempo e fatica. Anzi tanta diligenza era in lui, come si vede anco talora in altri, che più tosto gli dava biasimo, atteso che tutte l'opere accettava e da ognuno l'arra, e poi le finiva quando Dio voleva. E se così fece in giovanezza, pensi ogni uomo quello che dovette fare negl'ultimi anni, quando, alla sua natural tardità, s'aggiunse quella che porta seco la vecchiezza. Per lo quale suo modo di fare, ebbe spesso con molti degl'im-pacci e delle noie più che voluto non arebbe. Onde mossosi a compassione di lui Messer Michele San Michele, se lo tirò in casa in Vinezia e lo trattò come amico e virtuoso.
Finalmente richiamato il Moro dai conti Giusti suoi vecchi padroni in Verona, si morì appresso di loro nei bellissimi palazzi di Santa Maria in Stella e fu sepolto nella chiesa di quella villa, essendo accompagnato da tutti quegli amorevolissimi signori alla sepoltura; anzi riposto dalle loro proprie mani con affezzione incredibile, amandolo essi come padre, sì come quelli erano nati e cresciuti mentre egli stava in casa loro.
Fu il Moro nella sua giovanezza destro e valoroso della persona e maneggiò benissimo ogni sorte d'arme. Fu fedelissimo agl'amici e patroni suoi, et ebbe spirito in tutte le sue azzioni. Ebbe amici particolari Messer Michele San Michele architetto, il Danese da Carrara scultore eccellente, et il molto reverendo e dottissimo fra' Marco de' Medici, il quale dopo i suoi studii andava spesso a starsi col Moro per vederlo lavorare e ragionar seco amichevolmente, per ricrear l'animo quando era stracco negli studi.
Fu discepolo e genero del Moro (avendo egli avuto due figliuole) Battista d'Agnolo, che fu poi detto Battista del Moro, il quale, se bene ebbe che fare un pezzo per l'eredità che gli lasciò molto intrigata il Moro, ha lavorato nondimeno molte cose che non sono se non ragionevoli. In Verona ha fatto un San Giovambatista, nella chiesa delle monache di San Giuseppo; et a fresco in Santa Eufemia, nel tramezzo sopra l'altare di San Paulo, l'istoria di quel Santo quando, convertito da Cristo, s'appresenta ad Anania; la quale opera, se ben fece essendo giovinetto, è molto lodata. Ai signori conti Canossi dipinse due camere et in una sala due fregi di battaglie, molto belli e lodati da ognuno. In Vinezia dipinse la facciata d'una casa vicina al Carmine, non molto grande, ma ben molto lodata: dove fece una Vinezia coronata e sedente sopra un lione, insegna di quella republica. [A] Camillo Trivisano dipinse la facciata della sua casa a Murano, et insieme con Marco suo figliuolo dipinse il cortile di dentro d'istorie di chiaro scuro bellissime. Et a concorrenza di Paulo Veronese dipinse nella medesima casa un camerone che riuscì tanto bello, che gl'acquistò molto onore et utile. Ha lavorato il medesimo molte cose di minio, et ultimamente in una carta bellissima un Santo Eustachio che adora Cristo apparitogli fra le corna d'una cervia, e due cani appresso che non possono essere più belli, oltre un paese pieno d'alberi che, andando pian piano alontanandosi e diminuendo, è cosa rarissima. Questa carta è stata lodata sommamente da infiniti che l'hanno veduta, e particolarmente dal Danese da Carrara, che la vide trovandosi in Verona a metter in opera la capella de' signori Fregosi, che è cosa rarissima fra quante ne sieno oggidì in Italia. Il Danese adunque, veduta questa carta, restò stupefatto per la sua bellezza, e persuase al sopra detto fra' Marco de' Medici suo antico e singolare amico, che per cosa del mondo non se la lasciasse uscir di mano, per metterla fra l'altre sue cose rare che ha in tutte le professioni. Per che avendo inteso Battista che il detto padre n'aveva disiderio, per la stessa amicizia, la quale sapea che aveva con il suo suocero tenuta, gliele diede, e quasi lo sforzò, presente il Danese, ad accettarla. Ma nondimeno gli fu di pari cortesia quel buon padre non ingrato. Ma perché il detto Battista e Marco suo figliuolo sono vivi, e tuttavia vanno operando, non si dirà altro di loro al presente.
Ebbe il Moro un altro discepolo chiamato Orlando Fiacco, il quale è riuscito buon maestro e molto pratico in far ritratti, come si vede in molti che n'ha fatti bellissimi e molto simili al naturale. Ritrasse il cardinal Caraffa nel suo ritorno di Germania, e lo rubò a lume di torchi mentre che nel Vescovado di Verona cenava; e fu tanto simile al vero, che non si sarebbe potuto migliorare. Ritrasse anco, e molto vivamente, il cardinal Lorena quando venendo dal Concilio di Trento passò per Verona nel ritornarsi a Roma, e così li due vescovi Lippomani di Verona, Luigi il zio et Agostino il nipote, i quali ha ora in suo camerino il Conte Giovambatista della Torre. Ritrasse Messer Adamo Fumani, canonico e gentiluomo literatissimo di Verona, Messer Vincenzio de' Medici da Verona, e madonna Isotta sua consorte in figura di Santa Elena e Messer Niccolò lor nipote. Parimente ha ritratto il conte Antonio della Torre, il conte Girolamo Canossi et il conte Lodovico et il conte Paulo suoi fratelli, et il signor Astor Baglioni, capitano generale di tutta la cavalleria leggera di Vinezia e governatore di Verona, armato d'arme bianche e bellissimo, e la sua consorte, la signora Ginevra Salviati; similmente il Palladio, architetto rarissimo, e molti altri. E tuttavia va seguitando per farsi veramente un Orlando, nell'arte della pittura, come fu quel primo gran paladino di Francia.
VITA DI FRANCESCO MONSIGNORI, PITTORE VERONESE
Essendosi sempre in Verona, dopo la morte di fra' Iocondo, dato straordinariamente opera al disegno, vi sono d'ogni tempo fioriti uomini eccellenti nella pittura e nell'architettura come, oltre quello che si è veduto a dietro, si vedrà ora nelle vite di Francesco Monsignori, di Domenico Moroni e Francesco suo figliuolo, di Paulo Cavazzuola, di Falconetto architettore et ultimamente di Francesco e Girolamo miniatori.
Francesco Monsignori, adunque, figliuolo d'Alberto, nacque in Verona l'anno 1455 e cresciuto che fu, dal padre, il quale si era sempre dilettato della pittura se bene non l'aveva esercitata se non per un piacere, fu consigliato a dar opera al disegno. Per che, andato a Mantoa a trovare il Mantegna, che allora in quella città lavorava, si affaticò di maniera, spinto dalla fama del suo precettore, che non passò molto che Francesco Secondo marchese di Mantoa, dilettandosi oltre modo della pittura, lo tirò appresso di sé, gli diede l'anno 1487 una casa per suo abitare in Mantoa, et assegnò provisione onorata. Dei quali benefizii non fu Francesco ingrato, perché servì sempre quel signore con somma fedeltà et amorevolezza, onde fu più l'un giorno che l'altro amato da lui e beneficato; in tanto che non sapeva uscir della città il Marchese, senza avere Francesco dietro, e fu sentito dire una volta, che Francesco gli era tanto grato quanto lo stato proprio. Dipinse costui molte cose a quel signore nel palazzo di San Sebastiano in Mantoa; e fuori nel castel di Gonzaga, e nel bellissimo palazzo di Marmirolo; et in questo avendo, dopo molte altre infinite pitture, dipinto Francesco l'an-no 1499 alcuni trionfi e molti ritratti di gentiluomini della corte, gli donò il Marchese, la vigilia di Natale, nel qual giorno diede fine a quell'opera, una possessione di cento campi sul mantoano, in luogo detto la Marzotta, con casa da signore, giardino, praterie et altri commodi bellissimi. A costui, essendo eccellentissimo nel ritrarre di naturale, fece fare il Marchese molti ritratti di se stesso, de' figliuoli, e d'altri molti signori di casa Gonzaga, i quali furono mandati in Francia et in Germania a donare a diversi principi; et in Mantoa ne sono ancora molti come è il ritratto di Federigo Barbarossa imperador, del Barbarigo doge di Vinezia, di Francesco Sforza duca di Milano, di Massimiliano duca pur di Milano che morì in Francia, di Massimiliano imperadore, del signor Ercole Gonzaga, che fu poi cardinale, del duca Federigo suo fratello essendo giovinetto, del signor Giovanfrancesco Gonzaga, di Messer Andrea Mantegna pittore, e di molti altri, de' quali si serbò copia Francesco in carte di chiaro scuro, le quali sono oggi in Mantoa appresso gl'eredi suoi. Nella qual città fece in San Francesco de' Zoccolanti, sopra il pulpito, San Lodovico e San Bernardino, che tengo-no in un cerchio grande un nome di Gesù, e nel refettorio di detti frati, è in un quadro di tela grande quanto la facciata da capo il Salvatore in mezzo ai dodici Apostoli in prospettiva, che son bellissimi e fatti con molte considerazioni; infra i quali è Giuda traditore con viso tutto differente dagl'altri, e con attitudine strana; e gl'altri tutti intenti a Gesù, che parla loro, essendo vicino alla sua Passione; dalla parte destra di quest'opera è un San Francesco grande quanto il naturale, che è figura bellissima e che rappresenta nel viso la santimonia stessa, e quella che fu propria di quel santissimo uomo; il quale Santo presenta a Cristo il marchese Francesco, che gli è a' piedi inginocchioni ritratto di naturale con un saio lungo, secondo l'uso di que' tempi, faldato e crespo, e con ricami a croci bianche, essendo forse egli allora capitano de' viniziani. Avanti al marchese detto è ritratto il suo primogenito, che fu poi il duca Federigo allora fanciullo bellissimo con le mani giunte; dall'altra parte è dipinto un S. Bernardino simile in bontà alla figura di S. Francesco, il quale similmente presenta a Cristo il cardinale Sigismondo Gonzaga, fratello di detto Marchese, in abito di cardinale, e ritratto an-ch'egli dal naturale, col rocchetto, e posto ginocchioni; et innanzi a detto cardinale, che è bellissima figura, è ritratta la signora Leonora, figlia del detto Marchese allora giovinetta, che fu poi Duchessa d'Urbino, la quale opera tutta è tenuta da i più eccellenti pittori cosa maravigliosa.
Dipinse il medesimo una tavola d'un S. Sebastiano, che poi fu messa alla Madonna delle Grazie fuor di Mantoa; et in questa pose ogni estrema diligenza e vi ritrasse molte cose dal naturale. Dicesi che andando il Marchese a vedere lavorare Francesco mentre faceva quest'opera (come spesso era usato di fare), che gli disse: “Francesco, se' si vuole in fare questo Santo pigliare l'essempio da un bel corpo”. A che rispondendo Francesco: “Io vo immitando un fachino, di bella persona, il qual lego a mio modo per fare l'opera naturale”. Soggiunse il Marchese: “Le membra di questo tuo Santo non somigliano il vero, perché non mostrano essere tirate per forza, né quel timore che si deve imaginare in un uomo legato e saettato; ma dove tu voglia mi dà il cuore di mostrarti quello che tu dei fare, per compimento di questa figura”. “Anzi ve ne prego, signore”, disse Francesco, et egli: “Come tu abbi qui il tuo fachino legato, fammi chiamare, et io ti mostrerò quello che tu dei fare”. Quando dunque ebbe il seguente giorno legato Francesco il fachino in quella maniera che lo volle, fece chiamare segretamente il Marchese, non però sapendo quello che avesse in animo di fare. Il Marchese dunque uscito d'una stanza, tutto infuriato con una balestra carica corse alla volta del fachino, gridando ad alta voce: “Traditore, tu se' morto, io t'ho pur colto dove io voleva”, et altre simili parole; le quali udendo il cattivello fachino, e tenendosi morto, nel volere rompere le funi con le quali era legato, nell'aggravarsi sopra quelle e tutto essendo sbigottito, rappresentò veramente uno che avesse ad essere saettato, mostrando nel viso il timore e l'orrore della morte, nelle membra stiracchiate e storte per cercar di fuggire il pericolo. Ciò fatto, disse il Marchese a Francesco: “Eccolo acconcio come ha da stare, il rimanente farai per te medesimo”. Il che tutto avendo questo pittore considerato, fece la sua figura di quella miglior perfezzione che si può imaginare. Dipinse Francesco, oltre molte altre cose, nel palazzo di Gonzaga la creazione de' primi signori di Mantoa, e le giostre che furono fatte in sulla piazza di S. Piero, la quale ha quivi in prospettiva. Avendo il Gran Turco per un suo uomo mandato a presentare al Marchese un bellissimo cane, un arco et un turcasso, il Marchese fece ritrarre nel detto palazzo di Gonzaga il cane, il Turco che l'aveva condotto e l'altre cose. E ciò fatto, volendo vedere se il cane dipinto veramente somigliava, fece condurre uno de' suoi cani di corte nimicissimo al cane turco, là dove era il dipinto, sopra un basamento finto di pietra; quivi dunque giunto il vivo, tosto che vide il dipinto, non altrimenti che se vivo stato fusse, e quello stesso che odiava la morte, si lanciò con tanto impeto, sforzando chi lo teneva, per adentarlo, che percosso il capo nel muro tutto se lo ruppe.
Si racconta ancora da persone che furono presenti, che avendo Benedetto Baroni nipote di Francesco un quadretto di sua mano, poco maggiore di due palmi, nel quale è dipinta una Madonna a olio dal petto in su quasi quanto il naturale et il canto a basso il Puttino, dalla spalla in su, che con un braccio steso in alto sta in atto di carezzare la madre, si racconta, dico, che quando era l'imperatore padrone di Verona, essendo in quella città don Alonso di Castiglia, et Alarcone famosissimo capitano per sua maestà e per lo re catolico, che questi signori, essendo in casa del conte Lodovico da Sesso Veronese, dissero avere gran disiderio di veder questo quadro: per che, mandato per esso, si stavano una sera contemplandolo a buon lume et amirando l'artificio dell'opera, quando la signora Caterina, moglie del Conte, andò dove erano que' signori con uno de' suoi figliuoli, il quale aveva in mano uno di quegli uccelli verdi, che a Verona si chiamano terranzi, perché fanno il nido in terra, e si avezzano al pugno come gli sparvieri. Avenne adunque, stando ella co-gl'altri a contemplare il quadro, che quell'uccello, veduto il pugno et il braccio disteso del bambino dipinto, volò per saltarvi sopra, ma non si essendo potuto attaccare alla tavola dipinta, e per ciò caduto in terra, tornò due volte per posarsi in sul pugno del detto bambino dipinto, non altrimenti che se fusse stato un di que' putti vivi, che se lo tenevano sempre in pugno. Di che stupefatti que' signori, vollono pagar quel quadro a Benedetto gran prezzo, perché lo desse loro; ma non fu possibile per niuna guisa cavarglielo di mano. Non molto dopo, essendo i medesimi dietro a farglielo rubar un dì di San Biagio in San Nazzaro a una festa, perché ne fu fatto avertito il padrone, non riuscì loro il disegno.
Dipinse Francesco in San Polo di Verona una tavola a guazzo, che è molto bella, et un'altra in San Bernardino, alla capella de' Bandi, bellissima. In Mantoa lavorò per Verona in una tavola che è alla capella dove è sepolto San Biagio, nella chiesa di San Nazzaro de' monaci neri, due bellissimi nudi, et una Madonna in aria col Figliuolo in braccio, et alcuni Angeli, che sono maravigliose figure. Fu Francesco di santa vita e nimico d'ogni vizio, intanto che non volle mai non che altro dipignere opere lascive, ancor che dal Marchese ne fusse molte volte pregato. E simili a lui furono in bontà i fratelli, come si dirà a suo luogo. Finalmente Francesco, essendo vecchio e patendo d'orina, con licenza del Marchese e per consiglio di medici andò con la moglie e con servitori a pigliar l'acqua de' bagni di Caldero sul veronese; là dove, avendo un giorno presa l'acqua, si lasciò vincere dal sonno e dormì alquanto, avendolo in ciò per compassione compiaciuto la moglie; onde sopravenutagli mediante detto dormire, che è pestifero a chi piglia quell'acqua, una gran febre, finì il corso della vita a due dì di luglio 1519. Il che essendo significato al Marchese, ordinò subito, per un corriere, che il corpo di Francesco fusse portato a Mantoa; e così fu fatto, quasi contra la volontà de' veronesi, dove fu onoratissimamente sotterrato in Mantoa, nella sepoltura della Compagnia segreta in San Francesco. Visse Francesco anni 64; et un suo ritratto, che ha Messer Fermo, fu fatto quando era d'anni cinquanta. Furono fatti in sua lode molti componimenti, e pianto da chiunque lo conobbe come virtuoso e santo uomo che fu. Ebbe per moglie madonna Francesca Gioachini veronese, ma non ebbe figliuoli.
Il maggiore d'i tre fratelli che egli ebbe, fu chiamato Monsignore, e perché era persona di belle lettere, ebbe in Mantoa uffizii dal marchese di buone rendite per amor di Francesco. Costui visse ottanta anni, e lasciò figliuoli, che tengono in Mantoa viva la famiglia de' Monsignori. L'altro fratello di Francesco ebbe nome al secolo Girolamo, e fra i Zoccolanti di San Francesco fra' Cherubino, e fu bellissimo scrittore e miniatore. Il terzo, che fu frate di San Domenico, osservante e chiamato fra' Girolamo, volle per umiltà esser converso, e fu non pur di santa e buona vita, ma anco ragionevole dipintore, come si vede nel convento di San Domenico in Mantoa, dove, oltre all'altre cose, fece nel refettorio un bellissimo Cenacolo e la passione del Signore, che per la morte sua rimase imperfetta. Dipinse il medesimo quel bellissimo Cenacolo che è nel rifettorio de' monaci di San Benedetto, nella ricchissima badia che hanno in sul mantoano. In San Domenico fece l'altare del Rosaio; et in Verona nel convento di Santa Nastasia fece a fresco una Madonna, San Remigio vescovo e Santa Nastasia, nel secondo chiostro; e sopra la seconda porta del Martello, in un archetto una Madonna, San Domenico e San Tommaso d'Aquino, e tutti di pratica. Fu fra' Girolamo persona semplicissima e tutto alieno dalle cose del mondo, e standosi in villa a un podere del convento, per fuggire ogni strepito et inquietudine, teneva i danari che gl'erano mandati dall'opere, de' quali si serviva a comperare colori et altre cose, in una scatola senza coperchio appiccata al palco, nel mezzo della sua camera, di maniera che ognuno che voleva potea pigliarne. E per non si avere a pigliar noia ogni giorno di quello che avesse a mangiare, coceva il lunedì un caldaio di fagiuoli per tutta la settimana. Venendo poi la peste in Mantoa, et essendo gl'infermi abbandonati da ognuno, come si fa in simili casi, fra' Girolamo, non da altro mosso che da somma carità, non abbandonò mai i poveri padri ammorbati; anzi con le proprie mani gli servì sempre; e così, non curando di perdere la vita per amore di Dio, s'infettò di quel male e morì di sessanta anni, con dolore di chiunche lo conobbe.
Ma tornando a Francesco Monsignori, egli ritrasse, il che mi si era di sopra scordato, il Conte Ercole Giusti veronese, grande di naturale con una roba d'oro indosso, come costumava di portare, che è bellissimo ritratto, come si può vedere in casa il conte Giusto suo figliuolo.
Domenico Moroni, il quale nacque in Verona circa l'anno 1430, imparò l'arte della pittura da alcuni che furono discepoli di Stefano, e dall'opere che egli vide e ritrasse del detto Stefano, di Iacopo Bellini, di Pisano e d'altri. E per tacere molti quadri, che fece sicondo l'uso di que' tempi, che sono ne' monasteri e nelle case di privati, dico ch'egli dipinse a chiaro scuro di terretta verde la facciata d'una casa della comunità di Verona sopra la piazza detta de' Signori, dove si veggiono molte fregiature et istorie antiche con figure et abiti de' tempi a dietro molto bene accomodati. Ma il meglio che si veggia di man di costui è in San Bernardino il Cristo menato alla croce, con moltitudine di gente e di cavalli, che è nel muro sopra la capella del Monte della Pietà, dove fece Liberale la tavola del Deposto con quegl'Angeli che piangono. Al medesimo fece dipignere dentro e fuori la capella, che è vicina a questa, con ricchezza d'oro e molta spesa, Messer Niccolò de' Medici cavaliere, il quale era in quei tempi stimato il maggior ricco di Verona; et il quale spese molti danari in altre opere pie, sì come quello che era a ciò da natura inclinato. Questo gentiluomo, dopo aver molti monasterii e chiese edificato, né lasciato quasi luogo in quella città ove non facesse qualche segnalata spesa in onore di Dio, si elesse la sopra detta capella per sua sepoltura, negl'ornamenti della quale si servì di Domenico allora più famoso d'altro pittore in quella città, essendo Liberale a Siena. Domenico adunque dipinse nella parte di dentro di questa capella miracoli di Santo Antonio da Padoa, a cui è dedicata, e vi ritrasse il detto cavaliere in un vecchio raso col capo bianco e senza berretta, con veste lunga d'oro, come costumavano di portare i cavalieri in que' tempi; la quale opera per cosa in fresco è molto ben disegnata e condotta. Nella volta poi di fuori, che è tutta messa a oro, dipinse in certi tondi i quattro Evangelisti, e nei pilastri dentro e fuori fece varie figure di Santi; e fra l'altre Santa Elisabetta del terzo Ordine di San Francesco, Santa Elena e Santa Caterina, che sono figure molto belle, e per disegno, grazia e colorito molto lo-date. Quest'opera dunque può far fede della virtù di Domenico e della magnificenza di quel cavaliere.
Morì Domenico molto vecchio e fu sepolto in San Bernardino, dove sono le dette opere di sua mano, lasciando erede delle facultà e della virtù sua Francesco Morone, suo figliuolo, il quale avendo i primi principii dell'arte apparati dal padre, s'affaticò poi di maniera che in poco tempo riuscì molto miglior maestro che il padre stato non era; come l'opere che fece a concorrenza di quelle del padre chiaramente ne dimostrano.
Dipinse adunque Francesco, sotto l'opera di suo padre, all'altare del Monte nella chiesa, detta di San Bernardino, a olio le portelle che chiuggono la tavola di Liberale. Nelle quali, dalla parte di dentro, fece in una la Vergine e nell'altra San Giovanni Evangelista grandi quanto il naturale, e bellissime nelle facce che piangono, nei panni et in tutte l'altre parti. Nella medesima capella dipinse a basso, nella facciata del muro che fa capo al tramezzo, il miracolo che fece il Signore dei cinque pani e due pesci che saziarono le turbe: dove sono molte figure belle e molti ritratti di naturale; ma sopra tutto è lodato un San Giovanni Evangelista che è tutto svelto e volge le reni in parte al popolo. Appresso fece nel-l'istesso luogo, allato alla tavola, nei vani del muro la quale è appoggiata, un San Lodovico vescovo e frate di San Francesco, et un'altra figura; e nella volta, in un tondo che fora, certe teste che scortano. E queste opere tutte sono molto lo-date dai pittori veronesi.
Dipinse nella medesima chiesa, fra questa capella e quella de' Medici, all'altare della Croce, dove sono tanti quadri di pittura, un quadro, che è nel mezzo sopra tutti, dove è Cristo in croce, la Madonna e San Giovanni, che è molto bello; e dalla banda manca di detto altare, dipinse in un altro quadro, che è sopra quello del Carota, il Signore che lava i piedi agl'Apostoli, che stanno in varie attitudini; nella quale opera dicono che ritrasse questo pittore se stesso in figura d'uno che serve a Cristo a portar l'acqua. Lavorò Francesco alla capella degl'Emilii nel Duomo un San Iacopo e San Giovanni, che hanno in mezzo Cristo che porta la croce, e sono queste due figure di tanta bellezza e bontà, quanto più non si può disiderare. Lavorò il medesimo molte cose a Lonico, in una badia de' monaci di Monte Oliveto, dove concorrono molti popoli a una figura della Madonna che in quel luogo fa miracoli assai.
Essendo poi Francesco amicissimo e come fratello di Girolamo dai Libri pittore e miniatore, presero a lavorare insieme le portelle degl'organi di Santa Maria in Organo de' frati di Monte Oliveto, in una delle quali fece Francesco, nel difuori, un San Benedetto vestito di bianco e San Giovanni Evangelista, e nel didentro Daniello et Isaia profeti, con due Angioletti in aria et il campo tutto pieno di bellissimi paesi. E dopo dipinse l'ancona dell'altare della Muletta, facendovi un San Piero et un San Giovanni che sono poco più d'un braccio d'altezza, ma lavorati tanto bene e con tanta diligenza, che paiono miniati. E gl'intagli di quest'opera fece fra' Giovanni da Verona, maestro di tarsie e d'intaglio.
Nel medesimo luogo dipinse Francesco nella facciata del coro due storie a fresco, cioè quando il Signore va sopra l'asina in Ierusalem e quando fa orazione nell'orto dove sono in disparte le turbe armate che, guidate da Giuda, vanno a prenderlo. Ma sopra tutte è bellissima la sagrestia in volta, tutta dipinta dal medesimo, eccetto il Santo Antonio battuto dai demonii, il quale si dice essere di mano di Domenico suo padre. In questa sagrestia dunque, oltre il Cristo che è nella volta et alcuni Angioletti che scortano all'insù, fece nelle lunette diversi papi, a due a due per nicchia, in abito pontificale, i quali sono stati dalla Relligione di San Benedetto assunti al pontificato. Intorno poi alla sagrestia, sotto le dette lunette della volta, è tirato un fregio alto quattro piedi e diviso in certi quadri nei quali sono in abito monastico dipinti alcuni imperatori, re, duchi et altri principi, che lasciati gli stati e' principati che avevano, si sono fatti monaci. Nelle quale figure ritrasse Francesco dal naturale molti dei monaci che mentre vi lavorò abitarono o furono per passaggio in quel monasterio. E fra essi vi sono ritratti molti novizii et altri monaci d'ogni sorte, che sono bellissime teste e fatte con molta diligenza. E nel vero fu allora, per questo ornamento, quella la più bella sagrestia che fusse in tutta Italia, perché, oltre alla bellezza del vaso ben proporzionato e di ragionevole grandezza, e le pitture dette che sono bellissime, vi è anco da basso una spalliera di banchi lavorati di tarsie e d'intaglio con belle prospettive, così bene che in que' tempi, e forse anche in questi nostri, non si vede gran fatto meglio, perciò che fra' Giovanni da Verona, che fece quell'opera, fu eccellentissimo in quell'arte, come si disse nella vita di Raffaello da Urbino, e come ne dimostrano, oltre molte opere fatte nei luoghi della sua Relligione, quelle che sono a Roma nel palazzo del papa, quelle di Monte Oliveto di Chiusuri in sul sanese et in altri luoghi. Ma quelle di questa sagrestia sono di quante opere fece mai fra' Giovanni le migliori; perciò che si può dire che quanto nell'altre vinse gl'altri, tanto in queste avanzasse se stesso. Intagliò fra' Giovanni per questo luogo, fra l'altre cose, un candeliere alto più di quattordici piedi per lo cero pasquale, tutto di noce, con incredibile diligenza; onde non credo che per cosa simile si possa veder meglio.
Ma tornando a Francesco, dipinse nella medesima chiesa la tavola che è alla capella de' conti Giusti, nella quale fece la Madonna e Santo Agostino e San Martino in abiti pontificali. E nel chiostro fece un Deposto di croce con le Marie et altri Santi che per cose a fresco in Verona sono molto lodate. Nella chiesa della Vettoria dipinse la capella de' Fumanelli, sotto il tramezzo che sostiene il coro, fatto edificare da Messer Niccolò de' Medici cavaliere, e nel chiostro una Madonna a fresco. E dopo ritrasse di naturale Messer Antonio Fumanelli, medico famosissimo per l'opere da lui scritte in quella professione. Fece anco a fresco sopra una casa, che si vede quando si cala il ponte delle Navi per andar a San Polo, a man manca, una Madonna con molti Santi che è tenuta, per disegno e per colorito, opera molto bella. Et in Brà, sopra la casa de' Sparvieri, dirimpetto all'orto de' frati di San Fermo, ne dipinse un'altra simile. Altre cose assai dipinse Francesco, delle quali non accade far menzione essendosi dette le migliori; basta che egli diede alle sue pitture grazia, disegno, unione e colorito vago et acceso quanto alcun altro.
Visse Francesco anni cinquantacinque e morì a dì sedici di maggio 1529, e fu sepolto in San Domenico accanto a suo padre, e volle essere portato alla sepoltura vestito da frate di San Francesco. Fu persona tanto da bene e così relligiosa e costumata, che mai s'udì uscire di sua bocca parola che meno fusse che onesta.
Fu discepolo di Francesco e seppe molto più che il maestro Paulo Cavazzuola veronese, il quale fece molte opere in Verona: dico in Verona, perché in altro luogo non si sa che mai lavorasse. In San Nazzario, luogo de' monaci neri in Verona, dipinse molte cose a fresco, vicino a quelle di Francesco suo maestro, che tutte sono andate per terra nel rifarsi quella chiesa dalla pia magnanimità del reverendo padre don Mauro Lonichi, nobile veronese et abbate di quel monasterio. Dipinse similmente a fresco, sopra la casa vecchia de' Fumanelli nella via del Paradiso, la Sibilla che mostra ad Augusto il Signor Nostro in aria nelle braccia della Madre; la quale opera, per delle prime che Paulo facesse, è assai bella. Alla capella de' Fontani, in Santa Maria in Organi, dipinse, pure a fresco, due Angioli nel di fuori di detta capella, cioè San Michele e San Raffaello. In Santa Eufemia, nella strada dove risponde la capella dell'Angelo Raffaello, sopra una finestra che dà lume a un ripostiglio della scala di detto Angelo, dipinse quello, et insieme con esso Tobia, guidato da lui nel viaggio, che fu bellissima operina. A San Bernardino fece, sopra la porta del Campanello, un San Bernardino a fresco in un tondo, e nel medesimo muro più a basso, sopra l'uscio d'un confessionario, pur in un tondo, un San Francesco che è bello e ben fatto, sì come è anco il S. Bernardino. E questo è quanto ai lavori che si sa Paulo aver fatto in fresco.
A olio poi nella chiesa della Madonna della Scala, all'altare della Santificazione, dipinse in un quadro un San Rocco a concorrenza del San Bastiano che, all'incontro, dipinse nel medesimo luogo il Moro; il quale San Rocco è una bellissima figura. Ma in San Bernardino è il meglio delle figure che facesse mai questo pittore, perciò che tutti i quadri gran-di, che sono all'altare della croce, intorno all'ancona principale, sono di sua mano, eccetto quello dove è il Crocifisso, la Madonna e San Giovanni, che è sopra tutti gl'altri, il quale è di mano di Francesco suo maestro. A lato a questo fece Paulo due quadri grandi nella parte di sopra: in uno de' quali è Cristo alla colonna battuto e, nell'altro, la sua Coronazione dipinse con molte figure alquanto maggiori che il naturale. Più a basso nel primo ordine, cioè nel quadro principale, fece Cristo deposto di croce, la Madonna, la Maddalena, San Giovanni, Nicodemo e Giuseppo, et in uno di questi ritrasse se stesso tanto bene che par vivissimo, in una figura che è vicina al legno della croce, giovane, con barba rossa e con uno scuffiotto in capo, come allora si costumava di portare. Dal lato destro fece il Signore nell'orto con i tre Discepoli appresso, e dal sinistro dipinse il Medesimo con la croce in spalla, condotto al monte Calvario. La bontà delle quali opere, che fanno troppo paragone a quelle che nel medesimo luogo sono di mano del suo maestro, daranno sempre luogo a Paulo fra i migliori artefici. Nel basamento fece alcuni Santi dal petto in su, che sono tutti ritratti di naturale. La prima figura con l'abito di San Francesco, fatta per un beato, è il ritratto di fra' Girolamo Reccalchi, nobile veronese. La figura, che è a canto a questa, fatta per San Bonaventura, è il ritratto di fra' Bonaventura Riccalchi, fratello del detto fra' Girolamo. La testa del San Giuseppo è il ritratto d'un agente de' marchesi Malespini, che allora aveva carico dalla Compagnia della Croce di far fare quell'opera, e tutte sono bellissime teste. Nella medesima chiesa fece Paulo la tavola della capella di San Francesco, nella quale, che fu l'ultima che facesse, superò se medesimo. Sono in questa sei figure maggiori che il naturale. Santa Lisabetta del terzo Ordine di San Francesco, che è bellissima figura, con aria ridente e volto grazioso, e con il grembo pieno di rose, e pare che gioisca veggendo, per miracolo di Dio, che il pane che ella stessa, gran signora, portava ai poveri, fusse convertito in rose: in segno che molto era accetta a Dio quella sua umile carità di ministrare ai poveri con le proprie mani. In questa figura è il ritratto d'una gentildonna vedova della famiglia de' Sacchi. L'altre figure sono San Bonaventura cardinale e San Lodovico vescovo, e l'uno e l'altro frate di San Francesco. Appresso a questi è San Lodovico re di Francia, Santo Eleazaro in abito bigio, e Santo Ivone in abito sacerdotale. La Madonna poi, che è di sopra in una nuvola con San Francesco et altre figure d'intorno, dicono non esser di mano di Paulo, ma d'un suo amico che gl'aiutò lavorare questa tavola; e ben si vede che le dette figure non sono di quella bontà che sono quelle da basso. Et in questa tavola è ritratta di naturale madonna Caterina de' Sacchi, che fece fare quest'opera.
Paulo dunque, essendosi messo in animo di farsi grande e famoso, e perciò facendo fatiche intolerabili, infermò e si morì giovane di 31 anno, quando a punto cominciava a dar saggio di quello che si sperava da lui nell'età migliore. E certo, se la fortuna non si attraversava al virtuoso operare di Paulo, sarebbe senza dubbio arivato a quegl'onori supremi che migliori e maggiori si possono nella pittura disiderare. Per che dolse la perdita di lui non pure agl'amici, ma a tutti i virtuosi e chiunche lo conobbe, e tanto più essendo stato giovane d'ottimi costumi e senza macchia d'alcun vizio. Fu sepolto in San Polo, rimanendo imortale nelle bellissime opere che lasciò.
VITA DI FALCONETTO, ARCHITETTO VERONESE
Stefano Veronese, pittore rarissimo de' suoi tempi, come si è detto, ebbe un fratello carnale chiamato Giovan Antonio il quale se bene imparò a dipignere dal detto Stefano, non però riuscì se non meno che mezzano dipintore, come si vede nelle sue opere, delle quali non accade far menzione. Di costui nacque un figliuolo che similmente fu dipintore di cose dozzinali, chiamato Iacopo, e di Iacopo nacquero Giovanmaria detto Falconetto, del quale scriviamo la vita, e Giovan Antonio. Questo ultimo attendendo alla pittura, dipinse molte cose in Roveretto, castello molto onorato nel Trentino, e molti quadri in Verona che sono per le case de' privati. Similmente dipinse nella valle dell'Adice sopra Verona molte cose, et in Sacco, riscontro a Roveretto, in una tavola San Niccolò con molti animali, e molte altre, dopo le quali finalmente si morì a Roveretto dove era andato ad abitare. Costui fece sopra tutto begli animali e frutti, de' quali molte carte miniate, e molto belle, furono portate in Francia dal Mondella veronese, e molte ne furono date da Agnolo suo figliuolo a Messer Girolamo Lioni in Vinezia, gentiluomo di bellissimo spirito.
Ma venendo oggimai a Giovanmaria, fratello di costui, egli imparò i principii della pittura dal padre e gli aggrandì e migliorò assai, ancor che non fusse anch'egli pittore di molta reputazione, come si vede nel Duomo di Verona, alle ca-pelle de' Maffei e degl'Emili; et in San Nazzaro, nella parte superiore della cupola et in altri luoghi. Avendo dunque conosciuta costui la poca perfezzione del suo lavorare nella pittura, e dilettandosi sopra modo dell'architettura, si diede a osservare e ritrarre con molta diligenza tutte l'antichità di Verona sua patria. Risoltosi poi di voler vedere Roma, e da quelle maravigliose reliquie, che sono il vero maestro, imparare l'architettura, là se n'andò, e vi stette dodici anni interi: il qual tempo spese, per la maggior parte, in vedere e disegnare tutte quelle mirabili antichità, cavando in ogni luogo tanto che potesse vedere le piante e ritrovare tutte le misure. Né lasciò cosa in Roma, o di fabrica o di membra, come sono cornici, colonne e capitegli di qual si voglia ordine, che tutto non disegnasse di sua mano con tutte le misure. Ritrasse anco tutte le sculture che furono scoperte in que' tempi. Di maniera che dopo detti dodici anni, ritornò alla patria richissimo di tutti i tesori di quest'arte. E non contento delle cose della città propria di Roma, ritrasse quanto era di bello e buono in tutta la campagna di Roma infino nel regno di Napoli, nel ducato di Spoleto et in altri luoghi. E perché essendo povero non aveva Giovanmaria molto il modo da vivere, né da trattenersi in Roma, dicono che due o tre giorni della settimana aiutava a qualcuno lavorare di pittura; e di quel guadagno, essendo allora i maestri ben pagati, e buon vivere, vivea gl'altri giorni della settimana, attendendo ai suoi studii d'architettura. Ritrasse dunque tutte le dette anticaglie come fussero intere, e le rappresentò in disegno, dalle parti e dalle membra, cavando la verità e l'integrità di tutto il resto del corpo di quelli edifizii con sì fatte misure e proporzioni che non potette errare in parte alcuna.
Ritornato dunque Giovanmaria a Verona e non avendo occasione di esercitare l'architettura, essendo la patria in travaglio per mutazione di stato, attese per allora alla pittura e fece molte opere. Sopra la casa di que' della Torre lavorò un'arme grande con certi trofei sopra, e per certi signori tedeschi, consiglieri di Massimiliano imperatore, lavorò a fresco in una facciata della chiesa piccola di San Giorgio alcune cose della Scrittura, e vi ritrasse que' due signori tedeschi grandi quanto il naturale, uno da una, l'altro dall'altra parte ginocchioni. Lavorò a Mantoa al signor Luigi Gonzaga cose assai, et a Osmo nella marca d'Ancona alcun'altre. E mentre che la città di Verona fu dell'imperatore, dipinse sopra tutti gl'edifizii publici l'armi imperiali et ebbe perciò buona provisione et un privilegio dall'imperatore, nel quale si vede che gli concesse molte grazie et essenzioni, sì per lo suo ben servire nelle cose dell'arte e sì perché era uomo di molto cuore, terribile e bravo con l'arme in mano; nel che poteva anco aspettarsi da lui valorosa e fedel servitù, e massimamente tirandosi dietro, per lo gran credito che aveva appresso i vicini, il concorso di tutto il popolo che abitava il borgo di San Zeno, che è parte della città molto popolosa e nella quale era nato e vi aveva preso moglie, nella famiglia de' Provali. Per queste cagioni adunque, avendo il seguito di tutti quelli della sua contrada, non era per altro nome nella città chiamato che il Rosso di S. Zeno.
Per che, mutato lo stato della città e ritornata sotto gl'antichi suoi signori viniziani, Giovanmaria, come colui che avea seguito la parte imperiale, fu forzato, per sicurtà della vita, partirsi. E così andato a Trento, vi si trattenne, dipignendo alcune cose, certo tempo. Ma finalmente, rassettate le cose, se n'andò a Padoa, dove fu prima conosciuto e poi molto favorito da monsignor reverendissimo Bembo, che poco appresso lo fece conoscere al magnifico Messer Luigi Cornaro, gentiluomo viniziano d'alto spirito e d'animo veramente regio, come ne dimostrano tante sue onoratissime imprese. Questi dunque dilettandosi, oltre all'altre sue nobilissime parti, delle cose d'architettura, la cognizione della quale è degna di qualunche gran principe, et avendo perciò vedute le cose di Vetruvio, di Leonbattista Alberti e d'altri che hanno scritto in questa professione, e volendo mettere le cose che aveva imparato in pratica, veduti i disegni di Falconetto e con quanto fondamento parlava di queste cose, e chiariva tutte le difficultà che possono nascere nella varietà degli ordini dell'architettura, s'inamorò di lui per sì fatta maniera che, tiratoselo in casa, ve lo tenne onoratamente ventun anno, ché tanto fu il rimanente della vita di Giovanmaria, il quale in detto tempo operò molte cose con detto Messer Luigi, il quale, desideroso di vedere l'anticaglie di Roma in fatto, come l'aveva vedute nei disegni di Giovanmaria, menandolo seco se n'andò a Roma, dove avendo costui sempre in sua compagnia, volle vedere minutamente ogni cosa.
Dopo tornati a Padoa, si mise mano a fare col disegno e modello di Falconetto la bellissima et ornatissima loggia che è in casa Cornara, vicina al Santo, per far poi il palazzo secondo il modello fatto da Messer Luigi stesso. Nella qual loggia è sculpito il nome di Giovanmaria in un pilastro. Fece il medesimo una porta dorica molto grande e magnifica al palazzo del capitano di detta terra, la qual porta, per opera schietta, è molto lodata da ognuno. Fece anco due bellissime porte della città, l'una detta di San Giovanni, che va verso Vicenza, la quale è bella e commoda per i soldati che la guardano, e l'altra fu porta Savonarola, che fu molto bene intesa. Fece anco il disegno e modello della chiesa di Santa Maria delle Grazie de' frati di San Domenico e la fondò; la quale opera, come si vede dal modello, è tanto ben fatta e bella, che di tanta grandezza non si è forse veduto infino a ora una pari in altro luogo. Fu fatto dal medesimo il modello d'un superbissimo palazzo al signor Girolamo Savorgnano nel fortissimo suo castello d'Usopo nel Friuli, che allora fu fondato tutto e tirato sopra terra; ma morto quel signore, si rimase in quel termine senza andar più oltre, ma se questa fabrica si fusse finita sarebbe stata maravigliosa. Nel medesimo tempo andò Falconetto a Pola d'Istria solamente per disegnare e vedere il teatro, amfiteatro et arco che è in quella città antichissima. E fu questi il primo che disegnasse teatri et anfiteatri e trovasse le piante loro; e quelli che si veggono, e massimamente quel di Verona, vennero da lui e furo-no fatti stampare da altri sopra i suoi disegni. Ebbe Giovanmaria animo grande, e come quello che non aveva mai fatto altro che disegnare cose grandi antiche, null'altro disiderava se non che se gli presentasse occasione di far cose simili a quelle in grandezza, e tallora ne faceva piante e disegni con quella stessa diligenza che avrebbe fatto se si avessero avuto a mettere in opera subitamente, et in questo, per modo di dire, tanto si perdeva, che non si degnava di far disegni di case private di gentiluomini, né per villa, né per le città, ancor che molto ne fusse pregato.
Fu molte volte Giovanmaria a Roma, oltre le dette di sopra; onde avea tanto familiare quel viaggio, che per ogni leggeri occasione, quando era giovane e gagliardo, si metteva a farlo. Et alcuni che ancor vivono raccontano che, venendo egli un giorno a contesa con uno architetto forestiero che a caso si trovò in Verona, sopra le misure di non so che cornicione antico di Roma, disse Giovanmaria dopo molte parole: “Io mi chiarirò presto di questa cosa”. Et andatosene di lungo a casa, si mise in viaggio per Roma.
Fece costui due bellissimi disegni di sepolture per casa Cornara, le quali dovevano farsi in Vinezia in San Salvado-re, l'una per la reina di Cipri di detta casa Cornara, e l'altra per Marco Cornaro cardinale, che fu il primo che di quella famiglia fusse di cotale dignità onorato. E per mettere in opera detti disegni furono cavati molti marmi a Carrara e condotti a Vinezia, dove sono ancora così rozzi nelle case di detti Cornari. Fu il primo Giovanmaria che portasse il vero modo di fabricare e la buona architettura in Verona, Vinezia et in tutte quelle parti: non essendo stato inanzi a lui chi sapesse pur fare una cornice o un capitello, né chi intendesse né misura, né proporzione di colonna, né di ordine alcuno, come si può vedere nelle fabriche che furono fatte inanzi a lui. La quale cognizione essendo poi molto stata aiutata da fra' Iocondo, che fu ne' medesimi tempi, ebbe il suo compimento da Messer Michele San Michele; di maniera che quelle parti deono per ciò essere perpetualmente obligate ai Veronesi, nella quale patria nacquero et in un medesimo tempo vissero questi tre eccellentissimi architetti, alli quali poi succedette il Sansovino, che oltre alla architettura, la quale già trovò fondata e stabilita dai tre sopra detti, vi portò anco la scultura, acciò con essa venissero ad avere le fabriche tutti quegl'ornamenti che loro si convengono. Di che si ha obligo, se è così lecito dire, alla rovina di Roma. Perciò che essendosi i maestri sparsi in molti luoghi, furono le bellezze di queste arti comunicate a tutta l'Europa.
Fece Giovanmaria lavorare di stucchi alcune cose in Vinezia, et insegnò a mettergli in opera. Et affermano alcuni che, essendo egli giovane, fece di stucco lavorare la volta della capella del Santo in Padoa a Tiziano da Padoa et a molti altri, e ne fece lavorare in casa Cornara, che sono assai belli. Insegnò a lavorare a due suoi figliuoli, cioè ad Ottaviano, che fu anch'esso pittore, et a Provolo. Alessandro, suo terzo figliuolo, attese a fare armature in sua gioventù, e dopo, datosi al mestier del soldo, fu tre volte vincitor in steccato; e finalmente essendo capitano di fanteria, morì combattendo valorosamente sotto Turino nel Piamonte, essendo stato ferito d'una archibusata. Similmente Giovanmaria, essendo storpiato dalle gotte, finì il corso della vita sua in Padoa, in casa del detto Messer Luigi Cornaro, che l'amò sempre come fratello, anzi quanto se stesso. Et acciò che non fussero i corpi di coloro in morte separati, i quali aveva congiunti insieme con gl'animi, l'amicizia e la virtù in questo mondo, aveva disegnato esso Messer Luigi che nella sua stessa sepoltura, che si dovea fare, fusse riposto insieme con esso seco Giovanmaria et il facetissimo poeta Ruzzante, che fu suo familiarissimo e visse e morì in casa di lui. Ma io non so se poi cotal disegno del magnifico Cornaro ebbe effetto.
Fu Giovanmaria bel parlatore e molto arguto ne' motti, e nella conversazione affabile e piacevole, intanto che il Cornaro affermava che de' motti di Giovanmaria si sarebbe fatto un libro intero. E perché egli visse allegramente ancor che fusse storpiato delle gotte, gli durò la vita insino a 76 anni e morì nel 1534. Ebbe sei figliuole femine, delle quali cinque maritò egli stesso, e la sesta fu dopo lui maritata dai fratelli a Bartolomeo Ridolfi veronese, il quale lavorò in compagnia loro molte cose di stucco e fu molto migliore maestro che essi non furono; come si può vedere in molti luoghi, e particolarmente in Verona in casa Fiorio della Seta sopra il ponte nuovo, dove fece alcune camere bellissime; et alcune altre in casa de' signori conti Canossi, che sono stupende, sì come anco sono quelle che fece in casa de' Murati vicino a San Nazzaro, al signor Giovanbatista della Torre, a Cosimo Moneta banchiere veronese alla sua bellissima villa, et a molti altri in diversi luoghi, che tutte sono bellissime. Afferma il Palladio architetto rarissimo non conoscere persona né di più bella invenzione, né che meglio sappia ornare con bellissimi partimenti di stucco le stanze di quello che fa questo Bartolomeo Ridolfi: il quale fu, non sono molti anni passati, da Spitech Giordan, grandissimo signore in Pollonia appresso al re, condotto con onorati stipendii al detto re di Pollonia, dove ha fatto e fa molte opere di stucco, ritratti grandi, medaglie e molti disegni di palazzi et altre fabriche, con l'aiuto d'un suo figliuolo che non è punto inferiore al padre.
VITA DI FRANCESCO E GIROLAMO DAI LIBRI PITTORI E MINIATORI VERONESI
Francesco Vecchio dai Libri veronese, se bene non si sa in che tempo nascesse a punto, fu alquanto inanzi a Libera-le; e fu chiamato dai Libri per l'arte che fece di miniare libri, essendo egli vivuto quando non era ancora stata trovata la stampa e quando poi cominciò a punto a essere messa in uso. Venendogli dunque da tutte le bande libri a miniare, non era per altro cognome nominato che dai Libri, nel miniar de' quali era eccellentissimo. E ne lavorò assai, perciò che chi faceva la spesa dello scrivere, che era grandissima, gli voleva anco poi ornati più che si poteva di miniature.
Miniò dunque costui molti libri di canto da coro che sono in Verona, in San Giorgio, in Santa Maria in Organi et in San Nazzaro, che tutti son belli, ma bellissimo è un libretto, cioè due quadretti che si serrano insieme a uso di libro, nel quale è da un lato un San Girolamo d'opera minutissima e lavorata con molta diligenza, e dall'altro un San Giovanni finto nell'isola di Pathmos et in atto di voler scrivere il suo libro dell'Apocalissi. La quale opera, che fu lasciata al conte Agostino Giusti da suo padre, è oggi in San Lionardo de' Canonici Regolari, nel qual convento ha parte il padre don Timoteo Giusti, figliuolo di detto Conte. Finalmente avendo Francesco fatte infinite opere a diversi signori, si morì contento e felice; perciò che, oltre la quiete d'animo che gli dava la sua bontà, lasciò un figliuolo chiamato Girolamo tanto grande nell'arte, che lo vide avanti la morte sua molto maggiore che non era egli.
Questo Girolamo adunque nacque in Verona l'anno 1472, e d'anni sedici fece in Santa Maria in Organo la tavola della capella de' Lischi, la quale fu scoperta e messa al suo luogo con tanta maraviglia d'ognuno, che tutta la città corse ad abbracciare e rallegrarsi con Francesco suo padre. È in questa tavola un Deposto di croce con molte figure, e fra molte teste dolenti molto belle e di tutte migliori, una Nostra Donna et un San Benedetto molto commendati da tutti gl'artefici. Vi fece poi un paese et una parte della città di Verona ritratta assai bene di naturale. Inanimito poi Girolamo dalle lodi che si sentiva dare, dipinse con buona pratica in San Polo l'altare della Madonna, e nella chiesa della Scala il quadro della Madonna con Sant'Anna, che è posto fra il San Bastiano et il San Rocco del Moro e del Cavazzuola. Nella chiesa della Vettoria fece l'ancona dell'altar maggiore della famiglia de' Zoccoli, e vicino a questa, la tavola di Santo Onofrio della famiglia de' Cipolli, la quale è tenuta, per disegno e colorito, la migliore opera che mai facesse.
Dipinse anco in San Lionardo nel Monte, vicino a Verona, la tavola dell'altar maggiore della famiglia de' Cartieri, la quale è opera grande, con molte figure, e molto stimata da tutti, e sopra tutto vi è un bellissimo paese. Ma una cosa, accaduta molte volte ai giorni nostri, ha fatto tenere quest'opera maravigliosa, e cioè un arbore dipinto da Girolamo in questa tavola, al quale pare che sia appoggiata una gran seggiola, sopra cui posa la Nostra Donna. E perché il detto arbore, che pare un lauro, avanza d'assai con i rami la detta sedia, se gli vede dietro, fra un ramo e l'altro che sono non molto spessi, un'aria tanto chiara e bella, che egli pare veramente un arbore vivo, svelto e naturalissimo. Onde sono sta-ti veduti molte fiate ucelli, entrati per diversi luoghi in chiesa, volare a questo arbore per posarvisi sopra, e massimamente rondini che avevano i nidi nelle travi del tetto et i loro rondinini parimente. E questo affermano aver veduto persone dignissime di fede, come fra gl'altri il padre don Giuseppo Mangiuoli veronese, stato due volte generale di quella Relligione e persona di santa vita, che non affermarebbe per cosa del mondo cosa che verissima non fusse; et il padre don Girolamo Volpini, similmente veronese, e molti altri. Dipinse anco Girolamo in Santa Maria in Organi, dove fece la prima opera sua, in una delle portelle dell'organo (avendo l'altra dipinta Francesco Morone suo compagno), due San-te dalla parte di fuori, e nel didentro un presepio. E dopo fece la tavola, che è riscontro alla sua prima, dove è una natività del Signore, pastori e paesi et alberi bellissimi. Ma sopra tutto sono vivi e naturali due conigli, lavorati con tanta diligenza che si vede, non che altro, in loro la divisione de' peli. Un'altra tavola dipinse alla capella de' Buonalivi con una Nostra Donna a sedere in mezzo, due altre figure e certi Angeli a basso che cantano. All'altare poi del Sagramento, nell'ornamento fatto da fra' Giovanni da Verona, dipinse il medesimo tre quadretti piccoli che sono miniati. In quel di mezzo è un Deposto di croce con due Angioletti, et in quei dalle bande sono dipinti sei martiri, tre per ciascun quadro, ginocchioni verso il Sagramento; i corpi de' quali Santi sono riposti in quel proprio altare, e sono i primi tre Canzio, Canziano e Cancianello, i quali furono nipoti di Diocliziano imperatore, gl'altri tre sono Proto, Grisogono et Anastasio, martirizzati ad Aquas Gradatas, appresso ad Aquileia. E sono tutte queste figure miniate e bellissime, per essere valuto in questa professione Girolamo sopra tutti gl'altri dell'età sua in Lombardia e nello stato di Vinezia.
Miniò Girolamo molti libri ai monaci di Montescaglioso nel regno di Napoli, alcuni a Santa Giustina di Padoa, e molti altri alla Badia di Praia sul padoano, et alcuni ancora a Candiana, monasterio molto ricco de' Canonici Regolari di San Salvatore; nel qual luogo andò in persona a lavorare, il che non volle mai fare in altro luogo, e stando quivi imparò allora i primi principii di miniare don Giulio Clovio, che era frate in quel luogo, il quale è poi riuscito il maggiore in questa arte che oggidì viva in Italia. Miniò Girolamo a Candiana una carta d'un Chirie, che è cosa rarissima; et ai medesimi la prima carta d'un salterio da coro; et in Verona molte cose per Santa Maria in Organo et ai frati di S. Giorgio. Medesimamente ai monaci negri di San Nazario, fece in Verona alcun'altri minii bellissimi. Ma quella che avanzò tutte l'altre opere di costui, che furono divine, fu una carta dove è fatto di minio il Paradiso terrestre con Adamo et Eva, cacciati dall'Angelo che è loro dietro con la spada in mano. Né si potria dire quanto sia grande e bella la varietà degl'alberi che sono in quest'opera, i frutti, i fiori, gl'animali, gl'uccelli e l'altre cose tutte. La quale stupenda opera fece fare don Giorgio Cacciamale bergamasco, allora priore in San Giorgio di Verona, il quale, oltre a molte altre cortesie che usò a Girolamo, gli donò sessanta scudi d'oro. Quest'opera dal detto padre fu poi donata in Roma a un cardinale, allora protettore di quella Relligione, il quale mostrandola in Roma a molti signori, fu tenuta la migliore opera di minio che mai fusse insin allora stata veduta.
Facea Girolamo i fiori con tanta diligenza, e così veri, belli e naturali, che parevano ai riguardanti veri. E contrafaceva camei piccoli et altre pietre e gioie intagliate di maniera che non si poteva veder cosa più simile, né più minuta. E fra le figurine sue se ne veggiono alcune, come in camei et altre pietre finte, che non sono più grandi che una piccola formica, e si vede nondimeno in loro tutte le membra e tutti i muscoli tanto bene, che a pena si può credere da chi non gli vede. Diceva Girolamo, nell'ultima sua vecchiezza, che allora sapea più che mai avesse saputo in quest'arte e dove aveano ad andare tutte le botte, ma che poi nel maneggiar il pennello gl'andavano a contrario, perché non lo serviva più né l'occhio, né la mano.
Morì Girolamo l'anno 1555 a due dì di luglio d'età d'anni ottantatré e fu sepolto in San Nazario nelle sepolture della Compagnia di San Biagio. Fu costui persona molto da bene, né mai ebbe lite né travaglio con persona alcuna, e fu di vita molto innocente. Ebbe fra gl'altri un figliuolo chiamato Francesco, il quale imparò l'arte da lui e fece, essendo anco giovinetto, miracoli nel miniare, in tanto che Girolamo affermava di quell'età non aver saputo tanto quanto il figliuolo sapeva. Ma gli fu costui sviato da un fratello della madre il quale, essendo assai ricco e non avendo figliuoli, se lo tirò appresso, facendolo attendere in Vicenza alla cura d'una fornace di vetri che facea fare. Nel che, avendo speso Francesco i migliori anni, morta la moglie del zio, cascò da ogni speranza e si trovò aver perso il tempo, perché presa colui un'altra moglie n'ebbe figliuoli. E così non fu altrimenti Francesco, sì come s'avea pensato, erede del zio. Per che rimessosi all'arte dopo sei anni et imparato qualche cosa, si diede a lavorare, e, fra l'altre cose, fece una palla grande di diametro quattro piedi, vota dentro e coperto il difuori, che era di legno, con colla di nervi di bue, temperata in modo che era fortissima, né si poteva temere in parte alcuna di rottura o d'altro danno. Dopo, essendo questa palla, la quale dovea servire per una sfera terrestre, benissimo compartita e misurata, con ordine e presenza del Fracastoro e del Beroldi, medici ambidue e cosmografi et astrologi rarissimi, si dovea colorire da Francesco per Messer Andrea Navagero, gentiluomo viniziano e dottissimo poeta et oratore, il quale volea farne dono al re Francesco di Francia, al quale dovea per la sua republica andar oratore. Ma il Navagero, essendo a pena arrivato in Francia in sulle poste, si morì, e quest'opera rimase imperfetta, la quale sarebbe stata cosa rarissima, come condotta da Francesco e col consiglio e parere di due sì grand'uomini. Rimase dunque imperfetta, e, che fu peggio, quello che era fatto ricevette non so che guastamento in assenza di Francesco. Tuttavia così guasta la comperò Messer Bartolomeo Lonichi, che non ha mai voluto compiacerne alcuno ancor che ne sia stato ricerco con grandissimi preghi e prezzo. N'aveva fatto Francesco innanzi a questa due altre minori, l'una delle quali è in mano del Mazzanti arciprete del Duomo di Verona, e l'altra ebbe il conte Raimondo dalla Torre, et oggi l'ha il conte Giovambatista suo figliuolo che la tiene carissima; perché anco questa fu fatta con le misure et assistenza del Fracastoro, il quale fu molto familiare amico del conte Raimondo. Francesco finalmente, increscendogli la tanta diligenza che ricercano i minii, si diede alla pittura et all'architettura, nelle quali riuscì peritissimo, e fece molte cose in Vinezia et in Padoa.
Era in quel tempo il vescovo di Tornai, fiamingo nobilissimo e ricchissimo, venuto in Italia per dare opera alle lettere, vedere queste provincie et apparare le creanze e modi di vivere di qua. Per che trovandosi costui in Padoa e dilettandosi molto di fabricare, come invaghito del modo di fabricare italiano, si risolvé di portare nelle sue parti la maniera delle fabriche nostre. E per poter ciò fare più comodamente, conosciuto il valore di Francesco, se lo tirò appresso con onorato stipendio per condurlo in Fiandra, dove avevano in animo di voler fare molte cose onorate. Ma venuto il tempo di partire e già avendo fatto disegnare le maggiori e migliori e più famose fabriche di qua, il poverello Francesco si morì, essendo giovane e di bonissima speranza, lasciando il suo padrone, per la sua morte, molto dolente. Lasciò Francesco un solo fratello, nel quale, essendo prete, rimane estinta la famiglia dai Libri, nella quale sono stati successivamente tre uomini in questa professione molto eccellenti. Et altri discepoli non sono rimasi di loro che tenghino viva quest'arte, eccetto don Giulio Clovio sopra detto, il quale l'apprese come abbian detto da Girolamo quando lavorava a Candiana, essendo lì frate, et il quale l'ha poi inalzata a quel supremo grado al quale pochissimi sono arrivati, e niuno l'ha trapassato già mai.
Io sapeva bene alcune cose dei sopra detti eccellenti e nobili artefici veronesi, ma tutto quello che n'ho raccontato non arei già saputo interamente, se la molta bontà e diligenza del reverendo e dottissimo fra' Marco de' Medici, veronese et uomo pratichissimo in tutte le più nobili arti e scienzie, et insieme il Danese Cataneo da Carrara eccellentissimo scultore, e miei amicissimi, non me n'avessero dato quell'intero e perfetto ragguaglio che di sopra, come ho saputo il meglio, ho scritto a utile e commodo di chi leggerà queste nostre vite: nelle quali mi sono stati e sono di grande aiuto le cortesie di molti amici, che per compiacermi e giovare al mondo, si sono in ricercar questa cosa affaticati.
E questo sia il fine delle vite dei detti veronesi, di ciascuno de' quali non ho potuto avere i ritratti, essendomi questa piena notizia non prima venuta alle mani, che quando mi sono poco meno che alla fine dell'opera ritrovato.
VITA DI FRANCESCO GRANACCI
PITTORE FIORENTINO

Grandissima è la ventura di quegli artefici che si accostano, o nel nascere o nelle compagnie che si fanno in fanciullezza, a quegl'uomini che il cielo ha eletto per segnalati e superiori agl'altri nelle nostre arti: atteso che fuor di modo s'acquista e bella e buona maniera nel vedere i modi del fare e l'opere degl'uomini eccellenti; senzaché anco la concorrenza e l'emulazione ha, come in altro luogo si è detto, gran forza negl'animi nostri.
Francesco Granacci, adunque, del quale si è di sopra favellato, fu uno di quegli che dal Magnifico Lorenzo de' Medici fu messo a imparare nel suo giardino; onde avvenne che, conoscendo costui ancor fanciullo il valore e la virtù di Michelagnolo, e quanto crescendo fusse per produrre grandissimi frutti, non sapeva mai levarsegli d'attorno; anzi, con sommessione et osservanza incredibile, s'ingegnò sempre di andar secondando quel cervello. Di maniera che Michelagnolo fu forzato amarlo sopra tutti gl'altri amici et a confidar tanto in lui, che a niuno più volentieri che al Granaccio conferì mai le cose, né comunicò tutto quello che allora sapeva nell'arte.
E così essendo ambidue stati insieme di compagnia in bottega di Domenico Grillandai, avvenne, perché il Granacci era tenuto dei giovani del Grillandai il migliore e quegli che avesse più grazia nel colorire a tempera e maggior disegno, che egli aiutò a Davitte e Benedetto Grillandai, fratelli di Domenico, a finire la tavola dell'altare maggiore di Santa Maria Novella, la quale per la morte di esso Domenico era rimasa imperfetta. Nel quale lavoro il Granaccio acquistò assai. E dopo fece della medesima maniera che è detta tavola, molti quadri che sono per le case de' cittadini, et altri che furo-no mandati di fuori. E perché era molto gentile e valeva assai in certe galanterie che per le feste di carnovale si facevano nella città, fu sempre in molte cose simili dal Magnifico Lorenzo de' Medici adoperato; ma particolarmente nella mascherata, che rappresentò il trionfo di Paulo Emilio della vittoria, che egli ebbe, di certe nazzioni straniere; nella quale mascherata, piena di bellissime invenzioni, si adoperò talmente il Granacci, ancor che fusse giovinetto, che ne fu sommamente lodato. Né tacerò qui che il detto Lorenzo de' Medici fu primo inventore, come altra volta è stato detto, di quelle mascherate che rappresentano alcuna cosa e sono detti a Firenze canti, non si trovando che prima ne fussero state fatte in altri tempi.
Fu similmente adoperato il Granacci l'anno 1513 negl'apparati che si fecero, magnifici e sontuosissimi, per la venuta di papa Leone Decimo de' Medici, da Iacopo Nardi, uomo dottissimo e di bellissimo ingegno; il quale, avendogli ordinato il magistrato degl'Otto di pratica che facesse una bellissima mascherata, fece rapresentare il trionfo di Camillo. La quale mascherata, per quanto apparteneva al pittore, fu dal Granacci tanto bene ordinata a bellezza et adorna, che meglio non può alcuno immaginarsi. E le parole della canzona che fece Iacopo cominciavano:
Contempla in quanta gloria sei salita,
felice alma Fiorenza,
poi che dal ciel discesa
e quello che segue.
Fece il Granacci pel medesimo apparato, e prima e poi, molte prospettive da comedia, e stando col Grillandaio lavorò stendardi da galea, bandiere et insegne d'alcuni cavalieri a sproni d'oro nell'entrare publicamente in Firenze, e tutto a spese de' capitani di Parte Guelfa, come allora si costumava e si è fatto anco, non ha molto, a' tempi nostri. Similmente, quando si facevano le potenze e l'armegerie, fece molte belle invenzioni d'abbigliamenti et acconcimi. La quale maniera di feste che è propria de' fiorentini et è piacevole molto vedendosi uomini quasi ritti del tutto a cavallo, in sulle staffe cortissime, rompere la lancia con quella facilità che fanno i guerrieri ben serrati nell'arcione, si fecero tutti per la detta venuta di Leone a Firenze. Fece anco, oltre all'altre cose, il Granacci un bellissimo arco trionfale dirimpetto alla porta di Badia, pieno di storie di chiaro scuro con bellissime fantasie. Il quale arco fu molto lodato, e particolarmente per l'invenzione dell'architettura e per aver finto, per l'entrata della via del palagio, il ritratto della medesima porta di Badia con le scalee et ogni altra cosa, che tirata in prospettiva non era dissimile la dipinta e posticcia dalla vera e propria. E per ornamento del medesimo arco fece di terra alcune figure di rilievo di sua mano bellissime, et in cima all'arco in una grande inscrizione, queste parole: “Leoni X pontifici maximo fidei cultori”.
Ma per venire oggimai ad alcune opere del Granacci che sono in essere, dico che, avendo egli studiato il cartone di Michelagnolo, mentre che esso Buonarroto per la sala grande di palazzo il faceva, acquistò tanto e di tanto giovamento gli fue, che, essendo Michelagnolo chiamato a Roma da papa Giulio Secondo perché dipignesse la volta della capella di palazzo, fu il Granacci de' primi, ricerchi da Michelagnolo, che gl'aiutassero colorire a fresco quell'opera, secondo i cartoni che esso Michelagnolo avea fatto. Bene è vero che, non piacendogli poi la maniera né il modo di fare di nessuno, trovò via senza licenziarli, chiudendo la porta a tutti e non si lasciando vedere, che tutti se ne tornarono a Fiorenza; do-ve dipinse il Granacci a Pierfrancesco Borgherini, nella sua casa di borgo Santo Apostolo in Fiorenza, in una camera dove Iacopo da Puntormo, Andrea del Sarto e Francesco Ubertini avevano fatto molte storie della vita di Ioseffo, sopra un lettuccio, una storia a olio de' fatti del medesimo in figure piccole, fatte con pulitissima diligenza e con vago e bel colorito; et una prospettiva, dove fece Giuseppo che serve Faraone, che non può essere più bella in tutte le parti. Fece ancora al medesimo, pure a olio, una Trinità in un tondo, cioè un Dio Padre che sostiene un Crucifisso. E nella chiesa di San Pier Maggiore è in una tavola di sua mano un'Assunta con molti Angeli e con un San Tommaso al quale ella dà la cintola, figura molto graziosa e ch'è svolta tanto bene, che pare di mano di Michelagnolo; e così fatta è anco la Nostra Donna. Il disegno delle quali due figure di mano del Granacci, è nel nostro libro con altri fatti similmente da lui. Sono dalle bande di questa tavola S. Paulo, San Lorenzo, S. Iacopo e S. Giovanni, che sono tutte così belle figure, che questa è tenuta la migliore opera che Francesco facesse mai. E nel vero questa sola, quando non avesse mai fatto altro, lo farà tenere sempre, come fu, eccellente dipintore.
Fece ancora nella chiesa di San Gallo, luogo già fuor della detta porta, de' frati Eremitani di Santo Agostino, in una tavola la Nostra Donna e due putti, San Zanobi vescovo di Fiorenza, e San Francesco; la quale tavola, che era alla ca-pella de' Girolami, della quale famiglia fu detto San Zanobi, è oggi in San Iacopo tra' Fossi in Firenze.
Avendo Michelagnolo Buonarruoti una sua nipote monaca in Santa Apollonia di Firenze, et avendo per ciò fatto l'ornamento et il disegno della tavola e dell'altar maggiore, vi dipinse il Granaccio alcune storie di figurette piccole a olio et alcune grandi, che allora sodisfecero molto alle monache et ai pittori ancora. Nel medesimo luogo dipinse da basso un'altra tavola, che per inavertenza di certi lumi lasciati all'altare abruciò una notte con alcuni parametri di molto valore; che certo fu gran danno, perciò che era quell'opera molto dagl'artefici lodata.
Alle monache di S. Giorgio in sulla Costa fece nella tavola dell'altar maggiore la Nostra Donna, Santa Caterina, San Giovanni Gualberto, San Bernardo Uberti cardinale e San Fedele. Lavorò similmente il Granacci molti quadri e tondi sparsi per la città nelle case de' gentiluomini; e fece molti cartoni per far finestre di vetro, che furono poi messi in opera dai frati degl'Ingesuati di Fiorenza. Dilettossi molto di dipignere drappi, e solo et in compagnia: onde, oltre le cose dette di sopra, fece molti drappelloni. E perché faceva l'arte più per passar tempo che per bisogno, lavorava agiatamente, e voleva tutte le sue commodità, fuggendo a suo potere i disagi più che altr'uomo. Ma nondimeno conservò sempre il suo, senza esser cupido di quel d'altri. E perché si diede pochi pensieri, fu piacevole uomo et attese a godere allegramente. Visse anni sessantasette; alla fine de' quali, di malatia ordinaria e di febre finì il corso della sua vita; e nella chiesa di Santo Ambruogio di Firenze ebbe sepoltura nel giorno di Santo Andrea Apostolo, nel MDXLIIII.
VITA DI BACCIO D'AGNOLO
ARCHITETTORE FIORENTINO

Sommo piacere mi piglio alcuna volta nel vedere i principii degl'artefici nostri, per veder salire molto tallora di basso in alto, e specialmente nell'architettura; la scienza della quale non è stata esercitata da parecchi anni a dietro se non da intagliatori o da persone soffistiche, che facevano professione sanza saperne pure i termini et i primi principii d'in-tendere la prospettiva. E pur è vero che non si può esercitare l'architettura perfettamente se non da coloro che hanno ottimo giudizio e buon disegno, o che in pitture, sculture o cose di legname abbiano grandemente operato. Conciò sia che in essa si misurano i corpi delle figure loro, che sono le colonne, le cornici, i basamenti e tutti l'ordin di quella; i quali a ornamento delle figure son fatti, e non per altra cagione. E per questo i legnaiuoli, di continuo maneggiandogli, diventano in ispazio di tempo architetti; e gli scultori similmente, per lo situare le statue loro, e per fare ornamenti a sepolture et altre cose tonde, col tempo l'intendono; et il pittore, per le prospettive e per la varietà dell'invenzioni, e per i casamenti da esso tirati, non può fare che le piante degl'edificii non faccia; attesoché non si pongono case né scale ne' piani dove le figure posano, che la prima cosa non si tiri l'ordine e l'architettura.
Lavorando dunque di rimessi Baccio nella sua giovanezza eccellentemente, fece le spalliere del coro di Santa Maria Novella nella capella maggiore, nella quale sono un San Giovanni Battista et un San Lorenzo bellissimi. D'intaglio lavorò l'ornamento della medesima capella e quello dell'altar maggiore della Nunziata, l'ornamento dell'organo di Santa Maria Novella et altre infinite cose, e publiche e private, nella sua patria Fiorenza. Della quale partendosi, andò a Roma, dove attese con molto studio alle cose d'architettura e, tornato, fece per la venuta di papa Leone Decimo, in diversi luoghi, archi trionfali di legname. Ma per tutto ciò non lasciando mai la bottega, vi dimoravano assai con esso lui, oltre a molti cittadini, i migliori e primi artefici dell'arte nostre; onde vi si facevano, massimamente la vernata, bellissimi discorsi e dispute d'importanza. Il primo di costoro era Raffaello da Urbino, allora giovane, e dopo Andrea Sansovino, Filippino, il Maiano, il Cronaca, Antonio e Giuliano Sangalli, il Granaccio, et alcuna volta, ma però di rado, Michelagnolo e molti giovani fiorentini e forestieri.
Avendo adunque per sì fatta maniera atteso Baccio all'architettura, et avendo fatto di sé alcuno esperimento, cominciò a essere a Firenze in tanto credito, che le più magnifiche fabriche che al suo tempo si facessero, furono allogate a lui et egli fattone capo. Essendo gonfaloniere Piero Soderini, Baccio insieme col Cronaca et altri, come si è detto di sopra, si trovò alle deliberazzioni che si fecero della sala grande di palazzo; e di sua mano lavorò di legname l'ornamento della tavola grande, che abbozzò fra' Bartolomeo, disegnato da Filippino. In compagnia de' medesimi fece la scala che va in detta sala, con ornamento di pietra molto bello; e di mischio le colonne e porte di marmo della sala, che oggi si chiama de' Dugento. Fece in sulla piazza di Santa Trinita un palazzo a Giovanni Bartolini, il quale è dentro molto adornato, e molti disegni per lo giardino del medesimo in Gualfonda. E perché fu il primo edifizio, quel palazzo, che fusse fatto con ornamento di finestre quadre, con frontispizii e con porta le cui colonne reggessino architrave, fregio e cornice, furono queste cose tanto biasimate dai fiorentini con parole, con sonetti e con appiccarvi filze di frasche, come si fa alle chiese per le feste, dicendosi che aveva più forma di facciata di tempio che di palazzo, che Baccio fu per uscir di cervello. Tuttavia, sapendo egli che aveva imitato il buono e che l'opera stava bene, se ne passò. Vero è che la cornice di tutto il palazzo riuscì, come si è detto in altro luogo, troppo grande, tuttavia l'opera è stata per altro sempre molto lodata.
A Lanfredino Lanfredini fece fabricare lungo Arno la casa loro, che è fra il ponte a Santa Trinita et il ponte alla Carraia, e su la piazza de' Mozzi cominciò, ma non finì, la casa de' Nasi, che risponde in sul renaio d'Arno. Fece ancora la casa de' Taddei, a Taddeo di quella famiglia, che fu tenuta commodissima e bella. Diede a Pierfrancesco Borgherini i disegni della casa che fece in borgo Santo Apostolo; et in quella con molta spesa fece far gl'ornamenti delle porte, camini bellissimi; e particolarmente fece per ornamento d'una camera cassoni di noce pieni di putti intagliati con somma diligenza. La quale opera sarebbe oggi impossibile a condurre a tanta perfezzione con quanta la condusse egli. Diedegli il disegno della villa che e' fece fare sul poggio di Bellosguardo, che fu di bellezza e di comodità grande e di spesa infinita. A Giovanmaria Benintendi fece un'anticamera et un recinto d'un ornamento, per alcune storie fatte da eccellenti maestri, che fu cosa rara. Fece il medesimo il modello della chiesa di S. Giuseppo da Santo Nofri, e fece fabricare la porta, che fu l'ultima opera sua. Fece condurre di fabrica il campanile di Santo Spirito in Fiorenza, che rimase imperfetto: oggi per ordine del duca Cosimo si finisce col medesimo disegno di Baccio. E similmente quello di San Miniato di Monte, dall'artiglieria del campo battuto, non però fu mai rovinato. Per lo che non minor fama s'acquistò per l'offesa che fece a' nemici, che per la bontà e bellezza con che Baccio l'aveva fatto lavorare e condurre.
Essendo poi Baccio, per la sua bontà e per essere molto amato dai cittadini, nell'Opera di Santa Maria del Fiore per architetto, diede il disegno di fare il ballatoio che cigne intorno la cupola; il quale Pippo Brunelleschi, sopragiunto dalla morte, aveva lasciato a dietro. E benché egli avesse anco di questo fatto il disegno, per la poca diligenza de' ministri dell'Opera, erano andati male e perduti. Baccio adunque, avendo fatto il disegno e modello di questo ballatoio, mise in opera tutta la banda che si vede verso il canto de' Bischeri. Ma Michelagnolo Buonarroti, nel suo ritorno da Roma, veggendo che nel farsi quest'opera si tagliavano le morse che aveva lasciato fuori non senza proposito Filippo Brunelleschi, fece tanto rumore che si restò di lavorare, dicendo esso che gli pareva che Baccio avesse fatto una gabbia da grilli, e che quella machina sì grande richiedeva maggior cosa e fatta con altro disegno, arte e grazia che non gli pareva che avesse il disegno di Baccio, e che mostrarebbe egli come s'aveva da fare. Avendo dunque fatto Michelagnolo un modello, fu la cosa lungamente disputata fra molti artefici e cittadini intendenti davanti al cardinale Giulio de' Medici. E finalmente non fu, né l'un modello, né l'altro messo in opera. Fu biasimato il disegno di Baccio in molte parti, non che di misura in quel grado non stesse bene, ma perché troppo diminuiva a comparazzione di tanta machina. E per queste cagioni non ha mai avuto questo ballatoio il suo fine.
Attese poi Baccio a fare i pavimenti di Santa Maria del Fiore, et altre sue fabriche, che non erano poche, tenendo egli cura particolare di tutti i principali monasterii e conventi di Firenze, e di molte case di cittadini dentro e fuori della città.
Finalmente vicino a 83 anni, essendo anco di saldo e buon giudizzio, andò a miglior vita nel 1543, lasciando Giuliano, Filippo e Domenico suoi figliuoli, dai quali fu fatto sepellire in San Lorenzo.
De' quali suoi figliuoli, che tutti dopo Baccio atteser all'arte dell'intaglio e falegname, Giuliano, che era il secondo, fu quegli che con maggiore studio, vivendo il padre, e dopo, attese all'architettura. Onde col favore del duca Cosimo succedette nel luogo del padre all'Opera di Santa Maria del Fiore, e seguitò non pure in quel tempio quello che il padre avea cominciato, ma tutte l'altre muraglie ancora, le quali per la morte di lui erano rimase imperfette. Et avendo in quel tempo Messer Baldassarre Turini da Pescia a collocare una tavola di mano di Raffaello da Urbino nella principale chiesa di Pescia, di cui era proposto, e farle un ornamento di pietra intorno, anzi una capella intera et una sepoltura, condusse il tutto con suoi disegni e modelli Giuliano, il quale rassettò al medesimo la sua casa di Pescia con molte belle et utili commodità. Fuor di Fiorenza a Montughi fece il medesimo a Messer Francesco Campana, già primo segretario del duca Alessandro e poi del duca Cosimo de' Medici, una casetta piccola a canto alla chiesa, ma ornatissima e tanto ben posta, che vagheggia, essendo alquanto rilevata, tutta la città di Firenze et il piano intorno. Et a Colle, patria del medesimo Campana, fu murata una commodissima e bella casa col disegno del detto Giuliano; il quale poco appresso cominciò per Messer Ugolino Grifoni, monsignor d'Altopascio, un palazzo a San Miniato al Tedesco che fu cosa magnifica. Et a Ser Giovanni Conti, uno de' segretarii del detto signor duca Cosimo, acconciò, con molti belli e commodi ornamenti, la casa di Firenze; ma ben è vero che nel fare le due finestre inginocchiate, le quali rispondono in sulla strada, uscì Giuliano del modo suo ordinario, e le tritò tanto con risalti, mensoline e rotti, ch'elle tengono più della maniera tedesca che dell'antica e moderna, vera e buona. E nel vero le cose d'architettura vogliono essere maschie, sode e semplici, et arricchite poi dalla grazia del disegno e da un sugetto vario nella composizione, che non alteri col poco o col troppo, né l'or-dine dell'architettura, né la vista di chi intende.
Intanto, essendo tornato Baccio Bandinelli da Roma, dove aveva finito le sepolture di Leone e Clemente, persuase al signor Duca Cosimo, allora giovinetto, che facesse nella sala grande del palazzo ducale una facciata in testa tutta piena di colonne e nicchie, con un ordine di ricche statue di marmo, la qual facciata rispondesse con finestre di marmo e macigni in piazza. A che fare risoluto il Duca, mise mano il Bandinello a fare il disegno, ma trovato, come si è detto nella vita del Cronaca, che la detta sala era fuor di squadra, e non avendo mai dato opera all'architettura il Bandinello, come quello che la stimava arte di poco valore e si faceva maraviglia e rideva di chi le dava opera, veduta la difficultà di quest'opera, fu forzato conferire il suo disegno con Giuliano e pregarlo che come architettore gli guidasse quell'ope-ra. E così, messi in opera tutti gli scarpellini et intagliatori di Santa Maria del Fiore, si diede principio alla fabrica, risoluto il Bandinello, col consiglio di Giuliano, di far che quell'opera andasse fuor di squadra, secondando in parte la muraglia. Onde avenne che gli bisognò fare tutte le pietre con le quadrature bieche, e con molta fatica condurle col pifferello, ch'è uno strumento d'una squadra zoppa. Il che diede tanto disgrazia all'opera che, come si dirà nella vita del Bandinello, è stato difficile ridurla in modo che ella accompagni l'altre cose. La qual cosa non sarebbe avenuta se il Bandinello avesse posseduto le cose d'architettura come egli possedeva quelle della scultura; per non dir nulla che le nicchie grandi, dove sono dentro nelle rivolte verso le facciate, riuscivano nane, e non senza difetto quella del mezzo, come si dirà nella vita di detto Bandinello. Quest'opera, dopo esservisi lavorato dieci anni, fu messa da canto, e così si è stata qualche tempo. Vero è che le pietre scorniciate e le colonne così di pietra del fossato come quelle di marmo furono condotte con diligenza grandissima dagli scarpellini et intagliatori per cura di Giuliano, e dopo tanto ben murate, che non è possibile vedere le più belle commettiture, e quadre tutte. Nel che fare si può Giuliano celebrare per eccellentissimo; e quest'opera, come si dirà a suo luogo, fu finita in cinque mesi, con una aggiunta, da Giorgio Vasari aretino. Giuliano intanto, non lasciando la bottega, attendeva insieme con i fratelli a fare di molte opere di quadro e d'intaglio, et a far tirare inanzi il pavimento di Santa Maria del Fiore. Nel qual luogo, perché si trovava capomaestro et architettore, fu ricerco dal medesimo Bandinello di far piante in disegno e modelli di legno sopra alcune fantasie di figure et altri ornamenti, per condurre di marmo l'altar maggiore di detta Santa Maria del Fiore. Il che Giuliano fece volentieri, come buonaria persona e da bene, e come quello che tanto si dilettava dell'architettura, quanto la spregiava il Bandinello; essendo anco a ciò tirato dalle promesse d'utili e d'onori, che esso Bandinello largamente faceva. Giuliano dunque, messo mano al detto modello, lo ridusse assai conforme a quello che già era semplicemente stato ordinato dal Brunellesco, salvo che Giuliano lo fece più ricco, radoppiando con le colonne l'arco disopra, il quale condusse a fine. Essendo poi questo modello et insieme molti disegni portato dal Bandinello al duca Cosimo, sua eccellenza illustrissima si risolvé con animo regio a fare non pure l'altare, ma ancora l'ornamento di marmo, che va intorno al coro, secondo che faceva l'ordine vecchio a otto faccie, con quegli ornamenti ricchi con i quali è stato poi condotto, conforme alla grandezza e magnificenza di quel tempio. Onde Giuliano con l'intervento del Bandinello diede principio a detto coro; senza alterar altro che l'entrata principale di quello, la qual è dirimpetto al detto altare, e la quale egli volle che fusse a punto et aves-se il medesimo arco et ornamento che il proprio altare. Fece parimente due altri archi simili, che vengono con l'entrata e l'altare a far croce; e questi per due pergami come aveva anco il vecchio, per la musica et altri bisogni del coro e dell'al-tare. Fece in questo coro Giuliano un ordine ionico attorno all'otto faccie; et in ogni angolo pose un pilastro che si ripiega la metà, et in ogni faccia uno; e perché diminuiva al punto ogni pilastro che voltava al centro, veniva di dentro strettissimo e ripiegato, e dalla banda di fuori acuto e largo. La quale invenzione non fu molto lodata, né approvata per cosa bella di chi ha giudizio, atteso che in un'opera di tanta spesa et in luogo così celebre, doveva il Bandinello, se non apprezzava egli l'architettura o non l'intendeva, servirsi di chi allora era vivo et arebbe saputo e potuto far meglio. Et in questo Giuliano merita scusa perché fece quello che seppe, che non fu poco, se bene è più che vero, che chi non ha disegno e grande invenzione da sé, sarà sempre povero di grazia, di perfezione e di giudizio ne' componimenti grandi d'architettura; fece Giuliano un lettuccio di noce per Filippo Strozzi, che è oggi a Città di Castello in casa degl'eredi del signor Alessandro Vitelli, et un molto ricco e bel fornimento a una tavola che fece Giorgio Vasari all'altare maggiore della badia di Camaldoli, in Casentino, col disegno di detto Giorgio; e nella chiesa di Santo Agostino del monte San Savino, fece un altro ornamento intagliato, per una tavola grande che fece il detto Giorgio; in Ravenna nella badia di Classi de' monaci di Camaldoli fece il medesimo Giuliano, pure a un'altra tavola di mano del Vasari, un altro bell'or-namento. Et ai monaci della Badia di Santa Fiore in Arezzo fece nel refettorio il fornimento delle pitture che vi sono di mano di detto Giorgio aretino. Nel Vescovado della medesima città, dietro all'altare maggiore, fece un coro di noce bellissimo, col disegno del detto, dove si aveva a tirare inanzi l'altare, e finalmente poco anzi che si morisse fece sopra l'al-tare maggiore della Nunziata il bello e richissimo ciborio del Santissimo Sagramento, e li due Angeli di legno, di tondo rilievo, che lo mettono in mezzo. E questa fu l'ultima opera che facesse, essendo andato a miglior vita l'anno 1555.
Né fu di minor giudizzio Domenico, fratello di detto Giuliano, perché, oltre che intagliava molto meglio di legname, fu anco molto ingegnoso nelle cose d'architettura, come si vede nella casa che fece fare col disegno di costui Bastiano da Montaguto nella via de' Servi, dove sono anco di legname molte cose di propria mano di Domenico; il quale fece per Agostino del Nero in sulla piazza de' Mozzi le cantonate, et un bellissimo terrazzo a quelle case de' Nasi già cominciate da Baccio suo padre. E se costui non fusse morto così presto, avrebbe, si crede, di gran lunga avanzato suo padre e Giuliano suo fratello.
VITE
DI VALERIO VICENTINO,
DI GIOVANNI DA CASTEL BOLOGNESE,
DI MATTEO DAL NASARO VERONESE
E D'ALTRI ECCELLENTI INTAGLIATORI DI CAMEI E GIOIE

Da che i Greci negl'intagli delle pietre orientali furono così divini, e ne' camei perfettamente lavorarono, per certo mi parrebbe fare non piccolo errore, se io passassi con silenzio coloro che quei maravigliosi ingegni hanno nell'età nostra imitato. Conciò sia che niuno è stato fra i moderni passati, secondo che si dice, che abbia passato i detti antichi di finezza e di disegno in questa presente e felice età, se non questi che qui di sotto conteremo. Ma prima che io dia principio, mi convien fare un discorso breve sopra questa arte dell'intagliar le pietre dure e le gioie, la quale doppo le rovine di Grecia e di Roma ancora loro si perderono insieme con l'altre parti del disegno.
Queste opere dello intagliare in cavo e di rilievo, se n'è visto giornalmente in Roma trovarsi spesso fra le rovine: cammei e corgniole, sardoni et altri eccellentissimi intagli, e molti e molti anni stette persa, che non si trovava chi vi attendesse; e se bene si faceva qualche cosa, non erono di maniera che se ne dovessi far conto, e per quanto se n'ha cognizione, non si trova che si cominciasse a far bene, e dar nel buono, se non nel tempo di papa Martino V e di Paolo II. Et andò crescendo di mano in mano per fino che 'l Magnifico Lorenzo de' Medici, il quale si dilettò assai degli intagli de' cammei antichi, e fra lui e Piero suo figliuolo ne ragunarono gran quantità, e massimamente calcidoni, corgniuole et altra sorte di pietre intagliate, rarissime, le quali erano con diverse fantasie dentro, che furono cagione che per metter l'arte nella loro città e' conducessino di diversi paesi maestri che, oltra al rassettar loro queste pietre, gli condussono dell'altre cose rare in quel tempo.
Imparò da questi, per mezzo del Magnifico Lorenzo, questa virtù dell'intaglio in cavo un giovane fiorentino chiamato Giovanni delle Corgniuole, il quale ebbe questo cognome perché le intagliò eccellentemente, come fa testimonio infinite che se ne veggono di suo, grandi e piccole, ma particolarmente una grande, dove egli fece dentro il ritratto di fra' Girolamo Savonarola, nel suo tempo adorato in Fiorenza per le sue predicazioni, ch'era rarissimo intaglio.
Fu suo concorrente Domenico de' Cammei, milanese che, allora vivendo il duca Lodovico il Moro, lo ritrasse in cavo in un balascio della grandezza più d'un giulio, che fu cosa rara e de' migliori intagli che si fusse visto de' maestri moderni.
Accrebbe poi in maggiore eccellenza questa arte nel pontificato di papa Leone Decimo, per la virtù et opere di Piermaria da Pescia, che fu grandissimo imitatore delle cose antiche. E gli fu concorrente Michelino, che valse non me-no di lui nelle cose piccole e grandi, e fu tenuto un grazioso maestro. Costoro apersono la via a quest'arte tanto difficile, poi che intagliando in cavo, che è proprio un lavorare al buio, da che non serve ad altro che la cera per occhiali a vedere di mano in mano quel che si fa, ridussono finalmente che Giovanni da Castel Bolognese e Valerio Vicentino e Matteo dal Nasaro et altri facessino tante bell'opere che noi faremo memoria. E per dar principio dico che Giovanni Bernardi da Castel Bolognese, il quale nella sua giovanezza, stando appresso il duca Alfonso di Ferrara, gli fece, in tre anni che vi stette onoratamente, molte cose minute, delle quali non accade far menzione; ma di cose maggiori la prima fu che egli fece, in un pezzo di cristallo incavato, tutto il fatto d'arme della Bastia, che fu bellissimo; e poi in un incavo d'ac-ciaio il ritratto di quel Duca, per far medaglie, e nel riverso Gesù Cristo preso dalle turbe. Dopo, andato a Roma, stimolato dal Giovio, per mezzo d'Ipolito cardinale de' Medici e di Giovanni Salviati cardinale, ebbe commodità di ritrarre Clemente Settimo, onde ne fece un incavo per medaglie che fu bellissimo, e nel rovescio quando Ioseffo si manifestò a' suoi fratelli. Di che fu da Sua Santità rimunerato col dono d'una mazza, che è un uffizio, del quale cavò poi al tempo di Paolo Terzo, vendendolo, dugento scudi. Al medesimo Clemente fece in quattro tondi di cristallo i quattro Evangelisti, che furono molto lodati e gl'acquistarono la grazia e l'amicizia di molti reverendissimi; ma particolarmente quella del Salviati e del detto Ippolito cardinale de' Medici, unico rifugio de' vertuosi, il quale ritrasse in medaglie d'acciaio et al quale fece di cristallo quando ad Alessandro Magno è presentata la figliuola di Dario. E dopo, venuto Carlo V a Bologna a incoronarsi, fece il suo ritratto in un acciaio; et improntata una medaglia d'oro, la portò subito all'imperatore, il quale gli donò cento doble d'oro, facendolo ricercare se voleva andar seco in Ispagna. Il che Giovanni ricusò con dire che non potea partirsi dal servizio di Clemente e d'Ippolito cardinale, per i quali avea alcuna opera cominciata, che ancora era imperfetta.
Tornato Giovanni a Roma, fece al detto cardinale de' Medici il ratto delle Sabine, che fu bellissimo; per le quali cose, conoscendosi di lui molto debitore il cardinale, gli fece infiniti doni e cortesie, ma quello fu di tutti maggiore quando, partendo il cardinale per Francia, accompagnato da molti signori e gentiluomini, si voltò a Giovanni che vi era fra gl'altri e, levatasi dal collo una piccola collana, alla quale era appiccato un cammeo che valeva oltre seicento scudi, gliele diede dicendogli che lo tenesse insino al suo ritorno, con animo di sodisfarlo poi di quanto conosceva che era degna la virtù di Giovanni. Il quale cardinale morto, venne il detto cammeo in mano del cardinal Farnese, per lo quale lavorò poi Giovanni molte cose di cristallo, e particolarmente per una croce un Crucifisso et un Dio Padre di sopra, e dagli lati la Nostra Donna, e San Giovanni, e la Maddalena a' piedi. Et in un triangolo a' piè della croce fece tre storie del-la Passione di Cristo, cioè una per angolo. E per due candelieri d'argento fece in cristallo sei tondi: nel primo è il centurione che prega Cristo che sani il figliuolo; nel secondo la probatica piscina; nel terzo la Trasfigurazione in sul monte Tabor; nel quarto è il miracolo de' cinque pani e due pesci; nel quinto quando cacciò i venditori del tempio; e nell'ulti-mo la ressurezione di Lazzaro, che tutti furono rarissimi. Volendo poi fare il medesimo cardinal Farnese una cassetta d'argento ricchissima, fattone fra l'opera a Marino orefice fiorentino, che altrove se ne ragionerà, diede a fare a Giovanni tutti i vani de' cristalli, quali gli condusse tutti pieni di storie e di marmo di mezzo rilievo; fece le figure d'argento e gli ornamenti tondi con tanta diligenza, che non fu mai fatta altra opera con tanta e simile perfezzione. Sono di mano di Giovanni nel corpo di questa cassa intagliate in ovati queste storie con arte maravigliosa, la caccia di Meleagro e del porco calidonio, le baccanti et una battaglia navale, e similmente quando Ercole combatté con l'amazzone, et altre bellissime fantasie del cardinale; ne fece fare i disegni finiti a Perino del Vaga et a altri maestri. Fece appresso in un cristallo il successo della presa della Goletta, et in un altro la guerra di Tunisi.
Al medesimo cardinale intagliò, pur in cristallo, la Nascita di Cristo, quando ora nell'orto, quando è preso da' Giudei, quando è menato ad Anna, Erode e Pilato, quando è battuto e poi coronato di spine, quando porta la croce, quando è confitto e levato in alto, et ultimamente la sua santissima e gloriosa Resurrezzione: le quali opere tutte furono non solamente bellissime, ma fatte anco con tanta prestezza, che ne restò ogni uomo maravigliato. Et avendo Michelagnolo fatto un disegno (il che mi si era scordato di sopra) al detto cardinale de' Medici, d'un Tizio a cui mangia un avoltoio il cuore, Giovanni intagliò benissimo in cristallo; sì come anco fece con un disegno del medesimo Buonarroto un Fetonte che, per non sapere guidare il carro del sole, cadé in Po, dove piangendo le sorelle sono convertite in alberi.
Ritrasse Giovanni madama Margherita d'Austria, figliuola di Carlo Quinto imperadore, stata moglie del duca Alessandro de' Medici et allora donna del duca Ottavio Farnese, e questo fece a concorrenza di Valerio Vicentino; per le quali opere fatte al cardinale Farnese, ebbe da quel signore in premio un uffizio d'un giannizzero, del quale trasse buona somma di danari; Et oltre ciò, fu dal detto signor tanto amato, che n'ebbe infiniti altri favori. Né passò mai il cardinale da Faenza, dove Giovanni aveva fabricato una commodissima casa, che non andasse ad alloggiare con esso lui.
Fermatosi dunque Giovanni in Faenza, per quietarsi dopo aver molto travagliato il mondo, vi si dimorò sempre; et essendogli morta la prima moglie, della quale non aveva avuto figliuoli, prese la seconda di cui ebbe due maschi et una femmina, con i quali, essendo agiato di possessioni e d'altre entrate, che gli rendevano meglio di quattrocento scudi, visse contento insino a sessanta anni. Alla quale età pervenuto, rendé l'anima a Dio il giorno della Pentecoste l'anno 1555.
Matteo del Nassaro, essendo nato in Verona d'un Iacopo dal Nassaro calzaiuolo, attese molto nella sua prima fanciullezza non solamente al disegno, ma alla musica ancora, nella quale fu eccellente, avendo in quella per maestri avuto Marco Carrà et il Tromboncino veronesi, che allora stavano col marchese di Mantoa. Nelle cose dell'intaglio gli furono di molto giovamento due veronesi d'onorate famiglie, con i quali ebbe continua pratica: l'uno fu Niccolò Avanzi, il qua-le lavorò in Roma privatamente cammei, corniuole et altre pietre, che furono portate a diversi principi. Et hacci di quegli che si ricordano aver veduto [in] un lapislazaro largo tre dita, di sua mano, la Natività di Cristo con molte figure, il quale fu venduto alla duchessa d'Urbino come cosa singolare. L'altro fu Galeazzo Mondella, il quale, oltre all'intagliar le gioie, disegnò benissimo. Da questi due adunque avendo Matteo tutto quello che sapevano apparato, venutogli un bel pezzo di diaspro alle mani, verde e macchiato di gocciole rosse come sono i buoni, v'intagliò dentro un Deposto di croce con tanta diligenza, che fece venire le piaghe in quelle parti del diaspro che erano macchiate di sangue; il che fece essere quell'opera rarissima, et egli commendatone molto. Il quale diaspro fu venduto da Matteo alla marchesana Isabella da Este.
Andatosene poi in Francia, dove portò seco molte cose di sua mano, perché gli facessero luogo in corte del re Francesco Primo, fu introdotto a quel signore, che sempre tenne in conto tutte le maniere de' virtuosi; il quale re, avendo preso molte delle pietre da costui intagliate, toltolo al servigio suo et ordinatogli buona provisione, non l'ebbe men caro per essere eccellente sonatore di liuto et ottimo musico, che per il mestiere dell'intagliar le pietre. E di vero niuna cosa accende maggiormente gl'animi alle virtù, che il veder quelle essere apprezzate e premiate dai principi e signori, in quella maniera che ha sempre fatto per l'adietro l'illustrissima casa de' Medici, et ora fa più che mai, e nella maniera che fece il detto re Francesco veramente magnanimo. Matteo dunque, stando al servigio di questo re, fece non pure per sua maestà molte cose rare, ma quasi a tutti i più nobili signori e baroni di quella corte, non essendovi quasi niuno che non avesse (usandosi molto allora di portare cammei et altre simili gioie al collo e nelle berette) dell'opere sue. Fece al detto re una tavola per l'altare della capella di sua maestà, che si faceva portare in viaggio, tutta piena di figure d'oro, parte tonde e parte di mezzo rilievo, con molte gioie intagliate sparse per le membra delle dette figure. Incavò parimenti molti cristalli, gl'esempi de' quali, in solfo e gesso, si veggiono in molti luoghi, ma particolarmente in Verona, dove sono tutti i pianeti bellissimi et una Venere con un Cupido che volta le spalle, il quale non può esser più bello. In un bellissimo calcidonio, stato trovato in un fiume, intagliò divinamente Matteo la testa d'una Deanira quasi tutta tonda con la spoglia del leone in testa e con la superficie lionata, et in un filo di color rosso, che era in quella pietra, accomodò Matteo nel fine della testa del lione il rovescio di quella pelle tanto bene, che pareva scorticata di fresco. In un'altra macchia accomodò i capegli, e nel bianco la faccia et il petto e tutto con mirabile magisterio. La quale testa ebbe insieme con l'altre cose il detto re Francesco. Et una impronta ne ha oggi in Verona il Zoppo orefice, che fu suo discepolo.
Fu Matteo liberalissimo e di grande animo, in tanto che più tosto arebbe donato l'opere sue, che vendutele per vilissimo prezzo; perché, avendo fatto a un barone un cammeo d'importanza e volendo colui pagarlo una miseria, lo pregò strettamente Matteo che volesse accettarlo in cortesia; ma colui, non lo volendo in dono, e pur volendolo pagare piccolissimo prezzo, venne in collora Matteo, et in presenza di lui con un martello lo stiacciò. Fece Matteo per lo medesimo re molti cartoni per panni d'arazzo, e con essi, come volle il re, bisognò che andasse in Fiandra e tanto vi dimorasse che fussono tessuti di seta e d'oro. I quali finiti e condotti in Francia, furono tenuti cosa bellissima. Finalmente, come quasi tutti gl'uomini fanno, se ne tornò Matteo alla patria portando seco molte cose rare di que' paesi, e particolarmente alcune tele di paesi fatte in Fiandra a olio et a guazzo, e lavorati da bonissime mani; le quali sono ancora per memoria di lui tenute in Verona molto care dal signor Luigi e signor Girolamo Stoppi. Tornato Matteo a Verona, si accomodò di stanza in una grotta cavata sotto un sasso, al quale è sopra il giardino de' frati Gesuati; luogo che, oltre all'esser caldissimo il verno e molto fresco la state, ha una bellissima veduta. Ma non poté godersi Matteo questa stanza fatta a suo capriccio quanto arebbe voluto: perché liberato che fu dalla sua prigionia, il re Francesco mandò subito per uno a posta a richiamar Matteo in Francia, e pagargli la provisione eziandio del tempo che era stato in Verona. E giunto là, lo fece maestro de' conii della zecca. Onde Matteo, presa moglie in Francia, s'accomodò, poiché così piacque al re suo signore, a vivere in que' paesi. Della qual moglie ebbe alcuni figliuoli, ma a lui tanto dissimili, che n'ebbe poca contentezza.
Fu Matteo così gentile e cortese, che chiunche capitava in Francia, non pure della sua patria Verona, ma lombardo, carezzava straordinariamente. Fu suo amicissimo in quelle parti Paulo Emilio Veronese, che scrisse l'istorie franzesi in lingua latina. Fece Matteo molti discepoli, e fra gl'altri un suo veronese, fratello di Domenico Brusciasorzi, due suoi nipoti, che andarono in Fiandra, et altri molti Italiani e Franzesi, de' quali non accade far menzione. E finalmente si morì non molto dopo la morte del re Francesco di Francia.
Ma per venire oramai all'eccellente virtù di Valerio Vicentino, del quale si ragionerà, egli condusse tante cose grande e piccole, d'intaglio, encavo e di rilievo, ancora con una pulitezza e facilità che è cosa da non credere; e se la natura avesse fatto così buon maestro Valerio di disegno, come ella lo fece eccellentissimo nello intaglio, e diligente e pazientissimo nel condur l'opere sue da che fu tanto e spedito, arebbe passato di gran lunga gli antichi, come gli paragonò, e con tutto ciò ebbe tanto ingegno, che si valse sempre o de' disegni da lui o degli intagli antichi nelle sue cose. Condusse Valerio a papa Clemente VII una cassetta tutta di cristalli, condotta con mirabil magisterio, che n'ebbe da quel Pontefice per sua fattura scudi duomila d'oro, dove Valerio intagliò in que' cristalli tutta la Passione di Gesù Cristo col disegno d'altri; la qual cassetta fu poi donata da papa Clemente al re Francesco a Nizza, quando andò a marito la sua nipote al duca d'Orliens, che fu poi il re Arrigo. Fece Valerio per il medesimo papa alcune paci bellissime, et una croce di cristal-lo divina, e similmente conii da improntar medaglie, dov'era il ritratto di papa Clemente con rovesci bellissimi, e fu cagione che nel tempo suo quest'arte si acrebbe di tanti maestri, che innanzi al sacco di Roma che da Milano e di altri paesi n'era cresciuto sì gran numero, che era una maraviglia.
Fece Valerio le medaglie de' dodici imperatori co' lor rovesci, cavate dallo antico, più belle, e gran numero di medaglie greche; intagliò tante altre cose di cristallo, che non si vede altro che pieno le botteghe degli orefici et il mondo che delle cose sua formate o di gesso o di zolfo o d'altre mesture da encavi, dove e' fece storie o figure o teste. Costui aveva una pratica tanto terribile che non fu mai nessuno del suo mestiero che facesse più opere di lui. Condusse ancora a papa Clemente molti vasi di cristalli quale parte donò a diversi principi e parte fur posti in Fiorenza nella chiesa di San Lorenzo insieme con molti vasi che erano in casa Medici, già del Magnifico Lorenzo Vecchio e d'altri di quella illustrissima casa, per conservare le reliquie di molti Santi, che quel pontefice donò per memoria sua a quella chiesa, che non è possibile veder la varietà de' garbi di que' vasi, che son parte di sardoni, agate, amatisti, lapislazzari e parte plasme et elitropie e diaspri, cristalli, corniuole che, per la valuta e bellezza loro, non si può desiderar più.
Fece a papa Paulo Terzo una croce e dua candellieri pur di cristallo, intagliatovi dentro storie della Passione di Gesù Cristo in varii spartimenti di quell'opera, et infinito numero di pietre piccole e grandi che troppo lungo saria il volerne far memoria. Trovasi appresso il cardinal Farnese molte cose di man di Valerio, il quale non lasciò manco cose lavorate, che facesse Giovanni sopra detto, e d'anni settantotto ha fatto con l'occhio e con le mani miracoli stupendissimi, et ha insegnato l'arte a una sua figliuola, che lavora benissimo. [Era] Valerio tanto vago di procacciare antiquità di marmi et impronte di gesso antiche e moderne, e disegni e pitture di mano di rari uomini, che non guardava a spesa niuna. Onde la sua casa in Vicenza è piena e di tante varie cose adorna, che è uno stupore, e nel vero si conosce che quando uno porta amore alla virtù, egli non resta mai infino alla fossa; onde n'ha merito e lode in vita, e si fa doppo la morte inmortale.
Fu Valerio molto premiato delle fatiche sue, et ebbe ufizii e benefizii assai da que' principi che egli servì. Onde possono quegli che sono rimasi doppo lui, mercé d'esso, mantenersi in grado onorato. Costui quando non poté più, per li fastidi che porta seco la vecchiezza, attendere all'arte, né vivere, rese l'anima a Dio l'anno 1546.
Fu ne' tempi a dietro in Parma il Marmita, il quale un tempo attese alla pittura poi si voltò allo intaglio, e fu grandissimo imitatore degli antichi. Di costui si vidde molte cose bellissime. Insegnò l'arte a un suo figliuolo chiamato Lodovico, che stette in Roma gran tempo col cardinal Giovanni de' Salviati, e fece per questo signore quattro ovati intagliati di figure nel cristallo molto eccellenti, che fur messi in una cassetta d'argento bellissima, che fu donata poi alla illustrissima signora Leonora di Tolledo, duchessa di Fiorenza. Costui fece fra molte sue opere un cammeo con una testa di Socrate molto bella, e fu gran maestro di contrafar medaglie antiche, delle quali ne cavò grandissima utilità.
Seguitò in Fiorenza Domenico di Polo fiorentino, eccellente maestro d'incavo, il quale fu discepolo di Giovanni del-le Corgnole di che s'è ragionato; il qual Domenico a' nostri giorni ritrasse divinamente il duca Alessandro de' Medici, e ne fé conii in acciaio e bellissime medaglie con un rovescio, dentrovi una Fiorenza. Ritrasse ancora il duca Cosimo il primo anno che fu eletto al governo di Fiorenza; e nel rovescio fece il segno del capricorno e molti altri intagli di cose piccole che non scade farne memoria, e morì d'età d'anni 65.
Morto Domenico, Valerio e il Marmita e Giovanni da Castel Bolognese, rimasono molti che gli hanno di gran lunga avanzati, come in Venezia Luigi Anichini ferrarese, il quale, di sottigliezza d'intaglio e di acutezza di fine, ha le sue cose fatto apparire mirabili; ma molto più ha passato innanzi a tutti in grazia, bontà et in perfezione e nell'essere universale, Alessandro Cesari, cognominato il Greco, il quale ne' cammei e nelle ruote ha fatto intagli di cavo e di rilievo con tanta bella maniera, e così in conii d'acciaio in cavo con i bulini, ha condotte le minutezze dell'arte con quella estrema diligenza, che maggior non si può imaginare, e chi vuole stupire de' miracoli suoi, miri una medaglia fatta a papa Pavo-lo Terzo del ritratto suo che par vivo, col suo rovescio, dove Alessandro Magno che, gettato a' piedi del gran sacerdote di Ierosolima, lo adora, che non figure da stupire e che non è possibile far meglio; e Michelagnolo Buonarroti stesso guardandole, presente Giorgio Vasari, disse che era venuto l'ora della morte nell'arte perciò che non si poteva veder meglio.
Costui fé per papa Iulio Terzo la sua medaglia l'anno santo 1550, con un rovescio di que' prigioni che al tempo degli antichi erano ne' lor giubilei liberati, che fu bellissima e rara medaglia, con molti altri conii e ritratti per le zecche di Roma, la quale ha tenuta esercitata molti anni. Ritrasse Pierluigi Farnese duca di Castro, il duca Ottavio suo figliuolo, et al cardinale Farnese fece in una medaglia il suo ritratto: cosa rarissima, ché la testa fu d'oro e 'l campo d'argento. Costui condusse la testa del re Arrigo di Francia per il cardinale Farnese della grandezza più d'un giulio in una corniuola, incavò d'intaglio in cavo che è stato uno de' più begli intagli moderni che si sia veduto mai, per disegno, grazia, bontà e diligenza. Vedesi ancora molti altri intagli di sua man in cammei, e perfettissima una femina ignuda fatta con grande arte, e così un altro dove è un leone e parimente un putto, e molti piccoli che non scade ragiornarne; ma quello che passò tutti, fu la testa di Fotione ateniese, che è miracolosa et il più bello cameo che si possa vedere.
Si adopera ancora oggi ne cammei Giovanantonio de' Rossi milanese, bonissimo maestro, il quale, oltra alle belle opere che ha fatto di rilievo e di cavo in varii intagli, ha per lo illustrissimo duca Cosimo de' Medici condotto un cammeo grandissimo, cioè un terzo di braccio alto e largo parimente, nel quale ha cavato dal mezzo in su due figure, cioè Sua Eccellenza e la illustrissima duchessa Leonora sua consorte, che ambidue tengano un tondo con le mani dentrovi una Fiorenza; sono apresso a questi ritratti di naturale il principe don Francesco con don Giovanni cardinale, don Garzia e don Arnando, e don Pietro insieme con donna Isabella e donna Lucrezia, tutti lor figliuoli, che non è possibile vedere la più stupenda opera di cammeo, né la maggior di quella, e perch'ella supera tutti i cammei et opere piccole che egli ha fatti, non ne farò altra menzione potendosi veder l'opere.
Cosimo, da Trezzo, ancora ha fatto molte opere degne di questa professione, il quale ha meritato, per le rare qualità sue, che il gran re Filippo Cattolico di Spagna lo tenga apresso di sé con premiallo et onorallo per le virtù sue nello intaglio in cavo e di rilievo della medesima professione, che non ha pari per far ritratti di naturale, nel quale egli vale infinitamente, e nell'altre cose.
Di Filippo Negrolo milanese, intagliatore di cesello in arme di ferro con fogliami e figure, non mi distenderò avendo operato, come si vede, in rame, cose che si veggono fuor di suo, che gli hanno dato fama grandissima. E Gasparo e Girolamo Misuroni milanesi intagliatori, di quali s'è visto vasi e tazze di cristallo bellissime, e particolarmente hanno condotti per il duca Cosimo dua che son miracolosi, oltre che ha fatto in un pezzo di elitropia un vaso di maravigliosa grandezza e di mirabile intaglio, così un vaso grande di lapislazari, che ne merita lode infinita; et Iacopo da Trezzo fa in Milano il medesimo; che nel vero hanno renduta questa arte molto bella e facile.
Molti sarebbano che io potrei raccontare, che nello intaglio di cavo per le medaglie, teste e rovesci, che hanno paragonato e passato gli antichi, come Benvenuto Cellini, che al tempo che egli esercitò l'arte dello orefice in Roma sotto papa Clemente, fece dua medaglie dove, oltra alla testa di papa Clemente che somigliò che par viva, fé in un rovescio la Pace che ha legato il Furore e bruscia l'armi, e nell'altra Moisè che, avendo percosso la pietra, ne cava l'acqua per il suo popolo assetato, che non si può far più in quell'arte così; poi nelle monete e medaglie che fece per il duca Alessandro in Fiorenza. Del cavalier Lione Aretino, che in questo fatto il medesimo, altrove se ne farà memoria e delle opere che ha fatto e che egli fa tuttavia.
Pietropavolo Galeotto romano, fece ancor lui, e fa appresso il duca Cosimo, medaglie de' suoi ritratti, e conii di monete, et opere di tarsia immitando gl'andari di maestro Salvestro, che in tale professione fece in Roma cose maravigliose, eccellentissimo maestro.
Pastorino da Siena ha fatto il medesimo nelle teste di naturale, che si può dire che abbi ritratto tutto il mondo di persone, e signori grandi e virtuosi, et altre basse genti; costui trovò uno stucco sodo da fare i ritratti che venissino coloriti a guisa de' naturali, con le tinte delle barbe, capelli e color di carni, che l'ha fatte parer vive; ma si debbe molto più lodare negli acciai, di che ha fatto conii di medaglie eccellenti. Troppo sarei lungo se io avessi di questi che fanno ritratti di medaglie di cera a ragionare, perché oggi ogni orefice fa, e gentiluomini assai vi si son dati e vi atendano, come Giovanbatista Sozini a Siena et il Rosso de' Giugni a Fiorenza et infiniti altri, che non vo' ora più ragionare, e, per dar fine a questi, tornerò agli intagliatori di acciaio, come Girolamo Fagiuoli bolognese, intagliatore di cesello e di rame, et in Fiorenza Domenico Poggini, che ha fatto e fa conii per la zecca con le medaglie del duca Cosimo, e lavora di marmo statue, imitando in quel che può i più rari et eccellenti uomini che abbin fatto mai cose rare in queste professioni.
VITA DI MARCANTONIO BOLOGNESE
E D'ALTRI INTAGLIATORI DI STAMPE

Perché nelle teoriche della pittura si ragionò poco delle stampe di rame, bastando per allora mostrare il modo del-l'intagliar l'argento col bulino - che è un ferro quadro tagliato a sghembo e che ha il taglio sottile - se ne dirà ora, con l'occasione di questa vita, quanto giudicheremo dovere essere a bastanza. Il principio dunque dell'intagliare le stampe venne da Maso Finiguerra fiorentino, circa gl'anni di nostra salute 1460, perché costui tutte le cose che intagliò in argento, per empierle di niello, le improntò con terra, e gittatovi sopra solfo liquifatto, vennero improntate e ripiene di fumo; onde a olio mostravano il medesimo che l'argento. E ciò fece ancora con carta umida e con la medesima tinta aggravandosi sopra con un rullo tondo, ma piano per tutto. Il che non solo le faceva apparire stampate, ma venivano come disegnate di penna. Fu seguitato costui da Baccio Baldini orefice fiorentino, il quale non avendo molto disegno, tutto quello che fece fu con invenzione e disegno di Sandro Botticello. Questa cosa venuta a notizia d'Andrea Mantegna in Roma, fu cagione che egli diede principio a intagliare molte sue opere, come si disse nella sua vita.
Passata poi questa invenzione in Fiandra, un Martino, che allora era tenuto in Anversa eccellente pittore, fece molte cose e mandò in Italia gran numero di disegni stampati, i quali tutti erano contrasegnati in questo modo: M C. Et i primi furono le cinque vergini stolte con le lampade spente e le cinque prudenti con le lampade accese, et un Cristo in croce con San Giovanni e la Madonna a' piedi; il quale fu tanto buono intaglio, che Gherardo miniatore fiorentino si mise a contrafarlo di bulino, e gli riuscì benissimo. Ma non seguitò più oltre, perché non visse molto. Dopo mandò fuora Mar-tino in quattro tondi i quattro Evangelisti, et in carte piccole Gesù Cristo con i dodici Apostoli, e Veronica con sei Santi della medesima grandezza, et alcune arme di signori tedeschi sostenute da uomini nudi e vestiti e da donne; mandò fuori similmente un San Giorgio che amazza il serpente, un Cristo che sta innanzi a Pilato mentre si lava le mani, et un transito di Nostra Donna assai grande, dove sono tutti gl'Apostoli. E questa fu delle maggiori carte che mai intagliasse costui. In un'altra fece Santo Antonio battuto dai diavoli e portato in aria da una infinità di loro in le più varie bizzarre forme che si possino imaginare, la quale carta tanto piacque a Michelagnolo, essendo giovinetto, che si mise a colorirla.
Dopo questo Martino, cominciò Alberto Duro in Anversa, con più disegno e miglior giudizio, e con più belle invenzioni, a dare opera alle medesime stampe, cercando d'imitar il vivo e d'accostarsi alle maniere italiane, le quali egli sempre apprezzò assai. E così, essendo giovanetto, fece molte cose che furono tenute belle quanto quelle di Martino, e le intagliava di sua man propria, segnandole col suo nome. E l'anno 1503 mandò fuori una Nostra Donna piccola, nella quale superò Martino e se stesso; et appresso, in molte altre carte, cavalli, a due cavalli per carta, ritratti dal naturale e bellissimi; et in un'altra il figliuol prodigo, il quale, stando a uso di villano ginocchioni con la mani incrocicchiate, guarda il cielo, mentre certi porci mangiano in un trogolo: et in questa sono capanne a uso di ville tedesche, bellissime. Fece un San Bastiano piccolo, legato con le braccia in alto, et una Nostra Donna che siede col Figliuolo in collo, et un lume di finestre gli dà addosso, che per cosa piccola non si può vedere meglio. Fece una femina alla fiaminga a cavallo con uno staffiere a' piedi. Et in un rame maggiore intagliò una ninfa portata via da un mostro marino, mentre alcun'altre ninfe si bagnano. Della medesima grandezza intagliò con sottilissimo magisterio, trovando la perfezzione et il fine di quest'arte, una Diana che bastona una ninfa, la quale si è messa per essere difesa in grembo a un satiro; nella quale carta volle Alberto mostrare che sapeva fare gl'ignudi.
Ma ancora che questi maestri fussero allora in que' paesi lodati, ne' nostri le cose loro sono per la diligenza solo del-l'intaglio, l'opere loro comendate. E voglio credere che Alberto non potesse per aventura far meglio, come quello che non avendo commodità d'altri, ritraeva, quando aveva a fare ignudi, alcuno de' suoi garzoni, che dovevano avere, come hanno per lo più i Tedeschi, cattivo ignudo, se bene vestiti si veggiono molti begl'uomini di que' paesi.
Fece molti abiti diversi alla fiaminga in diverse carte stampate piccole, di villane e villani, che suonano la cornamusa e ballano, alcuni che vendono polli et altre cose, e d'altre maniere assai. Fece uno che dormendo in una stufa ha in-torno Venere che l'induce a tentazione in sogno, mentre che Amore, salendo sopra due zanche, si trastulla, et il diavolo con un soffione, o vero mantice, lo gonfia per l'orecchie. Intagliò anco due San Cristofani diversi, che portano Cristo fanciullo, bellissimi e condotti con molta diligenza ne' capegli sfilati, et in tutte l'altre [parti]. Dopo le quali opere, vedendo con quanta larghezza di tempo intagliava in rame, e trovandosi avere gran copia d'invenzioni diversamente disegnate, si mise a intagliare in legno. Nel qual modo di fare coloro che hanno maggior disegno hanno più largo campo da poter mostrare la loro perfezzione. E di questa maniera mandò fuori l'anno 1510 due stampe piccole: in una delle quali è la decollazione di San Giovanni, e nell'altra quando la testa del medesimo è presentata in un bacino a Erode, che siede a mensa, et in altre carte San Cristofano, San Sisto papa, Santo Stefano e San Lorenzo. Per che, veduto questo modo di fare essere molto più facile che l'intagliare in rame, seguitandolo, fece un San Gregorio che canta la messa, accompagnato dal diacono e sodiacono. E cresciutogli l'animo, fece in un foglio reale l'anno 1510 parte della Passione di Cristo, cioè ne condusse, con animo di fare il rimanente, quattro pezzi: la cena, l'esser preso di notte nell'orto, quando va al limbo a trarne i Santi Padri, e la sua gloriosa Resurrezione. E la detta seconda parte fece anco in un quadretto a olio molto bello, che è oggi in Firenze appresso al signor Bernardetto de' Medici. E se bene sono poi state fatte l'altre otto parti, che furono stampate col segno d'Alberto, a noi non pare verisimile che sieno opera di lui, atteso che sono mala cosa e non somigliano né le teste, né i panni, né altra cosa la sua maniera. Onde si crede che siano state fatte da altri dopo la morte sua per guadagnare, senza curarsi di dar questo carico ad Alberto. E che ciò sia vero, l'anno 1511 egli fece della medesima grandezza in venti carte tutta la vita di Nostra Donna tanto bene, che non è possibile, per invenzione, componimenti di prospettiva, casamenti, abiti e teste di vecchi e giovani, far meglio. E nel vero, se quest'uomo sì raro, sì diligente e sì universale avesse avuto per patria la Toscana, come egli ebbe la Fiandra, et avesse potuto studiare le cose di Roma, come abbiam fatto noi, sarebbe stato il miglior pittore de' paesi nostri, sì come fu il più raro e più celebrato che abbiano mai avuto i Fiaminghi.
L'anno medesimo, seguitando di sfogare i suoi capricci, cercò Alberto di fare della medesima grandezza quindici forme intagliate in legno della terribile visione che San Giovanni Evangelista scrisse nell'isola di Patmos nel suo Apocalisse. E così, messo mano all'opera con quella sua imaginativa stravagante, e molto a proposito a cotal suggetto, figurò tutte quelle cose, così celesti come terrene, tanto bene, che fu una maraviglia. E con tanta varietà di fare in quegli animali e mostri, che fu gran lume a molti de' nostri artefici, che si son serviti poi dell'abondanza e copia delle belle fantasie et invenzioni di costui. Vedesi ancora di mano del medesimo in legno un Cristo ignudo, che ha intorno i misterii della sua Passione, e piange con le mani al viso i peccati nostri, che per cosa piccola non è se non lodevole. Dopo, cresciuto Alberto in facultà et in animo, vedendo le sue cose essere in pregio, fece in rame alcune carte, che feciono stupire il mondo. Si mise anco ad intagliare, per una carta d'un mezzo foglio, la Malinconia con tutti gl'instrumenti che riducono l'uomo, e chiunche gl'adopera, a essere malinconico; e la ridusse tanto bene, che non è possibile col bulino intagliare più sottilmente. Fece in carte piccole tre Nostre Donne variate l'una dall'altre, e d'un sottilissimo intaglio. Ma troppo sarei lungo, se io volessi tutte l'opere raccontare che uscirono di mano ad Alberto. Per ora basti sapere che, a-vendo disegnato per una passione di Cristo trentasei pezzi, e poi intagliatigli, si convenne con Marcantonio bolognese di mandar fuori insieme queste carte. E così capitando in Vinezia, fu quest'opera cagione che si sono poi fatte in Italia cose maravigliose in queste stampe, come di sotto si dirà.
Mentre che in Bologna Francesco Francia attendeva alla pittura fra molti suoi discepoli, fu tirato innanzi, come più ingegnoso degl'altri, un giovane chiamato Marcantonio, il quale, per essere stato molti anni col Francia e da lui molto amato, s'acquistò il cognome de' Franci. Costui dunque, il quale aveva miglior disegno che il suo maestro, maneggiando il bulino con facilità e con grazia, fece, perché allora erano molto in uso, cinture et altre molte cose niellate, che furono bellissime, perciò che era in quel mestiero veramente eccellentissimo.
Venutogli poi disiderio, come a molti aviene, d'andare pel mondo a vedere diverse cose et i modi di fare degl'altri artefici, con buona grazia del Francia se n'andò a Vinezia, dove ebbe buon ricapito fra gl'artefici di quella città. Intanto capitando in Vinezia alcuni fiaminghi con molte carte intagliate e stampate in legno et in rame da Alberto Duro, vennero vedute a Marcantonio in sulla piazza di San Marco. Per che, stupefatto della maniera del lavoro e del modo di fare d'Alberto, spese in dette carte quasi quanti danari aveva portati da Bologna, e fra l'altre cose comperò la Passione di Gesù Cristo intagliata in trentasei pezzi di legno in quarto foglio, stata stampata di poco dal detto Alberto. La quale opera cominciava dal peccare d'Adamo, et essere cacciato di Paradiso dall'Angelo, infino al mandare dello Spirito Santo. E considerato Marcantonio quanto onore et utile si avrebbe potuto acquistare chi si fusse dato a quell'arte in Italia, si dispose di volervi attendere con ogni accuratezza e diligenza; e così cominciò a contrafare di quegli intagli d'Alberto, studiando il modo de' tratti et il tutto delle stampe che avea comperate: le qual per la novità e bellezza loro, erano in tanta riputazzione, che ognuno cercava d'averne. Avendo dunque contrafatto in rame d'intaglio grosso, come era il legno che aveva intagliato Alberto, tutta la detta Passione e vita di Cristo in trentasei carte, e fattovi il segno che Alberto faceva nelle sue opere, cioè questo: AE, riuscì tanto simile di maniera che, non sapendo nessuno ch'elle fussero fatte da Marcantonio, erano credute d'Alberto, e per opere di lui vendute e comperate. La qual cosa, essendo scritta in Fiandra ad Alberto, e mandatogli una di dette passioni contrafatte da Marcantonio, venne Alberto in tanta collora che, partitosi di Fiandra, se ne venne a Vinezia e, ricorso alla Signoria, si querelò di Marcantonio. Ma però non ottenne altro se non che Marcantonio non facesse più il nome e né il segno sopradetto d'Alberto nelle sue opere.
Dopo le quali cose, andatosene Marcantonio a Roma, si diede tutto al disegno. Et Alberto tornato in Fiandra, trovò un altro emulo che già aveva cominciato a fare di molti intagli sottilissimi a sua concorrenza: e questi fu Luca d'Olanda, il quale, se bene non aveva tanto disegno quanto Alberto, in molte cose nondimeno lo paragonava col bulino. Fra le molte cose che costui fece, e grandi e belle, furono le prime, l'anno 1509, due tondi: in uno de' quali Cristo porta la croce, e nell'altro è la sua Crucifissione. Dopo mandò fuori un Sansone, un Davit a cavallo et un San Pietro martire con i suoi percussori. Fece poi in una carta in rame un Saul a sedere e Davit giovinetto che gli suona intorno. Né molto dopo, avendo acquistato assai, fece in un grandissimo quadro di sottilissimo intaglio, Virgilio spenzolato dalla finestra nel cestone, con alcune teste e figure tanto maravigliose, che elle furono cagione che, assottigliando Alberto per questa concorrenza l'ingegno, mandasse fuori alcune carte stampate tanto eccellenti, che non si può far meglio. Nelle quali volendo mostrare quanto sapeva, fece un uomo armato a cavallo, per la fortezza umana, tanto ben finito, che vi si vede il lustrare dell'arme e del pelo d'un cavallo nero; il che fare è difficile in disegno. Aveva questo uomo forse la morte vicina, il tempo in mano et il diavolo dietro. Evvi similmente un can peloso, fatto con le più difficili sottigliezze che si possino fare nell'intaglio.
L'anno 1512 uscirono fuori di mano del medesimo sedici storie piccole in rame della Passione di Gesù Cristo, tanto ben fatte, che non si possono vedere le più belle, dolci e graziose figurine, né che abbiano maggior rilievo. Da questa medesima concorrenza mosso il detto Luca d'Olanda, fece dodici pezzi simili e molti begli, ma non già così perfetti nel-l'intaglio e nel disegno. Et oltre a questi, un S. Giorgio, il quale conforta la fanciulla che piagne per aver a essere dal serpente devorata, un Salamone che adora gli idoli, il Battesimo di Cristo, Piramo e Tisbe, Asuero e la regina Ester ginocchioni. Dall'altro canto Alberto, non volendo essere da Luca superato, né in quantità né in bontà d'opere, intagliò una figura nuda sopra certe nuvole, e la Temperanza con certe ale mirabili, con una coppa d'oro in mano, et una briglia, et un paese minutissimo; et appresso un Santo Eustachio inginocchiato dianzi al cervio che ha il Crucifisso fra le corna: la quale carta è mirabile, e massimamente per la bellezza d'alcuni cani in varie attitudini, che non possono essere più belli. E fra i molti putti che egli fece in diverse maniere per ornamenti d'armi e d'imprese, ne fece alcuni che tengono uno scudo, dentro al quale è una morte con un gallo per cimieri, le cui penne sono in modo sfilate, che non è possibile fare col bulino cosa di maggior finezza. Et ultimamente mandò fuori la carta del San Ieronimo che scrive et è in abito di cardinale, col lione a' piedi che dorme; et in questa finse Alberto una stanza con finestre di vetri, nella quale, percotendo il sole, ribatte i razzi là dove il Santo scrive, tanto vivamente, che è una maraviglia; oltre che vi sono libri, oriuoli, scritture e tante altre cose, che non si può in questa professione far più, né meglio. Fece poco dopo, e fu quasi dell'ulti-me cose sue, un Cristo con i dodici Apostoli, piccoli, l'anno 1523. Si veggiono anco di suo molte teste di ritratti naturali in istampa, come Erasmo Roterodamo, il cardinale Alberto di Brandinburgo elettore dell'imperio, e similmente quello di lui stesso. Né con tutto che intagliasse assai, abbandonò mai la pittura, anzi di continuo fece tavole, tele et altre dipinture tutte rare, e, che è più, lasciò molti scritti di cose attinenti all'intaglio, alla pittura, alla prospettiva et all'architet-tura. Ma per tornare agl'intagli delle stampe, l'opere di costui furono cagione che Luca d'Olanda seguitò quanto poté le vestigia d'Alberto. E dopo le cose dette, fece quattro storie intagliate in rame de' fatti di Ioseffo, i quattro Evangelisti, i tre Angeli che apparvero ad Abraam nella valle Mambrè, Susanna nel bagno, Davit che ora, Mardocheo che triomfa a cavallo, Lotto innebbriato dalle figliuole, la creazzione d'Adamo e d'Eva, il comandar loro Dio che non mangino del pomo d'un alberto che Egli mostra, Caino che amazza Abel suo fratello: le quali tutte carte uscirono fuori l'anno 1529.
Ma quello che più che altro diede nome e fama a Luca, fu una carta grande, nella quale fece la Crucifissione di Gesù Cristo, et un'altra dove Pilato lo mostra al popolo dicendo: “Ecce homo”. Le quali carte, che sono grandi e con gran numero di figure, sono tenute rare; sì come è anco una conversione di San Paolo e l'essere menato così cieco in Damasco. E queste opere bastino a mostrare che Luca si può fra coloro annoverare che con eccellenza hanno maneggiato il bulino. Sono le composizioni delle storie di Luca molto proprie e fatte con tanta chiarezza, et in modo senza confusione, che par proprio che il fatto che egli esprime non dovesse essere altrimenti: e sono più osservate, secondo l'ordine dell'arte, che quelle d'Alberto. Oltre ciò, si vede che egli usò una discrezione ingegnosa nell'intagliare le sue cose; conciò sia che tutte l'opere, che di mano in mano si vanno allontanando, sono manco tocche, perché elle si perdono di veduta, come si perdono dall'occhio le naturali, che vede da lontano; e però le fece con queste considerazzioni, e sfumate e tanto dolci, che col colore non si farebbe altrimenti; le quali avertenze hanno aperto gl'occhi a molti pittori. Fece il medesimo molte stampe piccole, diverse Nostre Donne, i dodici Apostoli con Cristo, e molti Santi e Sante, et arme e cimieri et altre cose simili. Et è molto bello un villano che, facendosi cavare un dente, sente sì gran dolore, che non s'accorge che intanto una donna gli vota la borsa: le quali tutte opere d'Alberto e di Luca sono state cagione che, dopo loro, molti altri fiaminghi e tedeschi hanno stampato opere simili bellissime.
Ma tornando a Marcantonio, arivato in Roma, intagliò in rame una bellissima carta di Raffaello da Urbino, nella quale era una Lucrezia romana che si uccideva, con tanta diligenza e bella maniera, che essendo subito portata da alcuni amici suoi a Raffaello, egli si dispose a mettere fuori in istampa alcuni disegni di cose sue, et appresso un disegno, che già avea fatto, del giudizio di Paris, nel quale Raffaello per capriccio aveva disegnato il carro del sole, le ninfe de' boschi, quelle delle fonti e quelle de' fiumi, con vasi, timoni et altre belle fantasie attorno. E così risoluto furono di maniera intagliate da Marcantonio, che ne stupì tutta Roma. Dopo queste fu intagliata la carta degl'innocenti con bellissimi nudi, femine e putti, che fu cosa rara; et il Nettuno con istorie piccole d'Enea intorno, il bellissimo ratto d'Elena, pur disegnato da Raffaello, et un'altra carta dove si vede morire Santa Felicita bollendo nell'olio, et i figliuoli essere decapitati. Le quali opere acquistarono a Marcantonio tanta fama, che erano molto più stimate le cose sue, pel buon disegno, che le fiaminghe; e ne facevano i mercanti bonissimo guadagno.
Aveva Raffaello tenuto molt'anni a macinar colori un garzone chiamato il Baviera e, perché sapea pur qualche cosa, ordinò che Marcantonio intagliasse et il Baviera attendesse a stampare, per così finire, tutte le storie sue, vendendole, et ingrosso et a minuto, a chiunche ne volesse. E così messo mano all'opera stamparono una infinità di cose, che gli furo-no di grandissimo guadagno. E tutte le carte furono da Marcantonio segnate con questi segni, per lo nome di Raffaello Sanzio da Urbino, SR; e per quello di Marcantonio MF. L'opere furono queste: una Venere, che amore l'abbraccia, disegnata da Raffaello; una storia, nella quale Dio Padre benedisce il seme ad Abraam, dove è l'ancilla con due putti; appresso furono intagliati tutti i tondi che Raffaello aveva fatto nelle camere del palazzo papale, dove fa la Cognizione delle cose: Caliope col suono in mano; la Providenza e la Iustizia; dopo in un disegno piccolo la storia che dipinse Raffaello nella medesima camera del monte Parnaso con Appollo, le muse e' poeti; et appresso Enea che porta in collo Anchise mentre che arde Troia, il quale disegno avea fatto Raffaello per farne un quadretto. Messero dopo questo in stampa la Galatea, pur di Raffaello, sopra un carro tirato in mare dai dalfini, con alcuni tritoni che rapiscano una ninfa. E queste finite, fece pure in rame molte figure spezzate, disegnate similmente da Raffaello: un Apollo con un suono in mano; una Pace alla quale porge amore un ramo d'ulivo; le tre virtù teologiche e le quattro morali. E della medesima grandezza un Iesù Cristo con i dodici Apostoli. Et in un mezzo foglio la Nostra Donna che Raffaello aveva dipinta nella tavola d'Araceli; e parimente quella che andò a Napoli in San Domenico, con la Nostra Donna, San Ieronimo e l'angelo Raffaello con Tobia. Et in una carta piccola, una Nostra Donna che abbraccia, sedendo sopra una seggiola, Cristo fanciulletto, mezzo vestito. E così molte altre Madonne ritratte dai quadri che Raffaello aveva fatto di pittura a diversi.
Intagliò dopo queste un San Giovanni Battista giovinetto a sedere nel diserto, et appresso la tavola, che Raffaello fece per San Giovanni in Monte, della Santa Cecilia, con altri Santi, che fu tenuta bellissima carta. Et avendo Raffaello fatto, per la capella del papa, tutti i cartoni dei panni d'arazzo, che furono poi tessuti di seta e d'oro, con istorie di San Piero, S. Paulo e S. Stefano, Marcantonio intagliò la predicazzione di San Paulo, la lapidazione di Santo Stefano, et il rendere il lume al cieco. Le quali stampe furono tanto belle per l'invenzione di Raffaello, per la grazia del disegno, e per la diligenza et intaglio di Marcantonio, che non era possibile veder meglio. Intagliò appresso un bellissimo Deposto di croce, con invenzione dello stesso Raffaello, con una Nostra Donna svenuta, che è maravigliosa. E non molto dopo, la tavola di Raffaello, che andò a Palermo, d'un Cristo che porta la croce, che è una stampa molto bella. Et un disegno, che Raffaello avea fatto, d'un Cristo in aria, con la Nostra Donna, S. Giovanni Battista e Santa Caterina in terra ginocchioni, e S. Paulo apostolo ritto, la quale fu una grande e bellissima stampa. E questa, sì come l'altre, essendo già quasi consumate per troppo essere state adoperate, andarono male, e furono portate via dai tedeschi et altri nel sacco di Roma. Il medesimo intagliò in profilo il ritratto di papa Clemente VII, a uso di medaglia col volto raso; e dopo, Carlo V imperatore, che allora era giovane, e poi un'altra volta, di più età. E similmente Ferdinando re de' Romani, che poi sucedette nell'imperio al detto Carlo v. Ritrasse anche in Roma di naturale Messer Pietro Aretino, poeta famosissimo, il quale ritratto fu il più bello che mai Marcantonio facesse. E non molto dopo i dodici imperadori antichi in medaglie. Delle quali carte mandò alcune Raffaello in Fiandra ad Alberto Duro, il quale lodò molto Marcantonio, et all'incontro mandò a Raffaello, oltre molte altre carte, il suo ritratto, che fu tenuto bello affatto.
Cresciuta dunque la fama di Marcantonio, e venuta in pregio e riputazione la cosa delle stampe, molti si erano acconci con esso lui per imparare. Ma tra gl'altri fecero gran profitto Marco da Ravenna, che segnò le sue stampe col segno di Raffaello: SR; et Agostino Viniziano, che segnò le sue opere in questa maniera: AV; i quali due misero in stampa molti disegni di Raffaello, cioè una Nostra Donna con Cristo morto a giacere e disteso; et a' piedi San Giovanni, la Madalena, Niccodemo e l'altre Marie. E di maggior grandezza intagliarono un'altra carta, dove è la Nostra Donna con le braccia aperte e con gl'occhi rivolti al cielo in atto pietosissimo, e Cristo similmente disteso e morto. Fece poi Agostino in una carta grande una Natività con i pastori et Angeli, e Dio Padre sopra; et intorno alla capanna fece molti vasi così antichi come moderni. E così un profumiere: cioè due femine con un vaso in capo traforato. Intagliò una carta d'uno converso in lupo, il quale va ad un letto per ammazzare uno che dorme. Fece ancora Alessandro con Rosana, a cui egli presenta una corona reale, mentre alcuni amori le volano intorno e le acconciano il capo; et altri si trastullano con l'armi di esso Alessandro. Intagliarono i medesimi la cena di Cristo con i dodici Apostoli, in una carta assai grande, et una Nunziata: tutti con disegno di Raffaello; e dopo, due storie delle nozze di Psiche, state dipinte da Raffaello non molto inanzi. E finalmente fra Agostino e Marco sopra detto furono intagliate quasi tutte le cose che disegnò mai, o dipinse Raffaello, e poste in istampa. E molte ancora delle cose state dipinte da Giulio Romano, e poi ritratte da quelle. E perché delle cose del detto Raffaello quasi niuna ne rimanesse, che stampata non fusse da loro, intagliarono in ultimo le storie che esso Giulio avea dipinto nelle logge col disegno di Raffaello.
Veggionsi ancora alcune delle prime carte col segno M. R., cioè Marco Ravignano, et altre col segno A. V., cioè Agostino Viniziano, essere state rintagliate sopra le loro da altri, come la creazione del mondo, e quando Dio fa gl'ani-mali, il sacrificio di Caino e di Abel, e la sua morte, Abraam che sacrifica Isac, l'arca di Noè et il diluvio, e quando poi n'escono gl'animali; il passare del mare Rosso, la tradozzione della legge dal monte Sinai per Moisè, la manna, David che amazza Golia, già stato intagliato da Marcantonio, Salamone che edifica il tempio, il giudizzio delle femmine del medesimo, la visita della reina Saba; e del Testamento Nuovo la Natività, la Ressurezzione di Cristo, e la missione del-lo Spirito Santo. E tutte queste furono stampate vivente Raffaello. Dopo la morte del quale, essendosi Marco et Agostino divisi, Agostino fu trattenuto da Baccio Bandinelli scultore fiorentino, che gli fece intagliare col suo disegno una notomia, che avea fatta d'ignudi secchi e d'ossame di morti, et appresso una Cleopatra, che amendue furono tenute molto buone carte; per che, cresciutogli l'animo, disegnò Baccio, e fece intagliare, una carta grande, delle maggiori che ancora fussero state intagliate infino allora, piena di femmine vestite e di nudi, che amazzano, per comandamento d'Ero-de, i piccoli fanciulli innocenti.
Marcantonio intanto, seguitando d'intagliare, fece in alcune carte i dodici Apostoli, piccoli, in diverse maniere, e molti Santi e Sante, acciò i poveri pittori, che non hanno molto disegno, se ne potessero ne' loro bisogni servire. Intagliò anco un nudo, che ha un lione a' piedi e vuole fermare una bandiera grande, gonfiata dal vento, che è contrario al volere del giovane; un altro che porta una basa addosso; et un San Ieronimo, piccolo, che considera la morte mettendo un dito nel cavo d'un teschio che ha in mano, il che fu invenzione e disegno di Raffaello; e dopo, una Iustizia, la quale ritrasse dai panni di capella; et appresso l'Aurora tirata da due cavalli, ai quali l'Ore mettono la briglia. E dall'antico ritrasse le tre Grazie, et una storia di Nostra Donna che saglie i gradi del tempio.
Dopo queste cose, Giulio Romano, il quale, vivente Raffaello suo maestro, non volle mai per modestia far alcuna delle sue cose stampare, per non parere di volere competere con esso lui, fece, dopo che egli fu morto, intagliare a Marcantonio due battaglie di cavalli bellissime in carte assai grandi, e tutte le storie di Venere, d'Apollo e di Iacinto, che egli avea fatto di pittura nella stufa che è alla vigna di Messer Baldassarre Turrini da Pescia. E parimente le quattro storie della Madalena, et i quattro Evangelisti, che sono nella volta della capella della Trinità, fatte per una meretrice, ancor che oggi sia di Messer Agnolo Massimi. Fu ritratto ancora, e messo in istampa dal medesimo, un bellissimo pilo antico, che fu di Maiano et è oggi nel cortile di San Pietro, nel quale è una caccia d'un Lione; e dopo una delle storie di marmo, antiche, che sono sotto l'arco di Gostantino, e finalmente molte storie, che Raffaello aveva disegnate per il corridore e logge di palazzo; le quali sono state poi rintagliate da Tommaso Barlacchi insieme con le storie de' panni, che Raffaello fece pel concistoro publico. Fece dopo queste cose Giulio Romano in venti fogli intagliare da Marcantonio, in quanti diversi modi, attitudini e positure giacciono i disonesti uomini con le donne, e, che fu peggio, a ciascun modo fece Messer Pietro Aretino un disonestissimo sonetto, in tanto che io non so qual fusse più, o brutto lo spettacolo dei disegni di Giulio all'occhio, o le parole dell'Aretino agl'orecchi; la quale opera fu da papa Clemente molto biasimata. E se quanto ella fu pubblicata Giulio non fusse già partito per Mantoa, ne sarebbe stato dallo sdegno del papa aspramente castigato. E poi che ne furono trovati di questi disegni in luoghi dove meno si sarebbe pensato, furono non solamente proibiti, ma preso Marcantonio e messo in prigione. E n'arebbe avuto il malanno, se il cardinale de' Medici e Baccio Bandinelli, che in Roma serviva il Papa, non l'avessono scampato. E nel vero non si doverebbono i doni di Dio adoperare, come molte volte si fa, in vituperio del mondo et in cose abominevoli del tutto.
Marcantonio, uscito di prigione, finì d'intagliare per esso Baccio Bandinelli una carta grande, che già aveva cominciata, tutta piena d'ignudi, che arostivano in sulla graticola San Lorenzo, la quale fu tenuta veramente bella e stata intagliata con incredibile diligenza, ancor che il Bandinello, dolendosi col Papa a torto di Marcantonio, dicesse, mentre Marcantonio l'intagliava, che gli faceva molti errori. Ma ne riportò il Bandinello di questa così fatta gratitudine quel merito, di che la sua poca cortesia era degna. Perciò che, avendo finita Marcantonio la carta, prima che Baccio lo sapesse, andò, essendo del tutto avisato, al Papa, che infinitamente si dilettava delle cose del disegno, e gli mostrò l'originale, stato disegnato dal Bandinello, e poi la carta stampata, onde il Papa conobbe che Marcantonio con molto giudizio avea non solo non fatto errori, ma correttone molti fatti dal Bandinello, e di non piccola importanza, e che più avea saputo et operato egli coll'intaglio, che Baccio col disegno. E così il Papa lo commendò molto, e lo vide poi sempre volentieri; e si crede gl'averebbe fatto del bene, ma succedendo il sacco di Roma, divenne Marcantonio poco meno che mendico, perché oltre al perdere ogni cosa, se volle uscire delle mani degli Spagnuoli gli bisognò sborsare una buona taglia; il che fatto, si partì di Roma, né vi tornò mai più. Là dove poche cose si veggiono fatte da lui da quel tempo in qua. È molto l'arte nostra obligata a Marcantonio, per avere egli in Italia dato principio alle stampe, con molto giovamento et utile dell'arte, e commodo di tutti i virtuosi; onde altri hanno poi fatte l'opere che di sotto si diranno.
Agostino Viniziano adunque, del quale si è di sopra ragionato, venne dopo le cose dette a Fiorenza, con animo d'ac-costarsi ad Andrea del Sarto, il quale dopo Raffaello era tenuto de' migliori dipintori d'Italia. E così da costui persuaso Andrea a mettere in istampa l'opere sue, disegnò un Cristo morto sostenuto da tre Angeli. Ma perché ad Andrea non riuscì la cosa, così a punto secondo la fantasia sua, non volle mai più mettere alcuna sua opera in istampa. Ma alcuni, dopo la morte sua, hanno mandato fuori la visitazione di Santa Elisabetta, e quando San Giovanni battezza alcuni popoli, tolti dalla storia di chiaro scuro che esso Andrea dipinse nello Scalzo di Firenze. Marco da Ravenna parimente, oltre le cose che si sono dette, le quali lavorò in compagnia d'Agostino, fece molte cose da per sé, che si conoscono al suo già detto segno, e sono tutte e buone e lodevoli.
Molti altri ancora sono stati dopo costoro che hanno benissimo lavorato d'intagli e fatto sì che ogni provincia ha potuto godere e vedere l'onorate fatiche degl'uomini eccellenti. Né è mancato a chi sia bastato l'animo di fare con le stampe di legno carte che paiono fatte col pennello a guisa di chiaro scuro, il che è stato cosa ingegnosa e difficile. E questi fu Ugo da Carpi, il quale, se bene fu mediocre pittore, fu nondimeno in altre fantasticherie d'acutissimo ingegno. Costui dico, come si è detto nelle teoriche al trentesimo capitolo, fu quegli che primo si provò, e gli riuscì felicemente, a fare con due stampe, una delle quali a uso di rame gli serviva a tratteggiare l'ombre, e con l'altra faceva la tinta del colore: per che, graffiata in dentro con l'intaglio, lasciava i lumi della carta in modo bianchi, che pareva, quando era stampata, lumeggiata di biacca. Condusse Ugo in questa maniera con un disegno di Raffaello, fatto di chiaro scuro, una carta nella quale è una Sibilla a sedere che legge et un fanciullo vestito che gli fa lume con una torcia. La qual cosa essendogli riuscita, prese animo, tentò Ugo di far carte con stampe di legno di tre tinte. La prima faceva l'ombra, l'altra, che era una tinta di colore più dolce, faceva un mezzo, e la terza, graffiata, faceva la tinta del campo più chiara et i lumi della carta bianchi; e gli riuscì in modo anco questa, che condusse una carta dove Enea porta addosso Anchise, mentre che arde Troia. Fece appresso un Deposto di croce e la storia di Simon Mago, che già fece Raffaello nei panni d'arazzo della già detta capella. E similmente Davitte che amazza Golia, e la fuga de' Filistei, di che avea fatto Raffaello il disegno per dipignerla nelle logge papali. E dopo molte altre cose di chiaro scuro, fece nel medesimo modo una Venere con molti amori che scherzano. E perché, come ho detto, fu costui dipintore, non tacerò che egli dipinse a olio senza adoperare pennello ma con le dita, e parte con suoi altri instrumenti capricciosi, una tavola che è in Roma all'altare del Volto Santo; la quale tavola, essendo io una mattina con Michelagnolo a udir messa al detto altare, e veggendo in essa scritto che l'aveva fatta Ugo da Carpi senza pennello, mostrai ridendo cotale inscrizione a Michelagnolo, il quale, ridendo an-ch'esso, rispose: “Sarebbe meglio che avesse adoperato il pennello e l'avesse fatta di miglior maniera”.
Il modo adunque di fare le stampe in legno di due sorti, e fingere il chiaro scuro, trovato da Ugo, fu cagione che, seguitando molti le costui vestigie, si sono condotte da altri molte bellissime carte. Per che dopo lui Baldassarre Peruzzi, pittore sanese, fece di chiaro scuro simile una carta d'Ercole che caccia l'Avarizia, carica di vasi d'oro e d'argento, dal monte di Parnaso, dove sono le muse in diverse belle attitudini, che fu bellissima. E Francesco Parmigiano intagliò in un foglio reale aperto un Diogene, che fu più bella stampa che alcuna che mai facesse Ugo. Il medesimo Parmigiano, avendo mostrato questo modo di fare le stampe con tre forme ad Antonio da Trento, gli fece condurre in una carta grande la decollazione di San Pietro e San Paulo di chiaro scuro. E dopo in un'altra fece con due stampe solo la Sibilla Tiburtina che mostra ad Ottaviano imperadore Cristo nato in grembo alla Vergine, et uno ignudo che sedendo volta le spalle in bella maniera, e similmente in un ovato una Nostra Donna a giacere, e molte altre, che si veggiono fuori di suo stampate dopo la morte di lui da Ioannicolò Vicentino. Ma le più belle poi sono state fatte da Domenico Beccafumi sanese, dopo la morte del detto Parmigiano, come si dirà largamente nella vita di esso Domenico.
Non è anco stata se non lodevole invenzione l'essere stato trovato il moda da intagliare le stampe più facilmente che col bulino, se bene non vengono così nette, cioè con l'acqua forte, dando prima in sul rame una coverta di cera, o di vernice, o colore a olio, e disegnando poi con un ferro, che abbia la punta sottile, che sgraffi la cera o la vernice o il colore che sia; per che messavi poi sopra l'acqua da partire, rode il rame di maniera che lo fa cavo, e vi si può stampare sopra. E di questa sorte fece Francesco Parmigiano molte cose piccole che sono molto graziose, sì come una Natività di Cristo, quando è morto e pianto dalle Marie, uno de' panni di cappella fatti col disegno di Raffaello; e molte altre cose.
Dopo costoro ha fatto cinquanta carte di paesi varii e belli Batista pittore vicentino e Battista del Moro veronese. Et in Fiandra ha fatto Ieronimo Coca l'arti liberali; et in Roma fra' Bastiano viniziano la Visitazione della Pace, e quella di Francesco Salviati della Misericordia; la festa di Testaccio, oltre a molte opere, che ha fatto in Vinezia Battista Franco pittore, e molti altri maestri. Ma per tornare alle stampe semplici di rame, dopo che Marcantonio ebbe fatto tante opere, quanto si è detto di sopra, capitando in Roma il Rosso, gli persuase il Baviera che facesse stampare alcuna delle cose sue, onde egli fece intagliare a Gian Iacopo del Caraglio veronese, che allora aveva bonissima mano e cercava con ogni industria d'imitare Marcantonio, una sua figura di notomia secca, che ha una testa di morte in mano, e siede sopra un serpente, mentre un cigno canta. La quale carta riuscì di maniera, che il medesimo fece poi intagliare, in carte di ragionevole grandezza, alcuna delle forze d'Ercole: l'ammazzar dell'Idra, il combatter col Cerbero, quando uccide Cacco, il rompere le corna al toro, la battaglia de' centauri, e quando Nesso centauro mena via Deianira. Le quali carte riuscirono tanto belle e di buono intaglio, che il medesimo Iacopo condusse, pur col disegno del Rosso, la storia delle Piche, le quali, per voler contendere e cantare a pruova et a gara con le Muse, furono convertite in cornacchie. Avendo poi il Ba-viera fatto disegnare al Rosso, per un libro, venti dèi posti in certe nicchie con i loro instrumenti, furono da Gian Iacopo Caraglio intagliati con bella grazia e maniera, e non molto dopo le loro trasformazioni. Ma di queste non fece il disegno il Rosso se non di due, perché venuto col Baviera in diferenza, esso Baviera ne fece fare dieci a Perino del Vaga. Le due del Rosso furono il ratto di Proserpina e Fillare trasformato in cavallo. E tutte furono dal Caraglio intagliate con tanta diligenza che sempre sono state in pregio. Dopo cominciò il Caraglio, per il Rosso, il ratto delle Sabine, che sarebbe stato cosa molto rara, ma sopravenendo il sacco di Roma non si poté finire, perché il Rosso andò via e le stampe tutte si perderono. E se bene questa è venuta poi col tempo in mano degli stampatori, è stata cattiva cosa, per avere fatto l'intaglio chi non se ne intendeva, e tutto per cavar danari. Intagliò appresso il Caraglio, per Francesco Parmigiano, in una carta lo sposalizio di Nostra Donna et altre cose del medesimo, e dopo per Tiziano Vecellio in un'altra carta una Natività, che già aveva esso Tiziano dipinta, che fu bellissima. Questo Gian Iacomo Caraglio, dopo aver fatto molte stampe di rame, come ingegnoso si diede a intagliare cammei e cristalli, in che essendo riuscito non meno eccellente che in fare le stampe di rame, ha atteso poi appresso al re di Pollonia non più alle stampe di rame, come cosa bassa, ma alle cose delle gioie, a lavorare d'incavo et all'architettura. Per che essendo stato largamente premiato dalla liberalità di quel re, ha speso e rinvestito molti danari in sul parmigiano per ridursi in vecchiezza e godere la patria e gli amici e' discepoli suoi e le sue fatiche di molti anni.
Dopo costoro è stato eccellente negli intagli di rame Lamberto Suave, di mano del quale si veggiono in tredici carte Cristo con i dodici Apostoli condotti, quanto all'intaglio, sottilmente a perfezzione. E se gli avesse avuto nel disegno più fondamento, come si conosce fatica, studio e diligenza nel resto, così sarebbe stato in ogni cosa maraviglioso, come apertamente si vede in una carta piccola d'un San Paulo che scrive, et in una carta maggiore una storia della resurrezzione di Lazzaro, nella quale si veggiono cose bellissime, e particolarmente è da considerare il foro d'un sasso nella caverna, dove finge che Lazzaro sia sepolto, et il lume che dà addosso ad alcune figure, perché è fatto con bella e capricciosa invenzione.
Ha similmente mostrato di valere assai in questo esercizio Giovanbatista Mantoano, discepolo di Giulio Romano, fra l'altre cose in una Nostra Donna, che ha la luna sotto i piedi et il Figliuolo in braccio, et in alcune teste con cimieri all'antica molto belle; et in due carte, nelle quali è un capitan di bandiera a' piè et uno a cavallo; et in una carta parimente, dove è un Marte armato che siede sopra un letto, mentre Venere mira un Cupido allattato da lei che ha molto del buono. Son anco molto capricciose di mano del medesimo due carte grandi, nelle quali è l'incendio di Troia fatto con invenzione, disegno e grazia straordinaria, le quali, e molte altre carte di man di costui, son segnate con queste lettere:
I.B.M.
Né è stato meno eccellente d'alcuno dei sopra detti Enea Vico da Parma, il quale, come si vede, intagliò in rame il ratto d'Elena del Rosso; e così col disegno del medesimo in un'altra carta Vulcano con alcuni amori, che alla sua fucina fabbricano saette, mentre anco i Ciclopi lavorano, che certo fu bellissima carta; et in un'altra fece la Leda di Michelagnolo; et una Nunziata col disegno di Tiziano, la storia di Iuditta, che Michelagnolo dipinse nella capella; et il ritratto del duca Cosimo de' Medici, quando era giovane, tutto armato, col disegno del Bandinello, et il ritratto ancora d'esso Bandinello; e dopo, la zuffa di Cupido e d'Apollo, presenti tutti gli dèi. E se Enea fusse stato trattenuto dal Bandinello e riconosciuto delle sue fatiche, gli avrebbe intagliato molte altre carte bellissime. Dopo, essendo in Fiorenza Francesco allievo de' Salviati, pittore eccellente, fece a Enea intagliare, aiutato dalla liberalità del duca Cosimo, quella gran carta della conversione di San Paulo, piena di cavagli e di soldati, che fu tenuta bellissima e diede gran nome ad Enea, il qua-le fece poi il ritratto del signor Giovanni de' Medici, padre del duca Cosimo, con uno ornamento pieno di figure. Parimente intagliò il ritratto di Carlo Quinto imperadore, con un ornamento pieno di vittorie e di spoglie fatte a proposito; di che fu premiato da Sua Maestà e lodato da ognuno. Et in un'altra carta molto ben condotta, fece la vittoria che Sua Maestà ebbe in su l'Albio. Et al Doni fece a uso di medaglie alcune teste di naturale con belli ornamenti: Arrigo re di Francia, il cardinal Bembo, Messer Lodovico Ariosto, il Gello Fiorentino, Messer Lodovico Domenichi, la signora Laura Terracina, Messer Cipriano Morosino et il Doni. Fece ancora per don Giulio Clovio, rarissimo miniatore, in una carta San Giorgio a cavallo che amazza il serpente, nella quale, ancor che fusse, si può dire, delle prime cose che intagliasse, si portò molto bene. Appresso, perché Enea aveva l'ingegno elevato e disideroso di passare a maggiori e più lodate imprese, si diede agli studii dell'antichità, e particolarmente delle medaglie antiche: delle quali ha mandato fuori più libri stampati, dove sono l'effigie vere di molti imperadori e le loro mogli, con l'inscrizioni e riversi di tutte le sorti, che possono arecare a chi se ne diletta cognizione e chiarezza delle storie. Di che ha meritato e merita gran lode. E chi l'ha tassato ne' libri delle medaglie, ha avuto il torto: perciò che chi considererà le fatiche che ha fatto e quanto siano utili e belle, lo scuserà se in qualche cosa di non molta importanza avesse fallato; e quelli errori che non si fanno se non per male informazioni, o per troppo credere o avere, con qualche ragione, diversa openione dagl'altri, sono degni di es-ser scusati: perché di così fatti errori hanno fatto Aristotile, Plinio e molti altri. Disegnò anco Enea, a commune sodisfazione et utile degl'uomini, cinquanta abiti di diverse nazzioni, cioè come costumano di vestire in Italia, in Francia, in Ispagna, in Portogallo, in Inghilterra, in Fiandra et in altre parti del mondo, così gl'uomini come le donne, e così i contadini come i cittadini. Il che fu cosa d'ingegno e bella e capricciosa. Fece ancora un albero di tutti gl'imperadori, che fu molto bello. Et ultimamente, dopo molti travagli e fatiche, si riposa oggi sotto l'ombra d'Alfonso Secondo, duca di Ferrara: al quale ha fatto un albero della genealogia de' marchesi e duchi estensi. Per le quali tutte cose, e molte altre che ha fatto e fa tuttavia, ho di lui voluto fare questa onorata memoria fra tanti virtuosi.
Si sono adoperati intorno agl'intagli di rame molti altri, i quali, se bene non hanno avuto tanta perfezzione, hanno nondimeno con le loro fatiche giovato al mondo e mandato in luce molte storie et opere di maestri eccellenti, e dato commodità di vedere le diverse invenzioni e maniere de' pittori a coloro che non possono andare in que' luoghi dove sono l'opere principali, e fatto avere cognizione agl'oltramontani di molte cose che non sapevano. Et ancor che molte carte siano state mal condotte dall'ingordigia degli stampatori, tirati più dal guadagno che dall'onore, pur si vede, oltre quelle che si son dette, in qualcun'altra essere del buono, come nel disegno grande della facciata della capella del papa, del Giudizio di Michelagnolo Buonarruoti, stato intagliato da Giorgio Mantoano; e come nella crucifissione di San Pietro e nella conversione di San Paulo dipinte nella capella Paulina di Roma et intagliate da Giovambatista de' Cavalieri; il quale ha poi con altri disegni messo in istampe di rame la meditazione di San Giovanni Battista, il Deposto di croce della capella che Daniello Ricciarelli da Volterra dipinse nella Trinità di Roma, et una Nostra Donna con molti Angeli, et altre opere infinite. Sono poi da altri state intagliate molte cose cavate da Michelagnolo a requisizzione d'Antonio Lanferri, che ha tenuto stampatori per simile essercizio, i quali hanno mandato fuori libri con pesci d'ogni sorte. Et appresso il Faetonte, il Tizio, il Ganimede, i Saettatori, la Baccanaria, il Sogno e la Pietà, e il Crocifisso fatti da Michelagnolo alla Marchesana di Pescara. Et oltre ciò, i quattro Profeti della capella, et altre storie, e disegni stati intagliati, e mandati fuori tanto malamente, che io giudico ben fatto tacere il nome di detti intagliatori e stampatori. Ma non debbo già tacere il detto Antonio Lanferri e Tommaso Barlacchi, perché costoro et altri hanno tenuto molti giovani a intagliare stampe con i veri disegni di mano di tanti maestri che è bene tacergli per non essere lungo; essendo stati in questa maniera mandati fuori, non che altre, grottesche, tempii antichi, cornici, base, capitegli e molte altre cose simili con tutte le misure. Là dove, vedendo ridurre ogni cosa in pessima maniera, Sebastian Serlio bolognese, architettore, mosso da pietà, ha intagliato in legno et in rame dua libri d'architettura, dove son fra l'altre cose trenta porte rustiche e venti delicate; il qual libro è intitolato al re Arrigo di Francia. Parimente Antonio Abbaco ha mandato fuori con bella maniera tutte le cose di Roma antiche e motabili, con le lor misure fatte con intaglio sottile e molto ben condotto da... perugino. Né me-no ha in ciò operato Iacopo Barazzo da Vignola architettore, il quale in un libro intagliato in rame ha con una facile re-gola insegnato ad aggrandire e sminuire secondo gli spazii de' cinque ordini d'architettura; la qual opera è stata utilissima all'arte, e si gli deve avere obligo, sì come anco per i suoi intagli e scritti d'architettura si deve a Giovanni Cugini da Parigi.
In Roma, oltre ai sopra detti, ha talmente dato opera a questi intagli di bulino Niccolò Beatricio loteringo, che ha fatto molte carte degne di lode: come sono due pezzi di pili con battaglie di cavalli, stampati in rame et altre carte tutte piene di diversi animali ben fatti, et una storia della figliuola della vedova resuscitata da Gesù Cristo, condotta fieramente col disegno di Girolamo Mosciano, pittore da Brescia. Ha intagliato il medesimo da un disegno di mano di Michelagnolo una Nunziata, e messo in stampa la nave di musaico, che fé Giotto nel portico di S. Piero. Da Vinezia similmente son venute molte carte in legno et in rame bellissime, da Tiziano in legno molti paesi, una Natività di Cristo, un San Ieronimo et un San Francesco, et in rame il Tantalo, l'Adone et altre molte carte, le quali da Iulio Buonasona bolognese sono state intagliate, con alcune altre di Raffaello, di Giulio Romano, del Parmigiano e di tanti altri maestri, di quanti ha potuto aver disegni.
E Battista Franco pittor viniziano ha intagliato, parte col bulino e parte con acqua da partir, molte opere di mano di diversi maestri, la Natività di Cristo, l'Adorazione de' Magi e la predicazione di San Piero, alcune carte degl'atti degl'A-postoli, con molte cose del Testamento Vecchio. Ed è tant'oltre proceduto quest'uso e modo di stampare, che coloro che ne fanno arte tengano disegnatori in opera continuamente, i quali ritraendo ciò che si fa di bello, lo mettono in istampa.
Onde si vede che di Francia son venute stampate, dopo la morte del Rosso, tutto quello che si è potuto trovare di sua mano, come Clelia con le Sabine che passano il fiume, alcune maschere fatte per lo re Francesco, simili alle Parche, una Nunziata bizzarra, un ballo di dieci femmine, et il re Francesco che passa solo al tempio di Giove, lasciandosi dietro l'ignoranza et altre figure simili. E queste furono condotte da Renato intagliatore di rame, vivente il Rosso. E molte più ne sono state disegnate et intagliate doppo la morte di lui, et oltre molte altre cose, tutte l'istorie d'Ulisse, e non che altro, vasi, lumiere, candelieri, saliere et altre cose simili infinite state lavorate d'argento con disegno del Rosso.
E Luca Penni ha mandato fuori due satiri che danno bere a un Bacco, et una Leda che cava le freccie del turcasso a Cupido, Susanna nel bagno, e molte altre carte cavate dai disegni del detto e di Francesco Bologna Primaticcio, oggi abbate di San Martino in Francia. E fra questi sono il Giudizio di Paris, Abraam che sacrifica Isac, una Nostra Donna, Cristo che sposa Santa Caterina, Giove che converte Calisto in orsa, il Concilio degli dei, Penelope che tesse con altre sue donne, et altre cose infinite stampate in legno, e fatte la maggior parte col bulino, le quali sono state cagione che si sono di maniera assotigliati gl'ingegni, che si son intagliate figure piccoline tanto bene, che non è possibile condurle a maggior finezza.
E chi non vede senza maraviglia l'opere di Francesco Marcolini da Forlì, il qual oltre all'altre cose stampò il libro del giardino de' pensieri in legno, ponendo nel principio una sfera d'astrologi e la sua testa col disegno di Giuseppo Porta da Castelnuovo della Garfagnana, nel qual libro sono figurate varie fantasie: il Fato, l'Invidia, la Calamità, la Timidità, la Laude e molte altre cose simili, che furono tenute bellissime.
Non furono anco se non lodevoli le figure che Gabriel Giolito stampatore de' libri, mise negl'Orlandi Furiosi, perciò che furono condotte con bella maniera d'intagli. Come furono anco gl'undici pezzi di carte grandi di notomia, che furo-no fatte da Andrea Vessalio e disegnate da Giovanni di Calcare fiamingo, pittore eccellentissimo, le quali furono poi ritratte in minor foglio et intagliate in rame dal Valverde, che scrisse della notomia dopo il Vessallio.
Fra molte carte poi, che sono uscite di mano ai Fiaminghi da dieci anni in qua, sono molto belle alcune disegnate da un Michele pittore, il quale lavorò molti anni in Roma in due capelle, che sono nella chiesa de' Tedeschi, le quali carte sono la storia delle serpi di Moisè, e trentadue storie di Psiche e d'Amore, che sono tenute bellissime.
Ieronimo Cocca similmente fiamingo ha intagliato, col disegno et invenzione di Martino Ems Kycr, in una carta grande, Dalila che tagliando i capegli a Sansone ha non lontano il tempio de' Filistei, nel quale, rovinate le torri, si vede la strage e rovina de' morti, e la paura de' vivi che fuggono. Il medesimo in tre carte minori ha fatto la creazione d'A-damo et Eva, il mangiar del pomo e quando l'Angelo gli caccia di Paradiso. Et in quattro altre carte della medesima grandezza, il diavolo che nel cuore dell'uomo dipigne l'avarizia e l'ambizione, e nell'altre tutti gl'affetti che i sopra detti seguono. Si veggiono anco di sua mano ventisette storie della medesima grandezza di cose del Testamento, dopo la cacciata d'Adamo del Paradiso, disegnate da Martino con fierezza e pratica molto risoluta, e molto simile alla maniera italiana.
Intagliò appresso Ieronimo in sei tondi i fatti di Susanna et altre ventitré storie del Testamento Vecchio simili alle prime di Abraam, cioè in sei carte i fatti di Davit, in otto pezzi quegli di Salomone, in quattro quegli di Balaam, et in cinque quegli di Iudit e Susanna. E del Testamento Nuovo intagliò ventinove carte, cominciando dall'anunziazione del-la Vergine insino a tutte la Passione e morte di Gesù Cristo. Fece anco col disegno del medesimo Martino le sette opere della misericordia, e la storia di Lazzero ricco e Lazzero povero. Et in quattro carte la parabola del samaritano ferito da' ladroni, et in altre quattro carte quella che scrive S. Matteo a' diciotto capitoli dei talenti. E mentre che Liè Frynch a sua concorrenza fece in dieci carte la vita e morte di San Giovanni Battista, egli fece le dodici tribù in altre tante carte, figurando per la lussuria Ruben in sul porco, Simeon con la spada per l'omicidio, e similmente gl'altri capi delle tribù con altri segni e proprietà della natura loro.
Fece poi d'intaglio più gentile in dieci carte le storie et i fatti di Davit, da che Samuel l'unse, fino a che se n'andò dinanzi a Saulo. Et in sei altre carte fece l'inamoramento d'Amon con Tamar sua sorella, e lo stupro e morte del medesimo Amon. E non molto dopo fece della medesima grandezza dieci storie de' fatti di Iobbe, e cavò da tredici capitoli de' proverbii di Salamone, cinque carte della sorte medesima. Fece ancora i Magi, e dopo in sei pezzi la parabola, che è in San Matteo a dodici, di coloro che per diverse cagioni recusarono d'andar al convito del re, e colui che v'andò non a-vendo la veste nuziale. E della medesima grandezza in sei carte alcuni degl'atti degl'Apostoli, et in otto carte simili figurò in varii abiti, otto donne di perfetta bontà: sei del Testamento vecchio, Iabil, Ruth, Abigail, Iudith, Esther e Susanna; e del nuovo, Maria Vergine madre di Gesù Cristo e Maria Madalena. E dopo queste fece intagliare in sei carte i trionfi della Pacienza, con varie fantasie. Nella prima è sopra un carro la Pacienza, che ha in mano uno stendardo, dentro al quale è una rosa fra le spine. Nell'altra si vede sopra un'ancudine un cuor che arde, percosso da tre martella; et il carro di questa seconda carta è tirato da due figure: cioè dal Disiderio, che ha l'ale sopra gl'omeri, e dalla Speranza che ha in mano un'àncora, e si mena dietro, come prigiona, la Fortuna, che ha rotto la ruota. Nell'altra carta è Cristo in sul carro con lo stendardo della croce e della sua Passione. Et in sui canti sono gl'Evangelisti in forma d'animati. E questo carro è tirato da dua agnelli, e dietro ha quattro prigioni: il diavolo, il mondo, o vero la carne, il peccato e la morte. Nel-l'altro trionfo è Isaac nudo sopra un camello, e nella bandiera che tiene in mano è un paio di ferri da prigione, e si tira dietro l'altare col montone, il coltello et il fuoco. In un'altra carta fece Iosef, che trionfa sopra un bue coronato di spighe e di frutti, con uno stendardo, dentro al quale è una cassa di pecchie. Et i prigioni, che si trae dietro, sono Zefira e l'In-vidia, che si mangiano un cuore. Intagliò in un altro trionfo Davit, sopra un lione, con la cetara e con uno standardo in mano, dentro al quale è un freno, e dietro a lui è Saul prigione et i Semei con la lingua fuora. In un'altra è Tobia che trionfa sopra l'asino, et ha in mano uno stendardo dentrovi una fonte; e si trae dietro legati come prigioni la Povertà e la Cecità. L'ultimo de' sei trionfi è Santo Stefano protomartire, il quale trionfa sopra un elefante et ha nello stendardo la Carità, et i prigioni sono i suoi persecutori. Le quali tutte sono state fantasie capricciose e piene d'ingegno; e tutte furo-no intagliate da Ieronimo Coch la cui mano è fiera, sicura e gagliarda molto.
Intagliò il medesimo con bel capriccio in una carta la Fraude e l'Avarizia, et in un'altra bellissima una bacanaria con putti che ballano. In un'altra fece Moisè che passa il Mare Rosso, secondo che l'aveva dipinta Agnolo Bronzino, pittore fiorentino, nel palagio del duca di Fiorenza, nella capella di sopra. A concorrenza del quale pur col disegno del Bronzino intagliò Giorgio Mantovan una Natività di Gesù Cristo, che fu molto bella. E dopo queste cose intagliò Ieronimo, per colui che ne fu inventore, dodici carte delle vittorie, battaglie e fatti d'arme di Carlo Quinto. Et al Verese, pittore e gran maestro, in quelle parti di prospettiva, in venti carte diversi casamenti, et a Ieronimo Bos una carta di San Martino con una barca piena di diavoli in bizzarrissime forme; et in un'altra un alchimista, che in diversi modi consumando il suo e stillandosi il cervello, getta via ogni suo avere, tanto che al fine si conduce allo spedale con la moglie e con i figliuoli; la qual carta gli fu disegnata da un pittore che gli fece intagliare i sette peccati mortali, con diverse forme di dèmoni, che furono cosa fantastica e da ridere, il Giudizio Universale, et un vecchio, il quale con una lanterna cerca della Quiete fra le mercerie del mondo e non la truova, e similmente un pesce grande, che si mangia alcuni pesci minuti; et un Carnovale che godendosi con molti a tavola, caccia via la Quaresima; et in un'altra poi la Quaresima che caccia via il Carnovale; e tante altre fantastiche e capricciose invenzioni che sarebbe cosa fastidiosa a volere di tutte ragionare.
Molti altri Fiaminghi hanno con sottilissimo studio imitata la maniera d'Alberto Duro, come si vede nelle loro stampe; e particolarmente in quelle di... che con intaglio di figure piccole ha fatto quattro storie della creazione d'Adamo, quattro dei fatti di Abraam e di Lotto, et altre quattro di Susanna, che sono bellissime. Parimente, G. P. ha intagliato in sette tondi piccioli, le sette opere della Misericordia; otto storie tratte dai libri de' Re; un Regolo messo nella botte piena di chiodi, et Artemisia, che è una carta bellissima. Et I. B. ha fatto i quattro Evangelisti tanto piccoli, che è quasi impossibile a condurli; et appresso cinque altre carte molto belle: nella prima delle quali è una vergine condotta dalla morte così giovinetta alla fossa; nella seconda Adamo; nella terza un villano; nella quarta un vescovo; e nella quinta un cardinale, tirato ciascuno, come la vergine, dalla morte all'ultimo giorno. Et in alcun'altre molti Tedeschi che vanno con loro donne a' piaceri, et alcuni satiri belli e capricciosi. E da... si veggono intagliati con diligenza i quattro Evangelisti, non men belli che si siano dodici storie del figliuol prodigo, di mano di M. con molta diligenza.
Ultimamente Francesco Flori, pittore in quelle parti famoso, ha fatto gran numero di disegni e d'opere, che poi sono state intagliate per la maggior parte da Ieronimo Coch, come sono in dieci carte le forze d'Ercole, et in una grande tutte l'azzioni dell'umana vita. In un'altra gl'Orazii et i Curiazii che combattono in uno steccato; il giudizio di Salamone, et un combattimento fra i pigmei et Ercole. Et ultimamente ha intagliato un Caino che ha occiso Abel, e sopra gli sono Adamo et Eva che lo piangono. Similmente un Abraam che sopra l'altare vuol sacrificare Isaac, con infinite altre carte piene di tante varie fantasie, che è uno stupore et una maraviglia considerare che sia stato fatto nelle stampe di rame e di legno.
Per ultimo basti vedere gl'intagli di questo nostro libro dei ritratti de' pittori, scultori et architetti disegnati da Giorgio Vasari e dai suoi creati, e state intagliate da maestro Cristofano..., che ha operato et opera di continuo in Vinezia infinite cose degne di memoria. E per ultimo di tutto il giovamento che hanno gl'oltramontani avuto dal vedere, mediante le stampe, le maniere d'Italia, e gl'Italiani dall'aver veduto quelle degli stranieri et oltramontani, si deve avere, per la maggior parte, obligo a Marcantonio bolognese, perché oltre all'aver egli aiutato i principii di questa professione quanto si è detto, non è anco stato per ancora chi l'abbia gran fatto superato, sì bene pochi in alcune cose gl'hanno fatto paragone. Il qual Marcantonio non molto dopo la sua partita di Roma si morì in Bologna. E nel nostro libro sono di sua mano alcuni disegni d'Angeli fatti di penna et altre carte molto belle, ritratte dalle camere che dipinse Raffaello da Urbino. Nelle quali camere fu Marcantonio, essendo giovane, ritratto da Raffaello in uno di que' palafrenieri che portano papa Iulio Secondo, in quella parte dove Enea sacerdote fa orazione.
E questo sia il fine della vita di Marcantonio Bolognese e degl'altri sopra detti intagliatori di stampe; de' quali ho voluto fare questo lungo, sì, ma necessario discorso, per sodisfare non solo agli studiosi delle nostre arti, ma tutti coloro ancora che di così fatte opere si dilettano.
VITA
D'ANTONIO DA SANGALLO
ARCHITETTORE FIORENTINO

Quanti principi illustri e grandi, e d'infinite ricchezze abbondantissimi, lasciarebbono chiara fama del nome loro, se con la copia de' beni della fortuna avessero l'animo grande et a quelle cose volto, che non pure abbeliscono il mondo, ma sono d'infinito utile e giovamento universalmente a tutti gl'uomini? E quali cose possono o devrebbono fare i principi e grandi uomini, che maggiormente e nel farsi, per le molte maniere d'uomini che s'adoperano, e fatte, perché dura-no quasi in perpetuo, che le grande e magnifiche fabbriche et edifizii? E di tante spese che fecero gl'antichi Romani, allora che furono nel maggior colmo della grandezza loro, che altro n'è rimaso a noi, con eterna gloria del nome romano, che quelle reliquie di edifizii, che noi come cosa santa onoriamo e come sole bellissime c'ingegniamo d'imitare? Al-le quali cose quanto avessero l'animo volto alcuni prìncipi che furono al tempo d'Antonio Sangallo architettore fiorentino, si vedrà ora chiaramente nella vita che di lui scriviamo.
Fu dunque figliuolo Antonio, di Bartolomeo Picconi di Mugello bottaio, et avendo nella sua fanciullezza imparato l'arte del legnaiuolo, si partì di Fiorenza, sentendo che Giuliano da San Gallo suo zio era in facende a Roma insieme con Anton suo fratello; perché da bonissimo animo, volto a le facende dell'arte dell'architettura, e seguitando quegli, prometteva di sé que' fini che nella età matura cumulatamente veggiamo per tutta l'Italia, in tante cose fatte da lui. Ora avvenne che essendo Giuliano, per lo impedimento che ebbe di quel suo male di pietra, sforzato ritornare a Fiorenza, Antonio venne in cognizione di Bramante da Casteldurante architetto, che cominciò per esso, che era vecchio e dal parletico impedito le mani non poteva come prima operare, a porgergli aiuto ne' disegni che si facevano; dove Antonio tanto nettamente e con pulitezza conduceva, che Bramante trovandogli di parità misuratamente corrispondenti, fu sforzato lasciargli la cura d'infinite fatiche che egli aveva a condurre, dandogli Bramante l'ordine che voleva, e tutte le invenzioni e componimenti che per ogni opera s'avevano a fare. Nelle quali con tanto giudizio e spedizione e diligenza si trovò servito da Antonio, che l'anno MDXII Bramante gli diede la cura del corridore che andava a' fossi di Castel Santo Agnolo, della quale opera cominciò avere una provisione di dieci scudi il mese. Ma seguendo poi la morte di Giulio II l'opera rimase imperfetta. Ma lo aversi acquistato Antonio già nome di persona ingegnosa nella architettura, e che nelle cose delle muraglie avesse bonissima maniera, fu cagione che Alessandro primo cardinal Farnese, poi papa Paulo III, venne in capriccio di far restaurare il suo palazzo vecchio, ch'egli in Campo di Fiore con la sua famiglia abitava. Per la quale opera disiderando Antonio venire in grado, fece più disegni in variate maniere. Fra i quali uno che ve n'era accomodato, con due appartamenti, fu quello che a Sua Santità reverendissima piacque, avendo egli il signor Pier Luigi e 'l signor Ranuccio suoi figliuoli, i quali pensò dovergli lasciare di tal fabbrica accomodati. E dato a tale opera principio, ordinatamente ogni anno si fabbricava un tanto.
In questo tempo al macello de' Corbi a Roma, vicino alla colonna Traiana, fabbricandosi una chiesa col titolo di Santa Maria da Loreto, ella da Antonio fu ridotta a perfezzione con ornamento bellissimo. Dopo questo, Messer Marchionne Baldassini, vicino a Santo Agostino, fece condurre col modello e reggimento di Antonio un palazzo, il quale è in tal modo ordinato, che per piccolo che egli sia, è tenuto per quello ch'egli è il più comodo et il primo allogiamento di Roma, nel quale le scale, il cortile, le logge, le porte et i camini con somma grazia sono lavorati. Di che rimanendo Messer Marchionne sodisfattissimo, deliberò che Perino del Vaga pittor fiorentino vi facesse una sala di colorito e storie et altre figure, come si dirà nella vita sua, quali ornamenti gli hanno recato grazia e bellezza infinita. Accanto a torre di Nona ordinò e finì la casa de' Centelli, la quale è piccola, ma molto comoda. E non passò molto tempo che andò a Gradoli, luogo su lo stato del reverendissimo cardinale Farnese, dove fece fabbricare per quello un bellissimo et utile palazzo. Nella quale andata fece grandissima utilità nel restaurare la rocca di Capo del Monte, con ricinto di mura basse e ben foggiate; e fece allora il disegno della fortezza di Capraruola. Trovandosi monsignor reverendissimo Farnese con tanta sodisfazione servito in tante opere da Antonio, fu costretto a volergli bene, e di continuo gli accrebbe amore, e sempre che poté farlo, gli fece favore in ogni sua impresa.
Appresso, volendo il cardinale Alborense lasciar memoria di sé nella chiesa della sua nazione, fece fabbricare da Antonio, e condurre a fine, in San Iacopo degli Spagnuoli una cappella di marmi et una sepoltura per esso; la quale cappella fra vani di pilastri fu da Pellegrino da Modana, come si è detto, tutta dipinta; e su lo altare, da Iacopo del Sansovino fatto un San Iacopo di marmo bellissimo: la quale opera di architettura è certamente tenuta lodatissima, per esservi la volta di marmo con uno spartimento di ottangoli bellissimo. Né passò molto che Messer Bartolomeo Ferratino, per comodità di sé e beneficio degli amici, et ancora per lasciare memoria onorata e perpetua, fece fabbricare da Antonio su la piazza d'Amelia un palazzo, il quale è cosa onoratissima e bella, dove Antonio acquistò fama et utile non mediocre.
Essendo in questo tempo in Roma Antonio di Monte cardinale di Santa Prassedia, volle che il medesimo gli facesse il palazzo, dove poi abitò, che risponde in Agone, dove è la statua di maestro Pasquino; nel mezzo risponde nella piazza, dove fabbricò una torre: la quale, con bellissimo componimento di pilastri e finestre dal primo ordine fino al terzo, con grazia e con disegno gli fu da Antonio ordinata e finita, e per Francesco dell'Indaco lavorata di terretta a figure, e storie da la banda di dentro e di fuora. Intanto avendo fatta Antonio stretta servitù col cardinal d'Arimini, gli fece fare quel signore in Tolentino della Marca un palazzo; oltra lo esser Antonio stato premiato, gli ebbe il cardinale di continuo obligazione. Mentre che queste cose giravano e la fama d'Antonio crescendo si spargeva, avvenne che la vecchiezza di Bramante, et alcuni suoi impedimenti, lo fecero cittadino dell'altro mondo; per che da papa Leone subito furono constituiti tre architetti sopra la fabrica di San Pietro: Raffaello da Urbino, Giuliano da San Gallo zio d'Antonio, e fra' Giocondo da Verona. E non andò molto che fra' Giocondo si partì di Roma, e Giuliano essendo vecchio ebbe licenza di potere ritornare a Fiorenza. Laonde Antonio avendo servitù col reverendissimo Farnese, strettissimamente lo pregò che volesse supplicare a papa Leone che il luogo di Giuliano suo zio gli concedesse. La qual cosa fu facilissima a ottenere: prima per le virtù di Antonio, che erano degne di quel luogo; poi per lo interesso della benivolenza fra il Papa e 'l reverendissimo Farnese. E così in compagnia di Raffaello da Urbino si continuò quella fabbrica assai freddamente.
Andando poi il Papa a Civitavecchia per fortificarla, et in compagnia di esso infiniti signori, e fra gli altri Giovan Paolo Baglioni e 'l signor Vitello, e similmente, di persone ingegnose, Pietro Navarra et Antonio Marchisi, architetto allora di fortificazioni - il quale per commessione del Papa era venuto da Napoli - e ragionandosi di fortificare detto luogo, infinite e varie circa ciò furono le opinioni; e chi un disegno e chi un altro facendo, Antonio, fra tanti, ne spiegò loro uno, il quale fu confermato dal Papa, e da quei signori et architetti, come di tutti migliore per bellezza e fortezza e bellissime et utili considerazioni. Onde Antonio ne venne in grandissimo credito appresso la corte. Dopo questo riparò la virtù d'Antonio a un gran disordine per questa cagione. Avendo Raffaello da Urbino nel fare le logge papali e le stanze, che sono sopra i fondamenti, per compiacere ad alcuni, lasciati molti vani, con grave danno del tutto per lo peso che sopra quelli si aveva a reggere, già cominciava quell'edifizio a minacciare rovina pel troppo gran peso che aveva sopra; e sarebbe certamente rovinato se la virtù d'Antonio, con aiuto di puntelli e travate, non avesse ripiene di dentro quelle stanzerelle e, rifondando per tutto, non l'avesse ridotte ferme e saldissime, come elle furono mai da principio.
Avendo intanto la nazione fiorentina, col disegno di Iacopo Sansovino, cominciata in strada Giulia dietro a' Banchi la chiesa loro, si era nel porla messa troppo dentro nel fiume; per che, essendo a ciò stretti dalla necessità, spesono dodicimila scudi in un fondamento in acqua, che fu da Antonio con bellissimo modo e fortezza condotto. La quale via, non potendo essere trovata da Iacopo, si trovò per Antonio; e fu murata sopra l'acqua parecchie braccia. Et Antonio ne fece un modello così raro, che se l'opera si conduceva a fine, sarebbe stata stupendissima. Tuttavia fu gran disordine e poco giudizio quello di chi allora era capo in Roma di quella nazione; perché non dovevano mai permettere che gl'ar-chitetti fondassono una chiesa sì grande in un fiume tanto terribile, per acquistare venti braccia di lunghezza, e gittare in un fondamento tante migliaia di scudi per avere a combattere con quel fiume in eterno, potendo massimamente far venire sopra terra quella chiesa col tirarsi innanzi e col darle un'altra forma; e, che è più, potendo quasi con la medesima spesa darle fine. E si confidarono nelle ricchezze de' mercanti di quella nazione; si è poi veduto, col tempo, quanto fusse cotal speranza fallace, perché in tanti anni che tennero il papato Leone e Clemente de' Medici e Giulio Terzo e Marcello, ancor che vivesse pochissimo, i quali furono del dominio fiorentino, con la grandezza di tanti cardinali, e con le ricchezze di tanti mercatanti, si è rimaso e si sta ora nel medesimo termine che dal nostro Sangallo fu lasciato. E per ciò deono, e gl'architetti e chi fa fare le fabriche, pensare molto bene al fine et ad ogni cosa, prima che all'opere d'im-portanza mettano le mani.
Ma per tornare ad Antonio, egli per commessione del Papa, che una state lo menò seco in quelle parti, restaurò la rocca di Monte Fiascone, già stata edificata da papa Urbano. E nell'isola Visentina, per volere del cardinal Farnese, fece nel lago di Bolsena due tempietti piccoli; uno de' quali era condotto di fuori a otto facce e dentro tondo, e l'altro era di fuori quadro e dentro a otto facce, e nelle facce de' cantoni erano quattro nicchie, una per ciascuno; i quali due tempietti condotti con bell'ordine fecero testimonianza quanto sapesse Antonio usare la varietà ne' termini dell'architettura. Mentre che questi tempii si fabricavano, tornò Antonio in Roma, dove diede principio in sul canto di Santa Lucia, là dove è la nuova Zecca, al palazzo del vescovo di Cervia, che poi non fu finito. Vicino a corte Savella fece la chiesa di Santa Maria di Monferrato, la quale è tenuta bellissima; e similmente la casa d'un Marrano, che è dietro al palazzo di Cibò, vicina alle case de' Massimi.
Intanto morendo Leone, e con esso lui tutte le belle e buone arti tornate in vita da esso e da Giulio Secondo suo antecessore, succedette Adriano Sesto; nel pontificato del quale furono talmente tutte l'arti e tutte le virtù battute, che se il governo della Sede apostolica fusse lungamente durato nelle sue mani, interveniva a Roma nel suo pontificato quello che intervenne altra volta, quando tutte le statue avanzate alle rovine de' Gotti (così le buone, come le ree) furono condennate al fuoco. E già aveva cominciato Adriano (forse per imitare i pontefici de' già detti tempi) a ragionare di volere gettare per terra la capella del divino Michelagnolo, dicendo ell'era una stufa d'ignudi. E sprezzando tutte le buone pitture e le statue, le chiamava lascivie del mondo, e cose obbrobriose et abominevoli. La qual cosa fu cagione, che non pure Antonio, ma tutti gl'altri begl'ingegni si fermarono in tanto che al tempo di questo pontefice non si lavorò, non che altro, quasi punto alla fabbrica di S. Pietro. Alla quale doveva pur al meno essere affezionato poiché dell'altre cose mondane si volle tanto mostrare nimico. Perciò dunque, attendendo Antonio a cose di non molta importanza, restaurò sotto questo Pontefice le navi piccole della chiesa di S. Iacopo degli Spagnuoli, et accomodò la facciata dinanzi con bellissimi lumi. Fece lavorare il tabernacolo dell'imagine di Ponte, di trivertino; il quale, benché piccolo sia, ha però molta grazia. Nel quale poi lavorò Perino del Vaga a fresco una bella operetta.
Erano già le povere virtù, per lo vivere d'Adriano, mal condotte, quando il cielo, mosso a pietà di quelle, volle con la morte d'uno farne risuscitar mille; onde lo levò del mondo e gli fece dar luogo a chi meglio doveva tenere tal grado e con altro animo governare le cose del mondo. Per che creato papa Clemente Settimo, pieno di generosità, seguitando le vestigie di Leone e degl'altri antecessori della sua illustrissima famiglia, si pensò che, avendo nel cardinalato fatto belle memorie, dovesse nel papato avanzare tutti gl'altri di rinovamenti di fabbriche et adornamenti. Questa elezzione, adunque, fu di refrigerio a molti virtuosi, et ai timidi et ingegnosi animi, che si erano aviliti, grandissimo fiato e disideratissima vita. I quali per ciò risurgendo, fecero poi quell'opere bellissime che al presente veggiamo. E primieramente Antonio, per commessione di Sua Santità messo in opera, subito rifece un cortile in palazzo dinanzi alle logge, che già furon dipinte con ordine di Raffaello; il quale cortile fu di grandissimo comodo e bellezza, perché dove si andava prima per certe vie storte e strette, allargandole Antonio e dando loro miglior forma, le fece comode e belle. Ma questo luogo non istà oggi in quel modo che lo fece Antonio: perché papa Giulio Terzo ne levò le colonne che vi erano di granito per ornarne la sua vigna, et alterò ogni cosa. Fece Antonio in Banchi la facciata della Zecca vecchia di Roma con bellissima grazia, in quello angolo girato in tondo che è tenuto cosa difficile e miracolosa; et in quell'opera mise l'arme del Papa. Rifondò il resto delle logge papali, che per la morte di Leone non s'erano finite, e per la poca cura d'Adriano non s'erano continuate, né tocche; e così secondo il volere di Clemente furono condotte a ultimo fine.
Dopo, volendo Sua Santità fortificare Parma e Piacenza, dopo molti disegni e modelli che da diversi furono fatti, fu mandato Antonio in que' luoghi, e seco Giulian Leno, sollecitatore di quelle fortificazioni.
E là arivati, essendo con Antonio l'Abbaco suo creato, Pierfrancesco da Viterbo, ingegnere valentissimo e Michele da San Michele architetto veronese, tutti insieme condussero a perfezzione i disegni di quelle fortificazioni. Il che fatto, rimanendo gl'altri, se ne tornò Antonio a Roma, dove essendo poca commodità di stanze in palazzo, ordinò papa Clemente che Antonio sopra la Ferraria cominciasse quelle dove si fanno i concistori publici, le quali furono in modo condotte, che il Pontefice ne rimase sodisfatto, e fece farvi poi sopra le stanze de' camerieri di Sua Santità. Similmente fece Antonio sopra il tetto di queste stanze, altre stanze comodissime, la quale opera fu pericolosa molto, per tanto rifondare. E nel vero in questo Antonio valse assai, atteso che le sue fabbriche mai non mostrarono un pelo; né fu mai fra i moderni altro architetto più sicuro, né più accorto in congiugnere mura.
Essendosi al tempo di papa Paulo Secondo la chiesa della Madonna di Loreto, che era piccola e col tetto in sui pilastri di mattoni alla salvatica, rifondata e fatta di quella grandezza che ella essere oggi si vede, mediante l'ingegno e virtù di Giuliano da Maiano, et essendosi poi seguitata dal cordone di fuori in su, da Sisto Quarto e da altri, come si è detto, finalmente al tempo di Clemente, non avendo prima fatto mai pur un minimo segno di rovina, s'aperse l'anno 1526 di maniera che non solamente erano in pericolo gl'archi della tribuna, ma tutta la chiesa in molti luoghi, per essere stato il fondamento debole e poco adentro. Per che, essendo da detto papa Clemente mandato Antonio a riparare a tanto disordine, giunto che egli fu a Loreto, puntellando gl'archi et armando il tutto con animo risolutissimo e di giudizioso architetto, la rifondò tutta. E ringrossando le mura et i pilastri fuori e dentro, gli diede bella forma del tutto, e nella proporzione de' membri, e la fece gagliarda da poter reggere ogni gran peso, continuando un medesimo ordine nelle crocere e navate della chiesa, con superbe modanature d'architravi sopra gl'archi, fregi e cornicioni. E rendé sopramodo bello e ben fatto l'imbasamento de' quattro pilastri grandi, che vanno intorno all'otto facce della tribuna, che reggono i quattro archi: cioè i tre delle crocere, dove sono le cappelle, e quello maggiore della nave del mezzo. La quale opera merita certo di essere celebrata per la migliore che Antonio facesse già mai, e non senza ragionevole cagione: perciò che coloro che fanno di nuovo alcun'opera o la levano dai fondamenti hanno facultà di potere alzarsi, abbassarsi e condurla a quella perfezzione che vogliono e fanno migliore, senza essere da alcuna cosa impediti; il che non aviene a chi ha da regolare o restaurare le cose cominciate da altri, e mal condotte o dall'artefice o dagl'avenimenti della fortuna, onde si può di-re che Antonio risuscitasse un morto e facesse quello che quasi non era possibile. E fatte queste cose, ordinò ch'ella si coprisse di piombo, e diede ordine come si avesse a condurre quello che restava da farsi, e così per opera di lui ebbe quel famoso tempio miglior forma e miglior grazia che prima non aveva, e speranza di lunghissima vita.
Tornato poi a Roma, dopo che quella città era stata messa a sacco, avendosi il papa in Orvieto, vi pativa la corte grandissimo disagio d'acqua. Onde, come volle il Pontefice, murò Antonio un pozzo tutto di pietra in quella città, largo venticinque braccia, con due scale a chiocciola intagliate nel tufo, l'una sopra l'altra, secondo che il pozzo girava; nel fondo del qual pozzo si scende, per le dette due scale a lumaca, in tal maniera che le bestie che vanno per l'acqua entra-no per una porta e calano per una delle due scale, e arrivate in sul ponte, dove si carica l'acqua, senza tornare indietro passano all'altro ramo della lumaca, che gira sopra quella della scesa, e per un'altra porta diversa, e contraria alla prima, riescono fuori del pozzo. La qual opera, che fu cosa ingegnosa, comoda e di maravigliosa bellezza, fu condotta quasi a fine inanzi che Clemente morisse. E perché restava solo a farsi la bocca di esso pozzo, la fece finire papa Paulo Terzo, ma non come aveva ordinato Clemente col consiglio d'Antonio, che fu molto per così bell'opera comendato. È certo che gl'antichi non fecero mai edifizio pari a questo né d'industria, né d'artifizio; essendo in quello così fatto il tondo del mezzo, che infino al fondo dà lume, per alcune finestre, alle due scale sopra dette. Mentre si faceva quest'opera ordinò l'istesso Antonio la fortezza d'Ancona, la quale fu col tempo condotta al suo fine. Deliberando poi papa Clemente, al tempo che Alessandro de' Medici suo nipote era duca di Fiorenza, di fare in quella città una fortezza inespugnabile, il signor Alessandro Vitelli, Pierfrancesco da Viterbo et Antonio ordinarono e fecero condurre con tanta prestezza quel castello, o vero fortezza, che è tra la porta il Prato e San Gallo, che mai niuna fabbrica simile antica o moderna fu condotta sì tosto al suo termine; et in un torrione, che fu il primo a fondarsi, chiamato il Toso, furono messi molti epigrammi e medaglie, con cirimonie e solennissima pompa. La quale opera è celebrata oggi per tutto il mondo e tenuta inespugnabile.
Fu per ordine d'Antonio condotto a Loreto il Tribolo scultore, Raffaello da Monte Lupo, Francesco di San Gallo al-lora giovane e Simon Cioli, i quali finirono le storie di marmo cominciate per Andrea Sansovino. Nel medesimo luogo condusse Antonio il Mosca fiorentino, intagliatore di marmi eccellentissimo, il quale allora lavorava, come si dirà nella sua vita, un camino di pietra agl'eredi di Pellegrino da Fossombrone, che per cosa d'intaglio riuscì opera divina. Costui, dico, a' preghi d'Antonio si condusse a Loreto, dove fece festoni, che sono divinissimi. Onde con prestezza e diligenza restò l'ornamento di quella camera di Nostra Donna del tutto finito ancor che Antonio in un medesimo tempo allora avesse alle mani cinque opere d'importanza; alle quali tutte, benché fussero in diversi luoghi e lontane l'una dall'altra, di maniera suppliva che non mancò mai da fare a niuna: perché dove egli alcuna volta non poteva così tosto essere, serviva l'aiuto di Batista suo fratello. Le quali cinque opere erano: la detta fortezza di Fiorenza, quella d'Ancona, l'opera di Loreto, il palazzo apostolico et il pozzo d'Orvieto. Morto poi Clemente e creato sommo pontefice Paulo Terzo Farnese, venne Antonio, essendo stato amico del Papa mentre era cardinale, in maggior credito. Per che avendo Sua Santità fatto duca di Castro il signor Pierluigi suo figliuolo, mandò Antonio a fare il disegno della fortezza che quel Duca vi fece fondare, e del palazzo che è in sulla piazza, chiamato l'Osteria, e della zecca, che è nel medesimo luogo murata di trevertino a similitudine di quella di Roma. Né questi disegni solamente fece Antonio in quella città, ma ancora molti altri di palazzi et altre fabbriche a diverse persone terrazzane e forestiere, che edificarono con tanta spesa, che a chi non le vede pare incredibile, così sono tutte fatte senza risparmio, ornate et agiatissime. Il che non ha dubbio fu fatto da molti per far piacere al Papa, essendo che anco con questi mezzi, secondo l'umore de' principi, si vanno molto procacciando favori. Il che non è se non cosa lodevole, venendone commodo, utile e piacere all'universale.
L'anno poi che Carlo Quinto imperadore tornò vittorioso da Tunizi, essendogli stati fatti in Messina, in Puglia et in Napoli onoratissimi archi, pel trionfo di tanta vettoria, e dovendo venire a Roma, fece Antonio al palazzo di San Marco, di comessione del Papa, un arco trionfale di legname in sotto squadra, acciò che potesse servire a due strade, tanto bello, che per opera di legname non s'è mai veduto il più superbo né il più proporzionato. E se in cotale opera fusse stata la superbia e la spesa de' marmi come vi fu studio, artifizio e diligenza nell'ordine e nel condurlo, si sarebbe potuto meritamente, per le statue e storie dipinte et altri ornamenti, fra le sette moli del mondo annoverare. Era questo arco, posto in sull'ultimo canto che volge alla piazza principale, d'opera corinta con quattro colonne tonde per banda messe d'argen-to, et i capitegli intagliati con bellissime foglie tutti messi d'oro da ogni banda, erano bellissimi architravi, fregii e cornicioni posati con risalti sopra ciascuna colonna, fra le quali erano due storie dipinte per ciascuna, tal che faceva uno spartimento di quattro storie per banda, che erano fra tutte dua le bande otto storie, dentrovi - come si dirà altrove da chi le dipinse - i fatti dello imperadore; eravi ancora per più richezza per finimento del frontespizio da ogni banda sopra detto arco, dua figure di rilievo di braccia quattro e mezza l'una, fatte per una Roma; e le mettevano in mezzo dua imperatori di casa d'Austria, che dinanzi erano Alberto e Massimiliano, e da l'altra parte Federigo e Ridolfo, e così da ogni parte in su' cantoni erano quattro prigioni, dua per banda, con gran numero di trofei pur di rilievo, e l'arme di Sua Santità e di Sua Maestà, tutte fatte condurre con l'ordine di Antonio da scultori eccellenti e dai miglior pittori che fussino al-lora a Roma. E non solo questo arco fu da Antonio ordinato, ma tutto l'apparato della festa, che si fece per ricevere un sì grande et invittissimo imperadore.
Seguitò poi il medesimo, per lo detto duca di Castro, la fortezza di Nepi e la fortificazione di tutta la città, che è inespugnabile e bella. Dirizzò nella medesima città molte strade, e per i cittadini di quella fece disegni di molte case e palazzi. Facendo poi fare Sua Santità i bastioni di Roma, che sono fortissimi, e venendo fra quelli compresa la porta di Santo Spirito, ella fu fatta con ordine e disegno d'Antonio, con ornamento rustico di trevertini, in maniera molto soda e molto rara, con tanta magnificenza, ch'ella pareggia le cose antiche. La quale opera dopo la morte d'Antonio fu chi cercò, più da invidia mosso che da alcuna ragionevole cagione, per vie straordinarie di farla rovinare, ma non fu permesso da chi poteva. Fu con ordine del medesimo rifondato quasi tutto il palazzo apostolico che, oltre quello che si è detto in altri luoghi molti, minacciava rovina; et in un fianco particolarmente la cappella di Sisto, dove sono l'opere di Michelagnolo, e similmente la facciata dinanzi, senza che mettesse un minimo pelo: cosa più di pericolo che d'onore. Accrebbe la sala grande della detta cappella di Sisto, facendovi in due lunette in testa quelle finestrone terribili, con sì maravigliosi lumi, e con que' partimenti buttati nella volta, e fatti di stucco tanto bene e con tanta spesa, che questa si può mettere per la più bella e ricca sala, che infino allora fusse nel mondo. Et in su quella accompagnò, per potere andare in San Pietro, alcune scale così comode e ben fatte, che fra l'antiche e moderne non si è veduto ancor meglio. E similmente la cappella Paulina, dove si ha da mettere il Sacramento, che è cosa vezzosissima e tanto bella, e sì bene misurata e partita, che per la grazia che si vede pare che ridendo e festeggiando ti s'appresenti. Fece Antonio la fortezza di Perugia, nelle discordie che furono tra i perugini et il Papa. La quale opera (nella quale andarono per terra le case de' Baglioni) fu finita con prestezza maravigliosa, e riuscì molto bella. Fece ancora la fortezza d'Ascoli, e quella in pochi giorni condusse a tal termine, ch'ella si poteva guardare. Il che gl'ascolani et altri non pensavano che si dovesse poter fare in molti anni. Onde avenne nel mettervi così tosto la guardia, che que' popoli restarono stupefatti, e quasi non credevano. Rifondò ancora in Roma, per difendersi dalle piene quando il Tevere ingrossa, la casa sua in strada Giulia. E non solo diede principio, ma condusse a buon termine il palazzo che egli abitava vicino a San Biagio, che oggi è del cardinale Riccio da Monte Pulciano, che l'ha finito con grandissima spesa e con ornatissime stanze, oltre quelle che Antonio vi aveva speso, che erano state migliaia di scudi.
Ma tutto quello che Antonio fece di giovamento e d'utilità al mondo è nulla a paragone del modello della venerandissima e stupendissima fabbrica di San Pietro di Roma. La quale, essendo stata a principio ordinata da Bramante, egli con ordine nuovo e modo straordinario l'aggrandì e riordinò, dandole proporzionata composizione e decoro, così nel tutto come ne' membri, come si può vedere nel modello fatto per mano d'Antonio d'Abaco suo creato, di legname, et interamente finito; il quale modello, che diede ad Antonio nome grandissimo, con la pianta di tutto l'edifizio sono stati dopo la morte d'Antonio Sangallo messi in istampa dal detto Antonio d'Abaco, il quale ha voluto perciò mostrare quanta fusse la virtù del Sangallo, e che si conosca da ogni uomo il parere di quell'architetto, essendo stati dati nuovi ordini in contrario da Michelagnolo Buonarroti; per la quale riordinazione sono poi nate molte contese, come si dirà a suo luogo. Pareva a Michelagnolo, et a molti altri ancora che hanno veduto il modello del Sangallo e quello che da lui fu messo in opera, che il componimento d'Antonio venisse troppo sminuzzato dai risalti e dai membri, che sono piccoli, sì come anco sono le colonne, archi sopra archi e cornici sopra cornici. Oltre ciò pare che non piaccia che i due campanili che vi faceva, le quattro tribune piccole e la cupola maggiore, avessino quel finimento o vero ghirlanda di colonne molte e piccole; e parimente non piacevano molto, e non piacciono, quelle tante aguglie che vi sono per finimento, parendo che in ciò detto modello immiti più la maniera et opera tedesca, che l'antica e buona che oggi osservano gl'architetti migliori.
Finito dall'Abaco tutti i detti modelli, poco dopo la morte d'Antonio, si trovò che detto modello di San Pietro costò (quanto apartiene solamente all'opere de' legnaiuoli e legname) scudi quattromilacentoottantaquattro. Nel che fare Antonio Abaco, che n'ebbe cura, si portò molto bene, essendo molto intendente delle cose d'architettura, come ne dimostra il suo libro stampato delle cose di Roma, che è bellissimo. Il qual modello, che si truova oggi in San Piero nella cappella maggiore, è lungo palmi trentacinque e largo 26 et alto palmi venti e mezzo. Onde sarebbe venuta l'opera, secondo questo modello, lunga palmi 1040, cioè canne 104, e larga palmi 360, che sono canne 36, perciò che secondo la misura de' muratori, la canna che corre a Roma è dieci palmi. Fu donato ad Antonio, per la fatica di questo suo modello e molti desegni fatti, dai deputati sopra la fabbrica di S. Pietro, scudi millecinquecento, de' quali n'ebbe contanti mille et il restante non riscosse, essendo poco dopo tal opera passato all'altra vita. Ringrossò i pilastri della detta chiesa di S. Pietro, acciò il peso di quella tribuna posasse gagliardamente; e tutti i fondamenti sparsi empié di soda materia e fece in modo forti, che non è da dubitare che quella fabrica sia per fare più peli o minacciare rovina, come fece al tempo di Bramante. Il qual magisterio, se fusse sopra la terra, come è nascosto sotto, farebbe sbigottire ogni terribile ingegno. Per le quali cose la fama et il nome di questo mirabile artefice doverà aver sempre luogo fra i più rari intelletti.
Trovasi che infino al tempo degl'antichi Romani sono stati e sono ancora, gl'uomini di Terni e quelli di Narni inimicissimi fra loro; perciò che il lago delle Marmora, alcuna volta tenendo in collo, faceva violenza all'uno de' detti popoli: onde, quando quei di Narni lo vedevano aprire, i ternani in niun modo ciò volevano acconsentire; per lo che è sempre stato diffidenza fra loro, o abbiano governato Roma i pontefici, o sia stata soggetta agl'imperatori. Et al tempo di Cicerone fu egli mandato dal senato a comporre tal differenza, ma si rimase non risoluta. Laonde, essendo per questa medesima cagione l'anno 1546 mandati ambasciadori a papa Paulo Terzo, egli mandò loro Antonio a terminar quella lite. E così per giudizio di lui fu risoluto che il detto lago da quella banda dove è il muro dovesse sboccare; e lo fece Antonio con grandissima difficultà tagliare. Onde avenne, per lo caldo che era grande et altri disagi, essendo Antonio pur vecchio e cagionevole, che si ammalò di febre in Terni, e non molto dopo rendé l'anima. Di che sentirono gl'amici e parenti suoi infinito dolore, e ne patirono molte fabriche, ma particolarmente il palazzo de' Farnesi, vicino a campo di Fiore.
Aveva papa Paulo Terzo, quando era Alessandro cardinal Farnese, condotto il detto palazzo a bonissimo termine, e nella facciata dinanzi fatto parte del primo finestrato, la sala di dentro, et aviata una banda del cortile, ma non però era tanto innanzi questa fabbrica, che si vedesse la sua perfezzione; quando, essendo creato Pontefice, Antonio alterò tutto il primo disegno, parendogli avere a fare un palazzo non più da cardinale, ma da pontefice. Rovinate dunque alcune case che gli erano intorno e le scale vecchie, le rifece di nuovo e più dolci, accrebbe il cortile per ogni verso e parimente tutto il palazzo, facendo maggior corpi di sale e maggior numero di stanze e più magnifiche, con palchi d'intaglio bellissimi et altri molti ornamenti. Et avendo già ridotta la facciata dinanzi, col secondo finestrato al suo fine, si aveva solamente a mettere il cornicione, che reggesse il tutto intorno intorno. E perché il Papa, che aveva l'animo grande et era d'ottimo giudicio, voleva un cornicione il più bello e più ricco che mai fusse stato a qual si voglia altro palazzo, volle, oltre quelli che avea fatto Antonio, che tutti i migliori architetti di Roma facessino ciascuno il suo per appiccarsi al migliore, e farlo nondimeno mettere in opera da Antonio. E così una mattina che desinava in Belvedere, gli furono portati inanzi tutti i disegni, presente Antonio. I maestri de' quali furono Perino del Vaga, fra' Bastiano del Piombo, Michelagnolo Buonarruoti e Giorgio Vasari, che allora era giovane e serviva il cardinal Farnese, di commessione del quale e del Papa aveva pel detto cornicione fatto, non un solo, ma due disegni variati. Ben è vero che il Buonarroto non portò il suo da per sé, ma lo mandò per detto Giorgio Vasari, al quale, essendo egli andato a mostrargli i suoi disegni perché gli dicesse l'animo suo come amico, diede Michelagnolo il suo acciò lo portasse al Papa, e facesse sua scusa, che non andava in persona, per sentirsi indisposto.
Presentati dunque tutti i disegni al papa, Sua Santità gli considerò lungamente e gli lodò tutti per ingegnosi e bellissimi, ma quello del divino Michelagnolo sopra tutti. Le quali cose non passavano, se non con malanimo d'Antonio, al quale non piaceva molto questo modo di fare del Papa, et averebbe voluto far egli di suo capo ogni cosa. Ma più gli dispiaceva ancora il vedere che il Papa teneva gran conto d'un Iacopo Melighino ferrarese, e se ne serviva nella fabbrica di San Piero per architetto, ancor che non avesse né disegno, né molto giudizio nelle sue cose, con la medesima provisione che aveva Antonio, al quale toccavano tutte le fatiche. E ciò aveniva perché questo Melighino, essendo state familiare servitore del Papa molti anni senza premio, a Sua Santità piaceva di rimunerarlo per quella via; oltre che aveva cura di Belvedere e d'alcun'altre fabriche del Papa. Poi dunque che il Papa ebbe veduti tutti i sopradetti disegni, disse, e forse per tentare Antonio: “Tutti questi son belli, ma non sarà male che noi veggiamo ancora uno che n'ha fatto il nostro Melighino”. Per che Antonio, risentendosi un poco e parendogli che il papa lo burlasse, disse: “Padre Santo, il Melighino è un architettore da motteggio”. Il che udendo il Papa, che sedeva, si voltò verso Antonio e gli rispose, chinandosi con la testa quasi infino in terra: “Antonio, noi vogliamo che Melighino sia un architettore da dovero, e vedetelo alla provisione”. E ciò detto si partì licenziandoci tutti. Et in ciò volle mostrare che i prìncipi, molte volte, più che i meriti, conducono gl'uomini a quelle grandeze che vogliono. Questa cornice fu poi fatta da Michelagnolo, come si dirà nella vita di lui, che rifece quasi in altra forma tutto quel palazzo.
Rimase, dopo la morte d'Antonio, Batista Gobbo suo fratello, persona ingegnosa, che spese tutto il tempo nelle fabbriche d'Antonio, che non si portò molto bene verso lui. Il quale Batista non visse molti anni dopo la morte d'Antonio, e morendo lasciò ogni suo avere alla Compagnia della Misericordia de' fiorentini in Roma, con carico che gl'uomini di quella facessino stampare un suo libro d'osservazioni sopra Vitruvio. Il quale libro non è mai venuto in luce, et è openione che sia buon'opera, perché intendeva molto bene le cose dell'arte, et era d'ottimo giudizio e sincero e da bene.
Ma tornando ad Antonio, essendo egli morto in Terni, fu condotto a Roma, con pompa grandissima portato alla sepoltura, accompagnandolo tutti gl'artefici del disegno e molti altri. E dopo fu dai soprastanti di San Pietro fatto mettere il corpo suo in un diposito vicino alla capella di papa Sisto in S. Pietro con l'infrascritto epitaffio:
Antonio Sancti Galli florentino, urbe munienda ac publicis operibus, praecipueque Divi Petri templo ornando architectorum facile principi, dum Velini lacus emissionem parat, Paulo Pontifice Maximo auctore, inter amne intempestive extincto, Isabella Deta uxor moestissima posuit 1546. III. calendis octobris.
E per vero dire, essendo stato Antonio eccellentissimo architettore, merita non meno di essere lodato e celebrato, come le sue opere ne dimostrano, che qual si voglia altro architettore antico o moderno.
VITA DI GIULIO ROMANO
PITTORE

Fra i molti, anzi infiniti, discepoli di Raffaello da Urbino, dei quali la maggior parte riuscirono valenti, niuno ve n'ebbe che più lo immitasse nella maniera, invenzione, disegno e colorito di Giulio Romano, né chi fra loro fusse di lui più fondato, fiero, sicuro, capriccioso, vano, abondante et universale; per non dire al presente, che egli fu dolcissimo nella conversazione, ioviale, affabile, grazioso e tutto pieno d'ottimi costumi. Le quali parti furono cagione che egli fu di maniera amato da Raffaello, che se gli fusse stato figliuolo, non più l'arebbe potuto amare. Onde avvenne che si servì sempre di lui nell'opere di maggiore importanza, e particolarmente nel lavorare le logge papali per Leone Decimo. Per che, avendo esso Raffaello fatto i disegni dell'architettura, degl'ornamenti e delle storie, fece condurre a Giulio molte di quelle pitture; e fra l'altre la creazione di Adamo et Eva, quella degl'animali, il fabricare dell'Arca di Noè, il sacrifizio, e molte altre opere che si conoscono alla maniera, come è quella dove la figliuola di Faraone, con le sue donne, trova Moisè nella cassetta gettato nel fiume dagl'Ebrei; la quale opera è maravigliosa per un paese molto ben condotto. Aiutò anco a Raffaello colorire molte cose nella camera di torre Borgia dove è l'incendio di Borgo, e particolarmente l'imba-samento fatto di colore di bronzo, la contessa Matilda, il re Pipino, Carlo Magno, Gottifredi Buglioni re di Ierusalem con altri benefattori della chiesa, che sono tutte bonissime figure. Parte della quale storia uscì fuori in istampa non è molto, tolta da un disegno di mano di esso Giulio; il quale lavorò anco la maggior parte delle storie che sono in fresco nella loggia di Agostin Chigi, et a olio lavorò sopra un bellissimo quadro d'una Santa Lisabetta, che fu fatto da Raffaello, e mandato al re Francesco di Francia insieme con un altro quadro d'una Santa Margherita, fatto quasi interamente da Giulio col disegno di Raffaello, il quale mandò al medesimo re il ritratto della vicereina di Napoli, il quale non fece Raffaello altro che il ritratto della testa di naturale, et il rimanente finì Giulio. Le quali opere, che a quel re furono gratissime, sono ancora in Francia a Fontanableò, nella cappella del re.
Adoperandosi dunque in questa maniera Giulio in servigio di Raffaello suo maestro, et imparando le più difficili cose dell'arte, che da esso Raffaello gl'erano con incredibile amorevolezza insegnate, non andò molto che seppe benissimo tirare in prospettiva, misurare gl'edifizii e lavorar piante. E disegnando alcuna volta Raffaello, e schizzando a modo suo l'invenzioni, le faceva poi tirar misurate e grandi a Giulio, per servirsene nelle cose d'architettura. Della quale cominciando a dilettarsi Giulio, vi attese di maniera, che poi esercitandola venne eccellentissimo maestro.
Morto Raffaello e rimasi eredi di lui Giulio e Giovanfrancesco detto il Fattore, con carico di finire l'opere da esso Raffaello incominciate, condussero onoratamente la maggior parte a perfezzione. Dopo avendo Giulio cardinale de' Medici, il qual fu poi Clemente Settimo, preso un sito in Roma sotto Monte Mario, dove oltre una bella veduta, erano acque vive, alcune boscaglie in ispiaggia et un bel piano che, andando lungo il Tevere per fino a ponte Molle, aveva da una banda e dall'altra una largura di prati che si estendeva quasi fino alla porta di San Piero, disegnò nella sommità del-la spiaggia, sopra un piano che vi era, fare un palazzo con tutti gl'agi e commodi di stanze, logge, giardini, fontane, boschi et altri, che si possono più belli e migliori desiderare, e diede di tutto il carico a Giulio, il quale, presolo volentieri e messovi mano, condusse quel palagio, che allora si chiamò la vigna de' Medici et oggi di Madama, a quella perfezzione che di sotto si dirà. Accommodandosi dunque alla qualità del sito et alla voglia del cardinale, fece la facciata dinanzi di quello in forma di mezzo circolo a uso di teatro con uno spartimento di nicchie e finestre d'opera ionica, tanto lodato che molti credono che ne facesse Raffaello il primo schizzo, e poi fusse l'opera seguitata e condotta a perfezzione da Giulio. Il quale vi fece molte pitture nelle camere et altrove, e particolarmente, passato il primo ricetto dell'entra-ta, in una loggia bellissima, ornata di nicchie grandi e piccole intorno, nelle quali è gran quantità di statue antiche: e fra l'altre vi era un Giove, cosa rara, che fu poi dai Farnesi mandato al re Francesco di Francia, con molte altre statue bellissime. Oltre alle quali nicchie ha la detta loggia lavorata di stucchi e di tutte dipinte le parieti e le volte con molte grottesche di mano di Giovanni da Udine. In testa di questa loggia fece Giulio in fresco un Polifemo grandissimo con infinito numero di fanciulli e satirini che gli giuocano intorno. Di che riportò Giulio molta lode, sì come fece ancora di tutte l'opere e disegni che [fece] per quel luogo, il quale adornò di peschiere, pavimenti, fontane rustiche, boschi et altre cose simili, tutte bellissime e fatte con bell'ordine e giudizio. Ben è vero che sopravenendo la morte di Leone, non fu per allora altrimenti seguitata quest'opera; perché creato nuovo pontefice Adriano, e tornatosene il cardinal de' Medici a Fiorenza, restarono indietro, insieme con questa, tutte l'opere publiche cominciate dal suo antecessore.
Giulio, intanto, e Giovanfrancesco diedero fine a molte cose di Raffaello ch'erano rimaste imperfette, e s'apparec-chiavano a mettere in opera parte de' cartoni, che egli avea fatto per le pitture della sala grande del palazzo, nella quale aveva Raffaello cominciato a dipignere quattro storie de' fatti di Gostantino imperatore, et aveva, quando morì, coperta una facciata di mistura per lavorarvi sopra a olio, quando s'avvidero Adriano, come quello che né di pitture o sculture, né d'altra cosa buona si dilettava, non si curare ch'ella si finisse altrimenti. Disperati adunque Giulio e Giovanfrancesco, et insieme con esso loro Perino del Vaga, Giovanni da Udine, Bastiano Viniziano e gli altri artefici eccellenti, furono poco meno (vivente Adriano) che per morirsi di fame. Ma come volle Dio, mentre che la corte avezza nelle grandezze di Leone era tutta sbigottita, e che tutti i migliori artefici andavano pensando dove ricoverarsi, vedendo niuna virtù essere più in pregio, morì Adriano e fu creato sommo pontefice Giulio cardinale de' Medici, che fu chiamato Clemente Settimo: col quale risuscitarono in un giorno, insieme con l'altre virtù, tutte l'arti del disegno. E Giulio e Giovanfrancesco si misero subito d'ordine del Papa a finire tutti lieti la detta sala di Gostantino, e gettarono per terra tutta la facciata coperta di mistura per dovere essere lavorata a olio; lasciando però nel suo essere due figure, ch'eglino avevano prima dipinte a olio, che sono per ornamento intorno a certi papi: e ciò furono una Iustizia et un'altra figura simile.
Era il partimento di questa sala, perché era bassa, stato con molto giudizio disegnato da Raffaello, il quale aveva messo ne' canti di quella, sopra tutte le porte, alcune nicchie grandi, con ornamento di certi putti che tenevano diverse imprese di Leone, gigli, diamanti, penne et altre imprese di casa Medici. E dentro alle nicchie sedevano alcuni papi in pontificale con un'ombra per ciascuno dentro alla nicchia. Et intorno ai detti papi erano alcuni putti a uso d'Angioletti, che tenevano libri et altre cose a proposito in mano. E ciascun papa aveva dalle bande due virtù, che lo mettevano in mezzo, secondo che più aveva meritato; e come Pietro apostolo aveva da un lato la Religione, dall'altro la Carità o vero Pietà, così tutti gli altri avevano altre simili virtù, et i detti papi erano Damaso Primo, Alessandro Primo, Leon Terzo, Gregorio, Salvestro et alcuni altri: i quali tutti furono tanto bene accommodati e condotti da Giulio, il quale in quest'o-pera a fresco fece i migliori che si conosce, che vi durò fatica e pose diligenza, come si può vedere in una carta d'un San Salvestro, che fu da lui proprio molto ben disegnata, et ha forse molto più grazia che non ha la pittura di quello; benché si può affermare che Giulio esprimesse sempre meglio i suoi concetti ne' disegni, che nell'operare o nelle pitture, vedendosi in quelli più vivacità, fierezza et affetto. E ciò potette forse avvenire perché un disegno lo faceva in un'o-ra, tutto fiero et acceso nell'opera, dove nelle pitture consumava i mesi e gl'anni; onde, venendogli a fastidio, e mancando quel vivo et ardente amore che si ha quando si comincia alcuna cosa, non è maraviglia se non dava loro quell'intera perfezzione che si vede ne' suo' disegni.
Ma tornando alle storie, dipinse Giulio in una delle faccie un parlamento che Gostantino fa a' soldati, dove in aria appare il segno della croce in uno splendore con certi putti e lettere che dicono: “In hoc signo vinces”. Et un nano che a' piedi di Gostantino si mette una celata in capo è fatto con molta arte. Nella maggior facciata poi, è una battaglia di cavalli, fatta vicino a ponte Molle, dove Gostantino mise in rotta Massenzio. La quale opera, per i feriti e morti che vi si veggiono, e per le diverse e strane attitudini de' pedoni e cavalieri che combattono aggruppati, fatti fieramente, è lodatissima, senzaché vi sono molti ritratti di naturale. E se questa storia non fusse troppo tinta e cacciata di neri, di che Giulio si dilettò sempre ne' suoi coloriti, sarebbe del tutto perfetta; ma questo le toglie molta grazia e bellezza. Nella medesima fece tutto il paese di Monte Mario, e nel fiume del Tevere Massenzio, che sopra un cavallo, tutto terribile e fiero, aniega. Insomma si portò di maniera Giulio in quest'opera, che per così fatta sorte di battaglia, ell'è stata gran lume a chi ha fatto cose simili doppo lui, il quale imparò tanto dalle colonne antiche di Traiano e d'Antonino che sono in Roma, che se ne valse molto ne gl'abiti de' soldati, nell'armadure, insegne, bastioni, steccati, arieti et in tutte l'altre cose da guerra, che sono dipinte per tutta quella sala. E sotto queste storie dipinse di color di bronzo intorno intorno molte cose, che tutte son belle e lodevoli. Nell'altra facciata fece San Salvestro papa che battezza Gostantino, figurando il proprio bagno che è oggi San Giovanni Laterano, fatto da esso Gostantino, e vi ritrasse papa Clemente di naturale nel San Salvestro che battezza, con alcuni asistenti parati e molti popoli. E fra molti familiari del Papa, che vi ritrasse similmente di naturale, vi ritrasse il Cavalierino, che allora governava Sua Santità, Messer Niccolò Vespucci cavaliere di Rodi; e sotto questa nel basamento fece, in figure finte di bronzo, Gostantino che fa murare la chiesa di San Piero in Roma, alludendo a papa Clemente, et in queste ritrasse Bramante architetto e Giulian Lemi col disegno in mano della pianta di detta chiesa, che è molto bella storia.
Nella quarta faccia, sopra il camino di detta sala, figurò in prospettiva la chiesa di S. Piero di Roma, con la residenza del Papa in quella maniera che sta quando il papa canta la messa pontificale, con l'ordine de' cardinali et altri prelati di tutta la corte, e la capella de' cantori e musici, et il papa a sedere, figurato per San Salvestro che ha Gostantino a' pie-di ginocchioni, il quale gli presenta una Roma d'oro fatta come quelle che sono nelle medaglie antiche: volendo per ciò dimostrare la dote che esso Gostantino diede alla chiesa romana. Fece Giulio in questa storia molte femine che ginocchioni stanno a vedere cotale cerimonia, le quali sono bellissime, et un povero che chiede la limosina, un putto sopra un cane che scherza, et i lanzi della guardia del papa che fanno far largo e star indietro il popolo, come si costuma. E fra i molti ritratti che in questa opera sono, vi si vede di naturale esso Giulio pittore et il conte Baldassarre Castiglioni formator del Cortigiano e suo amicissimo, il Pontano, il Marullo e molti altri letterati e cortigiani. Intorno e fra le finestre dipinse Giulio molte imprese e poesie che furono vaghe e capricciose, onde piacque molto ogni cosa al Papa, il quale lo premiò di cotale fatiche largamente.
Mentre che questa sala si dipigneva, non potendo essi sodisfar anco in parte agl'amici, fecero Giulio e Giovanfrancesco in una tavola una assunzione di Nostra Donna che fu bellissima, la quale fu mandata a Perugia e posta nel monasterio delle monache di Montelucci. E dopo Giulio ritiratosi da sé solo, fece in un quadro una Nostra Donna con una gatta dentrovi, tanto naturale che pareva vivissima: onde fu quel quadro chiamato il quadro della gatta. In un altro quadro grande fece un Cristo battuto alla colonna, che fu posto sopra l'altare della chiesa di Santa Prasedia in Roma. Né molto dopo Messer Giovanmatteo Giberti, che fu poi vescovo di Verona, che allora era datario di papa Clemente, fece far a Giulio, che era molto suo dimestico amico, il disegno d'alcune stanze che si murarono di mattoni vicino alla porta del palazzo del papa, le quali rispondono sopra la piazza di San Piero, dove stanno a sonare i trombetti quando i cardinali vanno a Concistoro, con una salita di commodissime scale che si possono salire a cavallo et a piedi. Al medesimo Messer Giovan Matteo fece in una tavola una lapidazione di Santo Stefano, la quale mandò a un suo benefizio in Genova, intitolato S. Stefano; nella qual tavola, che è per invenzione, grazia e componimento bellissima, si vede, mentre i Giudei lapidano S. Stefano, il giovane Saulo sedere sopra i panni di quello. Insomma non fece mai Giulio la più bell'o-pera di questa, per le fiere attitudini de' lapidatori e per la bene espressa pacienza di Stefano; il quale pare che veramente veggia sedere Gesù Cristo alla destra del Padre in un cielo dipinto divinamente. La quale opera insieme col benefizio diede Messer Giovan Matteo a' monaci di Monte Oliveto, che n'hanno fatto un monasterio.
Fece il medesimo Giulio a Iacopo Fuccheri tedesco, per una cappella che è in Santa Maria de Anima in Roma, una bellissima tavola a olio, nella quale è la Nostra Donna, S. Anna, S. Giuseppo, San Iacopo, San Giovanni putto e ginocchioni e San Marco Evangelista che ha un leone a' piedi, il quale standosi a giacere con un libro, ha i peli che vanno girando secondo ch'egli è posto. Il che fu difficile e bella considerazione, senza che il medesimo leone ha corte ale sopra le spalle con le penne così piumose e morbide, che non pare quasi da credere che la mano d'un artefice possa cotanto imitare la natura. Vi fece oltre ciò un casamento che gira a uso di teatro in tondo, con alcune statue così belle e bene accommodate, che non si può veder meglio. E fra l'altre, vi è una femina che filando guarda una sua chioccia et alcuni pulcini, che non può esser cosa più naturale. E sopra la Nostra Donna sono alcuni putti che sostengono un padiglione molto ben fatti e graziosi. E se anco questa tavola non fusse stata tanto tinta di nero, onde è diventata scurissima, certo sarebbe stata molto migliore. Ma questo nero fa perdere o smarrire la maggior parte delle fatiche che vi sono dentro; conciò sia che il nero, ancora che sia vernicato, fa perdere il buono, avendo in sé sempre dell'alido, o sia carbone o avorio abruciato o nero di fumo o carta arsa.
Fra molti discepoli ch'ebbe Giulio mentre lavorò queste cose, i quali furono Bartolomeo da Castiglioni, Tommaso Paperello cortonese, Benedetto Pagni da Pescia, quegli di cui più familiarmente si serviva fu Giovanni da Lione e Raffaello dal Colle del Borgo San Sepolcro, l'uno e l'altro de' quali nella sala di Gostantino e nell'altre opere, delle quali si è ragionato, avevano molte cose aiutato a lavorare. Onde non mi par da tacere che, essendo essi molto destri nel dipignere e molto osservando la maniera di Giulio nel mettere in opera le cose che disegnava loro, eglino colorirono col disegno di lui, vicino alla Zecca vecchia in Banchi, un'arme di papa Clemente Settimo; cioè la metà ciascuno di loro, con due figure a uso di termini, che mettono la detta arme in mezzo. Et il detto Raffaello, non molto doppo, col disegno d'un cartone di Giulio dipinse a fresco dentro la porta del palazzo del cardinale della Valle, in un mezzo tondo, una Nostra Donna che con un panno cuopre un fanciullo che dorme, e da una banda sono S. Andrea apostolo e dall'altra S. Niccolò: che fu tenuta, con verità, pittura eccellente.
Giulio in tanto, essendo molto dimestico di Messer Baldassarri Turrini da Pescia, fatto il disegno e modello, gli condusse sopra il monte Ianicolo, dove sono alcune vigne che hanno bellissima veduta, un palazzo con tanta grazia e tanto commodo, per tutti quegl'agi che si possono in un sì fatto luogo disiderare, che più non si può dire. Et oltre ciò furono le stanze non solo adornate di stucchi, ma di pittura ancora, avendovi egli stesso dipinto alcune storie di Numa Pompilio che ebbe in quel luogo il suo sepolcro. Nella stufa di questo palazzo dipinse Giulio alcune storie di Venere e d'Amore, e d'Apollo e di Iacinto con l'aiuto de' suoi giovani, che tutti sono in istampa. Et essendosi del tutto diviso da Giovanfrancesco, fece in Roma diverse opere d'architettura, come fu il disegno della casa degli Alberini in Banchi, se bene alcuni credono che quell'ordine venisse da Raffaello; e così un palazzo, che oggi si vede sopra la piazza della Do-gana di Roma, che è stato per essere di bello ordine posto in istampa. E per sé fece sopra un canto del Macello de' Corbi, dove era la sua casa nella quale egli nacque, un bel principio di finestre, il quale, per poca cosa che sia, è molto grazioso. Per le quali sue ottime qualità, essendo Giulio dopo la morte di Raffaello per lo migliore artefice d'Italia celebrato, il conte Baldassarre Castiglioni, che allora era in Roma ambasciadore di Federigo Gonzaga, marchese di Mantova et amicissimo come s'è detto di Giulio, essendogli dal marchese suo signore comandato che procacciasse di mandargli un architettore per servirsene ne' bisogni del suo palagio e della città, e particolarmente che arebbe avuto carissimo Giulio, tanto adoperò il conte con prieghi e con promesse, che Giulio disse che andrebbe ogni volta, pur che ciò fusse con licenza di papa Clemente. La quale licenza ottenuta, nell'andare il conte a Mantova, per quindi poi andare, mandato dal Papa, all'imperadore, menò Giulio seco, et arrivato, lo presentò al marchese che, dopo molte carezze, gli fece dar una casa fornita orrevolmente e gl'ordinò provisione, et il piatto per lui, per Benedetto Pagni suo creato e per un altro giovane che lo serviva; e, che è più, gli mandò il marchese parecchie canne di veluto e raso, altri drappi e panni per vestir-si; e dopo, intendendo che non aveva cavalcatura, fattosi venire un suo favorito cavallo chiamato Luggeri, glielo donò; e montato che Giulio vi fu sopra, se n'andarono fuor della porta di S. Bastiano, lontano un tiro di balestra, dove sua eccellenza aveva un luogo e certe stalle chiamato il T., in mezzo a una prateria, dove teneva la razza de' suoi cavalli e ca-valle. E quivi arrivati, disse il marchese che arebbe voluto, senza guastare la muraglia vecchia, accomodare un poco di luogo da potervi andare e ridurvisi tal volta a desinare, o a cena per ispasso.
Giulio, udita la volontà del marchese, veduto il tutto, e levata la pianta di quel sito, mise mano all'opera; e servendosi delle mura vecchie fece in una parte maggiore la prima sala, che si vede oggi all'entrare, col seguito delle camere che la mettono in mezzo. E perché il luogo non ha pietre vive, né commodi di cave da potere far conci e pietre intagliate, come si usa nelle muraglie da chi può farlo, si servì di mattoni e pietre cotte, lavorandole poi di stucco. E di questa materia fece colonne, base, capitegli, cornici, porte, finestre et altri lavori, con bellissime proporzioni: e con nuova e stravagante maniera gl'ornamenti delle volte, con spartimenti dentro bellissimi e con ricetti riccamente ornati. Il che fu cagione che, da un basso principio, si risolvesse il marchese di far poi tutto quello edifizio a guisa d'un gran palazzo, perché Giulio fatto un bellissimo modello, tutto fuori e dentro nel cortile d'opera rustica, piacque tanto a quel signore che, ordinata buona provisione di danari e da Giulio condotti molti maestri, fu condotta l'opera con brevità al suo fine. La forma del quale palazzo è così fatta: è questo edifizio quadro et ha nel mezzo un cortile scoperto a uso di prato, o vero piazza, nella quale sboccano in croce quattro entrate. La prima delle quali in prima vista trafora, o vero passa, in una grandissima loggia che sbocca per un'altra nel giardino, e due altre vanno a diversi appartamenti, e queste sono ornate di stucchi e di pitture. E nella sala, alla quale dà entrata la prima, è dipinta in fresco la volta fatta in varii spartimenti, e nelle facciate sono ritratti di naturale tutti i cavalli più belli e più favoriti della razza del marchese, et insieme con essi i cani di quello stesso mantello, o macchie, che sono i cavalli, co' nomi loro; che tutti furono disegnati da Giulio e coloriti sopra la calcina a fresco da Benedetto Pagni e da Rinaldo Mantovano, pittori e suoi creati, e nel vero così bene che paiono vivi. Da questa si cammina in una stanza, che è in sul canto del palazzo, la quale ha la volta fatta con spartimento bellissimo di stucchi e con variate cornici, in alcuni luoghi tocche d'oro. E queste fanno un partimento con quattro ottangoli, che levano nel più alto della volta con quadro, nel quale è Cupido, che nel cospetto di Giove (che è abbagliato nel più alto da una luce celeste), sposa alla presenza di tutti gli dèi Psiche. Della quale storia non è possibile veder casa fatta con più grazia e disegno; avendo Giulio fatto scortare quelle figure con la veduta al disotto in su tanto bene, et alcune di quelle non sono affatica lunghe un braccio, e si mostrano nella vista da terra di tre braccia nell'altezza. E nel vero sono fatte con mirabili arte et ingegno, avendo Giulio saputo far sì che, oltre al parer vive (così hanno rilievo), ingannano con piacevole veduta l'occhio umano. Sono poi negl'ottangoli tutte l'altre prime storie di Psiche, dell'avversi-tà che le avvennero per lo sdegno di Venere, condotte con la medesima bellezza e perfezzione. Et in altri angoli sono molti amori, come ancora nelle finestre, che secondo gli spazii fanno varii effetti: e questa volta è tutta colorita a olio di mano di Benedetto e Rinaldo sopra detti. Il restante, adunque, delle storie di Psiche sono nelle facce da basso, che sono le maggiori, cioè in una a fresco quando Psiche è nel bagno e gl'amori la lavano, et appresso con bellissimi gesti la rasciugano; in un'altra parte s'appresta il convito da Mercurio, mentre ella si lava, con le Baccanti che suonano, dove sono le Grazie che con bellissima maniera fioriscono la tavola; e Sileno, sostenuto da' satiri col suo asino sopra una capra a sedere, ha due putti che gli suggono le poppe, mentre si sta in compagnia di bacco che ha a' piedi due tigri e sta con un braccio appoggiato alla credenza: dall'uno de' lati della quale è un camello e dall'altro un liofante; la qual credenza, che è a mezzo tondo in botte, è ricoperta di festoni di verzure e fiori e tutta piena di viti cariche di grappoli d'uve e di pampani, sotto i quali sono tre ordini di vazi bizzarri, bacini, boccali, tazze, coppe et altri così fatti, con diverse forme e modi fantastichi e tanto lustranti, che paiono di vero argento e d'oro, essendo contrafatti con un semplice colore di giallo e d'altro così bene, che mostrano l'ingegno, la virtù e l'arte di Giulio, il quale in questa parte mostrò esser vario, ricco e copioso d'invenzione e d'artifizio. Poco lontano si vede Psiche che, mentre ha intorno molte femine che la servono e la presentano, vede nel lontano fra i poggi spuntar Febo col suo carro solare, guidato da quattro cavalli, mentre sopra certe nuvole si sta Zefiro tutto nudo a giacere, che soffia, per un corno che ha in bocca, suavissime aure che fanno gioconda e placida l'aria che è d'intorno a Psiche. Le quali storie furono, non sono molti anni, stampate col disegno di Batista Franco viniziano, che le ritrasse in quel modo appunto che elle furono dipinte, con i cartoni grandi di Giulio da Benedetto da Pescia e da Rinaldo Mantovano, i quali misero in opera tutte queste storie, eccetto che il Bacco, il Sileno et i due putti che poppano la capra. Ben è vero che l'opera fu poi quasi tutta ritocca da Giulio, onde è come fusse tutta stata fatta da lui. Il qual modo, che egli imparò da Raffaello suo precettore, è molto utile per i giovani che in esso si esercitano, perché riescono per lo più eccellenti maestri. E se bene alcuni si persuadono essere da più di chi gli fa opera-re, conoscono questi cotali, mancata la guida loro prima che siano al fine, o mancando loro il disegno e l'ordine d'opera-re, che per aver perduta anzi tempo o lasciata la guida, si trovano come ciechi in un mare d'infiniti errori.
Ma tornando alle stanze del T., si passa da questa camera di Psiche in un'altra stanza tutta piena di fregi doppi di figure di basso rilievo, lavorate di stucco, col disegno di Giulio, da Francesco Primaticcio bolognese, allora giovane, e da Giovambatista Mantovano. Ne' quali fregi è tutto l'ordine de' soldati che sono a Roma nella colonna Traiana, lavorati con bella maniera. Et in un palco, o vero soffittato d'una anticamera, è dipinto a olio quando Icaro, ammaestrato dal padre Dedalo, per volere troppo alzarsi volando, veduto il segno del cancro, il carro del sole tirato da quattro cavalli in iscorto vicino al segno del leone, rimane senz'ali, essendo dal calore del sole distrutta la cera; et appresso il medesimo precipitando si vede in aria quasi cascare addosso a chi lo mira, tutto tinto nel volto di color di morte. La quale invenzione fu tanto bene considerata et immaginata da Giulio, ch'ella par proprio vera: perciò che vi si vede il calore del sole, friggendo, abruciar l'ali del misero giovane, il fuoco acceso far fumo, e quasi si sente lo scoppiare delle penne che abruciano, mentre si vede scolpita la morte nel volto d'Icaro et in Dedalo la passione et il dolore vivissimo. E nel nostro libro de' disegni di diversi pittori è il proprio disegno di questa bellissima storia di mano di esso Giulio; il quale fece nel medesimo luogo le storie de' dodici mesi dell'anno e quello che in ciascuno d'essi fanno l'arti più dagl'uomini esercitate; la quale pittura non è meno capricciosa e di bella invenzione e dilettevole, che fatta con giudizio e diligenza. Passata questa loggia grande lavorata di stucchi e con molte armi et altri varii ornamenti bizzarri, s'arriva in certe stanze piene di tante varie fantasie che vi s'abaglia l'intelletto; perché Giulio, che era capricciosissimo et ingegnoso, per mostrare quanto valeva, in un canto del palazzo che faceva una cantonata simile alla sopra detta stanza di Psiche, disegnò di fare una stanza la cui muraglia avesse corrispondenza con la pittura, per ingannare quanto più potesse gl'uomini che dovevano vederla. Fatto dunque fondare quel cantone, che era in luogo paduloso, con fondamenti alti e doppi, fece tirare sopra la cantonata una gran stanza tonda e di grossissime mura, acciò che i quattro cantoni di quella muraglia dalla banda di fuori venissero più gagliardi e potessino regger una volta doppia e tonda a uso di forno. E ciò fatto, avendo quella camera cantoni, vi fece per lo girare di quella a' suoi luoghi murare le porte, le finestre et il camino di pietre rustiche a caso scantonate e quasi in modo scommesse e torte, che parea proprio pendessero in sur un lato e rovinassero veramente. E murata questa stanza così stranamente, si mise a dipignere in quella la più capricciosa invenzione che si potesse trovare, cioè Giove che fulmina i giganti; e così figurato il cielo, nel più alto della volta vi fece il trono di Giove, facendono in iscorto al disotto in su et in faccia e dentro a un tempio tondo sopra le colonne trasforato di componimento ionico e con l'ombrella nel mezzo sopra il seggio, con l'aquila sua, e tutto posto sopra le nuvole; e più a basso fece Giove irato che fulmina i superbi giganti, e più a basso è Giunone che gli aiuta, et intorno i venti che con certi visi strani soffiano verso la terra, mentre la dea Opis si volge con i suoi leoni al terribile rumor de' fulmini, sì come ancor fanno gl'al-tri dei e dee e massimamente Venere, che è a canto a Marte e Momo, che con le braccia aperte pare che dubiti che non rovini il cielo, e non di meno sta immobile. Similmente le Grazie si stanno tutte piene di timore, e l'Ore appresso quelle nella medesima maniera. Et insomma ciascuna deità si mette con i suoi carri in fuga; la luna con Saturno et Iano vanno verso il più chiaro de' nuvoli per allontanarsi da quell'orribile spavento e furore, et il medesimo fa Nettunno, perciò che con i suoi delfini pare che cerchi fermarsi sopra il tridente. E Pallade con le nove Muse sta guardando che cosa orribile sia quella. E Pan, abbracciata una ninfa che trema di paura, pare voglia scamparla da quello incendio e lampi de' fulmini di che è pieno il cielo. Apollo si sta sopra il carro solare, et alcune dell'Ore pare che voglino ritenere il corso de' cavalli. Bacco e Sileno con satiri e ninfe mostrano aver grandissima paura. E Vulcano col ponderoso martello sopra una spalla guarda verso Ercole, che parla di quel caso con Mercurio, il quale si sta allato a Pomona tutta paurosa, come sta anche Vertunno con tutti gl'altri dèi sparsi per quel cielo dove sono tanto bene sparsi tutti gl'effetti della paura, così in coloro che stanno, come in quelli che fuggono, che non è possibile, non che vedere, imaginarsi più bella fantasia di questa in pittura.
Nelle parti da basso, cioè nelle facciate che stanno per ritto, sotto il resto del girare della volta, sono i giganti, alcuni de' quali, sotto Giove, hanno sopra di loro monti et addosso grandissimi sassi, i quali reggono con le forti spalle per fare altezza e salita al cielo, quando s'apparecchia la rovina loro, perché Giove fulminando, e tutto il cielo adirato contra di loro, pare che non solo spaventi il temerario ardire de' giganti, rovinando loro i monti addosso, ma che sia tutto il mondo sotto sopra e quasi al suo ultimo fine. Et in questa parte fece Giulio Briareo in una caverna oscura quasi ricoperto da pezzi altissimi di monti, e gli altri giganti tutti infranti et alcuni morti sotto le rovine delle montagne. Oltre ciò si vede per un straforo nello scuro d'una grotta, che mostra un lontano fatto con bel giudizio, molti giganti fuggire tutti percossi da' fulmini di Giove e quasi per dovere allora essere oppressi dalle rovine de' monti come gl'altri. In un'altra parte figurò Giulio altri giganti, a' quali rovinano sopra tempii, colonne et altri pezzi di muraglie, facendo di quei superbi grandissima strage e mortalità. Et in questo luogo è posto, fra queste muraglie che rovinano, il camino della stanza, il quale mostra, quando vi si fa fuoco, che i giganti ardono, per esservi dipinto Plutone che con il suo carro tirato da cavagli secchi et accompagnato dalle furie infernali si fugge nel centro. E così non si partendo Giulio, con questa invenzione del fuoco, dal proposito della storia, fa ornamento bellissimo al camino. Fece oltre ciò Giulio in quest'opera, per farla più spaventevole e terribile, che i giganti grandi e di strana statura (essendo in diversi modi dai lampi e da' fulgori percossi) rovinato a terra: e quale inanzi e quale a dietro si stanno, chi morto, chi ferito e chi da monti e rovine di edifizii ricoperto. Onde non si pensi alcuno vedere mai opera di pennello più orribile e spaventosa, né più naturale di questa. E chi entra in quella stanza, vedendo le finestre, le porte et altre così fatte cose torcersi e quasi per rovinare, et i monti e gl'edifizii cadere, non può non temere che ogni cosa non gli rovini addosso, vedendo massimamente in quel cielo tutti gli dii andare chi qua e chi là fuggendo. E quello che è in questa opera maraviglioso, è il veder tutta quella pittura non avere principio né fine, et attaccata tutta e tanto bene continuata insieme senza termine o tramezzo di ornamento, che le cose, che sono appresso de' casamenti, paiono grandissime, e quelle che allontanano, dove sono paesi, vanno perdendo in infinito. Onde quella stanza, che non è lunga più di quindici braccia, pare una campagna di paese; senzaché, essendo il pavimento di sassi tondi, piccioli, murati per coltello, et il cominciare delle mura che vanno per diritto dipinte de' medesimi sassi, non vi appare canto vivo e viene a parere quel piano grandissima cosa. Il che fu fatto con molto giudizio e bell'arte da Giulio, al quale per così fatte invenzioni deveno molto gl'artefici nostri.
Diventò in quest'opera perfetto coloritore il sopra detto Rinaldo Mantovano, perché lavorando con i cartoni di Giulio, condusse tutta quest'opera a perfezzione et insieme l'altre stanze. E se costui non fusse stato tolto al mondo così giovane, come fece onore a Giulio mentre visse, così arebbe fatto dopo morte. Oltre a questo palazzo, nel quale fece Giulio molte cose degne di essere lodate, le quali si tacciono sì per fuggire la troppa lunghezza, rifece di muraglia molte stanze del castello dove in Mantova abita il duca, e due scale a lumaca grandissime, con apartamenti ricchissimi et ornati di stucco per tutto. Et in una sala fece dipignere tutta la storia e guerra troiana, e similmente in una anticamera dodici storie a olio, sotte le teste de' dodici imperadori state prima dipinte da Tiziano Vecellio che sono tenute rare. Parimente a Marmiruolo, luogo lontano da Mantova cinque miglia, fu fatta con ordine e disegno di Giulio una commodissima fabbrica e grandi pitture, non men belle che quelle del castello e del palazzo del T. Fece il medesimo, in Santo Andrea di Mantova, alla cappella della signora Isabella Buschetta, in una tavola a olio, una Nostra Donna in atto di adorare il puttino Gesù che giace in terra, e Giuseppo e l'asino et il bue vicini a un presepio, e da una banda San Giovanni Evangelista, e dall'altra San Longino, figure grandi quanto il naturale. Nelle facciate poi di detta cappella, fece colorire a Rinaldo, con suoi disegni, due storie bellissime: cioè in una la Crocifissione di Gesù Cristo con i ladroni et alcuni Angeli in aria, e da basso i crocifissori con le Marie e molti cavalli, de' quali si dilettò sempre e gli fece bellissimi a maraviglia, e molti soldati in varie attitudini; nell'altra fece quando al tempo della contessa Matilda si trovò il sangue di Cristo, che fu opera bellissima. E doppo fece Giulio al duca Federigo in un quadro di sua propria mano la Nostra Donna che lava Gesù Cristo fanciulletto, che sta in piedi dentro a un bacino, mentre San Giovannino getta l'acqua fuor d'un vaso, le quali amendue figure, che sono grandi quanto il naturale, sono bellissime; e dal mezzo in su nel lontano sono di figure piccole alcune gentildonne che vanno a visitarla. Il qual quadro fu poi donato dal duca alla signora Isabella Buschetta. Della quale signora fece poi Giulio il ritratto, e bellissimo, in un quadretto piccolo d'una Natività di Cristo, alto un braccio, che è oggi appresso al signor Vespasiano Gonzaga con un altro quadro donatogli dal duca Federigo, pur di mano di Giulio, nel quale è un giovane et una giovane abbracciati insieme sopra un letto, in atto di farsi carezze, mentre una vecchia dietro a un uscio nascosamente gli guarda. Le quali figure sono poco meno che il naturale e molto graziose. Et in casa il medesimo è in un altro quadro molto eccellente un San Ieronimo bellissimo di mano pur di Giulio. Et appresso del conte Nicola Maffei è un quadro d'uno Alessandro Magno, con una vettoria in mano, grande quanto il naturale, ritratto da una medaglia antica, che è cosa molto bella. Dopo queste opere dipinse Giulio a fresco, per Messer Girolamo organista del Duomo di Mantova suo amicissimo, sopra un camino, a fresco un Vulcano che mena con una mano i mantici e con l'altra, che ha un paio di molle, tiene il ferro d'una freccia che fabrica, mentre Venere ne tempera in un vaso alcune già fatte e le mette nel turcasso di Cupido. E questa è una delle belle opere che mai facesse Giulio, e poco altro in fresco si vede di sua mano. In San Domenico fece per Messer Lodovico da Fermo in una tavola un Cristo morto, il quale s'apparecchiano Giuseppo e Nicodemo di porlo nel sepolcro, et appresso la madre e l'altre Marie e S. Giovanni Evangelista. Et un quadretto, nel quale fece similmente un Cristo morto, è in Vinezia in casa Tommaso da Empoli fiorentino.
In quel medesimo tempo che egli queste et altre pitture lavorava, avenne che il signor Giovanni de' Medici, essendo ferito da un moschetto, fu portato a Mantova dove egli si morì, per che Messer Pietro Aretino, affezzionatissimo servitore di quel signore et amicissimo di Giulio, volle che così morto esso Giulio lo formasse di sua mano. Onde egli fattone un cavo in sul morto, ne fece un ritratto che stette poi molti anni appresso il detto Aretino.
Nella venuta di Carlo Quinto imperatore a Mantova, per ordine del Duca fé Giulio molti bellissimi apparati d'archi, prospettive per comedie e molte altre cose, nelle quali invenzioni non aveva Giulio pari. E non fu mai il più capriccioso nelle mascherate e nel fare stravaganti abiti per giostre, feste e torneamenti come allora si vide, con stupore e maraviglia di Carlo imperadore e di quanti v'intervennero. Diede oltre ciò per tutta quella città di Mantova in diversi tempi tanti disegni di cappelle, case, giardini e facciate, e talmente si dilettò d'abellirla et ornarla che la ridusse in modo che dove era prima sottoposta al fango e piena d'acqua brutta a certi tempi e quasi inabitabile, ell'è oggi, per industria di lui, asciutta, sana e tutta vaga e piacevole.
Mentre Giulio serviva quel Duca, rompendo un anno il Po gl'argini suoi, allagò in modo Mantova, che in certi luoghi bassi della città s'alzò l'acqua presso a quattro braccia, onde per molto tempo vi stavano quasi tutto l'anno le rannochie, per che pensando Giulio in che modo si potesse a ciò rimediare, adoperò di maniera che ella ritornò per allora nel suo primo essere. Et acciò altra volta non avenisse il medesimo, fece che le strade, per comandamento del Duca, si alzarono tanto da quella banda, che superata l'altezza dell'acque, i casamenti rimasero al disopra. E perché da quella parte erano casucce piccole e deboli, e di non molta importanza, diede ordine che si riducessero a migliore termine rovinando quelle per alzare le strade e riedificandone sopra delle maggiori e più belle per utile e commodo della città. Alla qual cosa opponendosi molti con dire al Duca che Giulio faceva troppo gran danno, egli non volle udire alcuno; anzi facendo allora Giulio maestro delle strade, ordinò che non potesse niuno in quella città murare senza ordine di Giulio. Per la qual cosa molti dolendosi et alcuni minacciando Giulio, venne ciò all'orecchie del Duca, il qual usò parole sì fatte in favore di Giulio, che fé conoscere che quanto si facesse in disfavore o danno di quello, lo reputarebbe fatto a se stesso e ne farebbe dimostrazione.
Amò quel duca di maniera la virtù di Giulio, che non sapea vivere senza lui; et all'incontro Giulio ebbe a quel signo-re tanta reverenza, che più non è possibile imaginarsi. Onde non dimandò mai per sé o per altri grazia che non l'ottenes-se, e si trovava, quando morì, per le cose avute da quel duca, avere d'entrata più di mille ducati. Fabbricò Giulio per sé una casa in Mantova dirimpetto a San Barnaba, alla quale fece di fuori una facciata fantastica tutta lavorata di stucchi coloriti, e dentro la fece tutta dipignere e lavorare similmente di stucchi, accomodandovi molte anticaglie condotte da Roma et avute dal Duca, al quale ne diede molte delle sue.
Disegnava tanto Giulio, e per fuori e per Mantova, che è cosa da non credere, perché, come si è detto, non si poteva edificare, massimamente nella città, palagi o altre cose d'importanza, se non con disegni di lui. Rifece sopra le mura vecchie la chiesa di San Benedetto di Mantova, vicino al Po, luogo grandissimo e ricco de' monaci neri: e con suoi disegni fu abbellita tutta la chiesa di pitture e tavole bellissime. E perché erano in sommo pregio in Lombardia le cose sue, volle Gian Matteo Giberti, vescovo di quella città, che la tribuna del Duomo di Verona, come s'è detto altrove, fusse tutta dipinta dal Moro Veronese con i disegni di Giulio. Il quale fece al Duca di Ferrara molti disegni per panni d'a-razzo, che furono poi condotti di seta e d'oro da maestro Niccolò e Giovan Batista Rosso fiaminghi, che ne sono fuori disegni in istampa, stati intagliati da Giovan Batista Mantovano, il quale intagliò infinite cose disegnate da Giulio e particolarmente, oltre a tre carte di battaglie intagliate da altri, un medico ch'apicca le coppette sopra le spalle a una femina, una Nostra Donna che va in Egitto, e Giuseppo ha a mano l'asino per la cavezza, et alcuni Angeli fanno piegare un dattero perché Cristo ne colga de' frutti. Intagliò similmente il medesimo col disegno di Giulio una lupa in sul Tevere che allatta Remo e Romulo, e quattro storie di Plutone, Giove e Nettunno che si dividono per sorte il cielo, la terra et il mare. Similmente la capra Alfea che, tenuta da Melissa, nutrisce Giove. Et in una carta grande molti uomini in una prigione, con varii ornamenti, cruciati. Fu anche stampato, con invenzione di Giulio, il parlamento che fecero alle rive del fiume con l'esercito Scipione et Annibale; la natività di San Giovanni Batista intagliata da Sebastiano da Reggio, e molte altre state intagliate e stampate in Italia. In Fiandra parimente et in Francia sono state stampate infinite carte con i disegni di Giulio, delle quali, come che bellissimi sieno, non accade far memoria; come neanche di tutti i suoi disegni, avendone egli fatto, per modo di dire, le some. E basti che gli fu tanto facile ogni cosa dell'arte, e particolarmente il disegnare, che non ci è memoria di chi abbia fatto più di lui. Seppe ragionare Giulio, il quale fu molto universale, d'ogni cosa, ma sopra tutto delle medaglie, nelle quali spese assai danari e molto tempo per averne cognizione. E se bene fu adoperato quasi sempre in cose grandi, non è però che egli non mettesse anco talor mano a cose menomissime per servigio del suo signore e degl'amici, né aveva sì tosto uno aperto la bocca per aprirgli un suo concetto, che l'aveva inteso e disegnato.
Fra le molte cose rare che aveva in casa sua, vi era in una tela di rensa sottile il ritratto naturale d'Alberto Duro di mano di esso Alberto, che lo mandò come altrove si è detto, a donare a Raffaello da Urbino. Il qual ritratto era cosa rara perché, essendo colorito a guazzo con molta diligenza e fatto d'acquarelli, l'aveva finito Alberto senza adoperare biacca, et in quel cambio si era servito del bianco della tela, delle fila della quale, sottilissime, aveva tanto ben fatti i peli della barba, che era cosa da non potersi imaginare, non che fare, et al lume traspareva da ogni lato. Il quale ritratto, che a Giulio era carissimo, mi mostrò egli stesso per miracolo quando, vivendo lui, andai per mie bisogne a Mantova.
Morto il duca Federigo, dal quale più che non si può credere era stato amato Giulio, se ne travagliò di maniera, che si sarebbe partito di Mantova, se il cardinale fratello del Duca, a cui era rimaso il governo dello stato per essere i figliuoli di Federigo piccolissimi, non l'avesse ritenuto in quella città dove aveva moglie, figliuoli, case, villaggi e tutti altri commodi che ad agiato gentiluomo sono richiesti. E ciò fece il cardinale, oltre alle dette cagioni, per servirsi del consiglio et aiuto di Giulio in rinovare e quasi far di nuovo tutto il Duomo di quella città: a che messo mano, Giulio lo condusse assai inanzi con bellissima forma.
In questo tempo Giorgio Vasari, che era amicissimo di Giulio, se bene non si conoscevano se non per fama e per lettere, nell'andare a Vinezia, fece la via per Mantova per vedere Giulio e l'opere sue. E così arrivato in quella città, andando per trovar l'amico senza essersi mai veduti, scontrandosi l'un l'altro si conobbono non altrimenti che se mille vol-te fussero stati insieme presenzialmente. Di che ebbe Giulio tanto contento et allegrezza, che per quattro giorni non lo staccò mai, mostrandogli tutte l'opere sue e particolarmente tutte le piante degli edifizii antichi di Roma, di Napoli, di Pozzuolo, di Campagna e di tutte l'altre migliori antichità di che si ha memoria, disegnate parte da lui e parte da altri. Di poi, aperto un grandissimo armario, gli mostrò le piante di tutti gl'edifizii che erano stati fatti con suoi disegni et ordine, non solo in Mantova et in Roma, ma per tutta la Lombardia, e tanto belli, che io per me non credo che si possano vedere né le più nuove, né le più belle fantasie di fabbriche, né meglio accommodate. Dimandando poi il cardinale a Giorgio quello che gli paresse dell'opere di Giulio, gli rispose (esso Giulio presente) che elle erano tali, che ad ogni canto di quella città meritava che fusse posta la statua di lui e che, per averla egli rinovata, la metà di quello stato non sarebbe stata bastante a rimunerar le fatiche e virtù di Giulio. A che rispose il cardinale Giulio essere più padrone di quello stato che non era egli. E perché era Giulio amorevolissimo e specialmente degli amici, non è alcuno segno d'a-more e di carezze che Giorgio non ricevesse da lui.
Il qual Vasari partito di Mantova et andato a Vinezia e di là tornato a Roma, in quel tempo a punto che Michelagnolo aveva scoperto nella cappella il suo Giudizio mandò a Giulio, per Messer Nino Nini da Cortona, segretario del detto cardinale di Mantova, tre carte de' sette peccati mortali ritratti dal detto Giudizio di Michelagnolo, che a Giulio furono oltre modo carissimi, sì per essere quello ch'egli erano, e sì perché, avendo allora a fare al cardinale una cappella in palazzo, ciò fu un destargli l'animo a maggior cose che quelle non erano che aveva in pensiero. Mettendo dunque ogni estrema diligenza in fare un cartone bellissimo, vi fece dentro con bel capriccio quando Pietro et Andrea chiamati da Cristo lasciano le reti per seguitarlo, e di pescatori di pesci divenire pescatori d'uomini. Il quale cartone, che riuscì il più bello che mai avesse fatto Giulio, fu poi messo in opera da Fermo Guisoni, pittore e creato di Giulio, oggi eccellente maestro.
Essendo non molto dopo i soprastanti della fabbrica di San Petronio di Bologna desiderosi di dar principio alla facciata dinanzi di quella chiesa, con grandissima fatica vi condussono Giulio in compagnia d'uno architetto milanese, chiamato Tofano Lombardino, uomo allora molto stimato in Lombardia per molte fabbriche che si vedevano di sua mano. Costoro dunque avendo fatti più disegni, et essendosi quegli di Baldassarre Peruzzi sanese perduti, fu sì bello e bene ordinato uno che fra gli altri ne fece Giulio, che meritò riceverne da quel popolo lode grandissima e con liberalissimi doni esser riconosciuto nel suo ritornarsene a Mantova. Intanto, essendo di que' giorni morto Antonio Sangallo in Roma, e rimasi perciò in non piccolo travaglio i deputati della fabbrica di San Piero, non sapendo essi a cui voltarsi per dargli carico di dovere con l'ordine cominciato condurre sì gran fabbrica a fine, pensarono niuno potere esser più atto a ciò che Giulio Romano, del quale sapevano tutti quanta l'eccellenza fusse et il valore; e così avisando che dovesse tal carico accettare più che volentieri per rimpatriarsi onoratamente e con grossa provisione, lo feciono tentare per mezzo d'alcuni amici suoi, ma invano, però che, se bene di bonissima voglia sarebbe andato, due cose lo ritennero: il cardinale che per niun modo volle che si partissi, e la moglie con gl'amici e parenti, che per tutte le vie lo sconfortarono. Ma non avrebbe per avventura potuto in lui niuna di queste due cose, se non si fusse in quel tempo trovato non molto ben sano, per che, considerando egli di quanto onore et utile sarebbe potuto essere a sé et a' suoi figliuoli accettar sì onorato partito, era del tutto volto, quando cominciò a ire peggiorando del male, a voler fare ogni sforzo che il ciò fare non gli fusse dal cardinale impedito. Ma perché era di sopra stabilito che non andasse più a Roma e che quello fusse l'ultimo termine della sua vita, fra il dispiacere et il male si morì in pochi giorni in Mantova, la quale poteva pur concedergli che, come aveva abbellita lei, così ornasse et onorasse la sua patria Roma.
Morì Giulio d'anni cinquantaquattro, lasciando un solo figliuol maschio, al quale, per la memoria che teneva del suo maestro, aveva posto nome Raffaello. Il qual giovinetto, avendo affatica appreso i primi principii dell'arte con speranza di dovere riuscir valent'uomo, si morì anch'egli, non dopo molti anni, insieme con sua madre, moglie di Giulio. Onde non rimase di lui altri che una figliuola chiamata Virginia, che ancor vive in Mantova, maritata a Ercole Malatesta. A Giulio, il quale infinitamente dolse a chiunque lo conobbe, fu dato sepoltura in San Barnaba con proposito di fargli qualche onorata memoria. Ma i figliuoli e la moglie, mandando la cosa d'oggi in domani, sono anch'eglino per lo più mancati senza farne altro. E pure è stato un peccato che di quell'uomo, che tanto onorò quella città, non è stato chi n'ab-bi tenuto conto nessuno, salvo coloro che se ne servivano, i quali se ne sono spesso ricordati ne' bisogni loro. Ma la propria virtù sua, che tanto l'onorò in vita, gli ha fatto mediante l'opere sue eterna sepoltura doppo la morte, che né il tempo, né gl'anni consumeranno.
Fu Giulio di statura né grande né piccolo, più presto compresso che leggeri di carne, di pel nero, di bella faccia, con occhio nero et allegro, amorevolissimo, costumato in tutte le sue azzioni, parco nel mangiare e vago di vestire e vivere onoratamente. Ebbe discepoli assai, ma i migliori furono Gian dal Lione, Raffaello da Colle Borghese, Benedetto Pagni da Pescia, Figurino da Faenza, Rinaldo e Giovanbatista Mantovani, e Fermo Guisoni, che si sta in Mantova e gli fa onore, essendo pittore eccellente, sì come ha fatto ancora Benedetto, il quale ha molte cose lavorato in Pescia sua patria, e del Duomo di Pisa una tavola che è nell'Opera, e parimente un quadro di Nostra Donna con bella e gentile poesia, a-vendo in quello fatta una Fiorenza che le presenta le dignità di casa Medici. Il qual quadro è oggi appresso il signor Mondragone spagnuolo, favoritissimo dell'illustrissimo signor principe di Fiorenza. Morì Giulio l'anno 1546, il giorno di tutti i Santi. E sopra la sua sepoltura fu posto questo epitaffio:
Romanus moriens secum tres Iulius arteis
abstulit (haud mirum) quatuor unus erat.
VITA DI SEBASTIAN VINIZIANO
FRATE DEL PIOMBO E PITTORE

Non fu, secondo che molti affermano, la prima professione di Sebastiano la pittura, ma la musica: perché oltre al cantare si dilettò molto di sonar varie sorti di suoni, ma sopra il tutto il liuto, per sonarsi in su quello stromento tutte le parti senz'altra compagnia. Il quale esercizio fece costui essere un tempo gratissimo a' gentiluomini di Vinezia, con i quali, come virtuoso, praticò sempre dimesticamente. Venutagli poi voglia, essendo anco giovane, d'attendere alla pittura, apparò i primi principii da Giovan Bellino allora vecchio. E doppo lui, avendo Giorgione da Castel Franco messi in quella città i modi della maniera moderna, più uniti e con certo fiammeggiare di colori, Sebastiano si partì da Giovanni e si acconciò con Giorgione, col quale stette tanto che prese in gran parte quella maniera. Onde fece alcuni ritratti in Vinegia di naturale molto simili, e fra gl'altri, quello di Verdelotto franzese, musico eccellentissimo, che era allora maestro di cappella in San Marco, e nel medesimo quadro quello di Ubretto, suo compagno cantore. Il qual quadro recò a Fiorenza Verdelotto quando venne maestro di cappella in San Giovanni, et oggi l'ha nelle sue case Francesco Sangallo scultore. Fece anco in que' tempi in San Giovanni Grisostomo di Vinezia una tavola con alcune figure che tengono tanto della maniera di Giorgione, ch'elle sono state alcuna volta, da chi non ha molta cognizione delle cose dell'arte, tenute per di mano di esso Giorgione. La qual tavola è molto bella e fatta con una maniera di colorito ch'ha gran rilievo. Per che, spargendosi la fama delle virtù di Sebastiano, Agostino Chigi sanese, ricchissimo mercante, il quale in Vinegia avea molti negozii, sentendo in Roma molto lodarlo, cercò di condurlo a Roma, piacendogli oltre la pittura che sapessi così ben sonare di liuto e fosse dolce e piacevole nel conversare. Né fu gran fatica condurre Bastiano a Roma, perché, sapendo egli quanto quella patria comune sia sempre stata aiutatrice de' begl'ingegni, vi andò più che volentieri. Andatosene dunque a Roma, Agostino lo mise in opera e la prima cosa che gli facesse fare furono gl'archetti che sono in su la loggia, la quale risponde in sul giardino dove Baldassarre Sanese aveva, nel palazzo d'Agostino in Trastevere, tutta la volta dipinta; nei quali archetti Sebastiano fece alcune poesie di quella maniera ch'aveva recato da Vinegia, molto disforme da quella che usavano in Roma i valenti pittori di que' tempi.
Dopo quest'opera, avendo Raffaello fatto in quel medesimo luogo una storia di Galatea, vi fece Bastiano, come vol-le Agostino, un Polifemo in fresco allato a quella, nel quale, comunche gli riuscisse, cercò d'avanzarsi più che poteva, spronato dalla concorrenza di Baldassarre Sanese e poi di Raffaello. Colorì similmente alcune cose a olio, delle quali fu tenuto, per aver egli da Giorgione imparato un modo di colorire assai morbido, in Roma grandissimo conto. Mentre che lavorava costui queste cose in Roma, era venuto in tanto credito Raffaello da Urbino nella pittura che gl'amici et aderenti suoi dicevano che le pitture di lui erano, secondo l'ordine della pittura, più che quelle di Michelagnolo, vaghe di colorito, belle d'invenzioni e d'arie più vezzose e di corrispondente disegno, e che quelle del Buonarroti non avevano dal disegno in fuori niuna di queste parti. E per queste cagioni giudicavano questi cotali Raffaello essere nella pittura, se non più eccellente di lui, almeno pari, ma nel colorito volevano che ad ogni modo lo passasse. Questi umori, seminati per molti artefici che più aderivano alla grazia di Raffaello che alla profondità di Michelagnolo, erano divenuti, per diversi interessi, più favorevoli nel giudizio a Raffaello che a Michelagnolo. Ma non già era de' seguaci di costoro Sebastiano perché, essendo di squisito giudizio, conosceva a punto il valore di ciascuno.
Destatosi dunque l'animo di Michelagnolo verso Sebastiano, perché molto gli piaceva il colorito e la grazia di lui, lo prese in protezzione, pensando che se egli usasse l'aiuto del disegno in Sebastiano, si potrebbe con questo mezzo, senza che egli operasse, battere coloro che avevano sì fatta openione, et egli sotto ombra di terzo giudicare quale di loro fusse meglio. Stando le cose in questi termini et essendo molto, anzi in infinito, inalzate e lodate alcune cose che fece Sebastiano, per le lodi che a quelle dava Michelagnolo, oltre che erano per sé belle e lodevoli, un messer non so chi da Viterbo, molto riputato appresso al Papa, fece fare a Sebastiano, per una cappella che aveva fatta fare in San Francesco di Viterbo, un Cristo morto con una Nostra Donna che lo piagne. Ma perché, se bene fu con molta diligenza finito da Sebastiano che vi fece un paese tenebroso molto lodato, l'invenzione però et il cartone fu di Michelagnolo, fu quell'opera tenuta da chiunque la vide veramente bellissima. Onde acquistò Sebastiano grandissimo credito e confermò il dire di coloro che lo favorivano. Per che, avendo Pierfrancesco Borgherini, mercante fiorentino, preso una cappella in San Pie-ro in Montorio entrando in chiesa a man ritta, ella fu col favor di Michelagnolo allogata a Sebastiano, perché il Borgherino pensò, come fu vero, che Michelagnolo dovesse far egli il disegno di tutta l'opera. Messovi dunque mano, la condusse con tanta diligenza e studio Sebastiano, ch'ella fu tenuta et è bellissima pittura. E perché dal piccolo disegno di Michelagnolo ne fece per suo commodo alcun'altri maggiori, uno fra gl'altri che ne fece molto bello è di man sua nel nostro libro, e perché si credeva Sebastiano avere trovato il modo di colorire a olio in muro, acconciò l'arricciato di questa cappella con una incrostatura, che a ciò gli parve dovere essere a proposito, e quella parte dove Cristo è battuto alla colonna tutta lavorò a olio nel muro.
Né tacerò che molti credono Michelagnolo avere non solo fatto il picciol disegno di quest'opera, ma che il Cristo detto, che è battuto alla colonna, fusse contornato da lui, per essere grandissima differenza fra la bontà di questa e quella dell'altre figure. E quando Sebastiano non avesse fatto altra opera che questa, per lei sola meriterebbe esser lodato in eterno. Perché oltre alle teste, che son molto ben fatte, sono in questo lavoro alcune mani e piedi bellissimi. Et ancora che la sua maniera fusse un poco dura, per la fatica che durava nelle cose che contrafaceva, egli si può non di meno fra i buoni e lodati artefici annoverare. Fece sopra questa storia in fresco due Profeti, e nella volta la Trasfigurazione; et i due Santi, cioè San Piero e San Francesco, che mettono in mezzo la storia di sotto, sono vivissime e pronte figure. E se bene penò sei anni a far questa piccola cosa, quando l'opere sono condotte perfettamente non si dee guardare se più presto o più tardi sono state finite, se ben'è più lodato chi presto e bene conduce le sue opere a perfezzione. E chi si scusa, quando l'opere non sodisfanno, se non è stato a ciò forzato, in cambio di scusarsi s'accusa. Nello scoprirsi quest'opera, Sebastiano, ancor che avesse penato assai a farla, avendo fatto bene, le male lingue si tacquero e pochi furono coloro che lo mordessero.
Dopo, facendo Raffaello, per lo cardinale de' Medici per mandarla in Francia, quella tavola che dopo la morte sua fu posta all'altare principale di San Piero a Montorio, dentrovi la Trasfigurazione di Cristo, Sebastiano in quel medesimo tempo fece anch'egli, in un'altra tavola della medesima grandezza, quasi a concorrenza di Raffaello, un Lazaro quattriduano e la sua resurrezzione. La quale fu contrafatta e dipinta con diligenza grandissima, sotto ordine e disegno in alcune parti di Michelagnolo. Le quali tavole finite, furono amendue publicamente in Concistoro poste in paragone, e l'u-na e l'altra lodata infinitamente. E benché le cose di Raffaello, per l'estrema grazia e bellezza loro, non avessero pari, furono nondimeno anche le fatiche di Sebastiano universalmente lodate da ognuno. L'una di queste mandò Giulio cardinale de' Medici in Francia a Nerbona al suo vescovado, e l'altra fu posta nella cancelleria, dove stette infino a che fu portata a San Piero a Montorio con l'ornamento che vi lavorò Giovan Barile. Mediante quest'opera, avendo fatto gran servitù col cardinale, meritò Sebastiano d'esserne onoratamente rimunerato nel pontificato di quello.
Non molto doppo, essendo mancato Raffaello et essendo il primo luogo nell'arte della pittura conceduto universalmente da ognuno a Sebastiano, mediante il favore di Michelagnolo, Giulio Romano, Giovanfrancesco Fiorentino, Perino del Vaga, Polidoro, Maturino, Baldessarre Sanese e gl'altri rimasero tutti a dietro. Onde Agostin Chigi, che con ordine di Raffaello faceva fare la sua sepoltura e cappella in Santa Maria del Popolo, convenne con Bastiano che egli tutta gliela dipignesse. E così fatta la turata, si stette coperta, senza che mai fusse veduta, insino all'anno 1554. Nel qual tempo si risolvette Luigi, figliuolo d'Agostino, poiché il padre non l'aveva potuta veder finita, voler vederla egli. E così allogata a Francesco Salviati la tavola e la cappella, egli la condusse in poco tempo a quella perfezzione che mai non le poté dare la tardità e l'irresoluzione di Sebastiano, il quale, per quello che si vede, vi fece poco lavoro, se bene si trova ch'egli ebbe dalla liberalità d'Agostino e degli eredi molto più che non se gli sarebbe dovuto quando l'avesse finita del tutto; il che non fece, o come stanco dalle fatiche dell'arte, o come troppo involto nelle commodità et in piaceri.
Il medesimo fece a Messer Filippo da Siena, cherico di camera, per lo quale nella Pace di Roma, sopra l'altare maggiore, cominciò una storia a olio sul muro e non la finì mai. Onde i frati, di ciò disperati, furono costretti levare il ponte che impediva loro la chiesa e coprire quell'opera con una tela et avere pacienza quanto durò la vita di Sebastiano. Il quale morto, scoprendo i frati l'opera, si è veduto che quello che è fatto è bellissima pittura; perciò che dove ha fatto la Nostra Donna che visita Santa Lisabetta, vi sono molte femmine ritratte dal vivo che sono molto belle e fatte con somma grazia. Ma vi si conosce che quest'uomo durava grandissima fatica in tutte le cose che operava, e ch'elle non gli venivano fatte con una certa facilità che suole tal volta dar la natura e lo studio a chi si compiace nel lavorare e si esercita continovamente. E che ciò sia vero, nella medesima Pace, nella cappella d'Agostin Chigi, dove Raffaello aveva fatte le sibille et i profeti, voleva nella nicchia, che di sotto rimase, dipignere Bastiano, per passare Raffaello, alcune cose sopra la pietra, e perciò l'aveva fatta incrostare di peperigni e le commettiture saldate con stucco a fuoco, ma se n'andò tanto in considerazione, che la lasciò solamente murata; per che essendo stata così dieci anni, si morì.
Bene è vero che da Sebastiano si cavava, e facilmente, qualche ritratto di naturale, perché gli venivano con più agevolezza e più presto finiti, ma il contrario avveniva delle storie et altre figure. E per vero dire il ritrarre di naturale era suo proprio, come si può vedere nel ritratto di Marc'Antonio Colonna, tanto ben fatto che par vivo. Et in quello ancora di Ferdinando marchese di Pescara, et in quello della Signora Vettoria Colonna, che sono bellissimi. Ritrasse similmente Adriano Sesto quando venne a Roma, et il cardinale Nincofort, il quale volle che Sebastiano gli facesse una cappella in Santa Maria de Anima in Roma. Ma trattenendolo d'oggi in domani, il cardinale la fece finalmente dipignere a Michele Fiamingo suo paesano, che vi dipinse storie della vita di Santa Barbara in fresco, imitando molto bene la maniera nostra d'Italia, e nella tavola fece il ritratto di detto cardinale.
Ma tornando a Sebastiano, egli ritrasse ancora il signor Federigo da Bozzolo, et un non so che capitano armato che è in Fiorenza appresso Giulio de' Nobili, et una femmina con abito romano, che è in casa di Luca Torrigiani. Et una testa, di mano del medesimo, ha Giovan Batista Cavalcanti, che non è del tutto finita. In un quadro fece una Nostra Donna che con un panno cuopre un putto, che fu cosa rara, e l'ha oggi nella sua guardaroba il cardinal Farnese. Abbozzò, ma non condusse a fine, una tavola molto bella d'un San Michele che è sopra un diavolo grande, la quale doveva andare in Francia al re che prima aveva avuto un quadro di mano del medesimo.
Essendo poi creato sommo pontefice Giulio cardinal de' Medici, che fu chiamato Clemente Settimo, fece intendere a Sebastiano, per il vescovo di Vasona, ch'era venuto il tempo di fargli bene e che se n'avedrebbe all'occasioni. Sebastiano intanto, essendo unico nel fare ritratti, mentre si stava con queste speranze fece molti di naturale, ma fra gli altri papa Clemente, che allora non portava barba; ne fece, dico, due: uno n'ebbe il vescovo di Vasona e l'altro, che era molto maggiore, cioè infino alle ginocchia et a sedere, è in Roma nelle case di Sebastiano. Ritrasse anche Antonfrancesco degl'Albizi fiorentino, che allora per sue facende si trovava in Roma, e lo fece tale che non pareva dipinto, ma vivissimo. Onde egli, come una preziosissima gioia se lo mandò a Fiorenza. Erano la testa e le mani di questo ritratto cosa certo maravigliosa, per tacere quanto erano ben fatti i velluti, le fodere, i rasi e l'altre parti tutte di questa pittura. E perché era veramente Sebastiano nel fare i ritratti di tutta finezza e bontà a tutti gli altri superiore, tutta Fiorenza stupì di questo ritratto d'Antonfrancesco.
Ritrasse ancora in questo medesimo tempo Messer Pietro Aretino, e lo fece sì fatto che, oltre al somigliarlo, è pittura stupendissima per vedervisi la differenza di cinque o sei sorti di neri che egli ha addosso: velluto, raso, ermisino, damasco e panno, et una barba nerissima sopra quei neri, sfilata tanto bene che più non può essere il vivo e naturale. Ha in mano questo ritratto un ramo di lauro et una carta dentrovi scritto il nome di Clemente Settimo e due maschere inanzi, una bella per Virtù e l'altra brutta per il Vizio. La quale pittura Messer Pietro donò alla patria sua, et i suoi cittadini l'hanno messa nella sala publica del loro consiglio, dando così onore alla memoria di quel loro ingegnoso cittadino e ricevendone da lui non meno. Dopo ritrasse Sebastiano Andrea Doria, che fu nel medesimo modo cosa mirabile, e la testa di Baccio Valori fiorentino, che fu anch'essa bella quanto più non si può credere.
In questo mentre, morendo frate Mariano Fetti, frate del Piombo, Sebastiano ricordandosi delle promesse fattegli dal detto vescovo di Vasona, maestro di casa di Sua Santità, chiese l'ufficio del Piombo, onde, se bene anco Giovanni da Udine, che tanto ancor egli aveva servito Sua Santità in minoribus e tuttavia la serviva, chiese il medesimo ufficio; il Papa, per i prieghi del vescovo e perché così la virtù di Sebastiano meritava, ordinò che esso Bastiano avesse l'ufficio e sopra quello pagasse a Giovanni da Udine una pensione di trecento scudi. Laonde Sebastiano prese l'abito del frate e subito per quello si sentì variare l'animo. Per che, vedendosi avere il modo di potere sodisfare alle sue voglie senza col-po di pennello, se ne stava riposando, e le male spese notti et i giorni affaticati ristorava con gli agi e con l'entrate. E quando pure aveva a fare una cosa si riduceva al lavoro con una passione che pareva andasse alla morte. Da che si può conoscere quanto s'inganni il discorso nostro e la poca prudenza umana, che bene spesso, anzi il più delle volte, brama il contrario di ciò che più ci fa di mestiero, e credendo segnarsi (come suona il proverbio tosco) con un dito, si dà nel-l'occhio.
È comune opinione degl'uomini che i premii e gl'onori accendino gl'animi de' mortali agli studii di quell'arti che più veggiono essere rimunerate, e che per contrario gli faccia stracurarle et abbandonarle il vedere che coloro, i quali in es-se s'affaticano, non siano dagl'uomini, che possono, riconosciuti. E per questo gl'antichi e moderni insieme biasimano quanto più sanno e possono que' prìncipi che non sollievano i virtuosi di tutte le sorti, e non dànno i debiti premii et onori a chi virtuosamente s'affatica. E come che questa regola per lo più sia vera si vede pur tuttavia, che alcuna volta la liberalità de' giusti e magnanimi prìncipi operare contrario effetto, poiché molti sono di più utile e giovamento al mondo in bassa e mediocre fortuna, che nelle grandezze et abbondanze di tutti i beni non sono. Et a proposito nostro, la magnificenza e liberalità di Clemente Settimo, a cui serviva Sebastiano viniziano, eccellentissimo pittore, rimunerandolo troppo altamente, fu cagione che egli, di sollecito et industrioso, divenisse infingardo e negligentissimo; e che dove, mentre durò la gara fra lui e Raffaello da Urbino e visse in povera fortuna, si affaticò di continuo, fece tutto il contrario poi che egli ebbe da contentarsi. Ma comunche sia, lasciando nel giudizio de' prudenti prìncipi il considerare come, quando, a cui, et in che maniera e con che regola deono la liberalità verso gl'artefici e virtuosi uomini usare, dico, tornando a Sebastiano, che egli condusse con gran fatica, poi che fu fatto frate del Piombo, al patriarca d'Aquilea un Cristo che porta la croce, dipinto in pietra dal mezzo in su, che fu cosa molto lodata, e massimamente nella testa e nelle mani, nelle quali parti era Bastiano veramente eccellentissimo.
Non molto dopo, essendo venuta a Roma la nipote del Papa, che fu poi et è ancora reina di Francia, fra' Sebastiano la cominciò a ritrarre, ma non finita si rimase nella guardaroba del Papa. E poco appresso, essendo il cardinale Ippolito de' Medici innamorato della signora Giulia Gonzaga, la quale allora si dimorava a Fondi, mandò il detto cardinale in quel luogo Sebastiano, accompagnato da quattro cavai leggeri, a ritrarla. Et egli in termine d'un mese fece quel ritratto; il quale, venendo dalle celesti bellezze di quella signora e da così dotta mano, riuscì una pittura divina; onde, portata a Roma, furono grandemente riconosciute le fatiche di quell'artefice dal cardinale che conobbe questo ritratto, come veramente era, passar di gran lunga quanti mai n'aveva fatto Sebastiano infino a quel giorno. Il qual ritratto fu poi mandato al re Francesco in Francia, che lo fe porre nel suo luogo di Fontanableò.
Avendo poi cominciato questo pittore un nuovo modo di colorire in pietra, ciò piaceva molto a' popoli, parendo che in quel modo le pitture diventassero eterne e che né il fuoco, né i tarli potessero lor nuocere. Onde cominciò a fare in queste pietre molte pitture, ricignendole con ornamenti d'altre pietre mischie, che fatte lustranti facevano accompagnatura bellissima. Ben è vero che, finite, non si potevano né le pitture, né l'ornamento, per lo troppo peso, né muovere, né trasportare se non con grandissima difficultà. Molti dunque tirati dalla novità della cosa e dalla vaghezza dell'arte, gli davano arre di danari perché lavorasse per loro, ma egli, che più si dilettava di ragionarne che di farle, mandava tutte le cose per la lunga. Fece non di meno un Cristo morto e la Nostra Donna in una pietra, per don Ferrante Gonzaga, il qua-le lo mandò in Ispagna con un ornamento di pietra, che tutto fu tenuto opera molto bella, et a Sebastiano fu pagata quella pittura cinquecento scudi da Messer Niccolò da Cortona, agente in Roma del cardinale di Mantova.
Ma in questo fu Bastiano veramente da lodare, perciò che dove Domenico suo compatriota, il quale fu il primo che colorisse a olio in muro, e dopo lui Andrea dal Castagno, Antonio e Piero del Pollaiuolo, non seppero trovar modo che le lor figure a questo modo fatte non diventassino nere, né invecchiassero così presto, lo seppe trovar Bastiano. Onde il Cristo alla colonna, che fece in San Piero a Montorio, infino ad ora non ha mai mosso et ha la medesima vivezza e colore che il primo giorno: perché usava costui questa così fatta diligenza, che faceva l'arricciato grosso della calcina con mistura di mastice e pece greca, e quelle insieme fondate al fuoco e date nelle mura, faceva poi spianare con una mescola da calcina fatta rossa, o vero rovente, al fuoco. Onde hanno potuto le sue cose reggere all'umido e conservare benissimo il colore senza farli far mutazione. E con la medesima mestura ha lavorato sopra le pietre di peperigni, di mar-mi, di mischi, di porfidi e lastre durissime, nelle quali possono lunghissimo tempo durare le pitture; oltre che ciò ha mostrato come si possa dipignere sopra l'argento, rame, stagno et altri metalli. Quest'uomo aveva tanto piacere in stare ghiribizzando e ragionare, che si tratteneva i giorni interi per non lavorare. E quando pur vi si riduceva, si vedea che pativa dell'animo infinitamente; da che veniva in gran parte che egli aveva openione che le cose sue non si potessino con verun prezzo pagare. Fece per il cardinale d'Aragona, in un quadro, una bellissima S. Agata ignuda e martirizata nelle poppe, che fu cosa rara. Il qual quadro è oggi nella guardaroba del signor Guidobaldo duca d'Urbino, e non è punto inferiore a molti altri quadri bellissimi che vi sono di mano di Raffaello da Urbino, di Tiziano e d'altri. Ritrasse anche di naturale il signor Piero Gonzaga in una pietra, colorito a olio, che fu un bellissimo ritratto, ma penò tre anni a finirlo.
Ora essendo in Firenze al tempo di papa Clemente Michelagnolo, il quale attendeva all'opera della nuova sagrestia di San Lorenzo, voleva Giuliano Bugiardini fare a Baccio Valori in un quadro la testa di papa Clemente et esso Baccio, et in un altro, per Messer Ottaviano de' Medici, il medesimo Papa e l'arcivescovo di Capua; per che Michelagnolo, mandando a chiedere a fra' Sebastiano che di sua mano gli mandasse da Roma dipinta a olio la testa del Papa, egli ne fece una e gliela mandò, che riuscì bellissima. Della quale, poi che si fu servito Giuliano e che ebbe i suoi quadri finiti, Michelagnolo, che era compare di detto Messere Ottaviano, gliene fece un presente. E certo di quante ne fece fra' Sebastiano, che furono molte, questa è la più bella testa di tutte e la più simigliante, come si può vedere in casa gli eredi del detto Messer Ottaviano. Ritrasse il medesimo papa Paolo Farnese subito che fu fatto sommo pontefice; e cominciò il duca di Castro suo figliuolo, ma non lo finì, come non fece anche molte altre cose, alle quali avea dato principio.
Aveva fra' Sebastiano vicino al Popolo una assai buona casa, la quale egli si avea murata, et in quella con grandissima contentezza si vivea senza più curarsi di dipignere o lavorare, usando spesso dire che è una grandissima fatica avere nella vecchiezza a raffrenare i furori a' quali nella giovanezza gli artefici per utilità, per onore e per gara si sogliono mettere; e che non era men prudenza cercare di viver quieto, che vivere con le fatiche inquieto per lasciare di sé no-me dopo la morte, dopo la quale hanno anco quelle fatiche e l'opere tutte ad avere, quando che sia, fine e morte. E come egli queste cose diceva, così a suo potere le metteva in essecuzione, perciò che i migliori vini e le più preziose cose che avere si potessero cercò sempre d'avere per lo vitto suo, tenendo più conto della vita che dell'arte. E perché era amicissimo di tutti gli uomini virtuosi, spesso avea seco a cena il Molza e Messer Gandolfo, facendo bonissima cera. Fu ancora suo grandissimo amico Messer Francesco Berni fiorentino, che gli scrisse un capitolo, al quale rispose fra' Sebastiano con un altro assai bello, come quelli che essendo universale seppe anco a far versi toscani e burlevoli accommodarsi.
Essendo fra' Sebastiano morso da alcuni, i quali dicevano che pure era una vergogna che, poi che egli aveva il modo da vivere, non volesse più lavorare, rispondeva a questo modo: “Ora che io ho il modo da vivere non vo' far nulla, perché sono oggi al mondo ingegni che fanno in due mesi quello che io soleva fare in due anni. E credo, s'io vivo molto, che non andrà troppo si vedrà dipinto ogni cosa. E da che questi tali fanno tanto, è bene ancora che ci sia chi non faccia nulla, acciò che eglino abbino quel più che fare”. E con simili et altre piacevolezze, si andava fra' Sebastiano, come quello che era tutto faceto e piacevole, trattenendo; e nel vero non fu mai il miglior compagno di lui. Fu, come si è detto, Bastiano molto amato da Michelagnolo. Ma è ben vero che, avendosi a dipigner la faccia della cappella del Papa, dove oggi è il Giudizio di esso Buonarroto, fu fra loro alquanto di sdegno, avendo persuaso fra' Sebastiano al Papa che la facesse fare a Michelagnolo a olio là dove esso non voleva farla se non a fresco. Non dicendo dunque Michelagnolo né sì, né no et acconciandosi la faccia a modo di fra' Sebastiano, si stette così Michelagnolo, senza metter mano all'ope-ra, alcuni mesi; ma essendo pur sollecitato, egli finalmente disse che non voleva farla se non a fresco, e che il colorire a olio era arte da donna e da persone agiate et infingarde, come fra' Bastiano; e così gettata a terra l'incrostatura fatta con ordine del frate, e fatto arricciare ogni cosa in modo da poter lavorare a fresco, Michelagnolo mise mano all'opera, non si scordando però l'ingiuria che gli pareva avere ricevuta da fra' Sebastiano, col quale tenne odio quasi fin alla morte di lui.
Essendo finalmente fra' Sebastiano ridotto in termine che né lavorare, né fare alcun'altra cosa voleva, salvo che attendere all'esercizio del frate, cioè di quel suo uffizio, e fare buona vita, d'età d'anni sessantadue si ammalò di acutissima febbre che, per essere egli rubicondo e di natura sanguigna, gl'infiammò talmente gli spiriti, che in pochi giorni rendé l'anima a Dio, avendo fatto testamento e lasciato che il corpo suo fusse portato alla sepoltura senza cerimonie di preti o di frati, o spese di lumi, e che quel tanto che in ciò fare si sarebbe speso fusse distribuito a povere persone per amor di Dio; e così fu fatto. Fu sepolto nella chiesa del Popolo del mese di giugno l'anno 1547. Non fece molta perdita l'arte per la morte sua; perché subito che fu vestito frate del Piombo si potette egli annoverare fra i perduti. Vero è che per la sua dolce conversazione dolse a molti amici et artefici ancora.
Stettono con Sebastiano in diversi tempi molti giovani per imparare l'arte, ma vi feciono poco profitto, perché dal-l'essempio di lui impararono poco altro che a vivere; eccetto però Tommaso Laureati ciciliano, il quale, oltre a molte altre cose, ha in Bologna con grazia condotto in un quadro una molto bella Venere et Amore che l'abbraccia e bacia. Il qual quadro è in casa Messer Francesco Bolognetti. Ha fatto parimente un ritratto del signor Bernardino Savelli, che è molto lodato, et alcune altre opere delle quali non accade far menzione.
VITA DI PERINO DEL VAGA
PITTOR FIORENTINO

Grandissimo è certo il dono della virtù, la quale non guardando a grandezza di roba, né a dominio di stati o nobiltà di sangue, il più delle volte cigne et abbraccia e sollieva da terra uno spirito povero: assai più che non fa un bene agiato di ricchezze. E questo lo fa il cielo per mostrarci quanto possa in noi l'influsso delle stelle e de' segni suoi, compartendo a chi più et a chi meno delle grazie sue; le quali sono il più delle volte cagione che nelle complessioni di noi medesimi ci fanno nascere più furiosi o lenti, più deboli o forti, più salvatichi o domestici, fortunati o sfortunati, e di minore e di maggior virtù. E chi di questo dubitasse punto, lo sgannerà al presente la vita di Perino del Vaga, eccellentissimo pittore e molto ingegnoso. Il quale nato di padre povero, e rimaso piccol fanciullo abbandonato da' suoi parenti, fu dalla virtù sola guidato e governato. La quale egli, come sua legittima madre, conobbe sempre, e quella onorò del continovo. E l'osservazione dell'arte della pittura fu talmente seguita da lui con ogni studio, che fu cagione di fare nel tempo suo quegli ornamenti tanto egregii e lodati, che hanno accresciuto come a Genova et al principe Doria. Laonde si può senza dubbio credere che il cielo solo sia quello che conduca gli uomini da quella infima bassezza dove nascono, al sommo della grandezza dove eglino ascendono quando, con l'opere loro affaticandosi, mostrano essere seguitatori delle scienze che pigliano a imparare; come pigliò e seguitò per sua Perino l'arte del disegno, nella quale mostrò eccellentissimamente e con grazia, somma perfezzione. E nelli stucchi non solo paragonò gli antichi, ma tutti gli artefici moderni in quel che abbraccia tutto il genere della pittura, con tutta quella bontà che può maggiore desiderarsi da ingegno umano che voglia far conoscere, nelle difficultà di quest'arte, la bellezza, la bontà e la vaghezza e leggiadria ne' colori e negli altri ornamenti. Ma vegnamo più particolarmente a l'origine sua.
Fu nella città di Fiorenza un Giovanni Buonaccorsi che, nelle guerre di Carlo Ottavo re di Francia, come giovane et animoso e liberale, in servitù con quel principe, spese tutte le facultà sue nel soldo e nel giuoco, et in ultimo ci lasciò la vita. A costui nacque un figliuolo, il cui nome fu Piero, che rimasto piccolo di due mesi per la madre morta di peste, fu con grandissima miseria allattato da una capra in una villa infino che il padre, andato a Bologna, riprese una seconda donna, alla quale erano morti di peste i figliuoli et il marito. Costei con il latte appestato finì di nutrire Piero, chiamato Pierino per vezzi, come ordinariamente per li più si costuma chiamare i fanciulli, il qual nome se gli mantenne poi tuttavia. Costui condotto dal padre in Fiorenza, e nel suo ritornarsene in Francia lasciatolo ad alcuni suoi parenti, quelli, o per non avere il modo o per non voler quella briga di tenerlo e farli insegnare qualche mestiero ingegnoso, l'acconcia-rono allo speziale del Pinadoro acciò che egli imparasse quel mestiero. Ma non piacendogli quell'arte, fu preso per fattorino da Andrea de' Ceri pittore, piacendogli e l'aria et i modi di Perino e parendogli vedere in esso un non so che d'in-gegno e di vivacità da sperare che qualche buon frutto dovesse col tempo uscir di lui.
Era Andrea non molto buon pittore, anzi ordinario e di questi che stanno a bottega aperta publicamente a lavorare ogni cosa meccanica; et era consueto dipignere ogni anno per la festa di San Giovanni certi ceri che andavano e vanno ad offerirsi, insieme con gli altri tributi della città; e per questo si chiamava Andrea de' Ceri, dal cognome del quale fu poi detto un pezzo Perino de' Ceri. Custodì dunque Andrea Perino qualche anno, et insegnatili i principii dell'arte il meglio che sapeva, fu forzato nel tempo dell'età di lui d'undici anni acconciarlo con miglior maestro di lui. Per che avendo Andrea stretta dimestichezza con Ridolfo, figliuolo di Domenico Ghirlandaio, che era tenuto nella pittura molto pratico e valente, come si dirà, con costui acconciò Andrea de' Ceri Perino, acciò che egli attendesse al disegno e cercasse di fare quell'acquisto in quell'arte che mostrava l'ingegno, che egli aveva grandissimo, con quella voglia et amore che più poteva. E così seguitando, fra molti giovani che egli aveva in bottega che attendevano all'arte, in poco tempo venne a passar a tutti gl'altri innanzi con lo studio e con la sollecitudine.
Eravi fra gli altri uno, il quale gli fu uno sprone che del continuo lo pugneva, il quale fu nominato Toto del Nunziata, il quale, ancor egli aggiugnendo col tempo a paragone con i begli ingegni, partì di Fiorenza, e con alcuni mercanti fiorentini condottisi in Inghilterra, quivi ha fatto tutte l'opere sue; e dal re di quella provincia, il quale ha anco servito nell'architettura e fatto particolarmente il principale palazzo, è stato riconosciuto grandissimamente. Costui adunque e Perino esercitandosi a gara l'uno e l'altro, e seguitando nell'arte con sommo studio, non andò molto tempo, divennero eccellenti. E Perino disegnando in compagnia di altri giovani, e fiorentini e forestieri, al cartone di Michelagnolo Buonarroti, vinse e tenne il primo grado fra tutti gl'altri. Di maniera che si stava in quella aspettazione di lui, che succedette di poi nelle belle opere sue, condotte con tanta arte et eccellenza.
Venne in quel tempo in Fiorenza il Vaga pittor fiorentino, il quale lavorava in Toscanella in quel di Roma cose grosse; per non essere egli maestro eccellente, e soprabondatogli lavoro, aveva di bisogno d'aiuti, e desiderava menar seco un compagno et un giovanetto che gli servisse al disegno, che non aveva, et all'altre cose dell'arte; per che veden-do costui Perino disegnare in bottega di Ridolfo insieme con gli altri giovani, e tanto superiore a quegli che ne stupì, e che più piacendogli l'aspetto et i modi suoi, atteso che Perino era un bellissimo giovanetto, cortesissimo, modesto e gentile, et aveva tutte le parti del corpo corrispondenti alla virtù dell'animo, se n'invaghì di maniera che lo domandò se egli volesse andar seco a Roma, che non mancherebbe aiutarlo negli studii e farli que' benefizii e patti che egli stesso volesse. Era tanta la voglia ch'aveva Perino di venire a qualche grado eccellente della professione sua, che quando sentì ricordar Roma, per la voglia che egli ne aveva, tutto si rintenerì e gli disse che egli parlasse con Andrea de' Ceri, che non voleva abbandonarlo, avendolo aiutato per fino allora. Così il Vaga, persuaso Ridolfo suo maestro et Andrea che lo teneva, tanto fece che alla fine condusse Perino et il compagno in Toscanella. Dove cominciando a lavorare, et aiutando loro Perino, non finirono solamente quell'opera che il Vaga aveva presa, ma molte ancora che pigliarono di poi. Ma dolendosi Perino che le promesse, con le quali fu condotto p[resso] a Roma, erano mandate in lunga per colpa dell'utile e commodità che ne traeva il Vaga, e risolvendosi andarci da per sé, fu cagione che il Vaga, lasciato tutte l'opere, lo condusse a Roma. Dove egli, per l'amore che portava all'arte, ritornò al solito suo disegno, e continuando molte settimane, più ogni giorno si accendeva. Ma volendo il Vaga far ritorno a Toscanella, e per questo fatto conoscere a molti pittori ordinarii Perino per cosa sua, lo raccomandò a tutti quegli amici che là aveva, acciò l'aiutassino e favorissino in assenza sua. E da questa origine, da indi innanzi, si chiamò sempre Perin del Vaga.
Rimaso costui in Roma, e vedendo le opere antiche nelle sculture e le mirabilissime machine degli edifizi, gran parte rimase nelle rovine, stava in sé ammiratissimo del valore di tanti chiari et illustri che avevano fatte quelle opere. E così accendendosi tuttavia più in maggior desiderio dell'arte, ardeva continuamente di pervenire in qualche grado vicino a quelli, sì che con le opere desse nome a sé et utile, come l'avevano dato coloro di chi egli si stupiva vedendo le bellissime opere loro. E mentre che egli considerava alla grandezza loro et alla infinita bassezza e povertà sua, e che altro che la voglia non aveva di volere aggiugnerli, e che senza avere chi lo intrattenesse che potesse campar la vita gli conveniva, volendo vivere, lavorare a opere per quelle botteghe oggi con uno dipintore e domane con un altro, nella maniera che fanno i zappatori a giornate; e quanto fusse disconveniente allo studio suo questa maniera di vita, egli medesimo per dolore se ne dava infinita passione non potendo far que' frutti, e così presto, che l'animo e la volontà et il bisogno suo gli promettevano. Fece adunque proponimento di dividere il tempo, la metà della settimana lavorando a giornate et il restante attendendo al disegno. Aggiugnendo a questo ultimo tutti i giorni festivi, insieme con una gran parte delle notti, e rubando al tempo il tempo, per divenire famoso e fuggir dalle mani d'altrui più che gli fusse possibile.
Messo in esecuzione questo pensiero, cominciò a disegnare nella cappella di papa Giulio, dove la volta di Michelagnolo Buonarroti era dipinta da lui, seguitando gli andari e la maniera di Raffaello da Urbino. E così continuando a le cose antiche di marmo, e sotto terra a le grotte per la novità delle grottesche, imparò i modi del lavorare di stucco e, mendicando il pane con ogni stento, sopportò ogni miseria per venir eccellente in questa professione. Né vi corse molto tempo ch'egli divenne, fra quegli che disegnavano in Roma, il più bello e miglior disegnatore che ci fusse; atteso che meglio intendeva i muscoli e le difficultà dell'arte negli ignudi che forse molti altri, tenuti maestri allora de' migliori. La qual cosa fu ancora fra molti signori e prelati e' fosse conosciuto, e, massimamente, che Giulio Romano e Giovan Francesco detto il Fattore, discepoli di Raffaello da Urbino, lodatolo al maestro pur assai, fecero ch'e' lo volle conoscere e vedere l'opere sue ne' disegni. I quali piaciutili, et insieme col fare la maniera e lo spirito et i modi della vita, giudicò lui, fra tanti quanti ne aveva conosciuti, dover venire in gran perfezzione in quell'arte.
Essendo intanto state fabbricate da Raffaello da Urbino le logge papali che Leon Decimo gli aveva ordinate, ordinò il medesimo che esso Raffaello le facesse lavorare di stucco e dipignere e metter d'oro come meglio a lui pareva. E così Raffaello fece capo di quell'opera, per gli stucchi e per le grottesche, Giovanni da Udine, rarissimo et unico in quegli, ma più negli animali e frutti et altre cose minute; e perché egli aveva scelto per Roma e fatto venir di fuori molti maestri, aveva raccolto una compagnia di persone valenti ciascuno nel lavorare, chi stucchi, chi grottesche, altri fogliami, altri festoni e storie, et altri altre cose; e così, secondo che eglino miglioravano, erano tirati innanzi e fatto loro maggior salari. Laonde, gareggiando in quell'opera, si condussono a perfezzione molti giovani che furon poi tenuti eccellenti nelle opere loro.
In questa compagnia fu consegnato Perino a Giovanni da Udine da Raffaello, per dovere con gli altri lavorare e grottesche e storie, con dirgli che secondo che egli si porterebbe sarebbe da Giovanni adoperato. Lavorando dunque Perino per la concorrenza e per far prova et acquisto di sé, non vi andò molti mesi che egli fu, fra tutti coloro che ci lavoravano, tenuto il primo, e di disegno e di colorito, anzi il migliore et il più vago e pulito, e quegli che con più leggiadra e bella maniera conducesse grottesche e figure, come ne rendono testimonio e chiara fede le grottesche et i festoni e le storie di sua mano che in quell'opera sono, le quali, oltre l'avanzar le altre, son dai disegni e schizzi che faceva lor Raffaello condotte le sue molto meglio et osservate molto, come si può vedere in una parte di quelle storie nel mezzo della detta loggia nelle volte, dove sono figurati gli Ebrei quando passano il Giordano con l'arca santa e quando, girando le mura di Gerico, quelle rovinano, e le altre che seguono dopo, come quando combattendo Iosuè con quegli Amorrei fa fermar il sole. E finte di bronzo sono nel basamento le migliore similmente quelle di mano di Perino, cioè quando Abraam sacrifica il figliuolo, Iacob fa alla lotta con l'Angelo, Iosef che raccoglie i dodici fratelli, et il fuoco che, scendendo dal cielo, abbrucia i figliuoli di Levi, e molte altre che non fa mestiero, per la moltitudine loro, nominarle, che si conoscono infra le altre. Fece ancora nel principio dove si entra nella loggia, del Testamento Nuovo, la natività e battesimo di Cristo e la cena degli Apostoli con Cristo, che sono bellissime; senzaché sotto le finestre sono, come si è detto, le migliori storie colorite di bronzo che siano in tutta quell'opera. Le quali cose fanno stupire ognuno, e per le pitture e per molti stucchi che egli vi lavorò di sua mano; oltraché il colorito suo è molto più vago e meglio finito che tutti gli altri. La quale opera fu cagione che egli divenne oltre ogni credenza famoso, né per ciò cotali lode furono cagione di addormentarlo, anzi, perché la virtù lodata cresce, di accenderlo a maggior studio, e quasi certissimo seguitandola di dover còrre que' frutti e quegli onori ch'egli vedeva tutto il giorno in Raffaello da Urbino et in Michelagnolo Buonarroti. Et in tanto più lo faceva volentieri, quanto da Giovanni da Udine e da Raffaello vedeva esser tenuto conto di lui et essere adoperato in cose importanti. Usò sempre una sommessione et un'obedienza certo grandissima verso Raffaello, osservandolo di maniera, che da esso Raffaello era amato come proprio figliuolo.
Fecesi in questo tempo, per ordine di papa Leone, la volta della sala de' Pontefici, che è quella per la quale si entra in sulle logge a le stanze di papa Alessandro Sesto dipinte già dal Pinturicchio, onde quella volta fu dipinta da Giovan da Udine e da Perino. Et in compagnia feciono e gli stucchi e tutti quegli ornamenti e grottesche et animali che vi si veggono, oltra le belle e varie invenzioni che da essi furono fatte nello spartimento, avendo diviso quella in certi tondi et ovati per sette pianeti del cielo, tirati dai loro animali, come Giove dall'aquile, Venere dalle colombe, la Luna dalle femmine, Marte dai lupi, Mercurio da' galli, il Sole da' cavalli e Saturno da' serpenti, oltre i dodici segni del zodiaco et alcune figure delle settantadue imagini del cielo, come l'Orsa maggiore, la Canicola e molte altre che, per la lunghezza loro, le taceremo senza raccontarle per ordine, potendosi l'opera vedere, le quali tutte figure sono per la maggior parte di mano di Perino. Nel mezzo della volta è un tondo con quattro figure finte per vittorie, che tengono il regno del papa e le chiavi, scortando al disotto in su, lavorate con maestrevol arte e molto bene intese. Oltra la leggiadria che egli usò negli abiti loro, velando l'ignudo con alcuni pannicini sottili che in parte scuoprono le gambe ignude e le braccia, certo con una graziosissima bellezza. La quale opera fu veramente tenuta, et oggi ancora si tiene, per cosa molto onorata e ricca di lavoro, e cosa allegra, vaga e degna veramente di quel Pontefice; il quale non mancò riconoscere le lor fatiche, degne certo di grandissima remunerazione.
Fece Perino una facciata di chiaro oscuro, allora messasi in uso per ordine di Polidoro e Maturino, la quale è dirimpetto alla casa della marchesa di Massa, vicino a maestro Pasquino, condotta molto gagliardamente di disegno e con somma diligenza.
Venendo poi, il terzo anno del suo pontificato, papa Leone a Fiorenza, per che in quella città si feciono molti trionfi, Perino, parte per vedere la pompa di quella città e parte per rivedere la patria, venne inanzi alla corte; e fece, in un arco trionfale a S. Trinita, una figura grande di sette braccia bellissima, avendone un'altra a sua concorrenza fatta Toto del Nunziata, già nella età puerile suo concorrente. Ma parendo a Perino ogni ora mille anni di ritornarsene a Roma, giudicando molto differente la maniera et i modi degli artefici da quegli che in Roma si usavano, si partì di Firenze e là se ne ritornò, dove, ripreso l'ordine del solito suo lavorare, fece in S. Eustachio da la Dogana un San Piero in fresco, il quale è una figura che ha rilievo grandissimo, fatto con semplice andare di pieghe, ma molto con disegno e giudizio lavorato.
Essendo in questo tempo l'arcivescovo di Cipri in Roma, uomo molto amatore delle virtù, ma particolarmente della pittura, et avendo egli una casa vicina alla Chiavica, nella quale aveva acconcio un giardinetto con alcune statue et altre anticaglie certo onoratissime e belle, e desiderando accompagnarle con qualche ornamento onorato, fece chiamare Perino, che era suo amicissimo; et insieme consultarono che e' dovesse fare intorno alle mura di quel giardino molte storie di baccanti, di satiri e di fauni e di cose selvagge, alludendo ad una statua d'un Bacco, che egli ci aveva, antico, che sedeva vicino a una tigre. E così adornò quel luogo di diverse poesie; vi fece fra l'altre cose una loggetta di figure piccole, e varie grottesche e molti quadri di paesi, coloriti con una grazia e diligenza grandissima. La quale opera è stata tenuta, e sarà sempre dagli artefici, cosa molto lodevole; onde fu cagione di farlo conoscere a' Fucheri mercanti tedeschi, i quali, avendo visto l'opera di Perino e piaciutali, perché avevano murato vicino a Banchi una casa, che è quando si va a la chiesa de' Fiorentini, vi fecero fare da lui un cortile et una loggia e molte figure, degne di quelle lodi che son l'altre cose di sua mano; nelle quali si vede una bellissima maniera et una grazia molto leggiadra.
Ne' medesimi tempi avendo Messer Marchionne Baldassini fatto murare una casa molto bene intesa, come s'è detto, da Antonio da Sangallo, vicino a S. Agostino, e desiderando che una sala che egli vi aveva fatta fusse dipinta tutta, esaminati molti di que' giovani acciò che ella fusse e bella e ben fatta, si risolvé dopo molti darla a Perino, con il quale, convenutosi del prezzo, vi messe egli mano; né da quella levò per altri l'animo, che egli felicissimamente la condusse a fresco. Nella quale sala fece uno spartimento a' pilastri, che mettono in mezzo nicchie grandi e nicchie piccole, e nelle grandi sono varie sorti di filosofi, due per nicchia, et in qualcuna un solo, e nelle minori sono putti ignudi e parte vestiti di velo, con certe teste di femmine finte di marmo sopra alle nicchie piccole. E sopra la cornice che fa fine a' pilastri, seguiva un altro ordine, partito sopra il primo ordine, con istorie di figure non molto grandi de' fatti de' Romani, cominciando da Romulo per fino a Numa Pompilio. Sonovi similmente varii ornamenti contrafatti di varie pietre di marmi; è sopra il cammino di pietre bellissimo una Pace la quale abbraccia armi e trofei, che è molto viva. Della quale opera fu tenuto conto, mentre visse Messer Marchionne, e di poi da tutti quelli che operano in pittura, oltra quelli che non sono della professione, che la lodano straordinariamente.
Fece nel monasterio delle monache di Santa Anna una cappella in fresco con molte figure, lavorata da lui con la solita diligenzia. Et in San Stefano del Cacco, ad un altare, dipinse in fresco per una gentildonna romana una Pietà con un Cristo morto in grembo alla Nostra Donna, e ritrasse di naturale quella gentildonna che par ancor viva. La quale opera è condotta con una destrezza molto facile e molto bella. Aveva in questo tempo Antonio da Sangallo fatto in Roma, in su una cantonata di casa, che si dice l'immagine di Ponte, un tabernacolo molto ornato di trevertino e molto onorevole, per farvi dentro di pitture qualcosa di bello; e così ebbe commessione dal padrone di quella casa che lo dessi a fare a chi li pareva che fusse atto a farvi qualche onorata pittura. Onde Antonio, che conosceva Perino di que' giovani che vi erano per il migliore, a lui la allogò. Et egli messovi mano, vi fece dentro Cristo quando incorona la Nostra Donna, e nel campo fece uno splendore con un coro di Serafini et Angeli che hanno certi panni sottili che spargono fiori, et altri putti molto belli e varii, e così nelle due facce del tabernacolo fece nell'una San Bastiano e nell'altra Santo Antonio, opera certo ben fatta e simile alle altre sue, che sempre furono e vaghe e graziose.
Aveva finito nella Minerva un protonotario, una cappella di marmo in su quattro colonne; e come quello che desiderava lassarvi una memoria d'una tavola, ancora che non fusse molto grande, sentendo la fama di Perino, convenne seco e gliela fece lavorare a olio, et in quella volle a sua elezzione un Cristo sceso di croce; il quale Perino, con ogni studio e fatica, si messe a condurre. Dove egli lo figurò esser già in terra deposto, et insieme le Marie intorno che lo piangono, fingendo un dolore e compassionevole affetto nelle attitudini e gesti loro; oltra che vi sono que' Niccodemi, e le altre figure ammiratissime, meste et afflitte nel vedere l'innocenza di Cristo morto. Ma quel che egli fece divinissimamente furono i duoi ladroni, rimasti confitti in sulla croce, che sono oltra al parer morti e veri, molto ben ricerchi di muscoli e di nervi, avendo egli occasione di farlo, onde si rappresentano, a gl'occhi di chi li vede, le membra loro in quella morte violenta tirate dai nervi et i muscoli da' chiovi e dalle corde. Èvvi oltre ciò un paese nelle tenebre, contrafatto con molta discrezione et arte. E se a questa opera non avesse la inondazione del diluvio che venne a Roma doppo il Sacco fatto dispiacere coprendola più di mezza, si vedrebbe la sua bontà, ma l'acqua rintenerì di maniera il gesso e fece gonfiare il legname di sorte, che tanto quanto se ne bagnò da piè si è scortecciato in modo che se ne gode poco, anzi fa compassione il guardalla e grandissimo dispiacere, perché ella sarebbe certo de le pregiate cose che avesse Roma.
Facevasi in questo tempo per ordine di Iacopo Sansovino rifar la chiesa di S. Marcello di Roma, convento de' frati de' Servi, che oggi è rimasa imperfetta; onde, avendo eglino tirate a fine di muraglia alcune cappelle e coperte di sopra, ordinaron que' frati che Perino facesse in una di quelle per ornamento d'una Nostra Donna, devozione in quella chiesa, due figure in due nicchie che la mettessino in mezzo: San Giuseppo e San Filippo, frate de' Servi et autore di quella Religione. E quelli finiti, fece loro sopra alcuni putti perfettissimamente, e ne messe in mezzo della facciata uno ritto in sur un dado che tiene sulle spalle il fine di due festoni che esso manda verso le cantonate della cappella, dove sono due altri putti che gli reggono a sedere in su quelli, facendo con le gambe attitudini bellissime. E questo lavorò con tant'arte, con tanta grazia, con tanta bella maniera, dandoli nel colorito una tinta di carne e fresca e morbida, che si può dire che sia carne vera, più che dipinta. E certo si possono tenere per i più begli che in fresco facesse mai artefice nessuno; la cagione è che nel guardo vivono, nell'attitudine si muovono, e ti fan segno con la bocca voler isnodar la parola, e che l'arte vince la natura, anzi che ella confessa non potere far in quella più di questo. Fu questo lavoro di tanta bontà nel conspetto di chi intendeva l'arte, che ne acquistò gran nome, ancora che egli avesse fatto molte opere e si sapesse certo quello che si sapeva del grande ingegno suo in quel mestiero; e se ne tenne molto più conto e maggiore stima, che prima non si era fatto.
E per questa cagione Lorenzo Pucci cardinale Santiquattro, avendo preso alla Trinità, convento de' frati calavresi e franciosi che vestono l'abito di San Francesco di Paula, una cappella a man manca allato alla cappella maggiore, la allogò a Perino, acciò che in fresco vi dipignesse la vita della Nostra Donna. La quale cominciata da lui, finì tutta la volta et una facciata sotto un arco; e così fuor di quella, sopra un arco della cappella, fece due Profeti grandi di quattro braccia e mezzo, figurando Isaia e Daniel, i quali nella grandezza loro mostrano quell'arte e bontà di disegno e vaghezza di colore, che può perfettamente mostrare una pittura fatta da artefice grande. Come apertamente vedrà chi considererà lo Esaia, che mentre legge si conosce la maninconia che rende in sé lo studio et il desiderio nella novità del leggere, perché affisato lo sguardo a un libro, con una mano alla testa mostra come l'uomo sta qualche volta quando egli studia. Similmente il Daniel immoto alza la testa alle contemplazioni celesti, per isnodare i dubbi a' suoi popoli. Sono, nel mezzo di questi, due putti che tengono l'arme del cardinale, con bella foggia di scudo, i quali oltre l'esser dipinti che paion di carne, mostrano ancor esser di rilievo. Sono sotto spartite nella volta quattro storie, dividendole la crocera, cioè gli spigoli delle volte. Nella prima è la concezzione di essa Nostra Donna; nella seconda è la natività sua; nella terza è quando ella saglie i gradi del tempio; e nella quarta quando San Giuseppo la sposa. In una faccia, quanto tiene l'arco della volta, è la sua visitazione, nella quale sono molte belle figure, e massimamente alcune che son salite in su certi basamenti; che, per veder meglio le cerimonie di quelle donne, stanno con prontezza molto naturale; oltraché i casamenti e l'altre figure hanno del buono e del bello in ogni loro atto. Non seguitò più giù, venendoli male; e guarito cominciò, l'anno 1523, la peste, la quale fu di sì fatta sorte in Roma, che se egli volle campar la vita, gli convenne far proposito partirsi. Era in questo tempo in detta città il Piloto orefice, amicissimo e molto familiare di Perino, il quale aveva volontà partirsi; e così desinando una mattina insieme, persuase Perino ad allontanarsi e venire a Fiorenza, atteso che egli era molti anni che egli non ci era stato, e che non sarebbe se non grandissimo onor suo farsi conoscere e lasciare in quella qualche segno della eccellenza sua. Et ancora che Andrea de' Ceri e la moglie che l'avevano allevato fussino morti, nondimeno egli, come nato in quel paese, ancor che non ci avesse niente, ci aveva amore. Onde non passò molto che egli et il Piloto una mattina partirono, et in verso Fiorenza ne vennero. Et arrivati in quella, ebbe grandissimo piacere riveder le cose vecchie dipinte da' maestri passati che già gli furono studio nella sua età puerile, e così ancora quelle di que' maestri che vivevano allora de' più celebrati e tenuti migliori in quella città, nella quale per opera degl'amici gli fu allogato un lavoro, come di sotto si dirà.
Avenne che, trovandosi un giorno seco per fargli onore molti artefici, pittori, scultori, architetti, orefici et intagliatori di marmi e di legnami, che secondo il costume antico si erano ragunati insieme, chi per vedere et accompagnare Perino et udire quello che e' diceva, e molti per veder che differenza fusse fra gli artefici di Roma e quegli di Fiorenza nella pratica - et i più v'erano per udire i biasimi e le lode che sogliono spesso dire gli artefici l'un de l'altro - avvenne, dico, che così ragionando insieme d'una cosa in altra, pervennero, guardando l'opere e vecchie e moderne per le chiese, in quella del Carmine per veder la cappella di Masaccio. Dove guardando ognuno fisamente e moltiplicando in varii ragionamenti in lode di quel maestro, tutti affermarono maravigliarsi che egli avesse avuto tanto di giudizio che egli in quel tempo, non vedendo altro che l'opere di Giotto, avesse lavorato con una maniera sì moderna nel disegno, nella imitazione e nel colorito, che egli avesse avuto forza di mostrare, nella facilità di quella maniera, la difficultà di quest'arte; oltreché nel rilievo e nella resoluzione e nella pratica non ci era stato nessuno di quegli che avevano operato, che ancora lo avesse raggiunto. Piacque assai questo ragionamento a Perino, e rispose a tutti quegli artefici, che ciò dicevano, queste parole: “Io non niego quel che voi dite che non sia, e molto più ancora, ma che questa maniera non ci sia chi la paragoni negherò io sempre; anzi dirò, se si può dire, con sopportazione di molti, non per dispregio, ma per il vero, che molti conosco e più risoluti e più graziati; le cose de' quali non sono manco vive in pittura di queste, anzi molto più belle. E mi duole in servigio vostro, io che non sono il primo dell'arte, che non ci sia luogo qui vicino da potervi fare una figura che, innanzi che io mi partisse di Fiorenza, farei una prova, allato a una di queste in fresco medesimamente, acciò che voi col paragone vedeste se ci è nessuno fra i moderni che l'abbia paragonato”. Era fra costoro un maestro tenuto il primo in Fiorenza nella pittura, e come curioso di veder l'opere di Perino e forse per abbassarli lo ardire, messe innanzi un suo pensiero, che fu questo: “Se bene egli è pieno”, diss'egli, “costì ogni cosa, avendo voi cotesta fantasia, che è certo buona e da lodare, egli è qua al dirimpetto dove è il San Paolo di sua mano, non meno buona e bella figura che si sia ciascuna di queste della cappella, uno spazio: agevolmente potrete mostrarci quello che voi dite, faccendo un altro Apostolo allato, o volete a quel San Piero di Masolino, o allato al San Paolo di Masaccio”. Era il San Piero più vicino alla finestra et eraci migliore spazio e miglior lume, et oltre a questo non era manco bella figura che il San Paolo. Adunque ognuno confortavano Perino a fare, perché avevano caro veder questa maniera di Roma; oltreché molti dicevano che egli sarebbe cagione di levar loro del capo questa fantasia, tenuta nel cervello tante decine d'anni, e che s'ella fusse meglio, tutti correrebbono a le cose moderne. Per il che, persuaso Perino da quel maestro, che gli disse in ultimo che non doveva mancarne, per la persuasione e piacere di tanti begli ingegni, oltre che elle erano due settimane di tempo quelle che a fresco conducevano una figura, e che loro non mancherebbono spender gli anni in lodare le sue fatiche, si risolvette di fare, se bene colui che diceva così era d'animo contrario, persuadendosi che egli non dovesse fare però cosa molto miglior di quello che facevano allora quegli artefici che tenevano il grado de' più eccellenti. Accettò Perino di far questa prova, e chiamato di concordia Messer Giovanni da Pisa priore del convento, gli dimandarono licenzia del luogo per far tal opera, che invero di grazia e cortesemente lo concedette loro; e così preso una misura del vano, con le altezze e larghezze, si partirono. Fu dunque fatto da Perino in un cartone un Apostolo in persona di S. Andrea e finito diligentissimamente, onde era già Perino risoluto voler dipignerlo, et avea fatto fare l'armatura per cominciarlo; ma inanzi a questo nella venuta sua molti amici suoi, che avevano visto in Roma eccellentissime opere sue, gli avevano fatto allogare quell'opera a fresco ch'io dissi, acciò lasciasse di sé in Fiorenza qualche memoria di sua mano che avesse a mostrare la bellezza e la vivacità dell'ingegno che egli aveva nella pittura, et acciò che fusse cognosciuto e forse, da chi governava allora, messo in opera in qualche lavoro d'importanza.
Erano in Camaldoli di Fiorenza allora uomini artefici che si ragunavano a una Compagnia, nominata de' Martiri, i quali avevano avuto voglia più volte di far dipignere una facciata, che era in quella, drentovi la storia di essi martiri quando e' sono condennati alla morte dinanzi a' due imperadori romani che, dopo la battaglia e presa loro, gli fanno in quel bosco crocifiggere e sospender a quegli alberi. La quale storia fu messa per le mani a Perino, et ancora che il luogo fusse discosto et il prezzo piccolo, fu di tanto potere l'invenzione della storia e la facciata che era assai grande, che egli si dispose a farla; oltreché egli ne fu assai confortato da chi gli era amico, atteso che questa opera lo metterebbe in quella considerazione che meritava la sua virtù fra i cittadini che non lo conoscevano, e fra gli artefici suoi in Fiorenza, do-ve non era conosciuto se non per fama. Deliberatosi dunque a lavorare, prese questa cura, e fattone un disegno piccolo, che fu tenuta cosa divina, e messo mano a fare un cartone grande quanto l'opera, lo condusse (non si partendo d'intorno a quello) a un termine che tutte le figure principali erano finite del tutto. E così l'Apostolo si rimase indietro, senza farvi altro.
Aveva Perino disegnato questo cartone in sul foglio bianco, sfumato e tratteggiato, lasciando i lumi della propria carta, e condotto tutto con una diligenza mirabile; nella quale erano i due imperadori nel tribunale che sentenziano a la croce tutti i prigioni, i quali erano volti verso il tribunale, chi ginocchioni, chi ritto et altro chinato, tutti ignudi legati per diverse vie, in attitudini varie, storcendosi con atti di pietà e conoscendo il tremar delle membra, per aversi a disgiugner l'anima nella passione e tormento della crocifissione; oltreché vi era accennato in quelle teste la constanzia della fede né vecchi, il timore della morte ne' giovani, in altri il dolore delle torture nello stringerli le legature il torso e le braccia. Vedevasi appresso il gonfiar de' muscoli, e fino al sudor freddo della morte, accennato in quel disegno. Appresso si vedeva ne' soldati che gli guidavano una fierezza terribile, impiissima e crudele nel presentargli al tribunale per la sentenza e nel guidargli a le croci. Avevano indosso gli imperadori e' soldati, corazze all'antica et abbigliamenti molto ornati e bizzarri, et i calzari, le scarpe, le celate, le targhe e le altre armadure fatte con tutta quella copia di bellissimi ornamenti che più si possa fare et imitare et aggiugnere all'antico, disegnate con quell'amore et artifizio e fine, che può far tutti gli estremi dell'arte. Il quale cartone, vistosi per gli artefici e per altri intendenti ingegni, giudicarono non aver visto pari bellezza e bontà in disegno dopo quello di Michelagnolo Buonarroti, fatto in Fiorenza per la sala del Consiglio. Laonde, acquistato Perino quella maggior fama che egli più poteva acquistare nell'arte, mentre che egli andava finendo tal cartone, per passar tempo, fece mettere in ordine e macinare colori a olio per fare al Piloto orefice suo amicissimo un quadretto non molto grande; il quale condusse a fine quasi più di mezzo, dentrovi una Nostra Donna.
Era già molti anni stato domestico di Perino un ser Raffaello di Sandro, prete zoppo, cappellano di San Lorenzo, il quale portò sempre amore agli artefici di disegno; costui dunque persuase Perino a tornar seco in compagnia, non avendo egli né chi gli cucinasse, né chi lo tenesse in casa, essendo stato il tempo che ci era stato, oggi con un amico e domani con un altro. Laonde Perino andò alloggiare seco e vi stette molte settimane. Intanto la peste cominciata a scoprirsi in certi luoghi in Fiorenza, messe a Perino paura di non infettarsi; per il che deliberato partirsi, volle prima sodisfare a ser Raffaello tanti dì ch'era stato seco a mangiare, ma non volle mai ser Raffaello acconsentire di pigliare niente; anzi disse: “E' mi basta un tratto avere uno straccio di carta di tua mano”. Per il che, visto questo, Perino tolse circa a quattro braccia di tela grossa, e fattola appiccare ad un muro che era fra due usci della sua saletta, vi fece un'istoria contrafatta di color di bronzo, in un giorno et in una notte. Nella quale tela, che serviva per ispalliera, fece l'istoria di Mosè quando passa il Mar Rosso e che faraone si sommerge in quello co' suoi cavalli e co' suoi carri: dove Perino fece attitudini bellissime di figure, chi nuota armato e chi ignudo, altri, abbracciando il collo a' cavalli, bagnati le barbe et i capelli, nuotano e gridano per la paura della morte, cercando il più che possono di scampare; da l'altra parte del mare vi è Mosè, Aron e gli altri Ebrei, maschi e femmine, che ringraziano Iddio; et un numero di vasi, ch'egli finge che abbino spogliato l'Egitto, con bellissimi garbi e varie forme, e femine con acconciature di testa molto varie, la quale finita lasciò per amorevolezza a ser Raffaello; al quale fu cara tanto, quanto se gli avesse lassato il priorato di San Lorenzo. La qual tela fu tenuta di poi in pregio e lodata, e dopo la morte di ser Raffaello rimase, con le altre sue robe, a Domenico di Sandro, pizzicagnolo, suo fratello.
Partendo dunque di Firenze, Perino lasciò in abbandono l'opera de' Martiri, della quale rincrebbe grandemente; e certo se ella fusse stata in altro luogo che in Camaldoli, l'arebbe egli finita; ma considerato che gli uffiziali della sanità avevano preso per gli appestati lo stesso convento di Camaldoli, volle più tosto salvare sé che lasciar fama in Fiorenza, bastandoli aver mostrato quanto e' valeva nel disegno. Rimase il cartone e l'altre sue robe a Giovanni di Goro orefice suo amico, che si morì nella peste; e dopo lui pervenne nelle mani del Piloto, che lo tenne molti anni spiegato in casa sua, mostrandolo volentieri a ogni persona d'ingegno come cosa rarissima; ma non so già dove e' si capitasse dopo la morte del Piloto. Stette fuggiasco molti mesi dalla peste Perino in più luoghi, né per questo spese mai il tempo indarno che egli continovamente non disegnasse e studiasse cose dell'arte; e cessata la peste se ne tornò a Roma et attese a far cose piccole, le quali io non narrerò altrimenti.
Fu l'anno 1523 creato papa Clemente Settimo, che fu un grandissimo refrigerio all'arte della pittura e della scultura, state da Adriano Sesto, mentre che e' visse, tenute tanto basse, che non solo non si era lavorato per lui niente, ma non se ne dilettando, anzi più tosto avendole in odio, era stato cagione che nessuno altro se ne dilettasse, o spendesse, o trattenesse nessuno artefice, come si è detto altre volte. Per il che Perino allora fece molte cose nella creazione del nuovo Pontefice.
Deliberandosi poi di far capo de l'arte, in cambio di Raffaello da Urbino già morto, Giulio Romano e Giovan Francesco detto il Fattore, acciò che scompartissino i lavori agli altri secondo l'usato di prima, Perino, che aveva lavorato un'arme del Papa in fresco col cartone di Giulio Romano sopra la porta del cardinal Ceserino, si portò tanto egregia-mente, che dubitarono non egli fusse anteposto a loro, perché, ancora che egli avessino nome di discepoli di Raffaello e d'avere eredato le cose sue, non avevano interamente l'arte e la grazia, che egli coi colori dava alle sue figure, eredato. Presono partito, adunque, Giulio e Giovan Francesco d'intrattenere Perino; e così l'anno santo del Giubileo 1525 diedero la Caterina, sorella di Giovan Francesco, a Perino per donna, acciò che fra loro fusse quella intera amicizia, che tanto tempo avevono contratta, convertita in parentado. Laonde, continovando l'opere che faceva, non vi andò troppo tempo che, per le lode dategli nella prima opera fatta in San Marcello, fu deliberato dal priore di quel convento e da certi capi della Compagnia del Crocifisso, la quale ci ha una cappella fabbricata dagli uomini suoi per ragunarvisi, che ella si dovesse dipignere; e così allogarono a Perino questa opera, con speranza di avere qualche cosa eccellente di suo.
Perino fattovi fare i ponti, cominciò l'opera; e fece nella volta a mezza botte, nel mezzo, un'istoria quando Dio, fatto Adamo, cava della costa sua Eva sua donna, nella quale storia si vede Adamo ignudo, bellissimo et artifizioso, che oppresso dal sonno giace, mentre che Eva vivissima a man giunte si leva in piedi e riceve la benedizzione dal suo fattore: la figura del quale è fatta di aspetto ricchissimo e grave, in maestà, diritta, con molti panni attorno, che vanno girando con i lembi l'ignudo; e da una banda a man ritta due Evangelisti, de' quali finì tutto il S. Marco et il San Giovanni, eccetto la testa et un braccio ignudo. Fecevi in mezzo fra l'uno e l'altro, due puttini che abracciano per ornamento un candeliere, che veramente son di carne vivissimi, e similmente i Vangelisti molto belli, nelle teste e ne' panni e braccia e tutto quel che lor fece di sua mano. La quale opera, mentre che egli fece, ebbe molti impedimenti, e di malattie e d'altri infortuni, che accaggiono giornalmente a chi ci vive; oltraché dicono che mancarono danari ancora a quelli della Compagnia; e talmente andò in lungo questa pratica che l'anno 1527 venne la rovina di Roma, che fu messa quella città a sacco, e spento molti artefici e distrutto e portato via molte opere. Onde Perino, trovandosi in tal frangente et avendo donna et una puttina, con la quale corse in collo per Roma per camparla di luogo in luogo, fu in ultimo miserissimamente fatto prigione, dove si condusse a pagar taglia con tanta sua disavventura, che fu per dar la volta al cervello.
Passato le furie del Sacco, era sbattuto talmente per la paura che egli aveva ancora, che le cose dell'arte si erano allontanate da lui; ma nientedimeno fece per alcuni soldati spagnuoli tele a guazzo et altre fantasie e, rimessosi in assetto, viveva come gli altri poveramente. Solo fra tanti il Baviera, che teneva le stampe di Raffaello, non aveva perso molto, onde per l'amicizia ch'egli aveva con Perino, per intrattenerlo gli fece disegnare una parte d'istorie, quando gli dèi si trasformano per conseguire i fini de' loro amori. I quali furono intagliati in rame da Jacopo Caraglio eccellente intagliatore di stampe. Et invero in questi disegni si portò tanto bene che, riservando i dintorni e la maniera di Perino, e tratteggiando quegli con un modo facilissimo, cercò ancora dar loro quella leggiadria e quella grazia che aveva dato Perino a' suoi disegni.
Mentre che le rovine del Sacco avevano distrutta Roma e fatto partir di quella gli abitatori et il Papa stesso, che si stava in Orvieto, non essendovi rimasti molti e non si facendo faccenda di nessuna sorte, capitò a Roma Niccola Viniziano, raro et unico maestro di ricami, servitore del principe Doria, il quale, e per l'amicizia vecchia che aveva con Perino e perché egli ha sempre favorito e voluto bene agli uomini de l'arte, persuase a Perino a partirsi di quella miseria et inviarsi a Genova, promettendogli che egli farebbe opera con quel prencipe, che era amatore e si dilettava della pittura, che gli farebbe fare opere grosse; e massimamente che sua eccellenza gli aveva molte volte ragionato che arebbe avuto voglia di far un appartamento di stanze con bellissimi ornamenti. Non bisognò molto persuader Perino per che, essendo dal bisogno oppresso e dalla voglia di uscir di Roma appassionato, deliberò con Niccola partire. E dato ordine di lasciar la sua donna e la figliuola bene accompagnata a' suoi parenti in Roma, et assettato il tutto, se ne andò a Genova. Dove arrivato, e per mezzo di Niccola fattosi noto a quel prencipe, fu tanto grato a sua eccellenza la sua venuta, quanto cosa che in sua vita per trattenimento avesse mai avuta. Fattogli dunque accoglienze e carezze infinite, doppo molti ragionamenti e discorsi, alla fine diedero ordine di cominciare il lavoro, e conchiusono dovere fare un palazzo ornato di stucchi e di pitture a fresco, a olio e d'ogni sorte, il quale più brevemente che io potrò m'ingegnerò di descrivere con le stanze e le pitture et ordine di quello, lasciando stare dove cominciò prima Perino a lavorar, acciò non confonda il dire quest'opera, che di tutte le sue è la migliore.
Dico adunque che all'entrata del palazzo del principe è una porta di marmo, di componimento et ordine dorico, fatta secondo i disegni e modelli di man di Perino, con sue appartenenze di piedistalli, base, fuso, capitelli, architrave, fregio, cornicione e frontespizio, e con alcune bellissime femmine a sedere che reggono un'arme. La quale opera e lavoro intagliò di quadro maestro Giovanni da Fiesole, e le figure condusse a perfezzione Silvio scultore da Fiesole, fiero e vivo maestro. Entrando dentro alla porta è, sopra il ricetto, una volta piena di stucchi con istorie varie e grottesche, con suoi archetti, ne' quali è dentro per ciascuno cose armigere, chi combatte appiè, chi a cavallo, e battaglie varie lavorate con una diligenza et arte certo grandissima.
Truovandosi le scale a man manca, le quali non possono avere il più bello e ricco ornamento di grotteschine all'anti-ca, con varie storie e figurine piccole, maschere, putti, animali et altre fantasie, fatte con quella invenzione e giudizio che solevano esser le cose sue, che in questo genere veramente si possono chiamare divine. Salita la scala, si giugne in una bellissima loggia, la quale ha nelle teste, per ciascuna, una porta di pietra bellissima, sopra le quali, ne' frontespizii di ciascuna, sono dipinte due figure, un maschio et una femmina, volte l'una al contrario dell'altra per l'attitudine, mostrando una la veduta dinanzi, l'altra quella di dietro. Èvvi la volta con cinque archi, lavorata di stucco superbamente, e così tramezzata di pitture con alcuni ovati, dentrovi storie fatte con quella somma bellezza che più si può fare; e le facciate son lavorate fino in terra, dentrovi molti capitani a sedere armati, parte ritratti di naturale e parte imaginati, fatti per tutti i capitani antichi e moderni di casa Doria, e di sopra loro son queste lettere d'oro grandi che dicono: “Magni viri, maximi duces, optima fecere pro patria”. Nella prima sala, che risponde in su la loggia dove s'entra per una delle due porte a man manca, nella volta sono ornamenti di stucchi bellissimi; in sugli spigoli e nel mezzo è una storia grande di un naufragio d'Enea in mare, nel quale sono ignudi vivi e morti, in diverse e varie attitudini, oltre un buon numero di galee e navi, chi salve e chi fracassate dalla tempesta del mare, non senza bellissime considerazioni delle figure vive che si adoprano a difendersi, senza gli orribili aspetti che mostrano nelle cere il travaglio dell'onde, il pericolo della vita e tutte le passioni che dànno le fortune marittime.
Questa fu la prima storia et il primo principio che Perino cominciasse per il prencipe, e dicesi che nella sua giunta in Genova era già comparso inanzi a lui per dipignere alcune cose Girolamo da Trevisi, il quale dipigneva una facciata che guardava verso il giardino, e mentre che Perino cominciò a fare il cartone della storia che di sopra s'è ragionato del naufragio, e mentre che egli a bell'agio andava trattenendosi e vedendo Genova, continovava o poco o assai al cartone, di maniera che già n'era finito gran parte in diverse fogge, e disegnati quegli ignudi, altri di chiaro e scuro, altri di carbone e di lapis nero, altri gradinati, altri tratteggiati e dintornati solamente, mentre, dico, che Perino stava così e non cominciava, Girolamo da Trevisi mormorava di lui, dicendo: “Che cartoni e non cartoni! Io, io ho l'arte su la punta del pennello”.
E sparlando più volte in questa o simil maniera, pervenne agli orecchi di Perino, il quale, presone sdegno, subito fece conficcare nella volta, dove aveva andare la storia dipinta, il suo cartone, e levato in molti luoghi le tavole del palco acciò si potesse veder di sotto, aperse la sala. Il che sentendosi, corse tutta Genova a vederlo e, stupiti del gran disegno di Perino, lo celebrarono immortalmente. Andovvi fra gli altri Girolamo da Trivisi, il quale vide quello che egli mai non pensò vedere di Perino; onde, spaventato dalla bellezza sua, si partì di Genova senza chieder licenza al prencipe Doria, tornandosene in Bologna dove egli abitava. Restò dunque Perino a servire il prencipe e finì questa sala colorita in muro a olio, che fu tenuta et è cosa singularissima nella sua bellezza, essendo (come dissi), in mezzo della volta e dattorno e fin sotto le lunette, lavori di stucchi bellissimi. Nell'altra sala, dove si entra per la porta della loggia a man ritta, fece medesimamente nella volta pitture a fresco, e lavorò di stucco in un ordine quasi simile quando Giove fulmina i giganti, dove sono molti ignudi, maggiori del naturale, molto begli. Similmente in cielo tutti gli dèi i quali, nella tremenda orribilità de' tuoni, fanno atti vivacissimi e molto proprii, secondo le nature loro; oltraché gli stucchi sono lavorati con somma diligenza et il colorito in fresco non può essere più bello, atteso che Perino ne fu maestro perfetto e molto valse in quello. Fecevi quattro camere, nelle quali tutte le volte sono lavorate di stucco in fresco, e scompartitevi dentro le più belle favole d'Ovidio che paiono vere, né si può imaginare la bellezza, la copia et il vario e gran numero che sono per quelle di figurine, fogliami, animali e grottesche, fatte con grande invenzione. Similmente da l'altra banda dell'altra sala fece altre quattro camere, guidate da lui e fatte condurre da' suoi garzoni, dando loro però i disegni così degli stucchi, come delle storie, figure e grottesche, che infinito numero, chi poco e chi assai, vi lavorarono, come Luzio Romano, che vi fece molte opere di grottesche e di stucchi, e molti lombardi. Basta che non vi è stanza che non abbia fatto qualche cosa e non sia piena di fregiature, per fino sotto le volte, di vari componimenti pieni di puttini, maschere bizzarre et animali che è uno stupore; oltreché gli studioli, le anticamere, i destri, ogni cosa è dipinto e fatto bello. Entrasi dal palazzo al giardino in una muraglia terragnola che in tutte le stanze e fin sotto le volte ha fregiature molto ornate, e così le sale e le camere e le anticamere, fatte dalla medesima mano. Et in quest'opera lavorò ancora il Pordenone come dissi nella sua vita; e così Domenico Beccafumi sanese rarissimo pittore, che mostrò non essere inferiore a nessuno degl'altri, quantunque l'opere che sono in Siena di sua mano siano le più eccellenti che egli abbia fatto in fra tante sue.
Ma per tornare all'opere che fece Perino doppo quelle che egli lavorò nel palazzo del prencipe, egli fece un fregio in una stanza di casa Giannettin Doria, dentrovi femmine bellissime, e per la città fece molti lavori a molti gentiluomini, in fresco e coloriti a olio, come una tavola in San Francesco molto bella, con bellissimo disegno, e similmente in una chiesa dimandata Santa Maria de Consolazione, ad un gentiluomo di casa Baciadonne, nella qual tavola fece una Natività di Cristo, opera lodatissima, ma messa in luogo, oscuro talmente, che per colpa del non aver buon lume, non si può conoscer la sua perfezzione, e tanto più che Perino cercò di dipignerla con una maniera oscura, onde avrebbe bisogno di gran lume. Senza i disegni, che e' fece de la maggior parte della Eneide con le storie di Didone, che se ne fece panni d'arazzi, e similmente i begli ornamenti disegnati da lui nelle poppe delle galee, intagliati e condotti a perfezzione dal Carota e dal Tasso, intagliatori di legname fiorentini, i quali eccellentemente mostrarono quanto e' valessino in quell'ar-te. Oltre tutte queste cose, dico, fece ancora un numero grandissimo di drapperie per le galee del prencipe et i maggiori stendardi che si potessi fare per ornamento e bellezza di quelle. Laonde fu per le sue buone qualità tanto amato da quel prencipe che, se egli avesse atteso a servirlo, arebbe grandemente conosciuta la virtù sua.
Mentre che egli lavorò in Genova, gli venne fantasia di levar la moglie di Roma, e così comperò in Pisa una casa, piacendoli quella città, e quasi pensava, invecchiando, elegger quella per sua abitazione.
Essendo dunque in quel tempo Operaio del Duomo di Pisa Messer Antonio di Urbano, il quale aveva desiderio grandissimo d'abbellir quel tempio, aveva fatto fare un principio d'ornamenti di marmo molto belli per le cappelle della chiesa, levando alcune vecchie e goffe che v'erano e senza proporzione, le quali aveva condotte di sua mano Stagio da Pietra Santa, intagliatore di marmi molto pratico e valente. E così dato principio, l'Operaio pensò di riempier dentro i detti ornamenti di tavole a olio, e fuora seguitare a fresco storie e partimenti di stucchi, e di mano de' migliori e più eccellenti maestri che egli trovasse, senza perdonare a spesa che ci fussi potuta intervenire; per che egli aveva già dato principio alla sagrestia e l'aveva fatta nella nicchia principale dietro a l'altar maggior, dove era finito già l'ornamento di marmo e fatti molti quadri da Gio-vann'Antonio Sogliani pittore fiorentino, il resto de' quali, insieme con le tavole e cappelle che mancavano, fu poi doppo molti anni fatto finire da Messer Sebastiano della Seta, Operaio di quel Duomo.
Venne in questo tempo in Pisa, tornando da Genova, Perino e visto questo principio per mezzo di Batista del Cervelliera, persona intendente nell'arte e maestro di legname, in prospettive et in rimessi ingegnosissimo, fu condotto al-l'Operaio; e discorso insieme delle cose dell'Opera del Duomo, fu ricerco che a un primo ornamento dentro alla porta ordinaria che s'entra dovessi farvi una tavola, che già era finito l'ornamento, e sopra quella una storia, quando San Giorgio ammazzando il serpente libera la figliuola di quel re. Così, fatto Perino un disegno bellissimo, che faceva in fresco un ordine di putti e d'altri ornamenti fra l'una cappella e l'altra, e nicchie con Profeti e storie in più maniere, piacque tal cosa all'Operaio, e così, fatto il cartone d'una di quelle, cominciò a colorir quella prima, dirimpetto alla porta detta di sopra, e finì sei putti, i quali sono molto bene condotti. E così doveva seguitare intorno intorno, che certo era ornamento molto ricco e molto bello, e sarebbe riuscita tutta insieme un'opera molto onorata, ma venutagli voglia di ritornare a Genova, dove aveva preso e pratiche amorose et altri suoi piaceri, a' quali egli era inclinato a certi tempi. Nella sua partita diede una tavoletta dipinta a olio, ch'egli aveva fatta loro, alle monache di San Maffeo, che è dentro nel munistero fra loro. Arrivato poi in Genova, dimorò in quella molti mesi facendo per il prencipe altri lavori ancora.
Dispiacque molto all'Operaio di Pisa la partita sua, ma molto più il rimanere quell'opera imperfetta, onde non resta-va di scrivergli ogni giorno che tornasse, né di domandarne la moglie d'esso Perino, la quale egli aveva lasciata in Pisa; ma veduto finalmente che questa era cosa lunghissima, non rispondendo o tornando, allogò la tavola di quella cappella a Giovann'Antonio Sogliani, che la finì e la mise al suo luogo. Ritornato non molto dopo Perino in Pisa, vedendo l'ope-ra del Sogliano si sdegnò, né volle altrimenti seguitare quello che aveva cominciato, dicendo non volere che le sue pitture servissino per fare ornamento ad altri maestri. Laonde si rimase per lui imperfetta quell'opera, e Giovan Antonio la seguitò tanto che egli vi fece quattro tavole, le quali parendo poi a Sebastiano della Seta, nuovo Operaio, tutte in una medesima maniera e più tosto manco belle della prima, ne allogò a Domenico Beccafumi sanese, dopo la prova di certi quadri che egli fece intorno alla sagrestia che son molto belli, una tavola ch'egli fece in Pisa. La quale non sodisfacendoli come i quadri primi, ne fecero fare due ultime, che vi mancavano, a Giorgio Vasari aretino, le quali furono poste alle due porte accanto alle mura delle cantonate nella facciata dinanzi della chiesa. De le quali insieme con le altre molte opere grandi e piccole, sparse per Italia e fuora in più luoghi, non conviene che io parli altramenti, ma ne lascerò il giudizio libero a chi le ha vedute o vedrà. Dolse veramente quest'opera a Perino, avendo già fatti i disegni, che erano per riuscire cosa degna di lui e da far nominare quel tempio, oltre all'antichità sue, molto maggiormente, e da fare immortale Perino ancora.
Era a Perino nel suo dimorare tanti anni in Genova, ancora che egli ne cavasse utilità e piacere, venutagli a fastidio, ricordandosi di Roma nella felicità di Leone. E quantunque egli nella vita del cardinale Ippolito de' Medici avesse avuto lettere di servirlo e si fusse disposto a farlo, la morte di quel signore fu cagione che così presto egli non si rimpaniassi. Stando dunque le cose in questo termine e molti suoi amici procurando il suo ritorno, et egli infinitamente più di loro, andarono più lettere in volta, et in ultimo una mattina gli toccò il capriccio, e senza far motto partì di Pisa et a Roma si condusse. Dove fattosi conoscere al reverendissimo cardinale Farnese e poi a papa Paulo, sté molti mesi che egli non fece niente: prima, perché era trattenuto d'oggi in domane, e poi, perché gli venne male in un braccio, di sorte che egli spese parecchi centinaia di scudi, senza il disagio, inanzi che ne potesse guarire; per il che, non avendo chi lo trattenesse, fu tentato per la poca carità della corte partirsi molte volte; pure, il Molza e molti altri suoi amici lo confortavano ad aver pacienza, con dirgli che Roma non era più quella, e che ora ella vuole che un sia stracco et infastidito da lei innanzi ch'ella l'elegga et accarezzi per suo; e massimamente chi seguita l'orme di qualche bella virtù.
Comperò in questo tempo Messer Pietro de' Massimi una cappella alla Trinità, dipinta la volta e le lunette con ornamenti di stucco, e così la tavola a olio, da Giulio Romano e da Giovan Francesco suo cognato; per che, disideroso quel gentiluomo di farla finire, dove nelle lunette erano quattro istorie a fresco di Santa Maria Maddalena e nella tavola a olio un Cristo che appare a Maria Maddalena in forma d'ortolano, fece far prima un ornamento di legno dorato alla tavola, che n'aveva un povero di stucco, e poi allogò le facciate a Perino, il quale, fatto fare i ponti e la turata, mise mano e dopo molti mesi a fine la condusse. Fecevi uno spartimento di grottesche bizzarre e belle, parte di basso rilievo e parte dipinte, e ricinse due storiette non molto grandi con un ornamento di stucchi molto varii, in ciascuna facciata la sua; nell'una era la probatica piscina, con quegli rattratti e malati e l'Angelo che viene a commover l'acque, con le vedute di que' portici che scortono in prospettiva benissimo, e gl'andamenti e gl'abiti de' sacerdoti fatti con una grazia molto pronta, ancora che le figure non sieno molto grandi; nell'altra fece la resurressione di Lazero quatriduano, che si mostra, nel suo riaver la vita, molto ripieno della palidezza e paura della morte, et intorno a esso sono molti che lo sciolgono e pure assai che si maravigliano et altri che stupiscono; senzaché la storia è adorna d'alcuni tempietti che sfuggono nel loro allontanarsi, lavorati con grandissimo amore et il simile sono tutte le cose dattorno di stucco. Sonvi quattro storiettine minori, due per faccia, che mettono in mezzo quella grande; nelle quali sono: in una, quando il centurione dice a Cristo che liberi con una parola il figliuolo che muore; nell'altra, quando caccia i venditori del tempio; la Trasfigurazione et un'altra simile. Fecevi, ne' risalti de' pilastri di dentro, quattro figure in abito di Profeti che sono veramente nella lor bellezza quanto eglino possino essere di bontà e di proporzione ben fatti e finiti; et è similmente quell'opera condotta sì diligentemente, che più tosto alle cose miniate che dipinte, per la sua finezza, somiglia. Vedevisi una vaghezza di colorito molto viva et una gran piacenza usata in condurla, mostrando quel vero amore che si debbe avere all'arte. E questa opera dipinse egli tutta di sua man propria, ancor che gran parte di quegli stucchi facesse condurre co' suoi disegni a Guglielmo Milanese, stato già seco a Genova e molto amato da lui, avendogli già voluto dare la sua figliuola per donna. Oggi costui, per restaurar le anticaglie di casa Farnese, è fatto frate del Piombo in luogo di fra' Bastian Viniziano. Non tacerò che in questa cappella era in una faccia una bellissima sepoltura di marmo e sopra la cassa una femmina morta di marmo, stata eccellentemente lavorata dal Bologna scultore, e due putti ignudi dalle bande; nel volto della qual femina era il ritratto e l'effigie d'una famosissima cortigiana di Roma che lasciò quella memoria; la quale fu levata da que' frati che si facevano scrupolo che una sì fatta femmina fusse quivi stata riposta con tanto onore. Quest'opera, con molti disegni che egli fece, fu cagione che il reverendissimo cardinale Farnese gli cominciasse a dar provisione e servirsene in molte cose.
Fu fatto levare per ordine di papa Paolo un cammino ch'era nella camera del Fuoco e metterlo in quella della Segnatura, dove erano le spalliere di legno in prospettiva fatte di mano di fra' Giovanni intagliatore per papa Giulio, onde, avendo nell'una e nell'altra camera dipinto Raffaello da Urbino, bisognò rifare tutto il basamento alle storie della camera della Segnatura, che è quella dove è dipinto il monte Parnaso; per il che fu dipinto da Perino un ordine finto di marmo con termini varii e festoni, maschere et altri ornamenti, et in certi vani storie contrafatte di color di bronzo che per cose in fresco sono bellissime. Nelle storie era, come di sopra trattando i filosofi della filosofia, i teologi della teologia et i poeti del medesimo, tutti i fatti di coloro che erano stati periti in quelle professioni. Et ancora che egli non le conducesse tutte di sua mano, egli le ritoccava in secco di sorte, oltra il fare i cartoni del tutto finiti, che poco meno sono che s'elle fussino di sua mano. E ciò fece egli perché, sendo infermo d'un catarro, non poteva tanta fatica. Laonde, visto il Papa che egli meritava, e per l'età e per ogni cosa sendosi raccomandato, gli fece una provisione di ducati venticinque il mese che gli durò infino alla morte, con questo: che avesse cura di servire il palazzo e così casa Farnese.
Aveva scoperto già Michelagnolo Buonarroti, nella cappella del papa, la facciata del Giudizio, e vi mancava di sotto a dipignere il basamento, dove si aveva appiccare una spalliera d'arazzi tessuta di seta e d'oro, come i panni che parano la cappella; onde, avendo ordinato il Papa che si mandasse a tessere in Fiandra, col consenso di Michelagnolo, fecero che Perino cominciò una tela dipinta della medesima grandezza, dentrovi femmine e putti e termini che tenevono festoni molto vivi, con bizzarrissime fantasie. La quale rimase imperfetta in alcune stanze di Belvedere dopo la morte sua, opera certo degna di lui e dell'ornamento di sì divina pittura.
Dopo questo, avendo fatto finire di murare Anton da Sangallo, in palazzo del papa, la sala grande de' re dinanzi alla cappella di Sisto Quarto, fece Perino nel cielo uno spartimento grande d'otto facce, e croce et ovati nel rilievo e sfondato di quella. Il che fatto, la diedero a Perino che la lavorasse di stucco e facesse quegli ornamenti più ricchi e più begli che si potesse fare nella difficultà di quell'arte. Così cominciò e fece negli ottangoli, in cambio d'una rosa, quattro putti tondi di rilievo che puntano i piedi al mezzo e, con le braccia girando, fanno una rosa bellissima. E nel resto dello spartimento sono tutte l'imprese di casa Farnese, e nel mezzo della volta l'arme del Papa. Onde veramente si può dire questa opera, di stucco, di bellezza e di finezza e di difficultà aver passato quante ne fecero mai gli antichi et i moderni, e degna veramente d'un capo della religione cristiana. Così furono con disegno del medesimo [fatte] le finestre di vetro dal Pastorin da Siena, valente in quel mestiero, e sotto fece fare Perino le facciate, per farvi le storie di sua mano, in ornamenti di stucchi bellissimi, che furon poi seguitati da Daniello Riciarelli da Volterra pittore. La quale [opera] se la mor-te non gli avesse impedito quel buono animo ch'aveva, arebbe fatto conoscere quanto i moderni avessino avuto cuore, non solo in paragonare con gli antichi l'opere loro, ma forse in passarle di gran lunga.
Mentre che lo stucco di questa volta si faceva e che egli pensava a' disegni delle storie in San Pietro di Roma, rovinandosi le mura vecchie di quella chiesa, per rifar le nuove della fabrica, pervennero i muratori a una pariete dove era una Nostra Donna et altre pitture di man di Giotto; il che veduto Perino, che era in compagnia di Messer Niccolò Acciaiuoli, dottor fiorentino e suo amicissimo, mosso l'uno e l'altro a pietà di quella pittura, non la lasciarono rovinare, anzi, fatto tagliare attorno il muro, la fecero allacciare con ferri e travi e collocarla sotto l'organo di San Piero in un luogo dove non era né altare, né cosa ordinata. Et innanzi che fusse rovinato il muro che era intorno alla Madonna, Perino ritrasse Orso dell'Anguillara senator romano, il quale coronò in Campidoglio Messer Francesco Petrarca che era a' piedi di detta Madonna. Intorno alla quale, avendosi a far certi ornamenti di stucchi e di pitture, et insieme mettervi la memoria di un Niccolò Acciaiuoli, che già fu senator di Roma, fecene Perino i disegni e vi messe mano subito, et aiutato da' suoi giovani e da Marcello Mantovano suo creato, l'opera fu fatta con molta diligenza.
Stava nel medesimo San Pietro il Sacramento, per rispetto della muraglia, molto [poco] onorato. Laonde, fatti sopra la compagnia di quello uomini deputati, ordinorono che si facesse in mezzo la chiesa vecchia una cappella da Antonio da Sangallo, parte di spoglie di colonne di marmo antiche e parte d'altri ornamenti e di marmi e di bronzi e di stucchi, mettendo un tabernacolo in mezzo di mano di Donatello per più ornamento, onde vi fece Perino un sopra cielo bellissimo, [con] molte storie minute delle figure del Testamento Vecchio, figurative del Sacramento. Fecevi ancora in mezzo a quella una storia un po' maggiore, dentrovi la cena di Cristo con gli Apostoli e sotto duoi Profeti che mettono in mezzo il corpo di Cristo. Fece far anco il medesimo alla chiesa di San Giuseppo vicino a Ripetta da que' suoi giovani la cappella di quella chiesa, che fu poi ritocca e finita da lui. Il quale fece similmente fare una cappella nella chiesa di San Bartolomeo in Isola con suoi disegni, la quale medesimamente ritoccò; et in San Salvatore del Lauro fece dipignere al-l'altar maggiore alcune storie e nella volta alcune grottesche; così di fuori nella facciata una Annunziata, condotta da Girolamo Sermoneta suo creato.
Così adunque, parte per non potere e parte perché gl'incresceva, piacendoli più il disegnare che il condur l'opere, andava seguitando quel medesimo ordine che già tenne Raffaello da Urbino nell'ultimo della sua vita; il quale quanto sia dannoso e di biasimo ne fanno segno l'opere de' Chigi e quelle che son condotte da altri, come ancora mostrano queste che fece condurre Perino; oltraché elle non hanno arrecato molto onore a Giulio Romano ancora quelle che non so-no fatte di sua mano. Et ancora che si faccia piacere a' prencipi, per dar loro l'opere presto, e forse benefizio agli artefici che vi lavorono, se fussino i più valenti del mondo non hanno mai quello amore alle cose d'altri, il che altri vi ha da se stesso. Né mai, per ben disegnati che siano i cartoni, si imita appunto e propriamente come fa la mano del primo autore. Il quale vedendo andare in rovina l'opera, disperandosi la lascia precipitare affatto; onde che chi ha sete d'onore debbe far da sé solo. E questo lo posso io dir per prova, che avendo faticato con grande studio ne' cartoni della sala della cancelleria nel palazzo di San Giorgio di Roma che, per aversi a fare con gran prestezza in cento dì vi si messe tanti pittori a colorirla, che diviarono talmente da' contorni e bontà di quelli, che feci proposito, e così ho osservato, che d'allora in qua nessuno ha messo mano in sull'opere mie. Laonde chi vuol conservare i nomi e l'opere, ne faccia meno e tutte di man sua, se e' vuol conseguire quell'intero onore che cerca acquistare un bellissimo ingegno. Dico adunque che Perino, per le tante cure commesseli, era forzato mettere molte persone in opera, et aveva sete più di guadagno che di gloria, parendoli aver gittato via e non avanzato niente nella sua gioventù. E tanto fastidio gli dava il veder venir giovani su che facessino, che cercava metterli sotto di sé, a ciò non gli avessino a impedire il luogo.
Venendo poi l'anno 1546 Tiziano da Cador pittor viniziano, celebratissimo per far ritratti, a Roma, et avendo prima ritratto papa Paolo quando Sua Santità andò a Bussé e non avendo remunerazione di quello né d'alcuni altri che aveva fatti al cardinale Farnese et a Santa Fiore, da essi fu ricevuto onoratissimamente in Belvedere. Per che levatosi una voce in corte e poi per Roma, qualmente egli era venuto per fare istorie di sua mano nella sala de' re in palazzo, dove Perino doveva farle egli, e vi si lavorava di già i stucchi, dispiacque molto questa venuta a Perino e se ne dolse con molti amici suoi; non perché credesse che nell'istoria Tiziano avesse a passarlo lavorando in fresco, ma perché desiderava trattenersi con quest'opera pacificamente et onoratamente fino alla morte. E se pur ne aveva a fare, farla senza concorrenza, bastandoli purtroppo la volta e la facciata della cappella di Michelagnolo a paragone, quivi vicina. Questa suspizione fu cagione che mentre Tiziano sté in Roma, egli lo sfuggì sempre e sempre stette di mala voglia fino alla partita sua.
Essendo castellano di Castel Sant'Agnolo Tiberio Crispo, che fu poi fatto cardinale, come persona che si dilettava delle nostre arti si messe in animo d'abbellire il castello, et in quello rifece logge, camere e sale et apparamenti bellissimi per poter ricevere meglio Sua Santità quando ella vi andava, e così fatte molte stanze et altri ornamenti, con ordine e disegni di Raffaello da Montelupo e poi in ultimo di Antonio da Sangallo. Fecevi far di stucco Raffaello una loggia, et egli vi fece l'Angelo di marmo, figura di sei braccia, posta in cima al castello su l'ultimo torrione, e così fece dipigner detta loggia a Girolamo Sermoneta, ch'è quella che volta verso i prati, che finita, fu poi il resto delle stanze date parte a Luzio Romano. Et in ultimo le sale et altre camere importanti, fece Perino, parte di sua mano e parte fu fatto da altri con suoi cartoni. La sala è molto vaga e bella, lavorata di stucchi e tutta piena d'istorie romane, fatte da' suoi giovani, et assai di mano di Marco da Siena, discepolo di Domenico Beccafumi, et in certe stanze sono fregiature bellissime.
Usava Perino, quando poteva avere giovani valenti, servirsene volentieri nell'opere sue, non restando per questo egli di lavorare ogni cosa meccanica. Fece molte volte i pennoni delle trombe, le bandiere del castello e quelle dell'armata della Religione. Lavorò drappelloni, sopraveste, portiere et ogni minima cosa dell'arte. Cominciò alcune tele per far panni d'arazzi per il prencipe Doria. E fece per il reverendissimo cardinal Farnese una cappella, e così uno scrittoio al-l'eccellentissima madama Margherita d'Austria. A Santa Maria del Pianto fece fare un ornamento intorno alla Madonna; e così in piazza Giudea alla Madonna pure un altro ornamento. E molte altre opere, delle quali per esser molte non farò al presente altra memoria, avendo egli massimamente costumato di pigliare a far ogni lavoro che gli veniva per le mani. La qual sua così fatta natura, perché era conosciuta dagl'uffiziali di palazzo, era cagione che egli aveva sempre che fare per alcuni di loro; e lo faceva volentieri, per trattenersegli, onde avessero cagione di servirlo ne' pagamenti del-le provisioni et altre sue bisogne.
Avevasi oltre ciò acquistata Perino un'autorità, che a lui si allogavano tutti i lavori di Roma; perciò che, oltre che parea che in un certo modo se gli dovessino, faceva alcuna volta le cose per vilissimo prezzo. Nel che faceva a sé et al-l'arte poco utile, anzi molto danno. E che ciò sia vero, se egli avesse preso a far sopra di sé la sala de' re in palazzo e lavoratovi insieme con i suoi garzoni, vi arebbe avanzato parecchi centinaia di scudi, che tutti furono de' ministri che avevano cura dell'opera e pagavano le giornate a chi vi lavorava. Laonde, avendo egli preso un carico sì grande e con tante fatiche, et essendo catarroso et infermo, non poté sopportar tanti disagi, avendo il giorno e la notte a disegnare e sodisfare a' bisogni di palazzo e fare, non che altro, i disegni di ricami, d'intagli a banderai et a tutti i capricci di molti ornamenti di Farnese e d'altri cardinali e signori. Et insomma, avendo sempre l'animo occupatissimo, et intorno scultori, maestri di stucchi, intagliatori di legname, sarti, ricamatori, pittori, mettitori d'oro et altri simili artefici, non aveva mai un'ora di riposo. E quanto di bene e contento sentiva in questa vita, era ritrovarsi talvolta con alcuni amici suoi al-l'osteria, la quale egli continuamente frequentò in tutti i luoghi dove gl'occorse abitare, parendoli che quella fusse la vera beatitudine, la requie del mondo et il riposo de' suoi travagli.
Dalle fatiche adunque dell'arte e da' disordini di Venere e della bocca guastatasi la complessione, gli venne un'asima che, andandolo a poco a poco consumando, finalmente lo fece cadere nel tisico; e così una sera, parlando con un suo amico vicino a casa sua, di mal di gocciola cascò morto d'età d'anni quarantasette. Di che si dolsero infinitamente molti artefici come d'una gran perdita che fece veramente la pittura. E da Messer Iosefo Cincio medico di madama, suo genero, e dalla sua donna gli fu nella Ritonda di Roma e nella cappella di San Giuseppo dato onorata sepoltura, con questo epitaffio:
Perino Bonaccursio Vagae florentino, qui ingenio et arte singulari egregios cum pictores permultos, tum plastas facile omnes superavit, Catherina Perini coniugi, Lavinia Bonaccursia parenti, Iosephus Cincius socero charissimo et optimo fecere. Vixit annos 46, menses 3, dies 21. Mortuus et 14 Calendis Novembris Anno Christi 1547.
Rimase nel luogo di Perino Daniello Volterrano, che molto lavorò seco e finì gl'altri due Profeti, che sono alla cap-pella del Crucifisso in San Marcello; e nella Trinità ha fatto una cappella bellissima di stucchi e di pittura alla signora Elena Orsina e molte altre opere, delle quali si farà a suo luogo memoria. Perino dunque, come si vede per cose dette e molte che si potrebbono dire, è stato uno de' più universali pittori de' tempi nostri, avendo aiutato gli artefici a fare eccellentemente gli stucchi e lavorato grottesche, paesi, animali e tutte l'altre cose che può sapere un pittore, e colorito in fresco, a olio et a tempera. Onde si può dire che sia stato il padre di queste nobilissime arti, vivendo le virtù di lui in coloro che le vanno imitando in ogni effetto onorato dell'arte. Sono state dopo la morte di Perino stampate molte cose ritratte dai suoi disegni, la fulminazione de' giganti fatta a Genova, otto storie di San Piero, tratte degli atti degli Apostoli, le quali fece in disegno perché ne fusse ricamato per papa Paolo Terzo un piviale; e molte altre cose, che si conoscono alla maniera. Si servì Perino di molti giovani et insegnò le cose dell'arte a molti discepoli; ma il migliore di tutti e quegli di cui egli si servì più che di tutti gli altri, fu Girolamo Siciolante da Sermoneta, del quale si ragionerà a suo luogo. Similmente fu suo discepolo Marcello Mantovano, il quale sotto di lui condusse in Castel Sant'Angelo, all'entrata, col disegno di Perino in una facciata una Nostra Donna con molti Santi a fresco, che fu opera molto bella; ma anco del-le opere di costui si farà menzione altrove. Lasciò Perino molti disegni alla sua morte, e di sua mano e d'altri parimente, ma fra gli altri tutta la cappella di Michel Agnolo Buonarroti, disegnata di mano di Lionardo Cungi dal Borgo San Sepolcro, che era cosa eccellente. I quali tutti disegni, con altre cose, furono dagli eredi suoi venduti. E nel nostro libro sono molte carte fatte da lui di penna, che sono molto belle.
IL FINE DELLA VITA DI PERINO DEL VAGA,
PITTORE FIORENTINO
E DEL PRIMO VOLUME DELLA TERZA PARTE
VITA DI DOMENICO BECCAFUMI
PITTORE E MAESTRO DI GETTI SANESE

Quello stesso, che per dono solo della natura si vide in Giotto et in alcun altro di que' pittori, de' quali avemo infin qui ragionato, si vidde ultimamente in Domenico Beccafumi pittore sanese, perciò che guardando egli alcune pecore di suo padre, chiamato Pacio e lavoratore di Lorenzo Beccafumi cittadin sanese, fu veduto esercitarsi da per sé, così fanciullo come era, in disegnando quando sopra le pietre, e quando in altro modo; per che avenne che, vedutolo un giorno il detto Lorenzo disegnare con un bastone apuntato alcune cose sopra la rena d'un piccol fiumicello, là dove guardava le sue bestiole, lo chiese al padre, disegnando servirsene per ragazzo et in un medesimo tempo farlo imparare. Essendo adunque questo putto, che allora era chiamato Mecherino, da Pacio suo padre conceduto a Lorenzo, fu condotto a Siena, dove esso Lorenzo gli fece per un pezzo spendere quel tempo, che gli avanzava da' servigii di casa, in bottega d'un pittore suo vicino di non molto valore. Tuttavia quello che non sapeva egli, faceva imparare a Mecherino da' disegni che aveva appresso di sé, di pittori eccellenti de' quali si serviva ne' suoi bisogni, come usano di fare alcuni maestri, che hanno poco peccato nel disegno. In questa maniera dunque esercitandosi mostrò Mecherino saggio di dovere riuscire ottimo pittore. Intanto capitando in Siena Pietro Perugino, allora famoso pittore, dove fece, come si è detto, due tavole, piacque molto la sua maniera a Domenico, per che messosi a studiarla et a ritrarre quelle tavole, non andò molto che egli prese quella maniera. Doppo, essendosi scoperta in Roma la cappella di Michelagnolo e l'opere di Raffaello da Urbino, Domenico, che non aveva maggior disiderio che d'imparare e conosceva in Siena perder tempo, presa licenza da Lorenzo Beccafumi, dal quale si acquistò la famiglia et il casato de' Beccafumi, se n'andò a Roma, dove acconciatosi con un dipintore che lo teneva in casa alle spese, lavorò insieme con esso lui molte opere, attendendo in quel mentre a studiare le cose di Michelagnolo, di Raffaello e degl'altri eccellenti maestri e le statue e pili antichi d'opera maravigliosa. Laonde non passò molto che egli divenne fiero nel disegnare, copioso nell'invenzioni e molto vago coloritore. Nel quale spazio, che non passò due anni, non fece altra cosa degna di memoria, che una facciata in Borgo con un'arme colorita di papa Giulio Secondo.
In questo tempo, essendo condotto in Siena, come si dirà a suo luogo, da uno degli Spanocchi mercante, Giovan Antonio da Verzelli pittore e giovane assai buon pratico e molto adoperato da' gentiluomini di quella città (che fu sempre amica e fautrice di tutti i virtuosi) e particolarmente in fare ritratti di naturale, intese ciò Domenico, il quale molto desiderava di tornare alla patria. Onde, tornatosene a Siena, veduto che Giovann'Antonio aveva gran fondamento nel disegno, nel quale sapeva che consiste l'eccellenza degl'artefici, si mise con ogni studio, non gli bastando quello che aveva fatto in Roma, a seguitarlo, esercitandosi assai nella notomia e nel fare ignudi. Il che gli giovò tanto, che in poco tempo cominciò a essere in quella città nobilissima molto stimato. Né fu meno amato per la sua bontà e costumi, che per l'arte: perciò che dove Giovan Antonio era bestiale, licenzioso e fantastico, e chiamato, perché sempre praticava e viveva con giovinetti sbarbati, il Soddoma e per tale ben volentieri rispondeva, era dall'altro lato Domenico tutto costumato e da bene e, vivendo cristianamente, e' stava il più del tempo solitario. E perché molte volte sono più stimati dagl'uomini certi che sono chiamati buon compagni e sollazevoli, che i virtuosi e costumati, i più de' giovani sanesi seguitavano il Soddoma celebrandolo per uomo singulare. Il qual Soddoma, perché come capriccioso aveva sempre in casa, per sodisfare al popolaccio, papagalli, bertuccie, asini nani, cavalli piccoli dell'Elba, un corbo che parlava, barbari da correr palii et altre sì fatte cose, si aveva acquistato un nome fra il volgo, che non si diceva se non delle sue pazzie.
Avendo dunque il Soddoma colorito a fresco la facciata della casa di Messer Agostino Bardi, fece a sua concorrenza Domenico in quel tempo medesimo dalla colonna della postierla vicina al Duomo, la facciata d'una casa de' Borghesi, nella quale mise molto studio. Sotto il tetto fece in un fregio di chiaro scuro alcune figurine molto lodate, e negli spazii fra tre ordini di finestre di trevertino che ha questo palagio, fece e di color di bronzo di chiaro scuro e colorite molte figure di dii antichi e d'altri, che furono più che ragionevoli, se bene fu più lodata quella del Soddoma; e l'una e l'altra di queste facciate fu condotta l'anno 1512. Dopo fece Domenico in San Benedetto, luogo de' monaci di Monte Oliveto, fuori della porta a Tufi in una tavola Santa Caterina da Siena che riceve le stimmate sotto un casamento, un San Benedetto ritto da man destra et a sinistra un San Ieronimo in abito di cardinale, la quale tavola per essere di colorito molto dolce et aver gran rilievo, fu et è ancora molto lodata. Similmente nella predella di questa tavola fece alcune storiette a tempera con fierezza e vivacità incredibile, e con tanta facilità di disegno, che non possono aver maggior grazia e nondimeno paiono fatte senza una fatica al mondo. Nelle quali storiette è quando alla medesima Santa Caterina l'angelo mette in bocca parte dell'ostia consacrata dal sacerdote; in un'altra è quando Gesù Cristo la sposa et appresso ella riceve l'abito da San Domenico, con altre storie.
Nella chiesa di San Martino fece il medesimo, in una tavola grande, Cristo nato et adorato dalla Vergine, da Giuseppo e da' pastori, et a sommo alla capanna un ballo d'Angeli bellissimo. Nella quale opera, che è molto lodata dagl'ar-tefici, cominciò Domenico a far conoscere a coloro che intendevano qualche cosa, che l'opere sue erano fatte con altro fondamento che quelle del Soddoma. Dipinse poi a fresco nello spedale grande la Madonna che visita Santa Elisabetta, in una maniera molto vaga e molto naturale, e nella chiesa di Santo Spirito fece in una tavola la Nostra Donna col Figliuolo in braccio, che sposa la detta Santa Caterina da Siena, e dagli lati San Bernardino, San Francesco, San Girolamo e Santa Caterina vergine e martire. E dinanzi, sopra certe scale, San Piero e San Paolo, ne' quali finse alcuni riverberi del color de' panni nel lustro delle scale di marmo molto artifiziosi. La quale opera, che fu fatta con molto giudizio e disegno, gl'acquistò molto onore, sì come fecero ancora alcune figurine fatte nella predella della tavola, dove San Giovanni battezza Cristo, un re fa gettar in un pozzo la moglie e' figliuoli di San Gismondo, San Domenico fa ardere i libri degl'eretici, Cristo fa presentar a Santa Caterina da Siena due corone, una di rose, l'altra di spine, e San Bernardino da Siena predica in sulla piazza di Siena a un popolo grandissimo.
Dopo, essendo allogata a Domenico per la fama di queste opere, una tavola che dovea porsi nel Carmine, nella qua-le aveva a far un San Michele che uccidesse Lucifero, egli andò, come capriccioso, pensando a una nuova invenzione per mostrare la virtù et i bei concetti dell'animo suo. E così, per figurar Lucifero co' suoi seguaci cacciati per la superbia dal cielo nel più profondo a basso, cominciò una pioggia d'ignudi molto bella, ancora che per esservisi molto affaticato dentro ella paresse anzi confusa che no. Questa tavola, essendo rimasta imperfetta, fu portata dopo la morte di Domenico nello spedale grande, salendo una scala che è vicina all'altare maggiore, dove ancora si vede con maraviglia per certi scorti d'ignudi bellissimi, e nel Carmine, dove dovea questa esser collocata, ne fu posta un'altra, nella qual è finto nel più alto un Dio Padre con molti Angeli intorno sopra le nuvole con bellissima grazia, e nel mezzo della tavola è l'angelo Michele armato, che volando mostra aver posto nel centro della terra Lucifero, dove sono muraglie che ardono, antri rovinati et un lago di fuoco, con Angeli in varie attitudini et anime nude che in diversi atti nuotano e si cruciano in quel fuoco. Il che tutto è fatto con tanta bella grazia e maniera, che pare che quell'opera maravigliosa, in quelle tenebre scure sia lumeggiata da quel fuoco, onde è tenuta opera rara. E Baldassarri Petrucci sanese, pittor eccellente, non si poteva saziare di lodarla et un giorno, che io la vidi seco scoperta, passando per Siena, ne restai maravigliato sì come feci ancora di cinque storiette, che sono nella predella, fatte a tempera con bella e giudiziosa maniera.
Un'altra tavola fece Domenico alle monache d'Ogni Santi della medesima città, nella qual è, di sopra Cristo in aria che corona la Vergine glorificata, et a basso San Gregorio, Sant'Antonio, Santa Maria Maddalena e S. Caterina vergine e martire. Nella predella similmente sono alcune figurine, fatte a tempera molto belle. In casa del signor Marcello Agostini dipinse Domenico a fresco nella volta d'una camera che ha tre lunette per faccia e due in ciascuna testa, con un partimento di fregii che rigirono intorno intorno, alcune opere bellissime. Nel mezzo della volta fa il partimento due quadri: nel primo, dove si finge che l'ornamento tenga un panno di seta, pare che si veggia tessuto in quello Scipione Africano rendere la giovane intatta al suo marito, e nell'altro Zeusi, pittore celebratissimo che ritrae più femmine ignude, per farne la sua pittura che s'avea da porre nel tempio di Giunone. In una delle lunette, in figurette di mezzo braccio in circa, ma bellissime, sono i due fratelli romani che, essendo nimici, per lo publico bene e giovamento della patria divengono amici. Nell'altra che segue è Torquato, che per osservare la legge, dovendo esser cavati gli occhi al figliuolo, ne fa cavare uno a lui et uno a sé. In quella che segue è la petizione... il quale, dopo essergli state lette le sue sceleratezze fatte contra la patria e popolo romano, è fatto morire. In quella che è a canto a questa è il popolo romano che delibera la spedizione di Scipione in Affrica. A lato di questa è in un'altra lunetta un sacrifizio antico pieno di varie figure bellissime, con un tempio tirato in prospettiva, che ha rilievo assai, perché in questo era Domenico veramente eccellente maestro. Nell'ultima è Catone che si uccide, essendo sopragiunto da alcuni cavalli che quivi sono dipinti bellissimi. Ne' vani similmente delle lunette sono alcune piccole istorie molto ben finite, onde la bontà di quest'opera fu cagione che Domenico fu da chi allora governava conosciuto per eccellente pittore e messo a dipignere nel palazzo de' Signori la volta d'una sala, nella quale usò tutta quella diligenza, studio e fatica che si poté maggiore, per mostrar la virtù sua et ornare quel celebre luogo della sua patria che tanto l'onorava.
Questa sala, che è lunga due quadri e larga uno, ha la sua volta non a lunette, ma a uso di schifo; onde, parendogli che così tornasse meglio, fece Domenico il partimento di pittura con fregi e cornici messe d'oro tanto bene, che senza altri ornamenti di stucchi o d'altro, è tanto ben condotto e con bella grazia, che pare veramente di rilievo. In ciascuna, dunque, delle due teste di questa sala è un gran quadro, con una storia et in ciascuna faccia ne sono due, che mettono in mezzo un ottangolo: e così sono i quadri sei, e gl'ottangoli due, et in ciascuno di essi una storia. Nei canti della volta, dove è lo spigolo, è girato un tondo che piglia dell'una e dell'altra faccia per metà, e questi, essendo rotti dallo spigolo della volta, fanno otto vani; in ciascuno de' quali sono figure grandi che siedono, figurate per uomini segnalati, ch'han-no difesa la republica et osservate le leggi. Il piano della volta nella maggiore altezza è diviso in tre parti, di maniera che fa un tondo nel mezzo sopra gli ottangoli a dirittura e due quadri sopra i quadri delle facciate. In uno adunque de-gl'ottangoli è una femmina con alcuni fanciulli attorno, che ha un cuore in mano per l'amore che si deve alla patria, nel-l'altro è un'altra femmina, con altri tanti putti fatta per la Concordia de' cittadini. E queste mettono in mezzo una Iustizia, che è nel tondo, con la spada e bilancie in mano e questa scorta al di sotto in su, tanto gagliardamente, che è una maraviglia, perché il disegno et il colorito che ha a' piedi comincia oscuro, va verso le ginocchia più chiaro, e così va facendo a poco a poco di maniera verso il torso, le spalle e le braccia, che la testa si va compiendo in un splendor celeste che fa parere che quella figura a poco a poco se ne vada in fumo. Onde non è possibile imaginare, non che vedere la più bella figura di questa, né altra fatta con maggior giudizio et arte fra quante ne furono mai dipinte, che scortassino al disotto in su.
Quanto alle storie, nella prima della testa, entrando nel salotto a man sinistra, è Marco Lepido e Fulvio Flacco censori, i quali essendo fra loro nimici, subito che furono colleghi nel magistrato della censura, a benefizio della patria, deposto l'odio particolare, furono in quell'uffizio come amicissimi. E questi Domenico fece ginocchioni, che si abbracciano con molte figure attorno e con un ordine bellissimo di casamenti e tempii tirati in prospettiva tanto bene et ingegnosamente, che in loro si vede quanto intendesse Domenico la prospettiva. Nell'altra faccia segue in un quadro l'istoria di Postumio Tiburzio dittatore, il quale avendo lasciato alla cura dell'essercito et in suo luogo un suo unico figliuolo, comandandogli che non dovesse altro fare che guardare gl'alloggiamenti, lo fece morire per essere stato disubidiente et avere con bella occasione assaltati gli inimici et avutone vittoria; nella quale storia fece Domenico Postumio vecchio e raso con la man destra sopra le scuri e con la sinistra che mostra all'essercito il figliuolo in terra morto, in iscorto molto ben fatto. E sotto questa pittura, che è bellissima, è una inscrizione molto bene accommodata. Nell'ottangolo che segue, in mezzo è Spurio Cassio il quale, il senato romano dubitando che non si facesse re, lo fece decapitare e rovinargli le case; et in questa, la testa che è a canto al carnefice et il corpo, che è in terra in iscorto, sono bellissimi. Nell'altro quadro è Publio Muzio Tribuno che fece abbruciare tutti i suoi colleghi tribuni, i quali aspiravano con Spurio alla tirannide della patria; et in questa il fuoco che arde que' corpi è benissimo fatto e con molto artifizio. Nell'altra testa del salotto, in un altro quadro è Codro ateniese il quale, avendo detto l'oracolo che la vittoria sarebbe da quella parte della quale il re sarebbe dagli inimici morto, deposte le vesti sue, entrò sconosciuto fra gli nemici, e si fece uccidere; dando a' suoi, con la propria morte, la vittoria. Domenico dipinse costui a sedere et i suoi baroni a lui d'intorno, mentre si spoglia appresso a un tempio tondo, bellissimo. E nel lontano della storia si vede quando egli è morto, col suo nome sotto in un epitaffio. Voltandosi poi all'altra facciata lunga dirimpetto a' due quadri, che mettono in mezzo l'ottangolo, nella prima storia è Seleuco prencipe, il quale fece cavare un occhio a sé et un al figliuolo per non violar le leggi, dove molti gli stanno intorno pregando che non voglia essere crudele contra di sé e del figliuolo, e nel lontano è il suo figliuolo che fa violenza a una giovane, e sotto vi è il suo nome in un epitaffio. Nell'ottangolo che è a canto a questo quadro è la storia di Marco Manilio fatto precipitare dal Campidoglio; la figura del Marco è un giovane gettato da alcuni ballatoi, fatta in uno scorto con la testa all'ingiù tanto bene che par viva, come anco paiono alcune figure che sono a basso. Nell'altro quadro è Spurio Melio, che fu dell'ordine de' cavalieri, il quale fu ucciso da Servilio tribuno per avere sospettato il po-polo che si facesse tiranno della patria. Il quale Servilio sedendo con molti a torno, uno ch'è nel mezzo mostra Spurio in terra morto, in una figura fatta con molta arte.
Ne' tondi poi, che sono ne' cantoni dove sono le otto figure, sono molti uomini stati rarissimi per avere difesa la patria. Nella parte principale è il famosissimo Fabio Massimo a sedere et armato. Dall'altro lato è Speusippo duca de' Tegeti il quale, volendogli persuader un amico che si levasse dinanzi un suo avversario et emulo, rispose non volere, da particolar interesse spinto, privare la patria d'un sì fatto cittadino. Nel tondo, che è nell'altro canto che segue, è da una parte Celio pretore, che per avere combattuto contra il consiglio e volere degl'aruspici, ancor che vincesse et avesse la vittoria fu dal senato punito: et a lato gli siede Trasibulo che, accompagnato da alcuni amici, uccise valorosamente trenta tiranni per liberar la patria: e questi è un vecchio raso con i capegli bianchi, il quale ha sotto il suo nome, sì come hanno anco tutti gl'altri. Dall'altra parte, nel cantone disotto in un tondo, è Genuzio Cippo pretore, al quale, essendosi posto in testa un ucello prodigiosamente con l'ali in forma di corna, fu risposto dall'oracolo che sarebbe re della sua patria, onde egli elesse, essendo già vecchio, d'andare in esilio per non soggiogarla. E perciò fece a costui Domenico uno ucello in capo. Appresso a costui siede Caronda, il quale essendo tornato di villa et in un subito andato in senato senza disarmarsi, contra una legge che voleva che fusse ucciso chi entrasse in senato con arme, uccise se stesso, accortosi del-l'errore. Nell'ultimo tondo dall'altra parte è Damone e Pitia, la singolar amicizia de' quali è notissima, e con loro è Dionisio tiranno di Sicilia. Et allato a questi siede Bruto, che per zelo della patria condannò a morte due suoi figliuoli perché cercavano di far tornare alla patria i Tarquini. Quest'opera, adunque, veramente singolare, fece conoscere a' sanesi la virtù e valore di Domenico, il quale mostrò in tutte le sue azzioni arte, giudizio et ingegno bellissimo.
Aspettandosi, la prima volta che venne in Italia l'imperator Carlo V, che andasse a Siena per averne dato intenzione agl'ambasciadori di quella republica, fra l'altre cose che si fecero magnifiche e grandissime per ricevere un sì grande imperatore, fece Domenico un cavallo di tondo rilievo, di braccia otto, tutto di carta pesta e voto dentro. Il peso del qual cavallo era retto da un'armadura di ferro e sopra esso era la statua di esso imperador armato all'antica con lo stocco in mano, e sotto aveva tre figure grandi, come vinte da lui, le quali anche sostenevano parte del peso, essendo il cavallo in atto di saltare e con le gambe dinanzi alte in aria, e le dette tre figure rapresentavano tre provincie state da esso imperador domate e vinte. Nella quale opera mostrò Domenico non intendersi meno della scultura che si facesse della pittura. A che si aggiugne che tutta quest'opera aveva messa sopra un castel di legname alto quattro braccia, con un ordine di ruote sotto, le quali mosse da uomini dentro, erano fatte caminare. Et il disegno di Domenico era che questo cavallo, nell'entrata di Sua Maestà, essendo fatto andare come s'è detto, l'accompagnasse dalla porta infino al palazzo de' Signori e poi si fermasse in sul mezzo della piazza. Questo cavallo, essendo stato condotto da Domenico a fine, che non gli mancava se non esser messo d'oro, si restò a quel modo, perché Sua Maestà per allora non andò altrimenti a Siena, ma coronatasi in Bologna si partì d'Italia e l'opera rimase imperfetta. Ma nondimeno fu conosciuta la virtù et ingegno di Domenico, e molto lodata da ognuno l'eccellenza e grandezza di quella machina, la quale stette nell'Opera del Duomo da questo tempo insino a che, tornando Sua Maestà dall'impresa d'Africa vittoriosa, passò a Messina e di poi a Napoli, Roma e finalmente a Siena, nel qual tempo fu la detta opera di Domenico messa in sulla piazza del Duomo, con molta sua lode.
Spargendosi dunque la fama della virtù di Domenico, il prencipe Doria, che era con la corte, veduto che ebbe tutte l'opere che in Siena erano di sua mano, lo ricercò che andasse a lavorare a Genova nel suo palazzo, dove avevano lavo-rato Perino del Vaga, Giovan Antonio da Pordenone e Girolamo da Trevisi. Ma non poté Domenico prometter a quel signore d'andare a servirlo allora, ma sì bene altra volta, per avere in quel tempo messo mano a finir nel Duomo una parte del pavimento di marmo, che già Duccio pittor sanese aveva con nuova maniera di lavoro cominciato. E perché già erano le figure e storie in gran parte disegnate in sul marmo, et incavati i dintorni con lo scarpello e ripieni di mistura nera, con ornamenti di marmi colorati attorno, e parimente i campi delle figure, vidde con bel giudizio Domenico che si potea molto quell'opera migliorare, per che, presi marmi bigi, acciò facessino nel mezzo dell'ombre, accostate al chiaro del marmo bianco e profilate con lo scarpello, trovò che in questo modo col marmo bianco e bigio si potevano fare cose di pietra a uso di chiaro scuro perfettamente. Fattone dunque saggio, gli riuscì l'opera tanto bene e per l'inven-zione e per lo disegno fondato e copia di figure, che egli a questo modo diede principio al più bello et al più grande e magnifico pavimento che mai fusse stato fatto, e ne condusse a poco a poco mentre che visse una gran parte. D'intorno all'altare maggiore fece una fregiatura di quadri, nella quale, per seguire l'ordine delle storie state cominciate da Duccio, fece istorie del Genesi, cioè Adamo et Eva, che sono cacciati del Paradiso e lavorano la terra; il sagrifizio d'Abel e quello di Melchisedech. E dinanzi all'altare è in una storia grande Abraam che vuole sacrificare Isaac, e questa ha in-torno una fregiatura di mezze figure, le quali portando varii animali, mostrano d'andare a sacrificare. Scendendo gli scalini, si truova un altro quadro grande, che accompagna quel di sopra: nel quale Domenico fece Moisè che riceve da Dio le leggi sopra il Monte Sinai; e da basso è quando trovato il popolo, che adorava il vitello dell'oro, si adira e rompe le tavole, nelle quali era scritta essa legge.
A traverso della chiesa, dirimpetto al pergamo, sotto questa storia è un fregio di figure in gran numero, il quale è composto con tanta grazia e disegno, che più non si può dire. Et in questo è Moisè, il quale percotendo la pietra nel deserto, ne fa scaturire l'acqua e dà bere al popolo assetato, dove Domenico fece, per la lunghezza di tutto il fregio diste-so, l'acqua del fiume della quale in diversi modi bee il popolo con tanta e vivezza e vaghezza, che non è quasi possibile imaginarsi le più vaghe leggiadrie e belle e graziose attitudini di figure, che sono in questa storia: chi si china a bere in terra, chi s'inginocchia dinanzi al sasso che versa l'acqua, chi ne attigne con vasi e chi con tazze, et altri finalmente bee con mano. Vi sono oltre ciò, alcuni che conducono animali a bere con molta letizia di quel popolo. Ma fra l'altre cose vi è maraviglioso un putto, il quale preso un cagnolo per la testa e pel collo, lo tuffa col muso nell'acqua, perché bea; e quello poi, avendo bevuto, scrolla la testa tanto bene, per non voler più bere, che par vivo. Et insomma questa fregiatura è tanto bella, che per cosa in questo genere non può esser fatta con più artifizio, atteso che l'ombre e gli sbattimenti che hanno queste figure sono più tosto maravigliosi che belli. Et ancora che tutta quest'opera, per la stravaganza del lavoro, sia bellissima, questa parte è tenuta la migliore e più bella. Sotto la cupola è poi un partimento esagono, che è par-tito in sette esagoni e sei rombi. De' quali esagoni ne finì quattro Domenico, innanzi che morisse, facendovi dentro le storie e sagrifizii d'Elia, e tutto con molto suo commodo, perché quest'opera fu lo studio et il passatempo di Domenico, né mai la dismesse del tutto per altri suoi lavori. Mentre dunque che lavorava quando in quella e quando altrove, fece in San Francesco, a man ritta entrando in chiesa, una tavola grande a olio, dentrovi Cristo che scende glorioso al limbo a trarne i Santi Padri, dove fra molti nudi è una Eva bellissima; et un ladrone, che è dietro a Cristo con la croce, è figura molto ben condotta; e la grotta del limbo et i demonii e fuochi di quel luogo sono bizzarri affatto.
E perché aveva Domenico oppenione che le cose colorite a tempera si mantenessino meglio che quelle colorite a olio, dicendo che gli pareva che più fussero invecchiate le cose di Luca da Cortona, de' Pollaiuoli e degli altri maestri che in quel tempo lavorarono a olio, che quelle di fra' Giovanni, di fra' Filippo, di Benozzo e degli altri, che colorirono a tempera inanzi a questi, per questo, dico, si risolvé, avendo a fare una tavola per la Compagnia di San Bernardino, in sulla piazza di San Francesco, di farla a tempera, e così la condusse eccellentemente, facendovi dentro la Nostra Donna con molti Santi. Nella predella, la quale fece similmente a tempera et è bellissima, fece San Francesco che riceve le stimmate, e Sant'Antonio da Padova, che per convertire alcuni eretici fa il miracolo dell'asino che s'inchina alla sacratissima ostia, e San Bernardino da Siena, che predica al popolo della sua città in sulla piazza de' Signori. Fece similmente nelle facce di questa Compagnia due storie in fresco della Nostra Donna, a concorrenza d'alcune altre che nel medesimo luogo avea fatte il Soddoma. In una fece la visitazione di S. Elisabetta e nell'altra il transito della Madonna con gl'Apostoli intorno. L'una e l'altra delle quali è molto lodata.
Finalmente, dopo essere stato molto aspettato a Genova dal prencipe Doria, vi si condusse Domenico, ma con gran fatica, come quello che era avezzo a una sua vita riposata e si contentava di quel tanto che il suo bisogno chiedeva senza più, oltreché non era molto avezzo a far viaggi, perciò che, avendosi murata una casetta in Siena et avendo fuor della porta a Comollia un miglio una sua vigna, la quale per suo passatempo facea fare a sua mano e vi andava spesso, non si era già un pezzo molto discostato da Siena. Arrivato dunque a Genova, vi fece una storia a canto a quella del Pordenone, nella quale si portò molto bene, ma non però di maniera che ella si possa fra le sue cose migliori annoverare. Ma perché non gli piacevano i modi della corte et era avezzo a viver libero, non stette in quel luogo molto contento, anzi pareva in un certo modo stordito. Per che, venuto a fine di quell'opera, chiese licenza al prencipe e si partì per tornarse-ne a casa; e passando da Pisa per vedere quella città, dato nelle mani a Batista del Cervelliera, gli furono mostrate tutte le cose più notabili della città, e particularmente le tavole del Sogliano et i quadri che sono nella nicchia del Duomo dietro all'altare maggiore. Intanto Sebastiano della Seta Operaio del Duomo, avendo inteso dal Cervelliera le qualità e virtù di Domenico, disideroso di finire quell'opera, stata tenuta in lungo da Giovanni Antonio Sogliani, allogò due quadri della detta nicchia a Domenico, acciò gli lavorasse a Siena e di là gli mandasse, fatti, a Pisa; e così fu fatto. In uno è Moisè, che trovato il popolo avere sacrificato al vitel d'oro, rompe le tavole; et in questo fece Domenico alcuni nudi che sono figure bellissime; e nell'altro è lo stesso Moisè, e la terra che si apre et inghiottisce una parte del popolo, et in que-sto anco sono alcuni ignudi, morti da certi lampi di fuoco, che sono mirabili. Questi quadri condotti a Pisa furono cagione che Domenico fece in quattro quadri, dinanzi a questa nicchia, cioè due per banda, i quattro Evangelisti, che furono quattro figure molto belle. Onde Sebastiano della Seta, che vedeva d'esser servito presto e bene, fece fare dopo questi a Domenico la tavola d'una delle cappelle del Duomo, avendone infino allora fatte quattro il Sogliano. Fermatosi dunque Domenico in Pisa, fece nella detta tavola la Nostra Donna in aria col putto in collo sopra certe nuvole rette da alcuni putti, e da basso molti Santi e Sante assai bene condotti, ma non però con quella perfezzione che furono i sopra detti quadri. Ma egli scusandosi di ciò con molti amici, e particolarmente una volta con Giorgio Vasari, diceva che come era fuori dell'aria di Siena e di certe sue commodità, non gli pareva saper far alcuna cosa. Tornatosene dunque a casa con proposito di non volersene più, per andar a lavorar altrove, partire, fece in una tavola a olio, per le monache di S. Paolo, vicine a S. Marco, la natività di Nostra Donna con alcune balie e S. Anna in un letto che scorta, finto dentro a una porta; una donna in uno scuro, che asciugando panni non ha altro lume che quello che le fa lo splendor del fuoco. Nella predella, che è vaghissima, sono tre storie a tempera: essa Vergine presentata al tempio, lo sposalizio, e l'adora-zione de' Magi.
Nella Mercanzia, tribunale in quella città, hanno gl'uffiziali una tavoletta, la quale dicono fu fatta da Domenico, quando era giovane, che è bellissima. Dentro vi è un San Paolo in mezzo che siede e, dagli lati, la sua conversione in uno di figure piccole e nell'altro quando fu decapitato. Finalmente fu data a dipignere a Domenico la nicchia grande del Duomo ch'è in testa dietro all'altare maggiore, nella quale egli primieramente fece tutto di sua mano l'ornamento di stucco con fogliami e figure, e due vittorie ne' vani del semicircolo, il quale ornamento fu invero opera ricchissima e bella. Nel mezzo poi fece di pittura a fresco l'Ascendere di Cristo in cielo, e dalla cornice in giù fece tre quadri divisi da colonne di rilievo e dipinte in prospettiva. In quel di mezzo, che ha un arco sopra in prospettiva, è la Nostra Donna, San Piero e San Giovanni, e dalle bande ne' due vani dieci Apostoli, cinque per banda in varie attitudini, che guardano Cristo ascendere in cielo; e sopra ciascuno de' due quadri degl'Apostoli è un Angelo in iscorto, fatti per que' due che dopo l'Ascensione dissono ch'egli era salito in cielo. Quest'opera certo è mirabile, ma più sarebbe ancora se Domenico avesse dato bell'aria alle teste, là dove hanno una certa aria non molto piacevole, perciò che pare che in vecchiezza e' pigliasse un'ariaccia di volti spaventata e non molto vaga. Quest'opera, dico, se avesse avuto bellezza nelle teste sarebbe tanto bella, che non si potrebbe veder meglio. Nella qual aria delle teste prevalse il Soddoma a Domenico al giudizio de' sanesi, perciò che il Soddoma le faceva molto più belle, se bene quelle di Domenico avevano più disegno e più forza. E nel vero la maniera delle teste in queste nostre arti importa assai, et il farle che abbiano bell'aria e buona grazia ha molti maestri scampati dal biasimo, che arebbono avuto per lo restante dell'opera. Fu questa di pittura l'ultima opera che facesse Domenico, il quale in ultimo entrato in capriccio di fare di rilievo, cominciò a dare opera al fondere de' bronzi, e tanto adoperò, che condusse, ma con estrema fatica, a sei colonne del Duomo, le più vicine all'altar maggiore, sei Angeli di bronzo tondi, poco minori del vivo, i quali tengono per posamento d'un candeliere che tiene un lume, alcune tazze
o vero bacinette, e sono molto belli. E negl'ultimi si portò di maniera che ne fu sommamente lodato; per che, cresciutogli l'animo, diede principio a fare i dodici Apostoli per mettergli alle colonne di sotto, dove ne sono ora alcuni di marmo vecchi e di cattiva maniera; ma non seguitò, perché non visse poi molto.
E perché era quest'uomo capricciosissimo e gli riusciva ogni cosa, intagliò da sé stampe di legno, per far carte di chiaro scuro, e se ne veggiono fuori due Apostoli fatti eccellentemente, uno de' quali n'avemo nel nostro libro de' disegni, con alcune carte di sua mano, disegnate divinamente. Intagliò similmente col bulino stampe di rame, e stampò con acqua forte alcune storiette molto capricciose d'archimia, dove Giove e gl'altri dèi volendo congelare Mercurio, lo mettono in un correggiuolo legato e facendogli fuoco attorno Vulcano e Plutone, quando pensarono che dovesse fermarsi, Mercurio volò via e se n'andò in fumo. Fece Domenico, oltre alle sopra dette, molte altre opere di non molta importanza, come quadri di Nostre Donne et altre cose simili da camera, come una Nostra Donna che è in casa il cavalier Donati et un quadro a tempera, dove Giove si converte in pioggia d'oro e piove in grembo a Danae. Piero Catanei similmente ha di mano del medesimo in un tondo a olio una Vergine bellissima. Dipinse anche per la Fraternita di S. Lucia una bellissima bara; e parimente un'altra per quella di Santo Antonio. Né si maravigli niuno che io faccia menzione di sì fatte opere, perciò che sono veramente belle a maraviglia, come sa chiunque l'ha vedute.
Finalmente, pervenuto all'età di sessantacinque anni, s'affrettò il fine della vita coll'affaticarsi tutto solo il giorno e la notte intorno a' getti di metallo et a rinettar da sé, senza volere aiuto niuno. Morì dunque a dì 18 di maggio 1549, e da Giuliano orefice, suo amicissimo, fu fatto sepellire nel Duomo, dove avea tante e sì rare opere lavorato. E fu portato alla sepoltura da tutti gli artefici della sua città, la quale allora conobbe il grandissimo danno che riceveva nella perdita di Domenico, et oggi lo conosce più che mai, ammirando l'opere sue. Fu Domenico persona costumata e da bene, te-mente Dio e studioso della sua arte, ma solitario oltre modo, onde meritò da' suoi sanesi, che sempre hanno con molta loro lode atteso a' belli studi et alle poesie, essere con versi e volgari e latini onoratamente celebrato.
VITA DI GIOVANN'ANTONIO LAPPOLI
PITTORE ARETINO

Rade volte aviene che d'un ceppo vecchio non germogli alcun rampollo buono, il quale col tempo crescendo non rinuovi e colle sue frondi rivesta quel luogo spogliato e faccia con i frutti conoscere a chi gli gusta il medesimo sapore che già si sentì del primo albero. E che ciò sia vero si dimostra nella presente vita di Giovann'Antonio, il quale, moren-do Matteo suo padre, che fu l'ultimo de' pittori del suo tempo assai lodato, rimase con buone entrate al governo della madre e così si stette infino a dodici anni; al qual termine della sua età pervenuto, Giovan Antonio, non si curando di pigliare altro esercizio che la pittura, mosso oltre all'altre cagioni dal volere seguire le vestigie e l'arte del padre, imparò sotto Domenico Pecori pittore aretino, che fu il suo primo maestro, il quale era stato insieme con Matteo suo padre discepolo di Clemente, i primi principii del disegno. Dopo, essendo stato con costui alcun tempo e desiderando far miglior frutto che non faceva sotto la disciplina di quel maestro et in quel luogo, dove non poteva anco da per sé imparare, ancor che avesse l'inclinazione della natura, fece pensiero di volere che la stanza sua fusse Fiorenza. Al quale suo proponimento, aggiuntosi che rimase solo per la morte della madre, fu assai favorevole la fortuna, perché maritata una sorella che aveva di piccola età a Lionardo Ricoveri ricco e de' primi cittadini ch'allora fusse in Arezzo, se n'andò a Fiorenza, dove fra l'opere di molti che vidde, gli piacque più che quella di tutti gli altri che avevano in quella città operato nella pittura, la maniera d'Andrea del Sarto e di Iacopo da Puntormo; per che risolvendosi d'andare a stare con uno di questi due, si stava sospeso a quale di loro dovesse appigliarsi, quando scoprendosi la Fede e la Carità fatta dal Puntormo sopra il portico della Nunziata di Firenze, deliberò del tutto d'andare a star con esso Puntormo, parendogli che la costui maniera fusse tanto bella, che si potesse sperare che egli, allora giovane, avesse a passare inanzi a tutti i pittori giovani della sua età, come fu in quel tempo ferma credenza d'ognuno. Il Lappoli adunque, ancor che fusse potuto andare a star con Andrea, per le dette cagioni si mise col Puntormo, appresso al quale continuamente disegnando, era da due sproni per la concorrenza cacciato alla fatica terribilmente. L'uno si era Giovan Maria dal Borgo a Sansepolcro, che sotto il medesimo attendeva al disegno et alla pittura, et il quale, consigliandolo sempre al suo bene, fu cagione che mutasse maniera e pigliasse quella buona del Puntormo. L'altro (e questi lo stimolava più forte) era il vedere che Agnolo chiamato il Bronzino era molto tirato innanzi da Iacopo, per una certa amorevole sommessione, bontà e diligente fatica che aveva nell'imitare le cose del maestro; senzaché disegnava benissimo e si portava ne' colori di maniera, che diede speranza di dovere a quell'eccellenza e perfezzione venire, che in lui si è veduta e vede ne' tempi nostri.
Giovan Antonio dunque, disideroso d'imparare e spinto dalle sudette cagioni, durò molti mesi a far disegni e ritratti dell'opere di Iacopo Puntormo tanto ben condotti e begli e buoni, che se egli avesse seguitato e per la natura, che l'aiu-tava, per la voglia del venire eccellente e per la concorrenza e buona maniera del maestro, si sarebbe fatto eccellentissimo: e ne possono far fede alcuni disegni di matita rossa, che di sua mano si veggiono nel nostro libro. Ma i piaceri, come spesso si vede avvenire, sono ne' giovani le più volte nimici della virtù e fanno che l'intelletto si disvia, e però bisognerebbe a chi attende agli studi di qual si voglia scienza, facultà et arte, non avere altre pratiche che di coloro che sono della professione e buoni e costumati. Giovan Antonio, dunque, essendosi messo a stare, per essere governato, in casa d'un ser Raffaello di Sandro Zoppo, cappellano in San Lorenzo, al quale dava un tanto l'anno, dismesse in gran parte lo studio della pittura; perciò che, essendo questo prete galantuomo e dilettandosi di pittura, di musica e d'altri trattenimenti, praticavano nelle sue stanze, che aveva in San Lorenzo, molte persone virtuose e fra gl'altri Messer Antonio da Lucca, musico e sonator di liuto eccellentissimo, che allora era giovinetto; dal quale imparò Giovan Antonio a sonar di liuto. E se bene nel medesimo luogo praticava anco il Rosso pittore et alcuni altri della professione, si attenne più tosto il Lappoli agl'altri che a quelli dell'arte, da' quali arebbe potuto molto imparare et in un medesimo tempo trattenersi. Per questi impedimenti, adunque, si raffreddò in gran parte la voglia che aveva mostrato d'avere della pittura in Giovan Antonio, ma tuttavia essendo amico di Pier Francesco di Iacopo di Sandro, il quale era discepolo d'Andrea del Sarto, andava alcuna volta a disegnare seco nello Scalzo e pitture et ignudi di naturale. E non andò molto che, datosi a colorire, condusse de' quadri di Iacopo, e poi da sé alcune Nostre Donne e ritratti di naturale, fra i quali fu quello di detto Messer Antonio da Lucca e quello di ser Raffaello, che sono molto buoni. Essendo poi l'anno 1523 la peste in Roma, se ne venne Perino del Vaga a Fiorenza, e cominciò a tornarsi anch'egli con ser Raffaello del Zoppo, per che, avendo fatta seco Giovan Antonio stretta amicizia, avendo conosciuta la virtù di Perino, se gli ridestò nell'animo il pensiero di volere, lasciando tutti gl'altri piaceri, attendere alla pittura, e cessata la peste andare con Perino a Roma. Ma non gli venne fatto perché, venuta la peste in Fiorenza, quando appunto avea finito Perino la storia di chiaro scuro della sommersione di faraone nel Mar Rosso, di color di bronzo, per ser Raffaello, al quale fu sempre presente il Lappoli, furono forzati l'uno e l'altro per non vi lasciare la vita, partirsi di Firenze. Onde tornato Giovan Antonio in Arezzo si mise, per passar tempo, a fare in una storia in tela la morte d'Orfeo, stato ucciso dalle Baccanti; si mise, dico, a fare questa storia in color di bronzo di chiaro scuro nella maniera che avea veduto fare a Perino la sopra detta; la quale opera finita gli fu lodata assai. Dopo si mise a finire una tavola, che Domenico Pecori già suo maestro aveva cominciata per le monache di Santa Margherita; nella quale tavola, che è oggi dentro al monasterio, fece una Nunziata. E due cartoni fece per due ritratti di naturale dal mezzo in su, bellissimi: uno fu Lorenzo d'Antonio di Giorgio, allora scolare e giovane bellissimo, e l'altro fu ser Piero Guazzesi, che fu persona di buon tempo. Cessata finalmente alquanto la peste, Cipriano d'Anghia-ni, uomo ricco in Arezzo, avendo fatta murare di que' giorni nella Badia di Santa Fiore in Arezzo una cappella con ornamenti e colonne di pietra serena, allogò la tavola a Giovan Antonio per prezzo di scudi cento. Passando in tanto per Arezzo il Rosso, che se n'andava a Roma et alloggiando con Giovan Antonio suo amicissimo, intesa l'opera che aveva tolta a fare, gli fece, come volle il Lappoli, uno schizzetto tutto d'ignudi molto bello; per che messo Giovan Antonio mano all'opera, imitando il disegno del Rosso, fece nella detta tavola la visitazione di S. Lisabetta, e nel mezzo tondo di sopra un Dio Padre con certi putti, ritraendo i panni e tutto il resto di naturale. E condottola a fine ne fu molto lodato e comendato e massimamente per alcune teste ritratte di naturale, fatte con buona maniera e molto utile. Conoscendo poi Giovan Antonio, che a voler fare maggior frutto nell'arte, bisognava partirsi d'Arezzo, passata del tutto la peste a Roma, deliberò andarsene là dove già sapeva ch'era tornato Perino, il Rosso e molti altri amici suoi, e vi facevano molte opere e grandi. Nel qual pensiero se gli porse occasioni d'andarvi comodamente. Per che, venuto in Arezzo Messer Paolo Valdarabrini, segretario di papa Clemente Settimo, che tornando di Francia in poste passò per Arezzo per vedere i fratelli e nipoti, l'andò Giovan Antonio a visitare; onde Messer Paolo, che era disideroso che in quella sua città fussero uomini rari in tutte le virtù, i quali mostrassero gl'ingegni che dà quell'aria e quel cielo a chi vi nasce, confortò Giovan Antonio, ancor che molto non bisognasse, a dovere andar seco a Roma, dove gli farebbe avere ogni commodità di pote-re attendere agli studi dell'arte. Andato dunque con esso Messer Paolo a Roma, vi trovò Perino, il Rosso et altri amici suoi, et oltre ciò gli venne fatto, per mezzo di Messer Paolo, di conoscere Giulio Romano, Bastiano Viniziano e Francesco Mazzuoli da Parma, che in que' giorni capitò a Roma; il quale Francesco, dilettandosi di sonare il liuto, e perciò ponendo grandissimo amor a Giovanni Antonio, fu cagione col praticare sempre insieme, che egli si mise con molto studio a disegnare e colorire et a valersi dell'occasione che aveva d'essere amico ai migliori dipintori che allora fussero in Roma. E già avendo quasi condotto a fine un quadro, dentrovi una Nostra Donna grande quanto è il vivo, il quale voleva Messer Paolo donare a papa Clemente per fargli conoscere il Lappoli, venne, sì come volle la fortuna che spesso s'attraversa a' disegni degli uomini, a sei di maggio l'anno 1527, il Sacco infelicissimo di Roma. Nel quale caso, correndo Messer Paulo a cavallo e seco Giovan Antonio alla porta di Santo Spirito in Trastevere, per far opera che non così tosto entrassero per quel luogo i soldati di Borbone, e vi fu esso Messer Paolo morto et il Lappoli fatto prigione dagli Spagnuoli. E poco dopo, messo a sacco ogni cosa, si perdè il quadro, i disegni fatti nella cappella e ciò che aveva il povero Giovan Antonio, il quale dopo molto essere stato tormentato dagli Spagnuoli, perché pagasse la taglia, una notte in camicia si fuggì con altri prigioni. E mal condotto e disperato, con gran pericolo della vita, per non esser le strade sicure, si condusse finalmente in Arezzo dove, ricevuto da Messer Giovanni Polastra, uomo litteratissimo, che era suo zio, ebbe che fare a riaversi, sì era mal condotto per lo stento e per la paura. Dopo, venendo il medesimo anno in Arezzo sì gran peste che morivano quattrocento persone il giorno, fu forzato di nuovo Giovan Antonio a fuggirsi tutto disperato e di mala voglia e star fuora alcuni mesi; ma cessata finalmente quella influenza, in modo che si poté cominciare a conversare insieme, un fra' Guasparri conventuale di San Francesco, allora guardiano del convento di quella città, allogò a Giovan Antonio la tavola dell'altar maggiore di quella chiesa per cento scudi, acciò vi facesse dentro l'adorazione de' Magi; per che il Lappoli, sentendo che 'l Rosso era al Borgo San Sepolcro e vi lavorava (essendosi anch'egli fuggito di Roma) la tavola della Compagnia di Santa Croce, andò a visitarlo, e dopo avergli fatto molte cortesie e fattogli portare alcune cose d'Arezzo, delle quali sapeva che aveva necessità, avendo perduto ogni cosa nel Sacco di Roma, si fece far un bellissimo disegno della tavola detta che aveva da fare per fra' Guasparri. Alla quale messo mano, tornato che fu in Arezzo, la condusse secondo i patti in fra un anno dal dì della locazione et in modo bene che ne fu sommamente lodato. Il quale disegno del Rosso l'ebbe poi Giorgio Vasari e da lui il molto reverendo don Vincenzio Borghini, spedalingo degli Innocenti di Firenze, e che l'ha in un suo libro di disegni di diversi pittori.
Non molto dopo, essendo entrato Giovan Antonio mallevador al Rosso per trecento scudi, per conto di pitture che dovea il detto Rosso fare nella Madonna delle Lacrime, fu Giovan Antonio molto travagliato perché, essendosi partito il Rosso senza finir l'opera, come si è detto nella sua vita, et astretto Giovanni Antonio a restituire i danari, se gl'amici e particolarmente Giorgio Vasari, che stimò trecento scudi quello che avea lasciato finito il Rosso, non l'avessero aiutato, sarebbe Giovan Antonio poco meno che rovinato per fare onore et utile alla patria. Passati que' travagli, fece il Lappoli per l'abbate Camaiani di Bibbiena, a Santa Maria del Sasso, luogo de' frati predicatori in Casentino, in una cappella nella chiesa di sotto, una tavola a olio dentrovi la Nostra Donna, San Bartolomeo e S. Matia; e si portò molto bene contrafacendo la maniera del Rosso. E ciò fu cagione che una Fraternita in Bibbiena gli fece poi fare, in un gonfalone da portare a processione, un Cristo nudo con la croce in ispalla, che versa sangue nel calice, e dall'altra banda una Nunziata, che fu delle buone cose che facesse mai. L'anno 1534, aspettandosi il duca Alessandro de' Medici in Arezzo, ordinarono gl'Aretini e Luigi Guicciardini commessario in quella città, per onorare il Duca, due comedie. D'una erano festaiuoli e n'avevano cura una compagnia de' più nobili giovani della città che si facevano chiamare gl'Umidi, e l'apparato e scena di questa, che fu una comedia degli Intronati da Siena, fece Niccolò Soggi, che ne fu molto lodato, e la comedia fu recitata benissimo e con infinita sodisfazione di chiunque la vidde. Dell'altra erano festaiuoli a concorrenza un'altra compagnia di giovani similmente nobili, che si chiamava la Compagnia degl'Infiammati. Questi dunque, per non esser meno lodati che si fussino stati gl'Umidi, recitando una comedia di Messer Giovanni Polastra, poeta aretino, guidata da lui medesimo, fecero far la prospettiva a Giovan Antonio, che si portò sommamente bene. E così la comedia fu con molto onore di quella compagnia e di tutta la città recitata. Né tacerò un bel capriccio di questo poeta, che fu veramente uomo di bellissimo ingegno. Mentre che si durò a fare l'apparato di queste et altre feste, più volte si era fra i giovani dell'una e l'altra Compagnia, per diverse cagioni e per la concorrenza, venuto alle mani e fattosi alcuna quistione, per che il Polastra, avendo menato la cosa secretamente affatto, ragunati che furono i popoli e i gentiluomini e le gentildonne dove si aveva la comedia a recitare, quattro di que' giovani, che altre volte si erano per la città affrontati, usciti con le spade nude e le cappe imbracciate, cominciarono in sulla scena a gridare e fingere d'ammazzarsi, et il primo che si vidde di loro uscì con una tempia fintamente insanguinata gridando: “Venite fuora, traditori”. Al quale rumore, levatosi tutto il popolo in piedi e cominciandosi a cacciar la mano all'armi, i parenti de' giovani, che mostravano di tirarsi coltellate terribili, correvano alla volta della scena, quando il primo che era uscito, voltosi agl'altri giovani, disse: “Fermate, signori; rimettete dentro le spade, che non ho male et ancora che siamo in discordia e crediate che la comedia non si faccia, ella si farà, e così ferito come sono, vo cominciare il prologo”. E così, dopo questa burla, alla quale rimasono colti tutti i spettatori e gli strioni medesimi, eccetto i quattro sopra detti, fu cominciata la comedia e tanto bene recitata, che l'anno poi 1540 quando il signor duca Cosimo e la signora duchessa Leonora furono in Arezzo, bisognò che Gio-vann'Antonio, di nuovo facendo la prospettiva in sulla piazza del vescovado, la facesse recitare a loro eccellenze, e sì come altra volta erano i recitatori di quella piaciuti, così tanto piacquero allora al signor Duca, che furono poi, il carnovale vegnente, chiamati a Fiorenza a recitare. In queste due prospettive adunque si portò il Lappoli molto bene e ne fu sommamente lodato.
Dopo fece un ornamento a uso d'arco trionfale, con istorie di color di bronzo, che fu messo intorno all'altare della Madonna delle Chiave. Essendosi poi fermo Giovan Antonio in Arezzo, con proposito, avendo moglie e figliuoli, di non andar più attorno, e vivendo d'entrate e degl'uffizii, che in quella città godono i cittadini di quella si stava senza molto lavorare. Non molto dopo queste cose, cercò che gli fussero allogate due tavole, che s'avevano a fare in Arezzo, una nella chiesa e compagnia di S. Rocco, e l'altra all'altare maggiore di S. Domenico, ma non gli riuscì; perciò che l'u-na e l'altra fu fatta fare a Giorgio Vasari, essendo il suo disegno, fra molti che ne furono fatti, più di tutti gli altri piaciuto.
Fece Giovann'Antonio per la Compagnia dell'Ascensione di quella città, in un golfalone da portare a processione, Cristo che risuscita, con molti soldati intorno al sepolcro, et il suo ascendere in cielo, con la Nostra Donna in mezzo a' dodici Apostoli, il che fu fatto molto bene e con diligenza. Nel castello della Pieve fece, in una tavola a olio, la visitazione di Nostra Donna et alcuni Santi attorno, et in una tavola, che fu fatta per la pieve a S. Stefano, la Nostra Donna et altri Santi. Le quali due opere condusse il Lappoli molto meglio che l'altre che aveva fatto infino allora, per avere veduti, con suo commodo, molti rilievi e gessi di cose formate dalle statue di Michelagnolo e da altre cose antiche, stati condotti da Giorgio Vasari nelle sue case d'Arezzo. Fece il medesimo alcuni quadri di Nostre Donne che sono per Arezzo et in altri luoghi, et una Iudit che mette la testa d'Oloferne in una sporta tenuta da una sua servente, la quale ha oggi monsignor Messer Bernardetto Minerbetti vescovo d'Arezzo, il quale amò assai Giovan Antonio, come fa tutti gl'altri virtuosi, e da lui ebbe, oltre all'altre cose, un S. Giovanbatista giovinetto nel deserto, quasi tutto ignudo, che è da lui tenuto caro perché è bonissima figura. Finalmente, conoscendo Giovan Antonio che la perfezzione di quest'arte non consisteva in altro che in cercar di farsi a buon'ora ricco d'invenzione e studiare assai gli ignudi e ridurre le difficultà del far in facilità, si pentiva di non avere speso il tempo, che aveva dato a' suoi piaceri, negli studii dell'arte e che non bene si fa in vecchiezza quello che in giovanezza si potea fare. E come che sempre conoscesse il suo errore, non però lo conobbe interamente, se non quando essendosi già vecchio messo a studiare, vidde condurre in quarantadue giorni una tavola a olio, lunga quattordici braccia et alta sei e mezzo, da Giorgio Vasari, che la fece per lo reffettorio de' monaci della Badia di S. Fiore in Arezzo, dove sono dipinte le nozze d'Ester e del re Assuero, nella quale opera sono più di sessanta figure maggiori del vivo.
Andando dunque alcuna volta Giovann'Antonio a vedere lavorare Giorgio e standosi a ragionar seco, diceva: “Or conosco io che 'l continuo studio e lavorare è quello che fa uscir gli uomini di stento, e che l'arte nostra non viene per Spirito Santo”. Non lavorò molto Giovan Antonio a fresco, perciò che i colori gli facevono troppa mutazione, nondimeno si vede di sua mano, sopra la chiesa di Murello, una Pietà con due Angioletti nudi assai bene lavorati. Finalmente essendo stato uomo di buon giudizio et assai pratico nelle cose del mondo, d'anni sessanta, l'anno 1552, amalando di febre acutissima si morì. Fu suo creato Bartolomeo Torri, nato di assai nobile famiglia in Arezzo, il quale condottosi a Roma, sotto don Giulio Clovio miniatore eccellentissimo, veramente attese di maniera al disegno et allo studio degl'i-gnudi, ma più alla notomia, che si era fatto valente e tenuto il migliore disegnatore di Roma. E non ha molto, che don Silvano Razzi mi disse don Giulio Clovio avergli detto in Roma, dopo aver molto lodato questo giovane, quello stesso che a me ha molte volte affermato, cioè non se l'essere levato di casa per altro che per le sporcherie della notomia, perciò che teneva tanto nelle stanze e sotto il letto membra e pezzi d'uomini, che ammorbavano la casa. Oltre ciò, stracurando costui la vita sua e pensando che lo stare come filosofaccio sporco e senza regola di vivere e fuggendo la conversazione degl'uomini, fusse la via da farsi grande et immortale, si condusse male affatto; perciò che la natura non può tolerare le soverchie ingiurie che alcuni tallora le fanno. Infermatosi adunque Bartolomeo d'anni venticinque, se ne tornò in Arezzo per curarsi e vedere di riaversi, ma non gli riuscì perché, continuando i suoi soliti studii et i medesimi disordini, in quattro mesi, poco dopo Giovan Antonio, morendo gli fece compagnia. La perdita del quale giovane dolse infinitamente a tutta la sua città, perciò che vivendo era per fare, secondo il gran principio dell'opere sue, grandissimo onore alla patria et a tutta Toscana, e chi vede dei disegni che fece, essendo anco giovinetto, resta maravigliato e, per essere mancato sì presto, pieno di compassione.
VITA DI NICCOLÒ SOGGI
PITTORE

Fra molti che furono discepoli di Pietro Perugino, niuno ve n'ebbe, dopo Raffaello da Urbino, che fusse né più studioso, né più diligente di Niccolò Soggi, del quale al presente scriviamo la vita. Costui, nato in Fiorenza di Iacopo Soggi, persona da bene, ma non molto ricca, ebbe col tempo servitù in Roma con Messer Antonio dal Monte, per che, a-vendo Iacopo un podere a Marciano in Valdichiana e standosi il più del tempo là, praticò assai, per la vicinità de' luoghi, col detto Messer Anton di Monte. Iacopo dunque, vedendo questo suo figliuolo molto inclinato alla pittura, l'ac-conciò con Pietro Perugino, et in poco tempo, col continuo studio, acquistò tanto che non molto tempo passò che Pietro cominciò a servirsene nelle cose sue, con molto utile di Niccolò, il quale attese in modo a tirare di prospettiva et a ritrarre di naturale, che fu poi nell'una cosa e nell'altra molto eccellente.
Attese anco assai Niccolò a fare modelli di terra e di cera, ponendo loro panni addosso e cartepecore bagnate; il che fu cagione che egli insecchì sì forte la maniera, che mentre visse tenne sempre quella medesima, né per fatica che facesse se la poté mai levare da dosso. La prima opera che costui facesse doppo la morte di Pietro suo maestro, si fu una tavola a olio in Fiorenza nello spedale delle Donne di Bonifazio Lupi in via Sangallo, cioè la banda di dietro dell'altare, dove l'Angelo saluta la Nostra Donna, con un casamento tirato in prospettiva, dove sopra i pilastri girano gl'archi e le crocere, secondo la maniera di Piero. Dopo l'anno 1512 avendo fatto molti quadri di Nostre Donne per le case dei cittadini, et altre cosette che si fanno giornalmente, sentendo che a Roma si facevano gran cose, si partì di Firenze, pensando acquistare nell'arte e dovere anco avanzare qualche cosa, e se n'andò a Roma dove, avendo visitato il detto Messer Antonio di Monte, che allora era cardinale, fu non solamente veduto volentieri, ma subito messo in opera a fare, in quel principio del pontificato di Leone, nella facciata del palazzo, dove è la statua di maestro Pasquino, una grand'arme in fresco di papa Leone in mezzo a quella del popolo romano e quella del detto cardinale. Nella quale opera Niccolò si portò non molto bene, perché nelle figure d'alcuni ignudi che vi sono et in alcune vestite, fatte per ornamento di quel-l'armi, cognobbe Niccolò che lo studio de' modegli è cattivo a chi vuol pigliare buona maniera. Scoperta dunque che fu quell'opera, la quale non riuscì di quella bontà che molti s'aspettavano, si mise Niccolò a lavorare un quadro a olio, nel quale fece S. Prassedia martire che preme una spugna piena di sangue in un vaso; e la condusse con tanta diligenza, che ricuperò in parte l'onore che gli pareva avere perduto nel fare la sopra detta arme. Questo quadro, il quale fu fatto per lo detto cardinale di Monte, titolare di S. Prassedia, fu posto nel mezzo di quella chiesa, sopra un altare, sotto il quale è un pozzo di sangue di Santi martiri, e con bella considerazione, alludendo la pittura al luogo dove era il sangue de' detti martiri. Fece Niccolò dopo questo, in un altro quadro alto tre quarti di braccio, al detto cardinale suo padrone, una Nostra Donna a olio col Figliuolo in collo, San Giovanni piccolo fanciullo et alcuni paesi, tanto bene e con tanta diligenza, che ogni cosa pare miniato e non dipinto. Il quale quadro, che fu delle migliori cose che mai facesse Niccolò, stette molti anni in camera di quel prelato. Capitando poi quel cardinale in Arezzo et alloggiando nella Badia di Santa Fiore, luogo de' monaci neri di San Benedetto, per le molte cortesie che gli furono fatte, donò il detto quadro alla sagrestia di quel luogo, nella quale si è infino a ora conservato e come buona pittura e per memoria di quel cardinale; col quale venendo Niccolò anch'egli ad Arezzo e dimorandovi poi quasi sempre, allora fece amicizia con Domenico Pecori pittore, il quale allora faceva in una tavola della Compagnia della Trinità la Circoncisione di Cristo, e fu sì fatta la dimestichezza loro, che Niccolò fece in questa tavola a Domenico un casamento in prospettiva di colonne con archi e girando sostengono un palco fatto, secondo l'uso di que' tempi, pieno di rosoni, che fu tenuto allora molto bello. Fece il medesimo al detto Domenico a olio, in sul drappo, un tondo d'una Nostra Donna con un popolo sotto, per il baldacchino della Fraternita d'Arezzo, il quale, come si è detto nella vita di Domenico Pecori, si abruciò per una festa che si fece in San Francesco.
Essendogli poi allogata una cappella nel detto San Francesco, cioè la seconda entrando in chiesa a man ritta, vi fece dentro a tempera la Nostra Donna, San Giovanni Batista, San Bernardo, Sant'Antonio, San Francesco e tre Angeli in aria che cantano, con un Dio Padre in un frontespizio, che quasi tutti furono condotti da Niccolò a tempera, con la punta del pennello. Ma perché si è quasi tutta scrostata per la fortezza della tempera, ella fu una fatica gettata via, ma ciò fece Niccolò per tentare nuovi modi. Ma conosciuto che il vero modo era il lavorare in fresco, s'attaccò alla prima occasione e tolse a dipignere in fresco una cappella in S. Agostino di quella città, a canto alla porta a man manca entrando in chiesa. Nella quale cappella, che gli fu allogata da un Scamarra maestro di fornaci, fece una Nostra Donna in aria con un popolo sotto e San Donato e San Francesco ginocchioni, e la miglior cosa che egli facesse in quest'opera fu un S. Rocco nella testata della cappella. Quest'opera, piacendo molto a Domenico Ricciardi aretino, il quale aveva nella chiesa della Madonna delle Lacrime una cappella, diede la tavola di quella a dipignere a Niccolò, il quale messo mano all'opera vi dipinse dentro la Natività di Gesù Cristo con molto studio e diligenza. E se bene penò assai a finirla, la condusse tanto bene, che ne merita scusa, anzi lode infinita, perciò che è opera bellissima. Né si può credere con quanti avertimenti ogni minima cosa conducesse, et un casamento rovinato, vicino alla capanna dove è Cristo fanciullino e la Vergine, è molto bene tirato in prospettiva; nel San Giuseppo et in alcuni pastori sono molte teste di naturale, cioè Stagio Sassoli pittore et amico di Niccolò, e Papino dalla Pieve suo discepolo, il quale averebbe fatto a sé et alla patria, se non fusse morto assai giovane, onor grandissimo. E tre Angeli che cantano in aria sono tanto ben fatti, che soli basterebbono a mostrare la virtù e pacienza che infino all'ultimo ebbe Niccolò intorno a quest'opera, la quale non ebbe sì tosto finita, che fu ricerco dagl'uomini della Compagnia di Santa Maria della Neve del Monte Sansovino di far loro una tavola per la detta Compagnia, nella quale fusse la storia della neve che, fiocando a Santa Maria Maggiore di Roma a' cinque dì d'agosto, fu cagione dell'edificazione di quel tempio. Niccolò dunque condusse a' sopra detti la detta tavola con molta diligenza, e dopo fece a Marciano un lavoro in fresco assai lodato. L'anno poi 1524 avendo nella terra di Prato Messer Baldo Magini fatto condurre di marmo da Antonio, fratello di Giuliano da Sangallo, nella Madonna delle Carcere un tabernacolo di due colonne con suo architrave, cornice e quarto tondo, pensò Antonio di far sì che Messer Baldo faces-se fare la tavola, che andava dentro a questo tabernacolo, a Niccolò, col quale aveva preso amicizia quando lavorò al Monte San Sovino nel palazzo del già detto cardinal di Monte. Messolo dunque per le mani a Messer Baldo, egli, ancor che avesse in animo di farla dipignere ad Andrea del Sarto, come si è detto in altro luogo, si risolvette, a preghiera e per il consiglio d'Antonio, di allogarla a Niccolò, il quale, messovi mano, con ogni suo potere si sforzò di fare una bell'ope-ra, ma non gli venne fatta perché dalla diligenza in poi non vi si conosce bontà di disegno, né altra cosa, che molto lodevole sia; perché quella sua maniera dura lo conduceva, con le fatiche di que' suoi modelli di terra e di cera, a una fine quasi sempre faticosa e dispiacevole. Né poteva quell'uomo, quanto alle fatiche dell'arte, far più di quello che faceva, né con più amore. E perché conosceva che niuno ..., mai si potè per molti anni persuadere che altri gli passasse innanzi d'eccellenza. In quest'opera adunque è un Dio Padre che manda sopra quella Madonna la corona della virginità et umiltà per mano d'alcuni Angeli che le sono intorno, alcuni de' quali suonano diversi stromenti. In questa tavola ritrasse Niccolò di naturale Messer Baldo ginocchioni a piè d'un Santo Ubaldo vescovo, e dall'altra banda fece San Giuseppo; e queste due figure mettono in mezzo l'imagine di quella Nostra Donna che in quel luogo fece miracoli. Fece di poi Niccolò, in un quadro alto tre braccia, il detto Messer Baldo Magini di naturale e ritto, con la chiesa di San Fabiano di Prato in mano, la quale egli donò al capitolo della calonaca della pieve. E ciò fece per lo capitolo detto il quale, per memoria del ricevuto beneficio, fece porre questa quadro in sagrestia, sì come veramente meritò quell'uomo singolare che con ottimo giudizio beneficiò quella principale chiesa della sua patria tanto nominata per la cintura che vi serba di Nostra Donna. E questo ritratto fu delle migliori opere che mai facesse Niccolò di pittura.
È openione ancora d'alcuni che di mano del medesimo sia una tavoletta che è nella Compagnia di San Pier martir[e] in sulla piazza di San Domenico di Prato, dove sono molti ritratti di naturale, ma secondo me, quando sia vero che così sia, ella fu da lui fatta inanzi a tutte l'altre sue sopra dette pitture. Dopo questi lavori, partendosi di Prato Niccolò sotto la disciplina del quale avea imparato i principii dell'arte della pittura Domenico Giuntalochi, giovane di quella terra di bonissimo ingegno, il quale per aver appreso quella maniera di Niccolò non fu di molto valore nella pittura, come si dirà, se ne venne per lavorare a Fiorenza. Ma veduto che le cose dell'arte di maggiore importanza si davano a' migliori e più eccellenti e che la sua maniera non era secondo il far d'Andrea del Sarto, del Puntormo, del Rosso e degli altri, prese partito di ritornarsene in Arezzo, nella quale città aveva più amici, maggior credito e meno concorrenza. E così a-vendo fatto, subito che fu arrivato, conferì un suo desiderio a Messer Giuliano Bacci, uno de' maggiori cittadini di quella città, e questo fu che egli desiderava che la sua patria fusse Arezzo, e che per ciò volentieri arebbe preso a far alcu-n'opera che l'avesse mantenuto un tempo nelle fatiche dell'arte, nelle quali egli arebbe potuto mostrare in quella città il valore della sua virtù. Messer Giuliano, adunque, uomo ingegnoso e che desiderava abellire la sua patria, e che in essa fussero persone che attendessero alle virtù, operò di maniera con gl'uomini che allora governavano la Compagnia della Nunziata, i quali avevano fatto di quei giorni murare una volta grande nella lor chiesa con intenzione di farla dipignere, che fu allogato a Niccolò un arco delle facce di quella, con pensiero di fargli dipignere il rimanente se quella prima parte, che aveva da fare allora, piacesse agl'uomini di detta Compagnia. Messosi dunque Niccolò intorno a quest'opera con molto studio, in due anni fece la metà, e non più di uno arco, nel quale lavorò a fresco la Sibilla tiburtina che mostra a Ottaviano imperadore la Vergine in cielo col Figliuol Gesù Cristo in collo et Ottaviano, che con reverenza l'adora. Nella figura del quale Ottaviano ritrasse il detto Messer Giuliano Bacci et in un giovane grande che ha un panno rosso, Domenico suo creato, et in altre teste altri amici suoi. Insomma si portò in quest'opera di maniera, che ella non dispiacque agl'uomini di quella Compagnia, né agl'altri di quella città. Ben è vero che dava fastidio a ognuno il vederlo così lungo e penar tanto a condurre le sue cose, ma con tutto ciò gli sarebbe stato dato a finire il rimanente se non l'avesse impedito la venuta in Arezzo del Rosso fiorentino, pittor singolare al quale, essendo messo inanzi da Giovan Antonio Lappoli pittore aretino e da Messer Giovanni Polastra, come si è detto in altro luogo, fu allogato con molto favore il rimanente di quell'opera. Di che prese tanto sdegno Niccolò, che se non avesse tolto l'anno inanzi donna et avutone un figliuolo, dove era accasato in Arezzo, si sarebbe subito partito. Pur finalmente quietatosi, lavorò una tavola per la chiesa di Sargiano, luogo vicino ad Arezzo due miglia, dove stanno frati de' zoccoli, nella quale fece la Nostra Donna assunta in cielo con molti putti che la portano, a' piedi di San Tomaso che riceve la cintola et a torno San Francesco, S. Lodovico, S. Giovanni Battista e Santa Lisabetta regina d'Ungheria. In alcuna delle quali figure e particularmente in certi punti, si portò benissimo; e così anco nella predella fece alcune storie di figure piccole, che sono ragionevoli. Fece ancora nel convento delle monache delle Murate del medesimo Ordine, in quella città, un Cristo morto con le Marie, che per cosa a fresco è lavorata pulitamente. E nella Badia di Santa Fiore de' monaci Neri, fece dietro al Crucifisso, che è posto in sull'altar maggiore, in una tela a olio, Cristo che ora nell'orto e l'Angelo che, mostrandogli il calice della Passione, lo conforta, che invero fu assai bella e buon'opera. Alle monache di San Benedetto d'Arezzo, dell'Ordine di Camaldoli, sopra una porta per la quale si entra nel monastero fece in un arco la Nostra Donna, San Benedetto e Santa Ca-terina, la quale opera fu poi, per aggrandire la chiesa, gettata in terra.
Nel castello di Marciano in Valdichiana, dov'egli si tratteneva assai, vivendo parte delle sue entrate che in quel luogo aveva e parte di qualche guadagno che vi faceva, cominciò Niccolò in una tavola un Cristo morto e molte altre cose con le quali si andò un tempo trattenendo. Et in quel mentre, avendo appresso di sé il già detto Domenico Giuntalochi da Prato, si sforzava, amandolo et appresso di sé tenendolo come figliuolo, che si facesse eccellente nelle cose dell'arte, insegnandoli a tirare di prospettiva, ritrarre di naturale e disegnare, di maniera che già in tutte queste parti riusciva bonissimo e di bello e buono ingegno. E ciò faceva Niccolò, oltre all'essere spinto dall'affezione et amore che a quel giovane portava, con isperanza, essendo già vicino alla vecchiezza, d'avere chi l'aiutasse e gli rendesse negl'ultimi anni il cambio di tante amorevolezze e fatiche. E di vero fu Niccolò amorevolissimo con ognuno e di natura sincero e molto amico di coloro che s'affaticavano per venire da qualche cosa nelle cose dell'arte; e quello che sapeva l'insegnava più che volentieri.
Non passò molto dopo queste cose, essendo da Marciano tornato in Arezzo Niccolò e da lui partitosi Domenico, che s'ebbe a dare dagli uomini della Compagnia del Corpo di Cristo di quella città a dipignere una tavola per l'altare maggiore della chiesa di San Domenico, per che disiderando di farla Niccolò e parimente Giorgio Vasari allora giovinetto, fece Niccolò quello che per aventura non farebbono oggi molti dell'arte nostra. E ciò fu che, veggendo egli, il quale era uno degli uomini della detta Compagnia, che molti per tirarlo inanzi si contentavano di farla fare a Giorgio e che egli n'aveva disiderio grandissimo, si risolvé, veduto lo studio di quel giovinetto, deposto il bisogno e disiderio proprio, di far sì che i suoi compagni l'allogassino a Giorgio; stimando più il frutto che quel giovane potea riportare di quell'opera, che il suo proprio utile et interesse. E come egli volle, così fecero a punto gli uomini di detta Compagnia. In quel mentre Domenico Giuntalochi essendo andato a Roma, fu di tanto benigna la fortuna che, conosciuto da don Martino ambasciatore del re di Portogallo, andò a star seco e gli fece una tela, con forse venti ritratti di naturale, tutti suoi familiari et amici e lui in mezzo di loro a ragionare. La quale opera tanto piacque a don Martino, che egli teneva Domenico per lo primo pittore del mondo. Essendo poi fatto don Ferrante Gonzaga viceré di Sicilia e desiderando per fortificare i luoghi di quel regno d'avere appresso di sé un uomo che disegnasse e gli mettesse in carta tutto quello che andava giornalmente pensando, scrisse a don Martino che gli provedesse un giovane, che in ciò sapesse e potesse servirlo, e quanto prima glielo mandasse. Don Martino adunque, mandati prima certi disegni di mano di Domenico a don Ferrante, fra i quali era un colosseo, stato intagliato in rame da Girolamo Fagiuoli bolognese per Antonio Salamanca, che l'aveva tirato in prospettiva Domenico, et un vecchio nel carruccio disegnato dal medesimo e stato messo in stampa, con lettere che di-cono: Ancora imparo; et in quadretto il ritratto di esso don Martino, gli mandò poco appresso Domenico, come volle il detto signor don Ferrante, al quale erano molto piacciute le cose di quel giovane.
Arrivato dunque Domenico in Sicilia, gli fu assegnata orrevole provisione e cavallo e servitore a spese di don Ferrante, né molto dopo fu messo a travagliare sopra le muraglie e fortezze di Sicilia, là dove lasciato a poco a poco il dipignere, si diede ad altro, che gli fu per un pezzo più utile, perché, servendosi come persona d'ingegno d'uomini che e-rano molto a proposito, per far fatiche con tener bestie da soma in man d'altri, e far portar rena, calcina e far fornaci, non passò molto che si trovò avere avanzato tanto che poté comperare in Roma ufficii per duemila scudi, e poco appresso degl'altri. Dopo, essendo fatto guardaroba di don Ferrante, avvenne che quel signor fu levato dal governo di Sicilia e mandato a quello di Milano, per che andato seco Domenico, adoperandosi nelle fortificazioni di quello stato, si fece con l'essere industrioso, et anzi misero che no, richissimo. E, che è più, venne in tanto credito che egli in quel reggimento governava quasi il tutto. La qual cosa sentendo Niccolò, che si trovava in Arezzo già vecchio, bisognoso e senza avere alcuna cosa da lavorare, andò a ritrovare Domenico a Milano, pensando che come non aveva egli mancato a Domenico quando era giovanetto, così non dovesse Domenico mancare a lui, anzi servendosi dell'opera sua là dove aveva molti al suo servigio, potesse e dovesse aiutarlo in quella sua misera vecchiezza. Ma egli si avide con suo danno che gl'umani giudicii, nel promettersi troppo d'altrui, molte volte s'ingannano e che gl'uomini che mutano stato, mutano eziandio il più delle volte natura e volontà. Perciò che arrivato Niccolò a Milano, dove trovò Domenico in tanta grandezza, che durò non picciola fatica a potergli favellare, gli contò tutte le sue miserie, pregandolo appresso che servendosi di lui, volesse aiutarlo. Ma Domenico, non si ricordando, o non volendo ricordarsi con quanta amorevolezza fusse stato da Niccolò allevato, come proprio figliuolo, gli diede la miseria d'una piccola somma di danari e quanto poté prima se lo levò d'intorno. E così tornato Niccolò ad Arezzo mal contento, conobbe che dove pensava aversi con fatica e spesa allevato un figliuolo, si aveva fatto poco meno che un nimico. Per poter dunque sostentarsi andava lavorando ciò che gli veniva alle mani, sì come aveva fatto molti anni innanzi, quando dipinse, oltre molte altre cose, per la comunità di Monte San Sovino, in una tela, la detta terra del monte et in aria una Nostra Donna e dagli lati due Santi. La qual pittura fu messa a uno altare nella Madonna di Vertigli, chiesa dell'Ordine de' monaci di Camaldoli non molto lontana dal Monte, dove al Signore è piaciuto e piace far ogni giorno molti miracoli e grazie a coloro che alla Regina del cielo si raccomandano.
Essendo poi creato sommo pontefice Giulio Terzo, Niccolò, per essere stato molto familiare della casa di Monte, si condusse a Roma vecchio d'ottanta anni, e baciato il piede a Sua Santità, la pregò volesse servirsi di lui nelle fabbriche che si diceva aversi a fare al Monte, il qual luogo avea dato in feudo al Papa il signor duca di Fiorenza. Il Papa adunque, vedutolo volentieri, ordinò che gli fusse dato in Roma da vivere senza affaticarlo in alcuna cosa et a questo modo si trattenne Niccolò alcuni mesi in Roma, disegnando molte cose antiche per suo passatempo. Intanto, deliberando il Papa d'accrescere il Monte San Sovino sua patria e farvi, oltre molti ornamenti, un acquidotto, perché quel luogo patisce molto d'acque, Giorgio Vasari, ch'ebbe ordine dal Papa di far principiar le dette fabbriche, raccomandò molto a Sua Santità Niccolò Soggi, pregando che gli fusse dato cura d'essere soprastante a quell'opere; onde, andato Niccolò ad Arezzo con queste speranze non vi dimorò molti giorni che, stracco dalle fatiche di questo mondo, dagli stenti e dal vedersi abandonato da chi meno dovea farlo, finì il corso della sua vita, et in San Domenico di quella città fu sepolto. Né molto dopo Domenico Giuntalochi, essendo morto don Ferrante Gonzaga, si partì di Milano, con intenzione di tornarsene a Prato, e quivi vivere quietamente il rimanente della sua vita; ma non vi trovando né amici, né parenti e conoscendo che quella stanza non faceva per lui, tardi pentito d'essersi portato ingratamente con Niccolò, tornò in Lombardia a servire i figliuoli di don Ferrante. Ma non passò molto che, infermandosi a morte, fece testamento, e lasciò alla sua comunità di Prato diecimila scudi perché ne comperasse tanti beni e facesse un'entrata, per tenere continuamente in studio un certo numero di scolari pratesi, nella maniera che ella ne teneva e tiene alcun'altri, secondo un altro lascio. E così è stato eseguito dagl'uomini della terra di Prato; come conoscenti di tanto benefizio, che invero è stato grandissimo e degno d'eterna memoria, hanno posta nel loro consiglio, come di benemerito della patria, l'imagine di esso Domenico.
FINE DELLA VITA DI NICCOLÒ SOGGI PITTORE
VITA DI NICCOLÒ DETTO IL TRIBOLO
SCULTORE ET ARCHITETTORE

Raffaello legnaiuolo, soprannominato il Riccio de' Pericoli, il quale abitava appresso al canto a Monteloro in Firenze, avendo avuto l'anno 1500, secondo che egli stesso mi raccontava, un figliuolo maschio, il qual volle che al battesimo fusse chiamato come suo padre Niccolò, deliberò, come che povero compagno fosse, veduto il putto aver l'ingegno pronto e vivace e lo spirito elevato, che la prima cosa egli imparasse a leggere e scrivere bene e far di conto; per che mandandolo alle scuole avvenne, per esser il fanciullo molto vivo et in tutte l'azzioni sue tanto fiero, che non trovando mai luogo, era fra gli altri fanciulli e nella scuola e fuori un diavolo che sempre travagliava e tribolava sé e gli altri, che si perdé il nome di Niccolò e s'acquistò di maniera il nome di Tribolo, che così fu poi sempre chiamato da tutti. Crescendo dunque il Tribolo, il padre, così per servirsene come per rafrenar la vivezza del putto, se lo tirò in bottega insegnandogli il mestiero suo; ma vedutolo in pochi mesi male atto a cotale esercizio, et anzi sparutello, magro e male complessionato che no, andò pensando, per tenerlo vivo, che lasciasse le maggior fatiche di quell'arte e si mettesse a intagliar legnami. Ma perché aveva inteso che senza il disegno, padre di tutte l'arti, non poteva in ciò divenire eccellente maestro, volle che il suo principio fusse impiegar il tempo nel disegno, e perciò gli faceva ritrarre ora cornici, fogliami e grottesche, et ora altre cose necessarie a cotal mestiero. Nel che fare, veduto che al fanciullo serviva l'ingegno e parimente la mano, considerò Raffaello, come persona di giudizio, che egli finalmente appresso di sé poteva altro imparare che lavorare di quadro; onde avutone prima parola con Ciappino legnaiuolo e da lui, che molto era domestico et amico di Nanni Unghero, consigliatone et aiutato, l'acconciò per tre anni col detto Nanni, in bottega del quale, dove si lavorava d'intaglio e di quadro, praticavano del continuo Iacopo Sansovino scultore, Andrea del Sarto pittore et altri, che poi sono stati tanto valentuomini. Ora, perché il Nanni, il quale in que' tempi era assai eccellente reputato, faceva molti lavori di quadro e d'intaglio per la villa di Zanobi Bartolini a Rovezzano, fuor della porta alla Croce e per lo palazzo de' Bartolini, che allora si faceva murare da Giovanni fratello del detto Zanobi in sulla piazza di S. Trinità et in Gualfonda pel giardino e casa del medesimo, il Tribolo, che da Nanni era fatto lavorare senza discrezione, non potendo per la debolezza del corpo quelle fatiche e sempre avendo a maneggiar seghe, pialle et altri ferramenti disonesti, cominciò a sentirsi di mala voglia et a dir al Riccio, che dimandava onde venisse quella indisposizione, che non pensava poter durare con Nanni in quell'arte, e che perciò vedesse di metterlo con Andrea del Sarto, o con Iacopo Sansovini da lui conosciuti in bottega dell'Unghero, perciò che sperava con qual si volesse di loro farla meglio e star più sano.
Per queste cagioni dunque il Riccio, pur col consiglio et aiuto del Ciappino, acconciò il Tribolo con Iacopo Sansovino, che lo prese volentieri per averlo conosciuto in bottega di Nanni Unghero et aver veduto che si portava bene nel disegno e meglio nel rilievo. Faceva Iacopo Sansovino, quando il Tribolo già guarito andò a star seco, nell'opera di Santa Maria del Fiore a concorrenza di Benedetto da Rovezzano, Andrea da Fiesole e Baccio Bandinelli, la statua del Sant'Iacopo Apostolo di marmo, che ancor oggi in quell'Opera si vede insieme con l'altre: per che il Tribolo, con queste occasioni d'imparare, facendo di terra e disegnando con molto studio, andò in modo acquistando in quell'arte, alla quale si vedeva naturalmente inclinato, che Iacopo, amandolo più un giorno che l'altro, cominciò a dargli animo et a tirarlo innanzi col fargli fare ora una cosa et ora un'altra, onde se bene aveva allora in bottega il Solosmeo da Settignano e Pippo del Fabbro, giovani da grande speranza, perché il Tribolo gli passava di gran lunga non pur gli paragonava, avendo aggiunto la pratica de' ferri al saper bene fare di terra e di cera, cominciò in modo a servirsi di lui nelle sue opere che finito l'Apostolo et un Bacco che fece a Giovanni Bartolini per la sua casa di Gualfonda, togliendo a fare per Mes-ser Giovanni Gaddi suo amicissimo un camino et un acquaio di pietra di macigno per le sue case, che sono alla piazza di Madonna, fece fare alcuni putti grandi di terra, che andavano sopra il cornicione, al Tribolo, il quale gli condusse tanto straordinariamente bene, che Messer Giovanni, veduto l'ingegno e la maniera del giovane, gli diede a fare due medaglie di marmo, le quali finite eccellentemente, furono poi collocate sopra alcune porte della medesima casa. Intanto cercandosi d'allogare per lo re di Portogallo una sepoltura di grandissimo lavoro, per essere stato Iacopo discepolo d'Andrea Contucci dal monte San Sovino et avere nome non solo di paragonare il maestro suo, uomo di gran fama, ma d'aver anco più bella maniera, fu cotale lavoro allogato a lui col mezzo de' Bartolini. Là dove, fatto Iacopo un superbissimo modello di legname, pieno tutto di storie e di figure di cera, fatte la maggior parte dal Tribolo, crebbe in modo, essendo riuscite bellissime, la fama del giovane, che Matteo di Lorenzo Strozzi, essendo partito il Tribolo dal Sansovino parendogli oggimai poter far da sé, gli diede a far certi putti di pietra e poco poi, essendogli quelli molto piaciuti, due di marmo, i quali tengono un delfino che vers'acqua in un vivaio, che oggi si vede a San Casciano, luogo lontano da Firenze otto miglia, nella villa del detto Messer Matteo. Mentre che queste opere dal Tribolo si facevano in Firenze, esendoci venuto per sue bisogne Messer Bartolomeo Barbazzi, gentiluomo bolognese, si ricordò che per Bologna si cercava d'un giovane che lavorasse bene, per metterlo a far figure e storie di marmo nella facciata di San Petronio, chiesa principale di quella città, per che ragionato col Tribolo e veduto delle sue opere che gli piacquero e parimenti i costumi e l'altre qualità del giovane, lo condusse a Bologna, dove egli con molta diligenza e con molta sua lode fece in poco tempo le due sibille di marmo, che poi furono poste nell'ornamento della porta di San Petronio che va allo spedale della Morte. Le quali opere finite, trattandosi di dargli a fare cose maggiori, mentre si stava molto amato e carezzato da Messer Bartolomeo, cominciò la peste dell'anno 1525 in Bologna e per tutta la Lombardia, onde il Tribolo, per fuggir la peste se ne venne a Firenze e statoci quanto durò quel male contagioso e pestilenziale, si partì cessato che fu e se ne tornò, essendo là chiamato, a Bologna dove Messer Bartolomeo non gli lasciando metter mano a cosa alcuna per la facciata, si risolvette, essendo morti molti amici suoi e parenti, a far fare una sepoltura per sé e per loro; e così fatto fare il modello, il quale volle vedere Messer Bartolomeo, anzi che altro facesse, compìto, andò il Tribolo stesso a Carrara a far cavar i marmi, per abozzargli in sul luogo e sgravargli, di maniera che non solo fusse (come fu) più agevole al condurgli, ma ancora acciò che le figure riuscissero maggiori.
Nel qual luogo per non perder tempo abozzò due putti grandi di marmo, i quali così imperfetti essendo stati condotti a Bologna per some con tutta l'opera, furono, sopragiugnendo la morte di Messer Bartolomeo, la quale fu di tanto dolor cagione al Tribolo, che se ne tornò in Toscana, messi con gli altri marmi in una cappella di San Petronio, dove ancora sono. Partito dunque il Tribolo da Carrara, nel tornare a Firenze, andando in Pisa a visitar maestro Stagio da Pietra Santa scultore suo amicissimo, che lavorava nell'Opera del Duomo di quella città due colonne con i capitelli di marmo, tutti traforati, che mettendo in mezzo l'altar maggiore et il tabernacolo del Sagramento, doveva ciascuna di loro aver sopra il capitello un Angelo di marmo alto un braccio e tre quarti con un candeliere in mano, tolse, invitato dal detto Stagio, non avendo allora altro che fare, a far uno de' detti Angeli, e quello, finito con tanta perfezzione con quanta si può di marmo finir perfettamente un lavoro sottile e di quella grandezza, riuscì di maniera, che più non si sarebbe potuto desiderare; perciò che mostrando l'Angelo col moto della persona, volando essersi fermo a tener quel lume, ha l'ignudo certi panni sottili intorno, che tornano tanto graziosi e rispondono tanto bene per ogni verso e per tutte le vedute, quanto più non si può esprimere. Ma avendo in farlo consumato il Tribolo, che non pensava se non alla dilettazione dell'arte, molto tempo, e non avendone dall'Operaio avuto quel pagamento che si pensava, risolutosi a non voler fare l'altro e tornato a Firenze, si riscontrò in Giovanbatista della Palla, il quale in quel tempo non pur faceva far più che potea sculture e pitture, per mandar in Francia al re Francesco Primo, ma comperava anticaglie d'ogni sorte e pitture d'ogni ragione, pur che fussino di mano di buon maestri, e giornalmente l'incassava e mandava via. E perché, quando appunto il Tribolo tornò, Giovanbatista aveva un vaso di granito antico di forma bellissima e voleva accompagnarlo, acciò servisse per una fonte di quel re, aperse l'animo suo al Tribolo e quello che dissegnava fare, onde egli messosi giù, gli fece una dea della natura che alzando un braccio tiene con le mani quel vaso che le ha in suo capo il piede, ornata il primo filare del-le poppe d'alcuni putti tutti traforati e spiccati dal marmo, che tenendo nelle mani certi festoni fanno diverse attitudini bellissime; seguitando poi l'altro ordine di poppe piene di quadrupedi et i piedi fra molti e diversi pesci, restò compiuta cotale figura con tanta diligenza e con tanta perfezzione, ch'ella meritò, essendo mandata in Francia con altre cose, es-ser carissima a quel re e d'esser posta come cosa rara a Fontanableò.
L'anno poi 1529, dandosi ordine alla guerra et all'assedio di Firenze, papa Clemente Settimo, per veder in che modo et in quai luoghi si potesse accommodare e spartir l'essercito e vedere il sito della città appunto, avendo ordinato che segretamente fosse levata la pianta di quella città, cioè di fuori a un miglio il paese tutto, con i colli, monti, fiumi, balzi, case, chiese, et altre cose, dentro le piazze e le strade et intorno le mura et i bastioni con l'altre difese, fu di tutto dato il carico a Benvenuto di Lorenzo dalla Volpaia, buon maestro d'oriuoli e quadranti e bonissimo astrologo, ma sopra tutto eccellentissimo maestro di levar piante. Il qual Benvenuto volle in sua compagnia il tribolo e con molto giudizio, perciò che il Tribolo fu quegli che mise inanzi che detta pianta si facesse, a ciò meglio si potesse considerare l'altezza de' monti, la bassezza de' piani e gl'altri particolari, di rilievo: il che far non fu senza molta fatica e pericolo; perché stando fuori tutta la notte a misurar le strade e segnar le misure delle braccia da luogo a luogo e misurar anche l'altezza e le cime de' campanili e delle torri, intersegando con la bussola per tutti i versi et andando di fuori a riscontrar con i monti la cupola, la quale avevano segnato per centro, non condussero così fatt'opera, se non dopo molti mesi, ma con molta diligenza, avendola fatta di sugheri, perché fusse più leggera, e ristretto tutta la machina nello spazio di quattro braccia e misurato ogni cosa a braccia piccole. In questo modo dunque finita quella pianta, essendo di pezzi, fu incassata segretamente et in alcune balle di lana, che andavano a Perugia, cavata di Firenze e consegnata a chi aveva ordine di mandarla al Papa, il quale nell'assedio di Firenze se ne servì continuamente, tenendola nella camera sua e vedendo di mano in mano secondo le lettere e gl'avisi, dove e come alloggiava il campo, dove si facevano scaramuccie et insomma in tutti gl'accidenti, ragionamenti e dispute che occorsono durante quell'assedio, con molta sua sodisfazzione, per esser cosa nel vero rara e maravigliosa.
Finita la guerra, nello spazio della quale il Tribolo fece alcune cose di terra per i suoi amici e per Andrea del Sarto suo amicissimo, tre figure di cera tonde, delle quali esso Andrea si servì nel dipigner in fresco e ritrarre di naturale in piazza presso alla condotta tre capitani che si erano fuggiti con le paghe, apiccati per un piede, chiamato Benvenuto dal Papa, andò a Roma a baciar i piedi a Sua Santità e da lui fu messo a custodia di Belvedere con onorata provisione. Nel qual governo avendo Benvenuto spesso ragionamenti col Papa, non mancò, quando di ciò far gli venne occasione, di celebrare il Tribolo, come scultore eccellente e raccomandarlo caldamente. Di maniera che Clemente, finito l'assedio, se ne servì; per che, disegnando dar fine alla cappella di Nostra Donna da Loreto stata cominciata da Leone e poi tralasciata per la morte d'Andrea Contucci dal Monte a San Sovino, ordinò che Antonio da Sangallo, il quale aveva cura di condurre quella fabbrica, chiamasse il Tribolo, e gli desse a finire di quelle storie che maestro Andrea aveva lasciato imperfette. Chiamato dunque il Tribolo dal Sangallo d'ordine di Clemente, andò con tutta la sua famiglia a Loreto dove, essendo andato similmente Simone nominato il Mosca, rarissimo intagliator di marmi, Raffaello Montelupo, Francesco da Sangallo il Giovane, Girolamo Ferrarese scultore discepolo di maestro Andrea, e Simone Cioli, Ranieri da Pietrasanta e Francesco dal Tadda per dar fine a quell'opera, toccò al Tribolo, nel compartirsi i lavori, come cosa di più importanza, una storia dove maestro Andrea aveva fatto lo sposalizio di Nostra Donna, onde, facendole il Tribolo una giunta, gli venne capriccio di far, fra molte figure che stanno a vedere sposare la Vergine, uno che rompe tutto pieno di sdegno la sua mazza, perché non era fiorita, e gli riuscì tanto bene, che non potrebbe colui con più prontezza mostrar lo sdegno che ha di non aver avuto egli così fatta ventura. La quale opera finita e quelle degli altri ancora con molta perfezzione, aveva il Tribolo già fatto molti modelli di cera per far di quei profeti, che andavano nelle nicchie di quella cappella già murata e finita del tutto, quando papa Clemente, avendo veduto tutte quell'opere e lodatole molto, e particolarmente quella del Tribolo, deliberò che tutti senza perdere tempo tornassino a Firenze, per dar fine, sotto la disciplina di Michelagnolo Buonarroti, a tutte quelle figure che mancavano alla sagrestia e libreria di S. Lorenzo et a tutto il lavoro, secondo i modelli e con l'aiuto di Michelagnolo quanto più presto acciò finita la sagrestia tutti potessero, mediante l'ac-quisto fatto sotto la disciplina di tant'uomo, finir similmente la facciata di San Lorenzo. E perché a ciò fare punto non si tardasse, rimandò il Papa Michelagnolo a Firenze, e con esso lui fra' Giovanni Agnolo de' Servi, il quale aveva lavorato alcune cose in Belvedere, acciò gl'aiutasse a traforar i marmi e facesse alcune statue, secondo che gl'ordinasse esso Michelagnolo, il quale diede a far un San Cosimo che insieme con un San Damiano allogato al Montelupo doveva metter in mezzo la Madonna. Date a far queste, volle Michelagnolo che il Tribolo facesse due statue nude, che avevano a metter in mezzo quella del duca Giuliano che già aveva fatta egli, l'una figurata per la Terra coronata di cipresso che dolente et a capo chino piangesse con le braccia aperte la perdita del duca Giuliano, e l'altra per lo Cielo, che con le braccia elevate tutto ridente e festoso mostrasse esser allegro dell'ornamento e splendore che gli recava l'anima e lo spirito di quel signore. Ma la cattiva sorte del Tribolo se gl'attraversò quando appunto voleva cominciar a lavorare la statua della Terra, perché, o fusse la mutazione dell'aria, o la sua debole complessione, o l'aver disordinato nella vita, s'ammalò di maniera che, convertitasi l'infermità in quartana, se la tenne adosso molti mesi con incredibile dispiacer di sé, che non era men tormentato dal dolor d'aver tralasciato il lavoro e dal vedere che il frate e Raffaello avevano preso campo, che dal male stesso; il quale male volendo egli vincer per non rimaner dietro agl'emuli suoi, de' quali sentiva far ogni giorno più celebre il nome, così indisposto fece di terra il modello grande della statua della Terra, e finitolo, cominciò a lavorare il marmo con tanta diligenza e sollecitudine, che già si vedeva scoperta tutta la banda dinanzi la statua, quando la fortuna, che a' bei principii sempre volentieri contrasta, con la morte di Clemente, allora che meno si temeva, troncò l'animo a tanti eccellenti uomini che speravano sotto Michelagnolo con utilità grandissime acquistarsi nome immortale e perpetua fama. Per questo accidente, stordito il Tribolo e tutto perduto d'animo essendo anche malato, stava di malissima voglia non vedendo né in Firenze né fuori poter dare in cosa che per lui fosse; ma Giorgio Vasari, che fu sempre suo amico e l'amò di cuor et aiutò quanto gli fu possibile, lo confortò con dirgli che non si smarisse, perché farebbe in modo che il duca Alessandro gli darebbe che fare, mediante il favore del Magnifico Ottaviano de' Medici, col quale gli aveva fatto pigliar assai stretta servitù; onde egli ripreso un poco d'animo, ritrasse di terra nella sagrestia di San Lorenzo, mentre s'andava pensando al bisogno suo, tutte le figure che aveva fatto Michelagnolo di marmo, cioè l'Aurora, il Crepuscolo, il Giorno e la Notte, e gli riusciron così ben fatte, che monsignor Giovan Batista Figiovanni priore di San Lorenzo, al quale donò la Notte perché gli faceva aprir la sagrestia, giudicandola cosa rara, la donò al duca Alessandro, che poi la diede al detto Giorgio, che stava con sua eccellenza, sapendo che egli attendeva a cotali studi; la qual figura è oggi in Arezzo nelle sue case, con altre cose dell'arte.
Avendo poi il Tribolo ritratto di terra parimente la Nostra Donna fatta da Michelagnolo per la medesima sagrestia, la donò al detto Magnifico Ottaviano de' Medici, il quale le fece fare da Batista del Cinque un ornamento bellissimo di quadro, con colonne, mensole, cornici et altri intagli molto ben fatti. Intanto col favore di lui che era depositario di sua eccellenza, fu dato da Bertoldo Casini, proveditor della fortezza che si murava allora, delle tre arme che secondo l'ordi-ne del Duca s'avevano a far, per metterne una a ciascun baluardo, a farne una di quattro braccia al Tribolo con due figure nude, figurate per due vettorie, la qual arme, condotta con prestezza e diligenza grande e con una giunta di tre mascheroni che sostengono l'arme e le figure, piacque tanto al Duca, che pose al Tribolo amore grandissimo: per che, essendo poco appresso andato a Napoli il Duca per difendersi, innanzi a Carlo Quinto imperatore tornato allora da Tunisi, da molte calunnie dategli da alcuni suoi cittadini, et essendosi non pur difeso, ma avendo ottenuto da Sua Maestà per donna la signora Margherita d'Austria sua figliuola, scrisse a Firenze che si ordinassero quattro uomini, i quali per tutta la città facessero far ornamenti magnifici e grandissimi per ricever con magnificenza conveniente l'imperatore che veniva a Firenze. Onde avendo io a distribuir i lavori di commissione di sua eccellenza che ordinò che io intervenissi con i detti quattro uomini, che furono Giovanni Corsi, Luigi Guicciardini, Palla Rucellai et Alessandro Corsini, diedi a fare al Tribolo le maggiori e più difficili imprese di quella festa, e furono quattro statue grandi: la prima un Ercole in atto d'aver occiso l'Idra, alto sei braccia e tutto tondo et inargentato, in quale fu posto in quell'angolo della piazza di San Felice, che è nella fine di via Maggio, con questo motto di lettere d'argento nel basamento: “Ut Hercules labore et aerumnis monstra edomuit, ita Caesar virtute et clementia, hostibus victis seu placatis, pacem orbi terrarum et quietem restituit”. L'altre furono due colossi d'otto braccia, l'uno figurato per lo fiume Bagrada che si posava su la soglia di quel serpente, che fu portato a Roma, e l'altro per l'Ibero con il corno d'Amaltea in una mano e con un timone nell'altra, coloriti come se fussero stati di bronzo, con queste parole ne' basamenti, cioè sotto l'Ibero: “Hiberus ex Hispania”, e sotto l'al-tro: “Bagradas ex Africa”. La quarta fu una statua di braccia cinque, in sul canto de' Medici, figurata per la Pace, la quale aveva in una mano un ramo d'oliva e nell'altra una face accesa, che metteva fuoco in un monte d'arme poste in sul basamento dov'ell'era collocata, con queste parole: “Fiat pax in virtute tua”. Non dette il fine che aveva disegnato al cavallo di sette braccia lungo, che si fece in sulla piazza di S. Trinita, sopra la quale aveva a essere la statua dell'impe-ratore armato, perché, non avendo il Tasso intagliator di legname, suo amicissimo, usato prestezza nel fare il basamento e l'altre cose, che vi andavano di legni intagliati, come quello che si lasciava fuggire di mano il tempo ragionando e burlando, a fatica si fu a tempo a coprire di stagnuolo, sopra la terra ancor fresca, il cavallo solo, nel cui basamento si leggevano queste parole: “Imperatori Carolo Augusto, victoriosissimo, post devictos hostes, Italiae pace restituta et salutato Ferdinando frate, expulsis iterum Turcis, Africaque perdomita, Alexander Medici dux Florentiae dedicavit”.
Partita sua maestà di Firenze, si diede principio, aspettandosi la figliuola, al preparamento delle nozze, e perché potesse alloggiare ella e la veceregina di Napoli che era in sua compagnia, secondo l'ordine di sua eccellenza, in casa Messer Ottaviano de' Medici comodamente, fatta in quattro settimane con stupore d'ognuno una giunta alle sue case vecchie, il Tribolo, Andrea di Cosimo pittore et io, in dieci dì con l'aiuto di circa novanta scultori e pittori della città fra garzoni e maestri, demmo compimento, quanto alla casa et ornamenti di quella, all'apparecchio delle nozze dipignendo le logge, i cortili e gl'altri ricetti di quella, secondo che a tante nozze conveniva. Nel quale ornamento fece il Tribolo, oltre all'altre cose, intorno alla porta principale due vittorie di mezzo rilievo, sostenute da due termini grandi, le quali reggevano un'arme dell'imperator, pendente dal collo d'un'aquila tutta tonda molto bella. Fece ancora il medesimo certi putti, pur tutti tondi e grandi, che sopra i frontespizii d'alcune porte mettevano in mezzo certe teste, che furono molto lodati. Intanto ebbe lettere il Tribolo da Bologna mentre si facevano le nozze, per le quali Messer Pietro del Magno, suo grande amico, lo pregava fusse contento andare a Bologna a far alla Madonna di Galina, dove era già fatto un ornamento bellissimo di marmo, una storia di braccia tre e mezzo pur di marmo, perché il Tribolo non si trovando aver allora altro che far, andò, e fatto il modello d'una Madonna che saglie in cielo, e sotto i dodici Apostoli in varie attitudini, che piacque essendo bellissima, mise mano a lavorare, ma con poca sua sodisfazione perché, essendo il marmo che lavorava di quelli di Milano, saligno, smeriglioso e cattivo, gli pareva gettar via il tempo, senza una dilettazione al mondo di quelle che si hanno nel lavorare, i quali si lavorano con piacere et in ultimo condotti mostrano una pelle che par propriamente di carne. Pur tanto fece, ch'ell'era già quasi che finita quando io, avendo disposto il duca Alessandro a far tornar Michelagnolo da Roma e gl'altri per finire l'opera della sagrestia cominciata da Clemente, dissegnava dargli che fare a Firenze e mi sarebbe riuscito, ma in quel mentre sopravenendo la morte d'Alessandro che fu amazzato da Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, rimase impedito non pure questo disegno, ma disperata del tutto la felicità e la grandezza dell'arte.
Intesa adunque il Tribolo la morte del Duca, se ne dolse meco per sue lettere, pregandomi, poi che m'ebbe confortato a portar in pace la morte di tanto principe, mio amorevole signore, che se io andava a Roma, com'egli aveva inteso che io voleva far in tutto deliberato di lasciare le corti e seguitar i miei studii, che io gli recassi di qualche partito, perciò che avendo miei amici, farebbe quanto io gl'ordinassi. Ma venne caso che non gli bisognò altramente cercar partito in Roma, perché, essendo creato duca di Fiorenza il signor Cosimo de' Medici, uscito che [fu] egli de' travagli che ebbe il primo anno del suo principato, per aver rotti i nimici a Monte Murlo, cominciò a pigliarsi qualche passo, e particolarmente a frequentare assai la villa di Castello, vicina a Firenze poco più di due miglia, dove cominciando a murare qualche cosa, per potervi star commodamente con la corte, a poco a poco, essendo a ciò riscaldato da maestro Piero da San Casciano, tenuto in que' tempi assai buon maestro e molto servitore della signora Maria madre del Duca, e stato sempre muratore di casa et antico servitore del signor Giovanni, si risolvette di condurre in quel luogo certe acque, che molto prima aveva avuto disiderio di condurvi, onde dato principio a far un condotto che ricevesse tutte l'acque del poggio della Castellina, luogo lontano a Castello un quarto di miglio o più, si seguitava con buon numero d'uomini il lavoro gagliardamente. Ma conoscendo il Duca che maestro Piero non aveva né invenzione, né disegno bastante a far un principio in quel luogo che potesse poi col tempo ricevere quell'ornamento, che il sito e l'acque richiedevano, un dì che sua eccellenza era in sul luogo e parlava di ciò con alcuni, Messer Ottaviano de' Medici e Cristofano Rinieri, amico del Tribolo e servitore vecchio della signora Maria e del Duca, celebrarono di maniera il Tribolo per uomo dotato di tutte quelle parti, che al capo d'una così fatta fabrica si richiedevano, che il Duca diede commessione a Cristofano che lo facesse venir da Bologna, il che avendo il Ranieri fatto tostamente, il Tribolo, che non poteva aver miglior nuova che d'aver a servire il duca Cosimo, se ne venne subito a Firenze; et arivato, fu condotto a Castello, dove sua eccellenza illustrissima avendo inteso da lui quello che gli pareva da far per ornamento di quelle fonti, diedegli commessione che facesse i modelli. Per che a quelli messo mano s'andava con essi trattenendo, mentre maestro Piero da San Casciano faceva l'acquidotto e conducea l'acque, quando il Duca, che intanto aveva cominciato per sicurtà della città a cingere in sul poggio di S. Miniato con un fortissimo muro i bastioni fatti al tempo dell'assedio col disegno di Michelagnolo, ordinò che il Tribolo facesse un'arme di pietra forte con due vettorie per l'angolo del puntone d'un baluardo che volta verso Firenze. Ma avendo affatica il Tribolo finita l'arme, che era grandissima et una di quelle vittorie alta quattro braccia che fu tenuta cosa bellissima, gli bisognò lasciare quell'opera imperfetta, perciò che avendo maestro Piero tirato molto innanzi il condotto e l'acque con piena sodisfazione del Duca, volle sua eccellenza che il Tribolo cominciasse a mettere in opera per ornamento di quel luogo i disegni et i modelli che già gl'aveva fatto veder, ordinandogli per allora otto scudi il mese di provisione, come anco aveva il San Casciano. Ma per non mi confondere nel dir gl'intrigamenti degl'acqui-dotti e gl'ornamenti delle fonti fia bene dir brevemente alcune poche cose del luogo e sito di Castello.
La villa di Castello, posta alle radici di monte Morello sotto la villa della Topaia, che è a mezza la costa, ha dinanzi un piano che scende a poco a poco per spazio d'un miglio e mezzo fino al fiume Arno, e là apunto dove comincia la salita del monte è posto il palazzo, che già fu murato da Pierfrancesco de' Medici con molto disegno: perché avendo la faccia principale diritta a mezzo giorno riguardante un grandissimo prato con due grandissimi vivai pieni d'acqua viva, che viene da uno acquidotto antico fatto da' Romani per condurre acque da Val di Marina a Firenze, dove sotto le volte ha il suo bottino, ha bellissima e molto dilettevole veduta. I vivai dinanzi sono spartiti nel mezzo da un ponte dodici braccia largo che camina a un viale della medesima larghezza, coperto dagli lati e di sopra nella sua altezza di dieci braccia, da una continua volta di mori, che caminando sopra il detto viale lungo braccia trecento, con piacevolissima ombra conduce alla strada maestra di Prato, per una porta posta in mezzo di due fontane che servono ai viandanti e a dar bere alle bestie. Dalla banda di verso levante, ha il medesimo palazzo una muraglia bellissima di stalle, e di verso ponente un giardino secreto al quale si camina dal cortile delle stalle, passando per lo piano del palazzo e per mezzo le logge, sale e camere terrene dirittamente. Dal qual giardin secreto, per una porta alla banda di ponente, si ha l'entrata in un altro giardino grandissimo, tutto pieno di frutti e terminato da un salvatico d'abeti, che cuopre le case de' lavoratori e degl'altri che lì stanno per servigio del palazzo e degl'orti. La parte poi del palazzo che volta verso il monte a tramontana, ha dinanzi un prato tanto lungo quanto sono tutti insieme il palazzo, le stalle et il giardino secreto, e da questo prato si saglie per gradi al giardino principale cinto di mura ordinarie, il quale acquistando con dolcezza la salita si discosta tanto dal palazzo alzandosi, che il sole di mezzo giorno lo scuopre e scalda tutto, come se non avesse il palazzo innanzi. E nell'estremità rimane tant'alto, che non solamente vede tutto il palazzo, ma il piano che è dinanzi e d'intorno et alla città parimente. E nel mezzo di questo giardino un salvatico d'altissimi e folti cipressi, lauri e mortelle, i quali girando in tondo fanno la forma d'un laberinto circondato di bossoli, alti due braccia e mezzo e tanto pari e con bell'ordine condotti, che paiono fatti col pennello. Nel mezzo del quale laberinto, come volle il Duca e come di sotto si dirà, fece il Tribolo una molto bella fontana di marmo. Nell'entrata principale, dove è il primo prato con i due vivai et il viale coperto di gelsi, voleva il Tribolo che tanto si accrescesse esso viale, che per ispazio di più d'un miglio col medesimo ordine e coperta andasse infino al fiume Arno e che l'acque che avanzavano a tutte le fonti, correndo lentamente dalle bande del viale in piacevoli canaletti, l'accompagnassero infino al detto fiume, pieni di diverse sorti di pesci e gamberi. Al palazzo (per dir così quello che si ha da fare, come quello che è fatto) voleva fare una loggia innanzi, la quale passando un cortile scoperto avesse dalla parte dove sono le stalle altre tanto palazzo quanto il vecchio e con la medesima proporzione di stanze, logge, giardin secreto et alto. Il quale accrescimento arebbe fatto quello essere un grandissimo palazzo et una bellissima facciata. Passato il cortile dove si entra nel giardin grande del laberinto, nella prima entrata dove è un grandissimo prato, saliti i gradi che vanno al detto laberinto, veniva un quadro di braccia trenta, per ogni verso in piano, in sul quale aveva a essere, come poi è stata fatta, una fonte grandissima di marmi bianchi, che schizzasse in alto sopra gl'ornamenti alti quattordici braccia, e che in cima, per bocca d'una statua, uscisse acqua che andasse alto sei braccia. Nelle teste del prato avevano a essere due logge, una dirimpetto all'altra e ciascuna lunga braccia trenta e larga quindici. E nel mezzo di ciascuna loggia andava una tavola di marmo di braccia dodici e fuori un pilo di braccia otto, che aveva a ricevere l'acqua da un vaso tenuto da due figure. Nel mezzo del laberinto già detto aveva pensato il Tribolo di fare lo sforzo dell'ornamento dell'acqua, con zampilli e con un sedere molto bello intorno alla fonte, la cui tazza di marmo, come poi fu fatta, aveva a essere molto minore che la prima della fonte maggiore e principale. E questa in cima aveva ad avere una figura di bronzo che gettasse acqua. Alla fine di questo giardino aveva a essere nel mezzo una porta, in mezzo a certi putti di marmo che gettassino acqua, da ogni banda una fonte e ne' cantoni nicchie doppie dentro alle qual andavano statue, sì come nell'altre che sono nei muri dalle bande, nei riscontri de' viali che traversano il giardino, i quali tutti sono coperti di verzure in varii spartimenti. Per la detta porta, che è in cima a questo giardino sopra alcune scale, si entra in un altro giardino largo quanto il primo, ma a dirittura non molto lungo rispetto al monte. Et in questo avevano a essere dagli lati due altre logge, e nel muro dirimpetto alla porta, che sostiene la terra del monte, aveva a essere nel mezzo una grotta con tre pile, nella quale piovesse artifiziosamente acqua. E la grotta aveva a essere in mezzo a due fontane, nel medesimo muro collocate e dirimpetto a queste due nel muro del giardino ne avevano a essere due altre, le quali mettessono in mezzo la detta porta. Onde tante sarebbono state le fonti di questo giardino quanto quelle dell'altro che gl'è sotto e che da questo, il quale è più alto, riceve l'acque. E questo giardino aveva a essere tutto pieno d'aranci, che vi arebbono avuto et averanno quanto che sia commodo luogo per essere dalle mura e dal monte difeso dalla tramontana et altri venti contrarii. Da questo si saglie, per due scale di selice, una da ciascuna banda, a un salvatico di cipressi, abeti, lecci et allori et altre verzure perpetue con bell'ordine compartite; in mezzo alle quali doveva essere, secondo il disegno del Tribolo, come poi si è fatto, un vivaio bellissimo. E perché questa parte, strignendosi a poco a poco, fa un angolo perché fusse ottuso, l'aveva a spuntare la larghezza d'una loggia, che salendo parecchi scaglioni scopriva nel mezzo il palazzo, i giardini, le fonti e tutto il piano di sotto et intorno, insino alla ducale villa del Poggio a Caiano, Fiorenza, Prato, Siena e ciò che vi è all'intorno a molte miglia.
Avendo dunque il già detto maestro Piero da San Casciano condotta l'opera sua dell'acquidotto infino a Castello e messovi dentro tutte l'acque della Castellina, sopraggiunto da una grandissima febbre in pochi giorni si morì. Per che il Tribolo, preso l'assunto di guidare tutta quella muraglia da sé, s'avvedde, ancor che fussero in gran copia l'acque state condotte, che nondimeno erano poche a quello che egli si era messo in animo di fare: senza che quella, che veniva dalla Castellina, non saliva a tanta altezza quanto era quella di che aveva di bisogno. Avuto adunque dal signor Duca commessione di condurvi quelle della Pretaia, che è cavalier a Castello più di centocinquanta braccia e sono in gran copia e buone, fece fare un condotto simile all'altro e tanto alto, che vi si può andar dentro, acciò per quello le dette acque della Pretaia venissero al vivaio per un altro acquidotto che avesse la caduta dell'acqua del vivaio e della fonte maggiore. E ciò fatto cominciò il Tribolo a murare la detta grotta, per farla con tre nicchie e con bel disegno d'architettura, e così le due fontane che la mettevano in mezzo; in una delle quali aveva a essere una gran statua di pietra per lo monte Asinaio, la quale spremendosi la barba versasse acqua per bocca in un pilo che aveva ad avere dinanzi. Del qual pilo uscendo l'acqua, per via occulta doveva passare il muro et andare alla fonte che oggi è dietro, finita [la salita] del giardino del laberinto, entrando nel vaso che ha in sulla spalla il fiume Mugnone, il quale è in una nicchia grande di pietra bigia con bellissimi ornamenti e coperta tutta di spugna. La quale opera se fusse stata finita in tutto come è in parte, arebbe avuto somiglianza col vero, nascendo Mugnone nel monte Asinaio; fece dunque il Tribolo per esso Mugnone, per dire quello che è fatto, una figura di pietra bigia lunga quattro braccia e raccolta in bellissima attitudine, la quale ha sopra la spalla un vaso che versa acqua in un pilo e l'altra posa in terra, appoggiandovisi sopra, avendo la gamba manca a cavallo sopra la ritta. E dietro a questo fiume è una femina figurata per Fiesole, la quale tutta ignuda nel mezzo della nicchia esce fra le spugne di que' sassi, tenendo in mano una luna, che è l'antica insegna de' Fiesolani. Sotto questa nicchia è un grandissimo pilo sostenuto da due capricorni grandi, che sono una dell'imprese del Duca, dai quali capricorni pendono alcuni festoni e maschere bellissime, e dalle labra esce l'acqua del detto pilo, che essendo colmo nel mezzo e sboccato dalle bande, viene tutta quella che sopravanza a versarsi dai detti lati, per le bocche de' capricorni et a caminar, poi che è cascato in sul basamento cavo del pilo, per gl'orticini che sono intorno alle mura del giardino del laberinto, dove sono fra nicchia e nicchia fonti, e fra le fonti spalliere di melaranci e melagrani.
Nel secondo sopra detto giardino, dove avea disegnato il Tribolo che si facesse il monte Asinaio, che aveva a dar l'acqua al detto Mugnone, aveva a essere dall'altra banda, passata la porta, il monte della Falterona in somigliante figura. E sì come da questo monte ha origine il fiume Arno, così la statua figurata per esso nel giardino del laberinto, dirimpetto a Mugnone, aveva a ricevere l'acqua della detta Falterona. Ma perché la figura di detto monte, né la sua fonte ha mai avuto il suo fine, parleremo della fonte e del fiume Arno, che dal Tribolo fu condotto a perfezzione. E dunque questo fiume [ha] il suo vaso sopra una coscia et appoggiasi con un braccio, stando a giacere, sopra un leone che tiene un giglio in mano, e l'acqua riceve il vaso dal muro forato, dietro al quale aveva a essere la Falterona, nella maniera a punto che si è detto ricevere la sua la statua del fiume Mugnone. E perché il pilo lungo è in tutto simile a quello di Mugnone non dirò altro se non che è un peccato che la bontà et eccellenza di queste opere non siano di marmo, essendo veramente bellissime. Seguitando poi il Tribolo l'opera del condotto, fece venire l'acqua della grotta, che passando sotto il giardino degl'aranci e poi l'altro, la condusse al laberinto e quivi preso in giro tutto il mezzo del laberinto, cioè il centro in buona larghezza, ordinò la canna del mezzo per la quale aveva a gettare acqua la fonte. Poi prese l'acque d'Arno e Mugnone, e ragunatele insieme sotto il piano del laberinto, con certe canne di bronzo che erano sparse per quel piano con bell'ordine, empié tutto quel pavimento di sottilissimi zampilli, di maniera che volgendosi una chiave si bagnano tutti coloro che s'accostano per vedere la fonte. E non si può agevolmente, né così tosto fuggire, perché fece il Tribolo intorno alla fonte et al lastricato, nel quale sono i zampilli, un sedere di pietra bigia, sostenuto da branche di leone, tramezzate da mostri marini di basso rilievo. Il che fare fu cosa difficile, perché volle, poiché il luogo è in ispiaggia e sta la squadra a pendio, di quello far piano e de' sederi il medesimo. Messa poi mano alla fonte di questo laberinto, le fece nel piede di marmo uno intrecciamento di mostri marini tutti tondi straforati, con alcune code aviluppate insieme così bene, che in quel genere non si può far meglio. E ciò fatto, condusse la tazza d'un marmo stato condotto molto prima a Castello, insieme con una gran tavola pur di marmo, dalla villa dell'Antella, che già comperò Messer Ottaviano de' Medici da Giuliano Salviati. Fece dunque il Tribolo per questa commodità prima che non arebbe per aventura fatto, la detta tazza, facendole intorno un ballo di puttini posti nella gola, che è appresso al labbro della tazza, i quali tengono certi festoni di cose marine traforati nel marmo con bell'artefizio. E così il piede, che fece sopra la tazza, condusse con molta grazia e con certi putti e maschere, per gettare acqua, bellissimi. Sopra il quale piede era d'animo il Tribolo che si ponesse una statua di bronzo, alta tre braccia, figurata per una Fiorenza, a dimostrare che dai detti monti Asinaia e Falterona vengono l'acque d'Arno e Mugnone a Fiorenza. Della quale figura aveva fatto un bellissimo modello, che spremendosi con le mani i capelli, ne faceva uscir acqua. Condotta poi l'acqua sul primo delle trenta braccia sotto il laberinto, diede principio alla fonte grande, che avendo otto facce, aveva a ricevere tutte le sopra dette acque nel primo bagno, cioè quelle dell'acque del laberinto e quelle parimente del condotto maggiore. Ciascuna dunque dell'otto facce saglie un grado alti un quinto, et ogni angolo dell'otto facce ha un risalto, come anco avea le scale che risaltando salgono ad ogni angolo scaglione di due quinti. Talché ripercuote la faccia del mezzo delle scale nei risalti, e vi muore il bastone, che è cosa bizzarra a vedere e molto commoda a salire. Le sponde della fonte hanno garbo di vaso et il corpo della fonte, cioè dentro dove sta l'acqua, gira intorno. Comincia il piede in otto facce, e seguita con otto sederi fin presso al bottone della tazza, sopra il quale seggono otto putti in varie attitudini e tutti tondi e grandi quanto il vivo, et incatenandosi con le braccia e con le gambe insieme fanno bellissimo vedere e ricco ornamento. E perché l'aggetto della tazza, che è tonda, ha di diametro sei braccia, traboccando del pari l'acque di tutta la fonte, versa intorno intorno una bellissima pioggia a uso di grondaia nel detto vaso a otto facce, onde i detti putti, che sono in sul piede della tazza, non si bagnano, e pare che mostrino con molta vaghezza quasi fanciullescamente essersi là entro per non bagnarsi scherzando ritirati intorno al labro della tazza, la quale nella sua semplicità non si può di bellezza paragonare. Sono dirimpetto ai quattro lati della crocera del giardino, quattro putti di bronzo a giacere scherzando in varie attitudini, i quali se bene sono poi stati fatti da altri, sono secondo il disegno del Tribolo. Comincia sopra questa tazza un altro piede, che ha nel suo principio, sopra alcuni risalti, quattro putti tondi di marmo, che stringono il collo a certe oche che versono acqua per bocca. E quest'ac-qua è quella del condotto principale che viene dal laberinto, la quale a punto saglie a questa altezza. Sopra questi putti è il resto del fuso di questo piede, il quale è fatto con certe cartelle che colono acqua con strana bizzarria e ripigliando forma quadra sta sopra certe maschere molto ben fatte. Sopra poi è un'altra tazza minore nella crocera della quale, al labbro, stanno appiccate con le corna quattro teste di capricorno in quadro, le quali gettono per bocca acqua nella tazza grande, insieme con i putti, per far la pioggia, che cade come si è detto nel primo ricetto, che ha le sponde a otto facce. Seguita più alto un altro fuso adorno con altri ornamenti e con certi putti di mezzo rilievo, che risaltando fanno un largo in cima tondo, che serve per basa della figura d'un Ercole che fa scoppiare Anteo, la quale secondo il segno del Tribolo è poi stata fatta da altri, come si dirà a suo luogo. Dalla bocca del quale Anteo, in cambio dello spirito, disegnò che dovesse uscire, et esce, per una canna acqua in gran copia, la quale acqua è quella del condotto grande della Pretaia, che vien gagliarda e saglie dal piano, dove sono le scale, braccia sedici, e ricascando nella tazza maggiore fa un vedere maraviglioso. In questo acquidotto medesimo vengono adunque non solo le dette acque della Pretaia, ma ancor quelle che vanno al vivaio et alla grotta, e queste, unite con quelle della Castellina, vanno alle fonti della Falterona e di Monte Asinaio e quindi a quelle d'Arno e Mugnone come si è detto e di poi, riunite alla fonte del laberinto, vanno al mezzo della fonte grande, dove sono i putti con l'oche. Di qui poi arebbono a ire, secondo il disegno del Tribolo, per due condotti ciascuno da per sé ne' pili delle logge et alle tavole e poi ciascuna al suo orto segreto. Il primo de' quali orti, verso ponente, è tutto pieno d'erbe straordinarie e medicinali, onde al sommo di quest'acqua, nel detto giardino di semplici, nel nicchio della fontana dietro a un pilo di marmo, arebbe a essere una statua d'Esculapio. Fu dunque la sopra detta fonte maggiore tutta finita di marmo dal Tribolo e ridotta a quella estrema perfezzione, che si può in opera di questa sorte disiderare migliore. Onde credo che si possa dire con verità ch'ella sia la più bella fonte e la più ricca, proporzionata e vaga che sia stata fatta mai. Perciò che nelle figure, nei vasi, nelle tazze et insomma per tutto, si vede usata diligenza et industria straordinaria. Poi il Tribolo, fatto il modello della detta statua d'Esculapio, cominciò a lavorare il marmo, ma impedito da altre cose lasciò imperfetta quella figura, che poi fu finita da Antonio di Gino, scultore e suo discepolo. Dalla banda di verso levante, in un pratello fuor del giardino, acconciò il Tribolo una quercia molto artifiziosamente, perciò che, oltre che è in modo coperta di sopra e d'intorno d'ellera intrecciata fra i rami, che pare un foltissimo boschetto, vi si saglie con una commoda scala di legno similmente coperta, in cima della quale nel mezzo della quercia è una stanza quadra con sederi intorno e con appoggiatoi di spalliere tutte di verzura viva, e nel mezzo una tavoletta di marmo, con un vaso di mischio nel mezzo. Nel quale, per una canna viene e schizza a l'aria molta acqua e per un'altra la caduta si parte, le quali canne vengono su per lo piede della quercia in modo coperte dall'ellera, che non si veggiono punto. E l'acqua si dà e toglie quando altri vuole col volgere di certe chiavi, né si può dire a pieno per quante vie si volge la detta acqua della quercia, con diversi instrumenti di rame per bagnare chi altri vuole, oltre che, con i medesimi instrumenti, se le fa fare diversi rumori e zuffolamenti.
Finalmente tutte queste acque, dopo aver servito a tante e diverse fonti et ufficii, ragunate insieme se ne vanno ai due vivai, che sono fuor del palazzo al principio del viale, e quindi ad altri bisogni della villa. Né lascerò di dire qual fusse l'animo del Tribolo intorno agl'ornamenti di statue che avevano a essere nel giardin grande del laberinto, nelle nicchie che si veggiono ordinariamente compartite nei vani. Voleva dunque, et a così fare l'aveva giudiziosamente consigliato Messer Benedetto Varchi, stato ne' tempi nostri poeta, oratore e filosofo eccellentissimo, che nelle teste di sopra e di sotto andassino i quattro tempi dell'anno, cioè primavera, state, autunno e verno, e che ciascuno fusse situato in quel luogo dove più si truova la stagion sua. All'entrata in sulla man ritta a canto al verno, in quella parte del muro che si distende all'insù, dovevano andare sei figure, le quali denotassino e mostrassero la grandezza e la bontà della casa de' Medici, e che tutte le virtù si truovono nel duca Cosimo, e queste erano la Iustizia, la Pietà, il Valore, la Nobiltà, la Sapienza e la Liberalità, le quali sono sempre state nella casa de' Medici et oggi sono tutte nell'eccellentissimo signor Duca, per essere giusto, valoroso, nobile, savio e liberale. E perché queste parti hanno fatto e fanno essere nella città di Firenze Leggi, Pace, Armi, Scienze, Sapienza, Lingue et Arti, e perché il detto signor Duca è giusto con le leggi, pietoso con la pace, valoroso per l'armi, nobile per le scienze, savio per introdurre le lingue e virtù e liberale nell'arti, voleva il Tribolo che all'incontro della Iustizia, Pietà, Valore, Nobiltà, Sapienza e Liberalità, furono quest'altre in sulla man manca, come si vedrà qui di sotto, cioè: Leggi, Pace, Arme, Scienze, Lingue et Arti. E tornava molto bene che in questa maniera le dette statue e simulacri fussero, come sarebbono stati, in su Arno e Mugnone a dimostrare che onorono Fiorenza. Andavano anco pensando di mettere in sui frontespizii, cioè in ciascuno, una testa d'alcun ritratto d'uomini della casa de' Medici, come dire: sopra la Iustizia il ritratto di sua eccellenza, per essere quella sua peculiare; alla Pietà il Magnifico Giuliano; al Valore il signor Giovanni; alla Nobiltà Lorenzo Vecchio; alla Sapienza Cosimo Vecchio o vero Clemente VII; alla Liberalità papa Leone, e ne' frontespizii di rincontro dicevano che si sarebbono potute mettere altre teste di casa Medici, o persone della città, da quella dependenti. Ma perché questi nomi fanno la cosa alquanto intrigata, si sono qui appresso messe con quest'ordine:
| STATE. | MUGNONE. | PORTA. | ARNO. | PRIMAVERA. |
| ARTI. | | LIBERALITÀ | |
| LINGUE. | | SAPIENZA. | |
| SCIENZE. | | NOBILTÀ | |
| ARMI. | | VALORE | |
| PACE. | | PIETÀ | |
LEGGI.
IUSTIZIA.
LOGGIA.
LOGGIA.
AUTUNNO. PORTA. LOGGIA. PORTA. VERNO.
I quali tutti ornamenti nel vero arebbono fatto questo il più ricco, il più magnifico et il più ornato giardino d'Europa, ma non furono le dette cose condotte a fine, perciò che il Tribolo, sin che il signor Duca era in quella voglia di fare, non seppe pigliar modo di far che si conducessino alla loro perfezzione, come arebbe potuto fare in breve, avendo uomini et il Duca che spendeva volentieri, non avendo di quegli impedimenti che ebbe poi col tempo. Anzi non si contentando allora sua eccellenza di sì gran copia d'acqua, quanta è quella che vi si vede, disegnava che s'andasse a trovare l'acqua di Valcenni, che è grossissima, per metterle tutte insieme, e da Castello, con uno acquidotto simile a quello che aveva fatto, condurle a Fiorenza in sulla piazza del suo palazzo. E nel vero se quest'opera fusse stata riscaldata da uomo più vivo e più disideroso di gloria, si sarebbe per lo meno tirata molto inanzi. Ma perché il Tribolo (oltre che era molto occupato in diversi negozii del Duca) era non molto vivo, non se ne fece altro. Et in tanto tempo che lavorò a Castello non condusse di sua mano altro che le due fonti con que' due fiumi, Arno e Mugnone, e la statua di Fiesole, nascendo ciò non da altro, per quello che si vede, che da essere troppo occupato come si è detto in molti negozii del Duca. Il quale fra l'altre cose gli fece fare fuor della porta a San Gallo, sopra il fiume Mugnone, un ponte in sulla strada maestra che va a Bologna. Il qual ponte, perché il fiume attraversa la strada in isbieco, fece fare il Tribolo, sbiecando anch'egli l'ar-co, secondo che sbiecamente imboccava il fiume, che fu cosa nuova e molto lodata, facendo massimamente congiungere l'arco di pietra sbiecato, in modo da tutte le bande che riuscì forte et ha molta grazia, et insomma questo ponte fu una molto bell'opera.
Non molto inanzi, essendo venuta voglia al Duca di fare la sepoltura del signor Giovanni de' Medici suo padre, e disiderando il Tribolo di farla, ne fece un bellissimo modello a concorrenza d'uno che n'avea fatto Raffaello da Monte Lupo, favorito da Francesco di Sandro, maestro di maneggiare arme appresso a sua eccellenza. E così essendo risoluto il Duca che si mettesse in opera quello del Tribolo, egli se n'andò a Carrara a fare cavare i marmi, dove cavò anco i due pili per le logge di Castello, una tavola e molti altri marmi.
Intanto essendo Messer Giovan Battista da Ricasoli, oggi vescovo di Pistoia, a Roma per negozii del signor Duca, fu trovato da Baccio Bandinelli, che aveva apunto finito nella Minerva le sepolture di papa Leone Decimo e Clemente Settimo, e richiesto di favore appresso sua eccellenza; per che, avendo esso Messer Giovanbatista scritto al Duca che il Bandinello disiderava servirlo, gli fu rescritto da sua eccellenza che nel ritorno lo menasse seco. Arivato adunque il Bandinello a Fiorenza, fu tanto intorno al Duca con l'audacia sua, con promesse e mostrare disegni e modelli, che la sepoltura del detto signor Giovanni, la quale doveva fare il Tribolo, fu allogata a lui. E così presi de' marmi di Michelagnolo, che erano in Fiorenza in via Mozza, guastatigli senza rispetto, cominciò l'opera; per che, tornato il Tribolo da Carrara, trovò essergli stato levato, per essere egli troppo freddo e buono, il lavoro. L'anno che si fece parentado fra il signor duca Cosimo et il signor don Petro di Tolledo, marchese di Villa Franca, allora veceré di Napoli, pigliando il signor Duca per moglie la signora Leonora sua figliuola, nel farsi in Fiorenza l'apparato delle nozze, fu dato cura al Tribolo di fare alla porta al Prato, per la quale doveva la sposa entrare venendo dal Poggio, un arco trionfale; il quale egli fece bellissimo, e molto ornato di colonne, pilastri, architravi, cornicioni e frontespizii. E perché il detto arco andava tutto pieno di storie e di figure, oltre alle statue, che furono di man del Tribolo, fecero tutte le dette pitture Battista Franco Viniziano, Ridolfo Ghirlandaio e Michele suo discepolo. La principal figura dunque, che fece il Tribolo in que-st'opera, la quale fu posta sopra il frontespizio nella punta del mezzo sopra un dado fatto di rilievo, fu una femina di cinque braccia, fatta per la Fecondità, con cinque putti, tre avolti alle gambe, uno in grembo e l'altro al collo. E questa, dove cala il frontespizio, era messa in mezzo da due figure della medesima grandezza, una da ogni banda. Delle quali figure, che stavano a giacere, una era la Sicurtà, che s'appoggiava sopra una colonna con una verga sottile in mano, e l'altra era l'Eternità con una palla nelle braccia e sotto ai piedi un vecchio canuto figurato per lo Tempo col Sole e Luna in collo.
Non dirò quali fussero l'opere di pittura che furono in questo arco, perché può vedersi ciascuno nella discrizione dell'apparato di quelle nozze, e perché il Tribolo ebbe particolar cura degl'ornamenti del palazzo de' Medici egli fece fare nelle lunette delle volte del cortile, molte imprese con motti a proposito a quelle nozze e tutte quelle de' più illustri di casa Medici. Oltre ciò nel cortile grande scoperto fece un suntuosissimo apparato pieno di storie, cioè da una parte di Romani e Greci, e dall'altre di cose state fatte da uomini illustri di detta casa Medici, che tutte furono condotte dai più eccellenti giovani pittori che allora fussero in Fiorenza di ordine del Tribolo, Bronzino, Pierfrancesco di Sandro, Francesco Bacchiacca, Domenico Conti, Antonio di Domenico e Battista Franco Viniziano. Fece anco il Tribolo in sulla piazza di San Marco, sopra un grandissimo basamento alto braccia dieci (nel quale il Bronzino aveva dipinte di color di bronzo due bellissime storie) nel zoccolo che era sopra le cornici, un cavallo di braccia dodici, con le gambe dinanzi in alto e sopra quello una figura armata e grande a proporzione, la quale figura avea sotto genti ferite e morte: rappresentava il valorosissimo signor Giovanni de' Medici padre di sua eccellenza. Fu quest'opera con tanto giudizio et arte condotta dal Tribolo, ch'ella fu ammirata da chiunche la vide, e quello che più fece maravigliare, fu la prestezza nella quale egli la fece, aiutato fra gl'altri da Santi Buglioni scultore, il quale cadendo, rimase storpiato d'una gamba, e poco mancò che non si morì. Di ordine similmente del Tribolo fece, per la comedia che si recitò, Aristotele da San Gallo (in queste veramente eccellentissimo, come si dirà nella vita sua) una maravigliosa prospettiva. Et esso Tribolo fece per gl'abiti degl'intermedii, che furono opera di Giovambatista Strozzi, il quale ebbe carico di tutta la comedia, le più vaghe e belle invenzioni di vestiti, di calzari, d'acconciature di capo e d'altri abbigliamenti, che sia possibile imaginarsi. Le quali cose furono cagione che il Duca si servì poi in molte capricciose mascherate dell'ingegno del Tribolo, come in quella del-l'Orsi, per un palio di Bufole, in quella de' Corbi et in altre. Similmente l'anno che al detto signor Duca nacque il signor don Francesco suo primogenito, avendosi a fare nel tempio di San Giovanni di Firenze un suntuoso apparato, il quale fusse onoratissimo e capace di cento nobilissime giovani, le quali l'avevano ad accompagnare dal palazzo insino al detto tempio, dove aveva a ricevere il battesimo, ne fu dato carico al Tribolo, il quale insieme col Tasso, accomodandosi al luogo, fece che quel tempio, che per sé è antico e bellissimo, pareva un nuovo tempio alla moderna ottimamente inteso, insieme con i sederi intorno riccamente adorni di pitture e d'oro.
Nel mezzo sotto la lanterna fece un vaso grande di legname intagliato in otto facce, il quale posava il suo piede sopra quattro scaglioni. Et in sui canti dell'otto facce erano certi viticcioni, i quali movendosi da terra, dove erano alcune zampe di leone, avevano in cima certi putti grandi i quali facendo varie attitudini tenevano con le mani la bocca del vaso e colle spalle alcuni festoni che giravano e facevano pendere nel vano del mezzo una ghirlanda attorno attorno. Oltre ciò aveva fatto il Tribolo nel mezzo di questo vaso un basamento di legname con belle fantasie attorno, in sul quale mi-se per finimento il San Giovanbattista di marmo, alto braccia tre, di mano di Donatello, che fu lasciato da lui nelle case di Gismondo Martelli, come si è detto nella vita di esso Donatello. Insomma, essendo questo tempio dentro e fuori stato ornato quanto meglio si può imaginare, era solamente stata lasciata in dietro la cappella principale, dove in un taberna-colo vecchio sono quelle figure di rilievo che già fece Andrea Pisano. Onde pareva, essendo rinovato ogni cosa, che quella capella così vecchia togliesse tutta la grazia che l'altre cose tutte insieme avevano. Andando dunque un giorno il Duca a vedere questo apparato, come persona di giudizio, lodò ogni cosa e conobbe quanto si fusse bene accomodato il Tribolo al sito e luogo et ad ogni altra cosa, solo biasimò sconciamente che a quella capella principale non si fusse avuto cura. Onde a un tratto, come persona risoluta con bel giudizio, ordinò che tutta quella parte fusse coperta con una tela grandissima dipinta di chiaro scuro, dentro la quale San Giovanni Battista battezzasse Cristo et intorno fussero popoli che stessono a vedere e si battezzassino, altri spogliandosi et altri rivestendosi in varie attitudini, e sopra fusse un Dio Padre che mandasse lo Spirito Santo, e due fonti in guisa di fiumi per Ior e Dan, i quali versando acqua facessero il Giordano. Essendo adunque ricerco di far questa opera da Messer Pierfrancesco Riccio, maiordomo allora del Duca, e dal Tribolo, Iacopo da Puntormo, non la volle fare, perciò che il tempo, che vi era solamente di sei giorni, non pensava che gli potesse bastare. Il simile fece Ridolfo Ghirlandaio, Bronzino e molti altri. In questo tempo essendo Giorgio Vasari tornato da Bologna e lavorando per Messer Bindo Altoviti la tavola della sua capella in Santo Apostolo in Firenze, non era in molta considerazione, se bene aveva amicizia col Tribolo e col Tasso. Perciò che avendo alcuni fatto una setta, sotto il favore del detto Messer Pierfrancesco Riccio, chi non era di quella non participava del favore della corte, ancor che fusse virtuoso e da bene. La quale cosa era cagione che molti, i quali con l'aiuto di tanto principe si sarebbono fatti eccellenti, si stavano abandonati, non si adoperando se non chi voleva il Tasso, il quale, come persona allegra, con le sue baie inzampognava colui di sorte che non faceva e non voleva in certi affari, se non quello che voleva il Tasso, il quale era architettore di palazzo e faceva ogni cosa. Costoro dunque avendo alcun sospetto di esso Giorgio, il quale si rideva di quella loro vanità e sciocchezze e più cercava di farsi da qualcosa mediante gli studii dell'arte, che con favore, non pensavano al fatto suo, quando gli fu dato ordine dal signor Duca che facesse la detta tela con la già detta invenzione. La quale opera egli condusse in sei giorni di chiaro scuro e la diede finita in quel modo che sanno coloro che videro quanta grazia et ornamento ella diede a tutto quello apparato e quanto ella rallegrasse quella parte, che più n'aveva bisogno in quel tempio e nelle magnificenze di quella festa.
Si portò dunque tanto bene il Tribolo, per tornare oggimai onde mi sono, non so come, partito, che ne meritò somma lode, et una gran parte degl'ornamenti, che fece fra le colonne, volse il Duca che vi fussero lasciati, e vi sono ancora e meritamente. Fece il Tribolo alla villa di Cristofano Rinieri a Castello, mentre che attendeva alle fonti del Duca, sopra un vivaio, che è in cima a una ragnaia, in una nicchia un fiume di pietra bigia grande quanto il vivo, che getta acqua in un pilo grandissimo della medesima pietra; il qual fiume, che è fatto di pezzi, è commesso con tanta arte e diligenza, che pare tutto d'un pezzo. Mettendo poi mano il Tribolo per ordine di sua eccellenza voler finire le scale della libreria di San Lorenzo, cioè quelle che sono nel ricetto dinanzi alla porta, messi che n'ebbe quattro scaglioni, non ritrovando né il modo, né le misure di Michelagnolo, con ordine del Duca andò a Roma, non solo per intendere il parere di Michelagnolo intorno alle dette scale, ma per far opera di condurre lui a Firenze. Ma non gli riuscì né l'uno, né l'altro, perciò che non volendo Michelagnolo partire di Roma con bel modo si licenziò, e quanto alle scale mostrò non ricordarsi più né di misure né d'altro. Il Tribolo dunque, essendo tornato a Firenze e non potendo seguitare l'opera delle dette scale, si diede a far il pavimento della detta libreria di mattoni bianchi e rossi, sì come alcuni pavimenti che aveva veduti in Roma, ma vi aggiunse un ripieno di terra rossa nella terra bianca, mescolata col bolo per fare diversi intagli in que' mattoni. E così questo pavimento fece ribattere tutto il palco e soffittato di sopra, che fu cosa molto lodata. Cominciò poi e non finì, per mettere nel maschio della fortezza della porta a Faenza, per don Giovanni di Luna, allora castellano, un'arme di pietra bigia et un'aquila di tondo rilievo grande con due capi, quali fece di cera perché fusse gettata di bronzo, ma non se ne fece altro e dell'arme rimase solamente finito lo scudo. E perché era costume della città di Fiorenza fare quasi ogni anno per la festa di San Giovanni Battista, in sulla piazza principale, la sera di notte una girandola, cioè una machina piena di trombe di fuoco e di razzi et altri fuochi lavorati, la quale girandola aveva ora forma di tempio, ora di nave, ora di scogli e talora d'una città o d'uno Inferno, come più piaceva all'inventore, fu dato cura un anno di farne una al Tribolo, il quale la fece, come di sotto si dirà, bellissima. E perché delle varie maniere di tutti questi così fatti fuochi, e particolarmente de' lavorati, tratta Vannoccio Sanese et altri, non mi distenderò in questo, dirò bene alcune cose delle qualità delle girandole. Il tutto adunque si fa di legname, con spazii larghi che spuntino in fuori da piè, acciò che i raggi, quando hanno avuto fuoco, non accendano gl'altri, ma s'alzino mediante le distanze a poco a poco del pari, e secondando l'un l'altro, empiano il cielo del fuoco, che è nelle grillande da sommo e da piè; si vanno, dico, spartendo larghi acciò non abrucino a un tratto, e facciano bella vista. Il medesimo fanno gli scoppi, i quali, stando legati a quelle parti ferme della girandola, fanno bellissime gazzarre. Le trombe similmente vanno accomodando negli ornamenti e si fanno uscire le più volte per bocca di maschere o d'altre cose simili, ma l'importanza sta nell'accomodarla in modo che i lumi, che ardono in certi vasi, durino tutta la notte e faccino la piazza luminosa. Onde tutta l'opera è guidata da un semplice stop-pino, che bagnato in polvere piena di solfo et acquavita a poco a poco camina ai luoghi, dove egli ha di mano in mano a dar fuoco, tanto che abbia fatto tutto. E perché si figurano, come ho detto, varie cose, ma che abbino che fare alcuna cosa col fuoco e sieno sottoposte agli incendii et era stata fatta molto inanzi la città di Soddoma e Lotto con le figliuole, che di quella uscivano, et altra volta Gerione con Virgilio e Dante addosso, sì come da esso Dante si dice nell'Inferno, e molto prima Orfeo che traeva seco da esso Inferno Euridice et altre molte invenzioni, ordinò sua eccellenza che non certi fantocciai, che avevano già molt'anni fatto nelle girandole mille gofferie, ma un maestro eccellente facesse alcuna cosa che avesse del buono, perché datane cura al Tribolo, egli con quella virtù et ingegno che aveva l'altre cose fatto, ne fece una in forma di tempio a otto facce bellissimo, alta tutta con gl'ornamenti venti braccia. In qual tempio egli finse che fusse quello della Pace, facendo in cima il simulacro della Pace, che metta fuoco in un gran monte d'arme che ave-va a' piedi. Le quali armi, statua della Pace e tutte altre figure, che facevano essere quella machina bellissima, erano di cartoni, terra e panni incollati, acconci con arte grandissima, erano, dico, di cotali materie, acciò l'opera tutta fusse leggera, dovendo essere da un canapo doppio, che traversava la piazza in alto, sostenuta per molto spazio alta da terra. Ben è vero che, essendo stati acconci dentro i fuochi troppo spessi e le guide degli stopini troppo vicine l'una all'altra, che datole fuoco, fu tanta la veemenza dell'incendio e grande e subita vampa, che ella si accese tutta a un tratto et abbruciò in un baleno, dove aveva a durare ad ardere un'ora al meno. E, che fu peggio, attaccatosi fuoco al legname et a quello che dovea conservarsi, si abbruciarono i canapi et ogni altra cosa a un tratto, con danno non piccolo e poco piacere de' popoli. Ma quanto apartiene all'opera, ella fu la più bella che altra girandola la quale insino a quel tempo fusse stata fatta già mai.
Volendo poi il Duca fare, per commodo de' suoi cittadini e mercanti, la loggia di Mercato Nuovo, e non volendo più di quello che potesse aggravare il Tribolo, il quale come capo maestro de' capitani di parte e commessarii de' fiumi e sopra le fogne della città, cavalcava per lo dominio per ridurre molti fiumi, che scorrevano con danno, ai loro letti, riturare ponti et altre cose simili, diede il carico di quest'opera al Tasso, per consiglio del già detto Messer Pierfrancesco maiordomo, per farlo di falegname architettore, il che invero fu contra la volontà del Tribolo, ancor che egli nol mostrasse e facesse molto l'amico con esso lui. E che ciò sia vero, conobbe il Tribolo nel modello del Tasso molti errori, de' quali, come si crede, nol volle altrimenti avvertire, come fu quello de' capitelli delle colonne che sono a canto ai pilastri, i quali non essendo tanto lontana la colonna che bastasse, quando tirato su ogni cosa si ebbero a mettere a' luoghi loro, non vi entrava la corona di sopra della cima di essi capitelli; onde bisognò tagliarne tanto che si guastò quell'ordi-ne, senza molti altri errori, de' quali non accade ragionare. Per lo detto Messer Pierfrancesco fece il detto Tasso la porta della chiesa di Santo Romolo et una finestra inginocchiata in sulla piazza del Duca, d'un ordine a suo modo, mettendo i capitegli per base e facendo tante altre cose senza misura o ordine, che si potea dire che l'ordine tedesco avesse cominciato a riavere la vita in Toscana per mano di quest'uomo. Per non dir nulla delle cose che fece in palazzo di scale e di stanze, le quali ha avuto il Duca a far guastare perché non avevano né ordine, né misura, né proporzione alcuna, anzi tutte storpiate, fuor di squadra e senza grazia o commodo niuno. Le quali tutte cose non passarono senza carico del Tribolo, il quale intendendo, come faceva, assai, non parea che dovesse comportare che il suo principe gettasse via i danari et a lui facesse quella vergogna in su gl'occhi, e, che è peggio, non dovea comportare cotali cose al Tasso che gl'era a-mico. E ben conobbono gl'uomini di giudizio la prosonzione e pazzia dell'uno in volere fare quell'arte che sapeva et il simular dell'altro, che affermava quello piacergli che certo sapeva che stava male. E di ciò facciano fede l'opere che Giorgio Vasari ha avuto a guastare in palazzo, con danno del Duca e molta vergogna loro.
Ma gli avvenne al Tribolo quello che al Tasso, perciò che sì come il Tasso lasciò lo intagliare di legname, nel quale esercizio non aveva pari, e non fu mai buono architettore per aver lasciato un'arte nella quale molto valeva, e datosi a un'altra della quale non sapea straccio, e gli apportò poco onore, così il Tribolo lasciando la scultura, nella quale si può dire con verità che fusse molto eccellente e facea stupire ognuno e datosi a volere dirizzare fiumi, l'una non seguitò con suo onore e l'altra gl'apportò anzi danno e biasimo che onore et utile, perciò che non gli riuscì rassettare i fiumi e si fece molti nimici, e particolarmente in quel di Prato per conto di Bisenzio, et in Valdinievole in molti luoghi.
Avendo poi compero il duca Cosimo il palazzo de' Pitti, del quale si è in altro luogo ragionato, e desiderando sua eccellenza di adornarlo di giardini, boschi e fontane e vivai et altre cose simili, fece il Tribolo tutto lo spartimento del monte in quel modo che egli sta, accomodando tutte le cose con bel giudizio ai luoghi loro, se ben poi alcune cose sono state mutate in molte parti del giardino. Del qual palazzo de' Pitti, che è il più bello d'Europa, si parlerà altra volta con migliore occasione. Dopo queste cose fu mandato il Tribolo da sua eccellenza nell'isola dell'Elba, non solo perché vedesse la città e porto che vi aveva fatta fare, ma ancora perché desse ordine di condurre un pezzo di granito tondo di dodici braccia per diametro, del quale si aveva a fare una tazza per lo prato grande de' Pitti, la quale ricevesse l'acqua della fonte principale. Andato dunque colà il Tribolo e fatta fare una scafa a posta per condurre questa tazza et ordinato agli scarpellini il modo di condurla, se ne tornò a Fiorenza, dove non fu sì tosto arivato, che trovò ogni cosa piena di romori e maladizioni contra di sé, avendo di que' giorni le piene et inondazioni fatto grandissimi danni intorno a que' fiumi che egli aveva rassettati, ancor che forse non per suo difetto in tutto fusse ciò avenuto. Comunche fusse, o la malignità d'alcuni ministri e forse l'invidia, o che pure fusse così il vero, fu di tutti que' danni data la colpa al Tribolo, il quale non essendo di molto animo et anzi scarso di partiti che no, dubitando che la malignità di qualcuno non gli faces-se perdere la grazia del Duca, si stava di malissima voglia, quando gli sopragiunse, essendo di debole complessione, una grandissima febre a dì 20 d'agosto, l'anno 1550, nel qual tempo, essendo Giorgio in Firenze per far condurre a Roma i marmi delle sepolture che papa Giulio Terzo fece fare in San Piero a Montorio, come quelli che veramente amava la virtù del Tribolo lo visitò e confortò, pregandolo che non pensasse se non alla sanità e che guarito si ritraesse a finire l'opera di Castello, lasciando andare i fiumi, che più tosto potevano affogargli la fama che fargli utile o onore nessuno. La qual cosa come promise di voler fare, arebbe, mi credo io, fatta per ogni modo se non fusse stato impedito dalla morte, che gli chiuse gl'occhi a dì 7 settembre del medesimo anno. E così l'opere di Castello, state da lui cominciate e messe inanzi, rimasero imperfette perciò che, se bene si è lavorato dopo lui ora una cosa et ora un'altra, non però vi si è mai atteso con quella diligenza e prestezza che si faceva vivendo il Tribolo e quando il signor Duca era caldissimo in quell'opera. E di vero chi non tira inanzi le grandi opere, mentre coloro che fanno farle spendono volentieri e non hanno maggior cura, è cagione che si devia e si lascia imperfetta l'opera che arebbe potuto la sollecitudine e studio condurre a perfezzione. E così per negligenza degl'operatori, rimane il mondo senza quello ornamento et eglino senza quella memoria et onore, perciò che rade volte adiviene, come a quest'opera di Castello, che mancando il primo maestro, quegli che in suo luogo succede voglia finirla secondo il disegno e modello del primo, con quella modestia che Giorgio Vasari, di commessione del Duca, ha fatto, secondo l'ordine del Tribolo, finire il vivaio maggiore di Castello e l'altre cose secondo che di mano in mano vorrà che si faccia sua eccellenza.
Visse il Tribolo anni 65. Fu sotterrato dalla Compagnia dello Scalzo nella lor sepoltura e lasciò dopo sé Raffaello suo figliuolo, che non ha atteso all'arte e due figliuole femine, una delle quali è moglie di Davitte, che l'aiutò a murare tutte le cose di Castello, et il quale come persona di giudizio et atto a ciò, oggi attende ai condotti dell'acqua di Fiorenza, di Pisa e di tutti gl'altri luoghi del dominio, secondo che piace a sua eccellenza.
IL FINE DELLA VITA DI NICCOLÒ, DETTO IL TRIBOLO
VITA DI PIERINO DA VINCI
SCULTORE
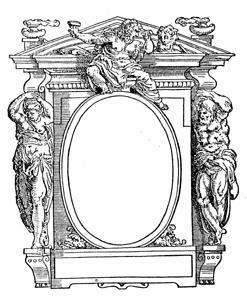
Benché coloro si sogliono celebrare i quali hanno virtuosamente adoperato alcuna cosa, nondimeno se le già fatte opere da alcuno mostrano le non fatte, che molte sarebbono state e molto più rare, se caso inopinato e fuor dell'uso comune non accadeva che le 'nterroppe, certamente costui, ove sia chi dell'altrui virtù voglia essere giusto estimatore, così per l'una come per l'altra parte e per quanto e' fece, e per quel che fatto arebbe, meritamente sarà lodato e celebrato. Non doverranno addunque al Vinci scultore nuocere i pochi anni che egli visse e torgli le degne lode nel giudizio di coloro che dopo noi verranno, considerando che egli allora fioriva e d'età e di studii, quando quel che ognuno ammira, fece e diede al mondo, ma era per mostrarne più copiosamente i frutti, se tempesta nimica i frutti e la pianta non isveglieva.
Ricordomi d'aver altra volta detto che nel castello di Vinci nel Valdarno di sotto fu ser Piero padre di Lionardo da Vinci pittore famosissimo. A questo ser Piero nacque, dopo Lionardo, Bartolomeo ultimo suo figliuolo, il quale standosi a Vinci e venuto in età, tolse per moglie una delle prime giovane del castello. Era desideroso Bartolomeo d'avere un figliuol mastio, e narrando molte volte alla moglie la grandezza dell'ingegno che aveva avuto Lionardo suo fratello, pregava Iddio che la facesse degna che per mezzo di lei nascesse in casa sua un altro Lionardo, essendo quello già morto. Natogli adunque in breve tempo, secondo il suo desiderio, un grazioso fanciullo, gli voleva porre il nome di Lionardo, ma consigliato da' parenti a rifare il padre, gli pose nome Piero. Venuto nell'età di tre anni, era il fanciullo di volto bellissimo e ricciuto e molta grazia mostrava in tutti i gesti e vivezza d'ingegno mirabile. In tanto che venuto a Vinci et in casa Bartolomeo alloggiato maestro Giuliano del Carmine, astrologo eccellente, e seco un prete chiromante, che era-no amendue amicissimi di Bartolomeo, e guardata la fronte e la mano del fanciullo, predissono al padre, l'astrologo e 'l chiromante insieme, la grandezza dell'ingegno suo e che egli farebbe in poco tempo profitto grandissimo nell'arti mercuriali, ma che sarebbe brevissima la vita sua. E troppo fu vera la costor profezia, perché nell'una parte e nell'altra (bastando in una), nell'arte e nella vita si volle adempiere.
Crescendo di poi Piero, ebbe per maestro nelle lettere il padre, ma da sé senza maestro, datosi a disegnar et a fare cotali fantoccini di terra, mostrò che la natura e la celeste inclinazione conosciuta dall'astrologo e dal chiromante già si svegliava e cominciava in lui a operare. Per la qual cosa Bartolomeo giudicò che 'l suo voto fusse esaudito da Dio; e parendogli che 'l fratello gli fusse stato renduto nel figliuolo, pensò a levare Piero da Vinci e condurlo a Firenze. Così fatto adunque senza indugio, pose Piero, che già era di dodici anni, a star col Bandinello in Firenze, promettendosi che 'l Bandinello, come amico già di Lionardo, terrebbe conto del fanciullo e gl'insegnerebbe con diligenza, perciò che gli pareva che egli più della scultura si dilettasse che della pittura. Venendo di poi più volte in Firenze, conobbe che 'l Bandinello non corrispondeva co' fatti al suo pensiero e non usava nel fanciullo diligenza, né studio, con tutto che pronto lo vedesse all'imparare. Per la qual cosa toltolo al Bandinello, lo dette al Tribolo, il quale pareva a Bartolomeo che più s'ingegnasse d'aiutare coloro i quali cercavano d'imparare e che più attendesse agli studii dell'arte e portasse ancora più affezzione alla memoria di Lionardo. Lavorava il Tribolo a Castello, villa di sua eccellenza, alcune fonti, là dove Piero, cominciato di nuovo al suo solito a disegnare, per aver quivi la concorrenza degl'altri giovani che teneva il Tribolo, si messe con molto ardore d'animo a studiare il dì e la notte, spronandolo la natura desiderosa di virtù e d'onore e maggiormente accendendolo l'essempio degli altri pari a sé, i quali tuttavia si vedeva intorno. Onde in pochi mesi acquistò tanto, che fu di maraviglia a tutti, e cominciato a pigliar pratica in su' ferri, tentava di vedere se la mano e lo scarpello obbediva fuori alla voglia di dentro et a' disegni suoi dell'intelletto. Vedendo il Tribolo questa sua prontezza et appunto avendo fatto allora fare un acquaio di pietra per Cristofano Rinieri, dette a Piero un pezzetto di marmo, del quale egli facesse un fanciullo per quell'acquaio, che gettasse acqua dal membro virile. Piero, preso il marmo con molta allegrezza e fatto prima un modelletto di terra, condusse poi con tanta grazia il lavoro, che 'l Tribolo e gli altri feciono coniettura che egli riuscirebbe di quegli che si truovano rari nell'arte sua. Dettegli poi a fare un mazzocchio ducale di pietra sopra un'arme di palle per Messer Pierfrancesco Riccio, maiordomo del Duca, et egli lo fece con due putti, i quali intrecciandosi le gambe insieme, tengono il mazzocchio in mano e lo pongono sopra l'arme, la quale è posta sopra la porta d'una casa, che allora teneva il maiordomo dirimpetto a San Giuliano allato a' preti di Sant'Antonio. Veduto que-sto lavoro, tutti gli artefici di Firenze feciono il medesimo giudizio ch'el Tribolo aveva fatto innanzi.
Lavorò dopo questo un fanciullo che stringe un pesce che getta acqua per bocca, per le fonti di Castello, et avendogli dato il Tribolo un pezzo di marmo maggiore, ne cavò Piero due putti che s'abbracciano l'un l'altro, e strignendo pesci, gli fanno schizzare acqua per bocca. Furono questi putti sì graziosi nelle teste e nella persona e con sì bella maniera condotti di gambe, di braccia e di capelli, che già si potette vedere che egli arebbe condotto ogni difficile lavoro a perfezzione. Preso addunque animo e comperato un pezzo di pietra bigia lungo due braccia e mezzo e condottolo a casa sua, al canto alla Briga, cominciò Piero a lavorarlo la sera quando tornava e la notte et i giorni delle feste, intanto che a poco a poco lo condusse al fine. Era questa una figura di Bacco, che aveva un satiro a' piedi, e con una mano tenendo una tazza, nell'altra aveva un grappolo d'uva e 'l capo le cingeva una corona d'uva secondo un modello fatto da lui stesso di terra. Mostrò in questo e negli altri suoi primi lavori Piero un'agevolezza maravigliosa, la quale non offende mai l'occhio, né in parte alcuna è molesta a chi riguarda. Finito questo Bacco, lo comperò Bongianni Capponi et oggi lo tiene Lodovico Capponi suo nipote in una sua corte.
Mentre che Piero faceva queste cose, pochi sapevano ancora che egli fusse nipote di Lionardo da Vinci, ma facendo l'opere sue lui noto e chiaro, di qui si scoperse insieme il parentado e 'l sangue, laonde tuttavia dappoi sì per l'origine del zio e sì per la felicità del proprio ingegno, col quale e' rassomigliava tanto uomo, fu per innanzi non Piero, ma da tutti chiamato il Vinci. Il Vinci addunque, mentre che così si portava, più volte e da diverse persone aveva udito ragionare delle cose di Roma appartenenti all'arte e celebrarle, come sempre da ognuno si fa; onde in lui s'era un grande desiderio acceso di vederle, sperando d'averne a cavare profitto, non solamente vedendo l'opere degli antichi, ma quelle di Michelagnolo e lui stesso allora vivo e dimorante in Roma. Andò addunque in compagnia d'alcuni amici suoi, e veduta Roma, e tutto quello che egli desiderava, se ne tornò a Firenze, considerato giudiziosamente che le cose di Roma erano ancora per lui troppo profonde e volevano esser vedute et immitate non così ne' principii, ma dopo maggior notizia del-l'arte. Aveva allora il Tribolo finito un modello del fuso della fonte del laberinto, nel quale sono alcuni satiri di basso rilievo e quattro maschere mezzane e quattro putti piccoli tutti tondi che seggono sopra certi viticci. Tornato addunque il Vinci, gli dette il Tribolo a fare questo fuso, et egli lo condusse e finì, facendovi dentro alcuni lavori gentili non usati da altri che da lui, i quali molto piacevano a ciascuno che gli vedeva. Avendo il Tribolo fatto finire tutta la tazza di marmo di quella fonte, pensò di fare in su l'orlo di quella quattro fanciulli tutti tondi, che stessino a giacere e scherzassino con le braccia e con le gambe nell'acqua con varii gesti, per gettargli poi di bronzo. Il Vinci per commessione del Tribolo gli fece di terra, i quali furono poi gettati di bronzo da Zanobi Lastricati scultore e molto pratico nelle cose di getto, e furono posti, non è molto tempo, intorno alla fonte, che sono cosa bellissima a vedere.
Praticava giornalmente col Tribolo Luca Martini, proveditore allora della muraglia di Mercato Nuovo, il quale desiderando di giovare al Vinci, lodando molto il valore dell'arte e la bontà de' costumi in lui, gli provvedde un pezzo di marmo alto due terzi e lungo un braccio et un quarto. Il Vinci preso il marmo, vi fece dentro un Cristo battuto alla colonna, nel quale si vede osservato l'ordine del basso rilievo e del disegno, e certamente egli fece maravigliare ognuno, considerando che egli non era pervenuto ancora a diciassette anni dell'età sua et in cinque anni di studio aveva acquistato quello nell'arte che gli altri non acquistano se non con lunghezza di vita e con grande sperienza di molte cose. In questo tempo il Tribolo, avendo preso l'ufficio del capomaestro delle fogne della città di Firenze, secondo il quale ufficio ordinò che la fogna della piazza vecchia di Santa Maria Novella s'alzasse da terra, acciò che più essendo capace, meglio potesse ricevere tutte l'acque che da diverse parti a lei concorrono, per questo addunque commesse al Vinci, che facesse un modello d'un mascherone di tre braccia il quale, aprendo la bocca, inghiottisse l'acque piovane. Di poi per ordine degli ufficiali della torre, allogata quest'opera al Vinci, egli, per condurla più presto chiamato Lorenzo Marignolli scultore, in compagnia di costui la finì in un sasso di pietra forte, e l'opera è tale, che con utilità non piccola della città tutta quella piazza adorna.
Già pareva al Vinci avere acquistato tanto nell'arte, che il vedere le cose di Roma maggiori et il praticare cogli artefici che sono quivi eccellentissimi, gli apporterebbe gran frutto; però porgendosi occasione d'andarvi, la prese volentieri. Era venuto Francesco Bandini da Roma, amicissimo di Michelagnolo Buonarroti; costui per mezzo di Luca Martini conosciuto il Vinci, e lodatolo molto, gli fece fare un modello di cera d'una sepoltura, la quale voleva fare di marmo alla sua cappella in Santa Croce, e poco dopo, nel suo ritorno a Roma, perciò che il Vinci aveva scoperto l'animo suo a Luca Martini, il Bandino lo menò seco, dove studiando tuttavia dimorò un anno e fece alcune opere degne di memoria. La prima fu un Crocifisso di basso rilievo, che rende l'anima al Padre, ritratto da un disegno fatto da Michelagnolo. Fece al cardinal Ridolfi un petto di bronzo per una testa antica et una Venere di basso rilievo di marmo, che fu molto lo-dato. A Francesco Bandini racconciò un cavallo antico, al quale molti pezzi mancavano e lo ridusse intero. Per mostrare ancora qualche segno di gratitudine, dove egli poteva, inverso Luca Martini, il quale gli scriveva ogni spaccio e lo raccomandava di continovo al Bandino, parve al Vinci di far di cera tutto tondo e di grandezza di dua terzi il Moisè di Michelagnolo, il quale è in San Piero in Vincola alla sepoltura di papa Giulio Secondo, che non si può vedere opera più bella di quella. Così fatto di cera il Moisè, lo mandò a donare a Luca Martini.
In questo tempo che 'l Vinci stava a Roma e le dette cose faceva, Luca Martini fu fatto dal Duca di Firenze proveditore di Pisa, e nel suo ufficio non si scordò dell'amico suo, per che scrivendogli che gli preparava la stanza e provvedeva un marmo di tre braccia, sì che egli se ne tornasse a suo piacere, perciò che nulla gli mancherebbe appresso di lui, il Vinci da queste cose invitato e dall'amore che a Luca portava, si risolvé a partirsi di Roma e per qualche tempo eleggere Pisa per sua stanza, dove stimava d'avere occasione d'esercitarsi e di fare sperienza della sua virtù. Venuto addunque in Pisa, trovò che 'l marmo era già nella stanza, acconcio secondo l'ordine di Luca, e cominciando a volerne cavare una figura in piè, s'avvedde che 'l marmo aveva un pelo, il quale lo scemava un braccio. Per lo che risoluto a voltarlo a giacere, fece un fiume giovane che tiene un vaso che getta acqua, et è il vaso alzato da tre fanciulli, i quali aiutano a versa-re l'acqua il fiume e sotto i piedi a lui molta copia d'acqua discorre, nella quale si veggono pesci guizzare et uccelli acquatici in varie parti volare. Finito questo fiume, il Vinci ne fece dono a Luca, il quale lo presentò alla Duchessa et a lei fu molto caro perché allora, essendo in Pisa don Grazzia di Tolledo suo fratello venuto con le galee, ella lo donò al fratello, il quale con molto piacere lo ricevette per le fonti del suo giardino di Napoli a Chiaia.
Scriveva in questo tempo Luca Martini sopra la Commedia di Dante alcune cose et avendo mostrata al Vinci la crudeltà descritta da Dante, la quale usorono i Pisani e l'arcivescovo Ruggeri contro al conte Ugolino della Gherardesca, facendo lui morire di fame con quattro suoi figliuoli nella torre, perciò cognominata della fame, porse occasione e pensiero al Vinci di nuova opera e di nuovo disegno. Però, mentre che ancora lavorava il sopra detto fiume, messe mano a fare una storia di cera per gettarla di bronzo alta più d'un braccio e larga tre quarti, nella quale fece due de' figliuoli del conte morti, uno in atto di spirare l'anima, uno che vinto dalla fame è presso all'estremo non pervenuto ancora all'ultimo fiato; il padre in atto pietoso e miserabile, cieco e di dolore pieno va brancolando sopra i miseri corpi de' figliuoli diste-si in terra. Non meno in questa opera mostrò il Vinci la virtù del disegno che Dante ne' suoi versi mostrasse il valore della poesia, perché non men compassione muovono in chi riguarda gli atti formati nella cera dallo scultore, che faccino in chi ascolta gli accenti e le parole notate in carta, vive, da quel poeta. E per mostrare il luogo dove il caso seguì, fece da piè il fiume d'Arno che tiene tutta la larghezza della storia, perché poco discosto dal fiume è in Pisa la sopra detta torre; sopra la quale figurò ancora una vecchia ignuda, secca e paurosa, intesa per la Fame quasi nel modo che la descrive Ovidio. Finita la cera, gettò la storia di bronzo, la quale sommamente piacque, et in corte e da tutti fu tenuta cosa singulare.
Era il duca Cosimo allora intento a beneficare et abbellire la città di Pisa e già di nuovo aveva fatto fare la piazza del mercato con gran numero di botteghe intorno e nel mezzo messe una colonna alta dieci braccia sopra la quale per disegno di Luca doveva stare una statua in persona della Dovizia. Addunque il Martini, parlato col Duca e messogli innanzi il Vinci, ottenne che 'l Duca volentieri gli concesse la statua, desiderando sempre sua eccellenza d'aiutare i virtuosi e di tirare innanzi i buoni ingegni. Condusse il Vinci di trevertino la statua tre braccia e mezzo alta, la quale molto fu da ciascheduno lodata perché, avendole posto un fanciulletto a' piedi, che l'aiuta tenere il corno dell'abbondanza, mostra in quel sasso ancora che ruvido e malagevole, nondimeno morbidezza e molta facilità. Mandò di poi Luca a Carrara a far cavare un marmo cinque braccia alto e largo tre, nel quale il Vinci avendo già veduto alcuni schizzi di Michelagnolo d'un Sansone che ammazzava un Filisteo con la mascella d'asino, disegnò da questo suggetto fare a sua fantasia due statue di cinque braccia. Onde mentre che 'l marmo veniva, messosi a fare più modelli variati l'uno dall'altro, si fermò a uno e di poi venuto il sasso, a lavorarlo incominciò e lo tirò innanzi assai, immitando Michelagnolo nel cavare a poco a poco de' sassi il concetto suo e 'l disegno senza guastargli o farvi altro errore. Condusse in questa opera gli strafori sotto squadra e sopra squadra, ancora che laboriosi, con molta facilità, e la maniera di tutta l'opera era dolcissima. Ma perché l'opera era faticosissima, s'andava intrattenendo con altri studi e lavori di manco importanza, onde nel medesimo tempo fece un quadro piccolo di basso rilievo di marmo, nel quale espresse una Nostra Donna con Cristo, con San Giovanni e con Santa Lisabetta, che fu et è tenuto cosa singulare; et ebbelo l'illustrissima Duchessa et oggi è fra le cose rare del Duca nel suo scrittoio.
Messe di poi mano a una istoria in marmo di mezzo e basso rilievo, alta un braccio e lunga un braccio e mezzo, nella quale figurava Pisa restaurata dal Duca, il quale è nell'Opera presente alla città et alla restaurazione di essa sollecitata dalla sua presenza. Intorno al Duca sono le sue virtù ritratte e particularmente una Minerva figurata per la Sapienza e per l'arti risuscitate da lui nella città di Pisa: et ella è cinta intorno da molti mali e difetti naturali del luogo i quali, a guisa di nimici, l'assediavano per tutto e l'affliggevano; da tutti questi è stata poi liberata quella città dalle sopradette virtù del Duca. Tutte queste virtù intorno al Duca e tutti que' mali intorno a Pisa erano ritratti con bellissimi modi et attitudini nella sua storia dal Vinci. Ma egli la lasciò imperfetta e desiderata molto da chi la vede per la perfezione delle cose finite in quella,
Cresciuta per queste cose e sparsa intorno la fama del Vinci, gli eredi di Messer Bartolomeo Turini da Pescia lo pregorono che e' facesse un modello d'una sepoltura di marmo per Messer Baldassarre, il quale fatto e piaciuto loro e convenuti che la sepoltura si facesse, il Vinci mandò a Carrara a cavare i marmi Francesco del Tadda, valente maestro d'intaglio di marmo. Avendogli costui mandato un pezzo di marmo, il Vinci cominciò una statua, e ne cavò una figura abbozzata sì fatta, che chi altro non avesse saputo, arebbe detto che certo Michelagnolo l'ha abbozzata. Il nome del Vinci e la virtù era già grande et ammirata da tutti e molto più, che a sì giovane età non sarebbe richiesto, et era per ampliare ancora a diventare maggiore e per adeguare ogni uomo nell'arte sua, come l'opere sue senza l'altrui testimonio fanno fede, quando il termine a lui prescritto dal cielo essendo dappresso, interroppe ogni suo disegno, fece l'aumento suo veloce in un tratto cessare e non patì più che avanti montasse e privò il mondo di molta eccellenza d'arte e d'opere, delle quali vivendo il Vinci egli si sarebbe ornato. Avvenne in questo tempo, mentre che 'l Vinci all'altrui sepoltura era intento, non sapendo che la sua si preparava, che 'l Duca ebbe a mandare per cose d'importanza Luca Martini a Genova, il quale sì perché amava il Vinci e per averlo in compagnia e sì ancora per dare a lui qualche diporto e sollazzo e fargli vedere Genova, andando lo menò seco. Dove mentre che i negozii si trattavano dal Martini, per mezzo di lui Messer Adamo Centurioni dette al Vinci di fare una figura di San Giovanni Batista, della quale egli fece il modello. Ma tosto venutagli la febbre, gli fu, per raddoppiare il male insieme, ancora tolto l'amico, forse per trovare che 'l fato s'adempies-se nella vita del Vinci. Fu necessario a Luca per lo 'nteresse del negozio a lui commesso, che egli andasse a trovare il Duca a Firenze, laonde partendosi dall'infermo amico con molto dolore dell'uno e dell'altro, lo lasciò in casa l'abate ne-ro e strettamente a lui lo raccomandò, benché egli mal volentieri restasse in Genova. Ma il Vinci ogni dì sentendosi peggiorare, si risolvé a levarsi di Genova, e fatto venire da Pisa un suo creato chiamato Tiberio Cavalieri, si fece con l'aiuto di costui condurre a Livorno per acqua e da Livorno a Pisa in ceste. Condotto in Pisa la sera a ventidua ore, travagliato et afflitto dal cammino e dal mare e dalla febbre, la notte mai non posò e la seguente mattina in sul far del giorno passò all'altra vita, non avendo dell'età sua ancora passato i ventitré anni. Dolse a tutti gli amici la morte del Vinci et a Luca Martini eccessivamente, e dolse a tutti gli altri, i quali s'erano permesso di vedere dalla sua mano di quelle cose che rare volte si veggono, e Messer Benedetto Varchi, amicissimo alle sue virtù et a quelle di ciascheduno, gli fece poi per memoria delle sue lode questo sonetto:
Come potrò da me, se tu non presti
forza, o tregua al mio gran duolo interno,
soffrirlo in pace mai, Signor superno,
che fin qui nuova ogn'or pena mi desti?
Dunque de' miei più cari or quegli, or questi
verde sen voli all'alto asilo eterno,
ed io canuto in questo basso inferno
a pianger sempre e lamentarmi resti?
Sciolgami al men tua gran bontate quinci,
or che reo fato nostro o sua ventura,
ch'era ben degno d'altra vita e gente,
per far più ricco il cielo e la scultura
men bella, e me col buon Martin dolente,
n'ha privi, o pieta, del secondo Vinci.
IL FINE DELLA VITA DI PIERO DA VINCI, SCULTORE
VITA DI BACCIO BANDINELLI
SCULTORE FIORENTINO

Ne' tempi ne' quali fiorirono in Fiorenza l'arti del disegno pe' favori et aiuti del Magnifico Lorenzo Vecchio de' Medici, fu nella città un orefice chiamato Michelagnolo di Viviano da Gaiuole, il quale lavorò eccellentemente di cesello, d'incavo, per ismalti e per niello et era pratico in ogni sorte di grosserie. Costui era molto intendente di gioie e benissimo le legava, e per la sua universalità e virtù a lui facevano capo tutti i maestri forestieri dell'arte sua et egli dava loro ricapito, sì come a' giovani ancora della città, di maniera che la sua bottega era tenuta et era la prima di Fiorenza. Da costui si forniva il Magnifico Lorenzo e tutta la casa de' Medici, et a Giuliano fratello del Magnifico Lorenzo, per la giostra che fece su la piazza di Santa Croce, lavorò tutti gl'ornamenti delle celate e cimieri et imprese con sottil magisterio; onde acquistò gran nome e molta famigliarità co' figliuoli del Magnifico Lorenzo, a' quali fu poi sempre molto cara l'opera sua et a lui utile la conoscenza loro e l'amistà, per la quale e per molti lavori ancora fatti da lui per tutta la città e dominio egli divenne benestante, non meno che riputato da molto nell'arte sua. A questo Michelagnolo, nella partita loro di Firenze l'anno 1494, lasciorno i Medici molti argenti e dorerie e tutto fu da lui segretissimamente tenuto e fedelmente salvato fino al ritorno loro, da' quali fu molto lodato dappoi della fede sua e ristorato con premio. Nacque a Michelagnolo l'anno 1487 un figliuolo, il quale egli chiamò Bartolomeo, ma di poi, secondo la consuetudine di Firenze, fu da tutti chiamato Baccio.
Desiderando Michelagnolo di lasciare il figliuolo erede dell'arte e dell'avviamento suo, lo tirò appresso di sé in bottega in compagnia d'altri giovani, i quali imparavano a disegnare, perciò che in que' tempi così usavano e non era tenuto buono orefice chi non era buon disegnatore e che non lavorasse bene di rilievo. Baccio, addunque, ne' suo' primi anni attese al disegno, secondo che gli mostrava il padre, non meno giovandogli a profittare la concorrenza degli altri giovani, tra' quali s'addomesticò molto con uno chiamato il Piloto, che riuscì di poi valente orefice e seco andava spesso per le chiese disegnando le cose de' buoni pittori, ma col disegno mescolava il rilievo, contrafacendo in cera alcune cose di Donato e del Verrocchio, et alcuni lavori fece di terra di tondo rilievo. Essendo ancora Baccio nell'età fanciullesca, si riparava alcuna volta nella bottega di Girolamo del Buda, pittore ordinario su la piazza di San Pulinari, dove essendo un verno venuta gran copia di neve e di poi dalla gente ammontata su detta piazza, Girolamo rivolto a Baccio gli disse per ischerzo: “Baccio, se questa neve fussi marmo, non se ne caverebbe egli un bel gigante come Marforio a giacere?” “Caverebbesi”, rispose Baccio, “et io voglio che noi facciamo come se fusse marmo.” E posata prestamente la cappa, messe nella neve le mani e da altri fanciulli aiutato, scemando la neve dove era troppa et altrove aggiugnendo, fece una bozza d'un Marforio di braccia otto a giacere, di che il pittore et ognuno restorono maravigliati, non tanto di ciò che egli avesse fatto, quanto dell'animo che egli ebbe di mettersi a sì gran lavoro così piccolo e fanciullo. Et invero Baccio a-vendo più amore alla scultura che alle cose dell'orefice, ne mostrò molti disegni, et andato a Pinzirimonte, villa comperata da suo padre, si faceva stare spesso innanzi i lavoratori ignudi e gli ritraeva con grande affetto, il medesimo facendo degli altri bestiami del podere. In questo tempo continovò molti giorni d'andare la mattina a Prato vicino alla sua villa, dove stava tutto il giorno a disegnare nella cappella della pieve, opere di fra' Filippo Lippi, e non restò fino a tanto che e' l'ebbe disegnata tutta ne' panni immitando quel maestro in ciò raro; e già maneggiava destramente lo stile e la penna e la matita rossa e nera, la quale è una pietra dolce che viene de' monti di Francia, e segatele le punte conduce i disegni con molta finezza. Per queste cose, vedendo Michelagnolo l'animo e la voglia del figliuolo, mutò ancora egli con lui pensiero, et insieme consigliato dagli amici lo pose sotto la custodia di Giovanfrancesco Rustici, scultore de' migliori della città dove ancora di continovo praticava Lionardo da Vinci. Costui, veduti i disegni di Baccio e piaciutigli, lo confortò a seguitare et a prendere a lavorare di rilievo e gli lodò grandemente l'opere di Donato, dicendogli che egli facesse qualche cosa di marmo, come o teste o di basso rilievo. Inanimito Baccio da' conforti di Lionardo, si messe a contraffar di marmo una testa antica d'una femmina, la quale aveva formata in un modello da una che è in casa Medici, e per la prima opera, la fece assai lodevolmente e fu tenuta cara da Andrea Carnesecchi, al quale il padre di Baccio la donò et egli la pose in casa sua nella via Larga, sopra la porta nel mezzo del cortile che va nel giardino. Ma Baccio seguitando di fare altri modegli di figure tonde di terra, il padre volendo non mancare allo studio onesto del figliuolo, fatti venire da Carrara alcuni pezzi di marmo, gli fece murare in Pinti nel fine della sua casa, una stanza con lumi accomodati da lavorare, la quale rispondeva in via Fiesolana, et egli si diede ad abbozzare in que' marmi figure diverse, e ne tirò innanzi una fra l'altre in un marmo di braccia dua e mezzo, che fu un Ercole che si tiene sotto fra le gambe un Cacco morto; queste bozze restorono nel medesimo luogo per memoria di lui.
In questo tempo essendosi scoperto il cartone di Michelagnolo Buonarroti, pieno di figure ignude, il quale Michelagnolo aveva fatto a Piero Soderini per la sala del Consiglio grande, concorsono, come s'è detto altrove, tutti gli artefici a disegnarlo per la sua eccellenza. Tra questi venne ancora Baccio e non andò molto che egli trapassò a tutti innanzi, perciò che egli dintornava, et ombrava, e finiva, e gl'ignudi intendeva meglio che alcuno degli altri disegnatori: tra' quali era Iacopo Sansovino, Andrea del Sarto, il Rosso ancor che giovane et Alfonso Barughetta spagnolo, insieme con molti altri lodati artefici. Frequentando più che tutti gli altri il luogo Baccio et avendone la chiave contraffatta, accadde in questo tempo che Piero Soderini fu deposto dal governo l'anno 1512 e rimessa in stato la casa de' Medici. Nel tumulto addunque del palazzo per la rinnovazione dello stato, Baccio da sé solo segretamente stracciò il cartone in molti pezzi; di che non si sapendo la causa, alcuni dicevano che Baccio l'aveva stracciato per avere appresso di sé qualche pezzo del cartone a suo modo: alcuni giudicarono che egli volesse tòrre a' giovani quella commodità perché non avessino a profittare e farsi noti nell'arte; alcuni dicevano che a far questo lo mosse l'affezzione di Lionardo da Vinci, al quale il cartone del Buonarroto aveva tolto molta riputazione; alcuni, forse meglio interpretando, ne davano la causa all'odio che egli portava a Michelagnolo, sì come poi fece vedere in tutta la vita sua. Fu la perdita del cartone alla città non piccola et il carico di Baccio grandissimo, il quale meritamente gli fu dato da ciascuno e d'invidioso e di maligno. Fece poi alcuni pezzi di cartoni di biacca e carbone, tra' quali uno ne condusse molto bello d'una Cleopatra ignuda, e lo donò al Piloto orefice.
Avendo di già Baccio acquistato nome di gran disegnatore, era desideroso d'imparare a dipignere co' colori, avendo ferma opinione non pur di paragonare il Buonarroto, ma superarlo di molto in amendue le professioni. E perché egli aveva fatto un cartone d'una Leda, nel quale usciva dell'uovo del cigno abbracciato da lei Castore e Polluce, e voleva colorirlo a olio, per mostrare che 'l maneggiar de' colori e mesticargli insieme per farne la varietà delle tinte co' lumi e con l'ombre non gli fusse stato insegnato da altri, ma che da sé l'avesse trovato, andò pensando come potesse fare, e trovò questo modo: ricercò Andrea del Sarto suo amicissimo che gli facesse in un quadro di pittura a olio il suo ritratto, avvisando di dovere di ciò conseguire duoi acconci al suo proposito: l'uno era il vedere il modo di mescolare i colori, l'altro il quadro e la pittura, la quale gli resterebbe in mano et avendola veduta lavorare gli potrebbe intendendola giovare e servire per essempio. Ma Andrea accortosi, nel domandare che faceva Baccio, della sua intenzione e sdegnandosi di cotal diffidanza et astuzia perché era pronto a mostrargli il suo desiderio, se come amico ne l'avesse ricerco, perciò senza far sembiante d'averlo scoperto, lasciando stare il far mestiche e tinte, messe d'ogni sorte colore sopra la tavolella et azzuffandoli insieme col pennello, ora da questo et ora da quello togliendo con molta prestezza di mano, così contrafaceva il vivo colore della carne di Baccio, il quale sì per l'arte che Andrea usò e perché gli conveniva sedere e star fermo, se voleva esser dipinto, non potette mai vedere né apprendere cosa che egli volesse. E venne ben fatto ad Andrea di castigare insieme la diffidenza dell'amico e dimostrare, con quel modo di dipignere da maestro pratico, assai maggiore virtù et esperienza dell'arte. Né per tutto questo si tolse Baccio dall'impresa nella quale fu aiutato dal Rosso pittore, il quale più liberamente poi domandò di ciò ch'egli disiderava. Addunque apparato il modo del colorire, fece in un quadro a olio i Santi Padri cavati del Limbo dal Salvatore, et in un altro quadro maggiore Noè, quando inebbriato dal vino scuopre in presenza de' figliuoli le vergogne. Provossi a dipignere in muro nella calcina fresca e dipinse nelle facce di casa sua teste, braccia, gambe e torsi in diverse maniere coloriti, ma vedendo che ciò gli arrecava più difficultà che non s'era permesso nel seccare della calcina, ritornò allo studio di prima a far di rilievo. Fece di marmo una figura alta tre braccia d'un Mercurio giovane con un flauto in mano, nella quale molto studio messe e fu lodata e tenuta cosa rara, la quale fu poi l'anno 1530 comperata da Giovanbatista Della Palla e mandata in Francia al re Francesco, il quale ne fece grande stima.
Dettesi con grande e sollecito studio a vedere et a fare minutamente anatomie, e così perseverò molti mesi et anni, e certamente in questo uomo si può grandemente lodare il desiderio d'onore e dell'eccellenza dell'arte e di bene operare in quella; dal quale desiderio spronato e da un'ardentissima voglia, la quale più tosto che attitudine e destrezza nell'arte aveva ricevuto dalla natura insino da' suoi primi anni, Baccio a niuna fatica perdonava, niuno spazio di tempo intrametteva, sempre era intento o all'apparar di fare o al fare, sempre occupato, non mai ozioso si trovava, pensando col continovo operare di trapassar qualunque altro avesse nell'arte sua già mai adoperato, e questo fine premettendosi a se medesimo di sì sollecito studio e di sì lunga fatica. Continovando addunque l'amore e lo studio, non solamente mandò fuora gran numero di carte disegnate in varii modi di sua mano, ma per tentare se ciò gli riusciva s'adoperò ancora che Agostino Viniziano, intagliatore di stampe, gl'intagliasse una Cleopatra ignuda et un'altra carta maggiore piena d'anatomie diverse, la quale gli acquistò molta lode. Messesi di poi a far di rilievo tutto tondo di cera una figura d'un braccio e mezzo di S. Girolamo in penitenza secchissimo, il quale mostrava in su l'ossa i muscoli astenuati e gran parte de' nervi e la pelle grinza e secca, e fu con tanta diligenza fatta da lui questa opera, che tutti gli artefici feciono giudicio e Lionardo da Vinci particularmente, che e' non si vedde mai in questo genere cosa migliore né con più arte condotta. Questa opera portò Baccio a Giovanni cardinale de' Medici et al Magnifico Giuliano suo fratello, e per mezzo di lei si fece loro conoscere per figliuolo di Michelagnolo orafo e quegli oltre alle lodi dell'opera gli feciono molti altri favori, e ciò fu l'anno 1512, quando erano ritornati in casa e nello stato.
Nel medesimo tempo si lavoravano nell'Opera di Santa Maria del Fiore alcuni Apostoli di marmo per mettergli ne' tabernacoli di marmo in quelli stessi luoghi dove sono in detta chiesa dipinti da Lorenzo di Bicci pittore. Per mezzo del Magnifico Giuliano fu allogato a Baccio San Piero alto braccia quattro e mezzo, il quale dopo molto tempo condusse a fine e benché non con tutta la perfezzione della scultura, nondimeno si vede in lui buon disegno. Questo Apostolo stette nell'Opera dall'anno 1513 insino al 1565, nel quale anno il duca Cosimo, per le nozze della reina Giovanna d'Austria sua nuora, volle che S. Maria del Fiore fusse imbiancata di dentro, la quale dalla sua edificazione non era stata di poi tocca, e che si ponessino quattro Apostoli ne' luoghi loro, tra' quali fu il sopra detto S. Piero. Ma l'anno 1515 nell'andare a Bologna passando per Firenze papa Leone X, la città per onorarlo, tra gli altri molti ornamenti et apparati, fece fare sotto un arco della loggia di piazza vicino al palazzo un colosso di braccia nove e mezzo e lo dette a Baccio. Era il colosso un Ercole il quale per le parole anticipate di Baccio s'aspettava che superassi il Davitte del Buonarroto quivi vicino, ma non corrispondendo al dire il fare, né l'opera al vanto, scemò assai Baccio nel concetto degli artefici e di tutta la città, il quale prima s'aveva di lui. Avendo allora papa Leone l'opera dell'ornamento di marmo che fascia la camera di Nostra Donna a Loreto e parimente statue e storie a maestro Andrea Contucci dal Monte Sansovino, il quale avendo già condotte molto lodatamente alcune opere et essendo intorno all'altre, Baccio in questo tempo portò a Roma al Papa un modello bellissimo d'un Davitte ignudo, che tenendosi sotto Golia gigante gli tagliava la testa, con animo di farlo di bronzo o di marmo per lo cortile di casa Medici in Firenze, in quel luogo appunto dove era prima il Davitte di Donato, che poi fu portato nello spogliare il palazzo de' Medici nel palazzo allora de' signori. Il Papa, lodato Baccio, non parendogli tempo di fare allora il Davitte, lo mandò a Loreto da maestro Andrea, che gli desse a fare una di quelle istorie. Arrivato a Loreto, fu veduto volentieri da maestro Andrea e carezzato, sì per la fama sua e per averlo il Papa raccomandato, e gli fu consegnato un marmo perché ne cavasse la Natività di Nostra Donna. Baccio fatto il modello dette principio all'opera, ma come persona che non sapeva comportare compagnia e parità e poco lodava le cose d'altri, cominciò a biasimare con gli altri scultori che v'erano l'opere di maestro Andrea e dire che non aveva disegno et il simigliante diceva degli altri, intanto che in breve tempo si fece mal volere a tutti. Per la qual cosa venuto agli orecchi di maestro Andrea tutto quel che detto aveva Baccio di lui, egli come savio lo riprese amorevolmente dicendo che l'opere si fanno con le mani, non con la lingua, e che 'l buon disegno non sta nelle carte, ma nella perfezzione dell'opera finita nel sasso e, nel fine, ch'e' dovesse parlare di lui per l'avvenire con altro rispetto. Ma Baccio rispondendogli superbamente molte parole ingiuriose, non potette maestro Andrea più tollerare e corsegli addosso per ammazzarlo; ma da alcuni, che v'entraron di mezzo, gli fu levato dinanzi, onde forzato a partirsi da Loreto, fece portare la sua storia in Ancona, la quale venutagli a fastidio, se bene era vicino al fine, lasciandola imperfetta se ne partì.
Questa fu poi finita da Raffaello da Montelupo e fu posta insieme con l'altre di maestro Andrea, ma non già pari a loro di bontà, con tutto che così ancora sia degna di lode. Tornato Baccio a Roma, impetrò dal Papa per favore del cardinal Giulio de' Medici, solito a favorire le virtù et i virtuosi, che gli fusse dato a fare per lo cortile del palazzo de' Medici in Firenze alcuna statua, onde venuto in Firenze fece un Orfeo di marmo, il quale col suono e canto placa Cerbero e muove l'Inferno a pietà. Immitò in questa opera l'Appollo di Belvedere di Roma, e fu lodatissima meritamente perché, con tutto che l'Orfeo di Baccio non faccia l'attitudine d'Appollo di Belvedere, egli nondimeno immita molto propriamente la maniera del torso e di tutte le membra di quello. Finita la statua, fu fatta porre dal cardinale Giulio nel sopraddetto cortile, mentre che egli governava Firenze, sopra una basa intagliata, fatta da Benedetto da Rovezzano scultore. Ma perché Baccio non si curò mai dell'arte dell'architettura, non considerando lui l'ingegno di Donatello, il quale al Davitte che v'era prima aveva fatto una semplice colonna, su la quale posava l'imbasamento disotto fesso et aperto, a fine che chi passava di fuora vedesse dalla porta da via l'altra porta di dentro dell'altro cortile al dirimpetto; però non avendo Baccio questo accorgimento, fece porre la sua statua sopra una basa grossa e tutta massiccia, di maniera che ella ingombra la vista di chi passa e cuopre il vano della porta di dentro, sì che passando e' non si vede se 'l palazzo va più indietro o se finisce nel primo cortile.
Aveva il cardinal Giulio fatto sotto Monte Mario a Roma una bellissima vigna; in questa vigna volle porre due giganti e gli fece fare a Baccio di stucco, che sempre fu vago di far giganti: sono alti otto braccia e mettono in mezzo la porta che va nel salvatico e furno tenuti di ragionevol bellezza. Mentre che Baccio attendeva a queste cose, non mai abbandonando per suo uso il disegnare, fece a Marco da Ravenna et Agostino Viniziano, intagliatori di stampe, intagliare una storia disegnata da lui in una carta grandissima nella quale era l'occisione de' fanciulli innocenti fatti crudelmente morire da Erode, la quale essendo stata da lui ripiena di molti ignudi, di masti e di femmine, di fanciulli vivi e morti e di diverse attitudini di donne e di soldati, fece conoscere il buon disegno che aveva nelle figure e l'intelligenza de' muscoli e di tutte le membra, e gli recò per tutta Europa gran fama. Fece ancora un bellissimo modello di legno, e le figure di cera per una sepoltura al re d'Inghilterra, la quale non sortì poi l'effetto da Baccio, ma fu data a Benedetto da Rovezzano scultore, che la fece di metallo.
Era tornato di Francia il cardinale Bernardo Divizio da Bibbiena, il quale vedendo che 'l re Francesco non aveva cosa alcuna di marmo né antica né moderna, e se ne dilettava molto, aveva promesso a sua maestà di operare col Papa sì che qualche cosa bella gli manderebbe. Dopo questo cardinale vennero al Papa due ambasciadori dal re Francesco, i quali vedute le statue di Belvedere, lodarono quanto lodar si possa il Laoconte. Il cardinal de' Medici e Bibbiena che erano con loro, domandorono se il re arebbe cara una simile cosa; risposono che sarebbe troppo gran dono. Allora il cardinale gli disse: “A sua maestà si manderà o questo o un simile che non ci sarà differenza”. E risolutosi di farne fare un altro a immitazione di quello, si ricordò di Baccio, e mandato per lui lo domandò se gli bastava l'animo di fare un Laoconte pari al primo. Baccio rispose che non che farne un pari gli bastava l'animo di passare quello di perfezzione. Risolutosi il cardinale che vi si mettesse mano, Baccio mentre che i marmi ancora venivano, ne fece uno di cera, che fu molto lodato; et ancora ne fece un cartone di biacca e carbone della grandezza di quello di marmo. Venuti i marmi e Baccio avendosi fatto in Belvedere fare una turata con un tetto per lavorare, dette principio a uno de' putti del Laoconte, che fu il maggiore, e lo condusse di maniera, che 'l Papa e tutti quegli che se ne intendevano rimasono satisfatti, perché dall'antico al suo non si scorgeva quasi differenza alcuna. Ma avendo messo mano all'altro fanciullo et alla statua del padre, che è nel mezzo, non era ito molto avanti, quando morì il Papa. Creato di poi Adriano Sesto, se ne tornò col cardinale a Firenze, dove s'intratteneva intorno agli studi del disegno; morto Adriano VI e creato Clemente Settimo, andò Baccio in poste a Roma per giugnere alla sua incoronazione, nella quale fece statue e storie di mezzo rilievo per ordine di Sua Santità. Consegnategli di poi dal Papa stanze e provisione, ritornò al suo Laoconte, la quale opera con due anni di tempo fu condotta da lui con quella eccellenza maggiore che egli adoperasse già mai. Restaurò ancora l'antico Laoconte del braccio destro, il quale essendo tronco e non trovandosi, Baccio ne fece uno di cera grande che corrispondeva co' muscoli e con la fierezza e maniera all'antico e con lui s'univa di sorte, che mostrò quanto Baccio intendeva dell'ar-te, e questo modello gli servì a fare l'intero braccio al suo. Parve questa opera tanto buona a Sua Santità, che egli mutò pensiero et al re si risolvé mandare altre statue antiche e questa a Firenze, et al cardinale Silvio Passerino cortonese le-gato in Fiorenza, il quale allora governava la città, ordinò che ponesse il Laoconte nel palazzo de' Medici nella testa del secondo cortile, il che fu l'anno 1525. Arrecò questa opera gran fama a Baccio, il quale, finito il Laoconte, si dette a disegnare una storia in un foglio reale aperto per satisfare a un disegno del Papa, il quale era di far dipignere nella cappella maggiore di San Lorenzo di Firenze il martirio di San Cosimo e Damiano in una faccia, e nell'altra quello di San Lorenzo quando da Decio fu fatto morire su la graticola. Baccio addunque l'istoria di San Lorenzo disegnando sottilissimamente, nella quale immitò con molta ragione et arte vestiti et ignudi et atti diversi de' corpi e delle membra e varii esercizii di coloro che intorno a San Lorenzo stavano al crudele ufficio e particularmente l'empio Decio, che con minaccioso volto affretta il fuoco e la morte all'innocente martire, il quale alzando un braccio al cielo raccomanda lo spirito suo a Dio; così con questa storia satisfece tanto Baccio al Papa, che egli operò che Marcantonio Bolognese la 'ntagliasse in rame, il che da Marcantonio fu fatto con molta diligenza et il Papa donò a Baccio per ornamento della sua virtù un cavalier di San Piero. Dopo questo, tornatosene a Firenze, trovò Giovanfrancesco Rustici, suo primo maestro, dipigneva un'istoria d'una conversione di San Pagolo. Per la qual cosa prese a fare a concorrenza del suo maestro, in un cartone, una figura ignuda d'un San Giovanni giovane nel diserto, il quale tiene un agnello nel braccio sinistro et il destro alza al cielo. Fatto di poi fare un quadro, si messe a colorirlo e finito che fu, lo pose a mostra su la bottega di Michelagnolo suo padre, dirimpetto allo sdrucciolo che viene da Orsanmichele in Mercato Nuovo. Fu dagli artefici lodato il disegno, ma il colorito non molto, per avere del crudo e non con bella maniera dipinto, ma Baccio lo mandò a donare a papa Clemente, et egli lo fece porre in guardaroba, dove ancora oggi si trova.
Era fino al tempo di Leone X stato cavato a Carrara, insieme co' marmi della facciata di S. Lorenzo di Firenze, un altro pezzo di marmo alto braccia nove e mezzo e largo cinque braccia da piè. In questo marmo Michelagnolo Buonarroti aveva fatto pensiero di far un gigante in persona d'Ercole che uccidesse Cacco per metterlo in piazza a canto al Davitte gigante, fatto già prima da lui, per essere l'uno e l'altro Davitte et Ercole insegna del palazzo, e fattone più disegni e variati modelli, aveva cerco d'avere il favore di papa Leone e del cardinale Giulio de' Medici, perciò che diceva che quel Davitte aveva molti difetti causati da maestro Andrea scultore che l'aveva prima abbozzato e guasto. Ma per la morte di Leone rimase allora indietro la facciata di S. Lorenzo e questo marmo; ma di poi a papa Clemente essendo venuta nuova voglia di servirsi di Michelagnolo per le sepolture degli eroi di casa Medici, le quali voleva che si facessino nella sagrestia di San Lorenzo, bisognò di nuovo cavare altri marmi. Delle spese di queste opere teneva i conti e ne era capo Domenico Boninsegni; costui tentò Michelagnolo a far compagnia seco segretamente sopra del lavoro di quadro della facciata di San Lorenzo. Ma ricusando Michelagnolo e non piacendogli che la virtù sua s'adoperasse in defraudando il Papa, Domenico gli pose tanto odio, che sempre andava opponendosi alle cose sue per abbassarlo e noiarlo, ma ciò copertamente faceva. Operò addunque che la facciata si dimettesse e si tirasse innanzi la sagrestia, le quali dice-va che erano due opere da tenere occupato Michelagnolo molti anni. Et il marmo da fare il gigante persuase il Papa che si desse a Baccio, il quale allora non aveva che fare, dicendo che Sua Santità per questa concorrenza di due sì grandi uomini sarebbe meglio e con più diligenza e prestezza servita, stimolando l'emulazione l'uno e l'altro all'opera sua. Piacque il consiglio di Domenico al Papa, e secondo quello si fece. Baccio, ottenuto il marmo, fece un modello grande di cera che era Ercole, il quale avendo rinchiuso il capo di Cacco con un ginocchio tra due assi, col braccio sinistro lo strigneva con molta forza, tenendoselo sotto fra le gambe rannicchiato in attitudine travagliata, dove mostrava Cacco il patire suo e la violenza e 'l pondo d'Ercole sopra di sé, che gli faceva scoppiare ogni minimo muscolo per tutta la persona. Parimente Ercole con la testa chinata verso il nimico appresso e digrignando e strignendo i denti, alzava il braccio destro e con molta fierezza rompendogli la testa gli dava col bastone l'altro colpo. Inteso che ebbe Michelagnolo che 'l marmo era dato a Baccio, ne sentì grandissimo dispiacere, e per opera che facesse intorno a ciò, non potette mai volgere il Papa in contrario, sì fattamente gli era piaciuto il modello di Baccio, al quale s'aggiugnevano le promesse et i vanti, vantandosi lui di passare il Davitte di Michelagnolo et essendo ancora aiutato dal Boninsegni, il quale diceva che Michelagnolo voleva ogni cosa per sé. Così fu priva la città d'un ornamento raro, quale indubitatamente sarebbe stato quel marmo informato dalla mano del Buonarroto. Il sopra detto modello di Baccio si truova oggi nella guardaroba del duca Cosimo et è da lui tenuto carissimo e dagli artefici cosa rara.
Fu mandato Baccio a Carrara a veder questo marmo et a' capomaestri dell'Opera di Santa Maria del Fiore si dette commessione che lo conducessino per acqua insino a Signa su per lo fiume d'Arno. Quivi condotto il marmo vicino a Firenze a otto miglia, nel cominciare a cavarlo del fiume per condurlo per terra, essendo il fiume basso da Signa a Firenze, cadde il marmo nel fiume, e tanto per la sua grandezza s'affondò nella rena, che i capomaestri non potettero per ingegni che usassero trarnelo fuora; per la qual cosa, volendo il Papa che 'l marmo si riavesse in ogni modo, per ordine dell'Opera, Piero Rosselli murator vecchio et ingegnoso s'adoperò di maniera, che rivolto il corso dell'acqua per altra via e sgrottata la ripa del fiume, con lieve et argani smosso lo trasse d'Arno e lo pose in terra, e di ciò fu grandemente lodato. Da questo caso del marmo, invitati alcuni, feciono versi toscani e latini ingegnosamente mordendo Baccio, il quale per esser loquacissimo e dir male degli altri artefici e di Michelagnolo, era odiato. Uno tra gli altri prese questo suggetto ne' suoi versi, dicendo che 'l marmo, poi che era stato provato dalla virtù di Michelagnolo, conoscendo d'avere a essere storpiato dalle mani di Baccio, disperato per sì cattiva sorte, s'era gittato in fiume. Mentre che 'l marmo si trae-va dell'acqua e per la difficultà tardava l'effetto, Baccio misurando trovò che né per altezza, né per grossezza non si poteva cavarne le figure del primo modello, laonde, andato a Roma e portato seco le misure, fece capace il Papa, come era costretto dalla necessità a lasciare il primo e fare altro disegno. Fatti addunque più modelli, uno più degli altri ne piacque al Papa, dove Ercole aveva Cacco fra le gambe e presolo pe' capelli lo teneva sotto a guisa di prigione. Questo si risolverono che si mettesse in opera e si facesse. Tornato Baccio a Firenze, trovò che Piero Rosselli aveva condotto il marmo nell'Opera di Santa Maria del Fiore, il quale avendo posto in terra prima alcuni banconi di noce per lunghezza e spianati in isquadra, i quali andava tramutando secondo che camminava il marmo, sotto il quale poneva alcuni curri tondi e ben ferrati sopra detti banconi, e tirando il marmo con tre argani, a' quali l'aveva attaccato, a poco a poco lo condusse facilmente nell'Opera. Quivi rizzato il sasso, cominciò Baccio un modello di terra grande quanto il marmo, formato secondo l'ultimo fatto dinanzi in Roma da lui, e con molta diligenza lo finì in pochi mesi, ma con tutto questo non parve a molti artefici che in questo modello fusse quella fierezza e vivacità che ricercava il fatto, né quella che e-gl'aveva data a quel suo primo modello. Cominciando di poi a lavorare il marmo, lo scemò Baccio intorno intorno fino al bellico, scoprendo le membra dinanzi, considerando lui tuttavia di cavarne le figure che fussino appunto come quelle del modello grande di terra. In questo medesimo tempo aveva preso a fare di pittura una tavola assai grande per la chiesa di Cestello e n'aveva fatto un cartone molto bello, dentrovi Cristo morto e le Marie intorno e Niccodemo con altre figure, ma la tavola non dipinse per la cagione che di sotto diremo. Fece ancora in questo tempo un cartone per fare un quadro, dove era Cristo deposto di croce tenuto in braccio da Niccodemo e la madre sua in piedi che lo piangeva, et un Angelo che teneva in mano i chiodi e la corona delle spine; e subito messosi a colorirlo, lo finì prestamente e lo messe a mostra in Mercato Nuovo su la bottega di Giovanni di Goro orefice, amico suo, per intenderne l'opinione degli uomini e quel che Michelagnolo ne diceva. Fu menato a vederlo Michelagnolo dal Piloto orefice, il quale considerato che ebbe ogni cosa, disse che si maravigliava che Baccio sì buono disegnatore si lasciasse uscir di mano una pittura sì cruda e senza grazia; che aveva veduto ogni cattivo pittore condurre l'opere sue con miglior modo; e che questa non era arte per Baccio. Riferì il Piloto il giudizio di Michelagnolo a Baccio il quale, ancor che gli portasse odio, conosceva che diceva il vero. E certamente i disegni di Baccio erano bellissimi, ma co' colori gli conduceva male e senza grazia, per che egli si risolvé a non dipignere più di sua mano, ma tolse appresso di sé un giovane che maneggiava i colori assai acconciamente, chiamato Agnolo, fratello del Francia Bigio, pittore eccellente, che pochi anni innanzi era morto. A questo Agnolo disiderava di far condurre la tavola di Cestello, ma ella rimase imperfetta, di che fu cagione la mutazione dello stato in Firenze, la quale seguì l'anno 1527, quando i Medici si partirono di Firenze dopo il Sacco di Roma. Dove Baccio non si tenendo sicuro, avendo nimicizia particulare con un suo vicino alla villa di Pinzerimonte, il quale era di fazzion popolare, sotterrato che ebbe in detta villa alcuni cammei et altre figurine di bronzo antiche che erano de' Medici, se n'andò a stare a Lucca. Quivi s'intrattenne fino a tanto che Carlo V imperadore venne a ricevere la corona in Bologna; di poi fattosi vedere al Papa se n'andò seco a Roma, dove ebbe al solito le stanze in Belvedere. Dimorando quivi Baccio, pensò Sua Santità di satisfare a un voto il quale aveva fatto mentre che stette rinchiuso in Castel Sant'Agnolo; il voto fu di porre sopra la fine del torrione tondo di marmo, che è a fronte al ponte di Castello, sette figure grandi di bronzo di braccia sei l'una, tutte a giacere in diversi atti, come cinte da un Angelo, il quale voleva che posasse nel mezzo di quel torrione sopra una colonna di mischio et egli fusse di bronzo con la spada in mano. Per questa figura del-l'Angelo intendeva l'angelo Michele, custode e guardia del Castello, il quale col suo favore et aiuto l'aveva liberato e tratto di quella prigione, e per le sette figure a giacere poste significava i sette peccati mortali, volendo dire che con l'aiuto dell'Angelo vincitore aveva superati e gittati per terra i suoi nimici, uomini scelerati et empi, i quali si rappresentavano in quelle sette figure de' sette peccati mortali. Per questa opera fu fatto fare da Sua Santità un modello, il quale essendole piaciuto ordinò che Baccio cominciasse a fare le figure di terra grande quanto avevano a essere, per gittarle poi di bronzo. Cominciò Baccio e finì in una di quelle stanze di Belvedere una di quelle figure di terra, la quale fu molto lodata. Insieme ancora, per passarsi tempo e per vedere come gli doveva riuscire il getto, fece molte figurine alte due terzi e tonde come Ercoli, Venere, Apollini, Lede et altre sue fantasie, e fattele gittar di bronzo a maestro Iacopo della Barba fiorentino, riuscirono ottimamente. Di poi le donò a Sua Santità et a molti signori, delle quali ora ne sono alcune nello scrittoio del duca Cosimo, fra un numero di più di cento antiche, tutte rare, e d'altre moderne.
Aveva Baccio in questo tempo medesimo fatto una storia di figure piccole di basso e mezzo rilievo d'una Deposizione di croce, la quale fu opera rara e la fece con gran diligenza gettare di bronzo: così finita la donò a Carlo Quinto di Genova, il quale la tenne carissima e di ciò fu segno che sua maestà dette a Baccio una commenda di San Iacopo e lo fece cavaliere. Ebbe ancora dal principe Doria molte cortesie, e dalla republica di Genova gli fu allogato una statua di braccia sei di marmo, la quale doveva essere un Nettunno in forma del principe Doria, per porsi in su la piazza in memoria delle virtù di quel principe e de' benefizii grandissimi e rari, i quali la sua patria Genova aveva ricevuti da lui. Fu allogata questa statua a Baccio per prezzo di mille fiorini, de' quali ebbe allora cinquecento, e subito andò a Carrara per abbozzarla alla cava del Polvaccio.
Mentre che 'l governo popolare, dopo la partita de' Medici, reggeva Firenze, Michelagnolo Buonarroti fu adoperato per le fortificazioni della città, e fugli mostro il marmo che Baccio aveva scemato insieme col modello d'Ercole e Cacco, con intenzione che se il marmo non era scemato troppo, Michelagnolo lo pigliasse e vi facesse due figure a modo suo. Michelagnolo, considerato il sasso, pensò un'altra invenzione diversa, e lasciato Ercole e Cacco, prese Sansone che tenesse sotto due Filistei abbattuti da lui, morto l'uno del tutto e l'altro vivo ancora, al quale menando un marrovescio con una mascella di asino, cercasse di farlo morire. Ma come spesso avviene che gli umani pensieri talora si promettono alcune cose, il contrario delle quali è determinato dalla sapienza d'Iddio, così accade allora perché, venuta la guerra contro alla città di Firenze, convenne a Michelagnolo pensare ad altro che a pulir marmi, et ebbesi per paura de' cittadini a discostare dalla città. Finita poi la guerra e fatto l'accordo, papa Clemente fece tornare Michelagnolo a Firenze a finire la sagrestia di San Lorenzo e mandò Baccio a dar ordine di finire il gigante, il quale mentre che egli era intorno, aveva preso le stanze nel palazzo de' Medici, e per parere affezzionato scriveva quasi ogni settimana a Sua Santità entrando, oltre alle cose dell'arte, ne' particolari de' cittadini e di chi ministrava il governo, con uffici odiosi e da recarsi più malivolenza addosso che egli non aveva prima. Là dove al duca Alessandro tornato dalla corte di sua maestà in Firenze furono da' cittadini mostrati i sinistri modi che Baccio verso di loro teneva, onde ne seguì che l'opera sua del gigante gli era da' cittadini impedita e ritardata quanto da loro far si poteva. In questo tempo, dopo la guerra d'Ungheria, papa Clemente e Carlo imperadore abboccandosi in Bologna dove venne Ippolito de' Medici cardinale et il duca Alessandro, parve a Baccio d'andare a baciare i piedi a Sua Santità, e portò seco un quadro alto un braccio e largo uno e mezzo d'un Cristo battuto alla colonna da due ignudi, il quale era di mezzo rilievo e molto ben lavorato. Donò questo quadro al Papa, insieme con una medaglia del ritratto di Sua Santità, la quale aveva fatta fare a Francesco dal Prato suo amicissimo; il rovescio della quale medaglia era Cristo flagellato. Fu accetto il dono a Sua Santità, alla quale espose Baccio gl'impedimenti e le noie avute nel finire il suo Ercole, pregandola che col duca operasse di dargli commodità di condurlo al fine, et aggiugneva che era invidiato et odiato in quella città, et essendo terribile di lingua e d'ingegno, persuase il Papa a fare che 'l duca Alessandro si pigliasse cura che l'opera di Baccio si conducesse a fine e si ponesse al luogo suo in piazza.
Era morto Michelagnolo orefice, padre di Baccio, il quale avendo in vita preso a fare con ordine del Papa, per gli Operai di Santa Maria del Fiore, una croce grandissima d'argento tutta piena di storie di basso rilievo della passione di Cristo, della quale croce Baccio aveva fatto le figure e storie di cera per formarle d'argento, l'aveva Michelagnolo morendo lasciata imperfetta, et avendola Baccio in mano con molte libbre d'argento, cercava che Sua Santità desse a finire questa croce a Francesco dal Prato, che era andato seco a Bologna. Dove il Papa, considerando che Baccio voleva non solo ritrarsi delle fatture del padre, ma avanzare nelle fatiche di Francesco qualche cosa, ordinò a Baccio che l'argento e le storie abbozzate e le finite si dessino agli Operai e si saldasse il conto e che gli Operai fondessero tutto l'argento di detta croce, per servirsene ne' bisogni della chiesa stata spogliata de' suoi ornamenti nel tempo dell'assedio; et a Baccio fece dare fiorini cento d'oro e lettere di favore acciò tornando a Firenze desse compimento all'opera del gigante. Mentre che Baccio era in Bologna, il cardinale Doria lo 'ntese che egli era per partirsi di corto: per che trovatolo a posta, con molte grida e con parole ingiuriose lo minacciò, perciò che aveva mancato alla fede sua et al debito, non dando fine alla statua del principe Doria, ma lasciandola a Carrara abbozzata, avendone presi cinquecento scudi, per la qual cosa disse che se Andrea lo potesse avere in mano, gliene farebbe scontare alla galea. Baccio umilmente e con buone parole si difese, dicendo che aveva avuto giusto impedimento, ma che in Firenze aveva un marmo della medesima altezza, del quale aveva disegnato di cavarne quella figura, e che tosto cavata e fatta, la manderebbe a Genova. E seppe sì ben dire e raccomandarsi, che ebbe tempo a levarsi dinanzi al cardinale. Dopo questo, tornato a Firenze e fatto mettere mano allo imbasamento del gigante e lavorando lui di continovo l'anno 1534, lo finì del tutto. Ma il duca Alessandro, per la mala relazione de' cittadini, non si curava di farlo mettere in piazza. Era tornato già il Papa a Roma molti mesi innanzi e desiderando lui di fare per papa Leone e per sé nella Minerva due sepolture di marmo, Baccio presa questa occasione andò a Roma, dove il Papa si risolvé che Baccio facesse dette sepolture, dopo che avesse finito di mettere in piazza il gigante; e scrisse al Duca il Papa che desse ogni commodità a Baccio per porre in piazza il suo Ercole. Laonde fatto uno assito intorno, fu murato l'imbasamento di marmo, nel fondo del quale messono una pietra con lettere in memoria di papa Clemente VII e buon numero di medaglie con la testa di Sua Santità e del duca Alessandro. Fu cavato di poi il gigante dell'Opera, dove era stato lavorato, e per condurlo commodamente e senza farlo patire, gli feciono una travata intorno di legname, con canapi che l'inforcavano tra le gambe e corde che l'armavano sotto le braccia e per tutto; e così sospeso fra le trave in aria, sì che non toccasse il legname, fu con taglie et argani e da dieci paia di gioghi di buoi tirato a poco a poco fino in piazza. Dettono grande aiuto due legni grossi mezzi tondi, che per lunghezza erano a piè della travata confitti a guisa di basa, i quali posavano sopra altri legni simili insaponati, e questi erano cavati e rimessi da' manovali di mano in mano, secondo che la macchina camminava. Con questi ordini et ingegni fu condotto con poca fatica e salvo il gigante in piazza. Questa cura fu data a Baccio d'Agnolo et Antonio vecchio da San Gallo architettori dell'Opera, i quali di poi con altre travi e con taglie doppie lo messono sicuramente in su la basa. Non sarebbe facile a dire il concorso e la moltitudine che per due giorni tenne occupata tutta la piazza, venendo a vedere il gigante tosto che fu scoperto; dove si sentivano diversi ragionamenti e pareri d'ogni sorte d'uomini e tutti in biasimo dell'Opera e del maestro. Furono appiccati ancora intorno alla basa molti versi latini e toscani, ne' quali era piacevole a vedere gl'ingegni de' componitori e l'invenzioni et i detti acuti. Ma trapassandosi col dir male e con le poesie satiriche e mordaci ogni convenevole segno, il duca Alessandro, parendogli sua indegnità per essere l'opera pubblica, fu forzato a far mettere in prigione alcuni, i quali senza rispetto apertamente andavano appiccando sonetti, la qual cosa chiuse tosto le bocche de' maldicenti. Considerando Baccio l'opera sua nel luogo proprio, gli parve che l'aria poco la favorisse, facendo apparire i muscoli troppo dolci; però fatto rifare nuova turata d'asse intorno, le ritornò addosso cogli scarpelli et affondando in più luoghi i muscoli, ridusse le figure più crude che prima non erano. Scoperta finalmente l'opera del tutto, da coloro che possono giudicare è stata sempre tenuta, sì come difficile, così molto bene studiata e ciascuna delle parti attesa e la figura di Cacco ottimamente accomodata. E nel vero il Davitte di Michelagnolo toglie assai di lode all'Ercole di Baccio, essendogli a canto et essendo il più bel gigante che mai sia stato fatto, nel quale è tutta grazia e bontà, dove la maniera di Baccio è tutta diversa. Ma veramente considerando l'Ercole di Baccio da sé, non si può se non grandemente lodarlo e tanto più, vedendo che molti scultori di poi hanno tentato di far statue grandi e nessuno è arrivato al segno di Baccio; il quale se dalla natura avesse ricevuta tanta grazia et agevolezza, quanta da sé si prese fatica e studio, egli era nell'arte della scultura perfetto interamente.
Desiderando lui di sapere ciò che dell'opera sua si diceva, mandò in piazza un pedante, il quale teneva in casa, dicendogli che non mancasse di riferirgli il vero di ciò che udiva dire. Il pedante non udendo altro che male, tornato malinconoso a casa e domandato da Baccio, rispose che tutti per una voce biasimano i giganti e che e' non piacciono loro. “E tu che ne di'?”, disse Baccio. Rispose: “Dicone bene e che e' mi piacciono per farvi piacere”. “Non vo' ch'e' ti piacciano”, disse Baccio “e dì pur male ancora tu, che come tu puoi ricordarti, io non dico mai bene di nessuno. La cosa va del pari.” Dissimulava Baccio il suo dolore e così sempre ebbe per costume di fare, mostrando di non curare del biasimo che l'uomo alle sue cose desse. Nondimeno egli è verisimile che grande fusse il suo dispiacere, perché coloro che s'affaticano, per l'onore e di poi ne riportano biasimo, è da credere, ancor che indegno sia il biasimo et a torto, che ciò nel cuor segretamente gli affligga e di continovo gli tormenti. Fu racconsolato il suo dispiacere da una possessione, la quale oltre al pagamento gli fu data per ordine di papa Clemente. Questo dono doppiamente gli fu caro e per l'utile et entrata e perché era allato alla sua villa di Pinzerimonte, e perché era prima di Rignadori allora fatto ribello e suo mor-tale nimico, col quale aveva sempre conteso per conto de' confini di questo podere. In questo tempo fu scritto al duca Alessandro dal principe Doria che operasse con Baccio che la sua statua si finisse, ora che il gigante era del tutto finito, e che era per vendicarsi con Baccio se egli non faceva il suo dovere. Di che egli impaurito non si fidava d'andare a Carrara, ma pur dal cardinal Cibo e dal duca Alessandro assicurato v'andò, e lavorando con alcuni aiuti tirava innanzi la statua. Teneva conto giornalmente il principe di quanto Baccio faceva; onde, essendogli riferito che la statua non era di quella eccellenza che gli era stato promesso, fece intendere il principe a Baccio che se egli non lo serviva bene che si vendicherebbe seco. Baccio sentendo questo, disse molto male del principe, il che tornatogli all'orecchie, era risoluto d'averlo nelle mani per ogni modo e di vendicarsi col fargli gran paura della galea. Per la qual cosa vedendo Baccio alcuni spiamenti di certi che l'osservavano, entrato di ciò in sospetto, come persona accorta e risoluta, lasciò il lavoro così come era e tornossene a Firenze.
Nacque circa questo tempo a Baccio d'una donna, la quale egli tenne in casa, un figliuolo, al quale, essendo morto in que' medesimi giorni papa Clemente, pose nome Clemente per memoria di quel pontefice che sempre l'aveva amato e favorito. Dopo la morte del quale intese che Ippolito cardinale de' Medici, et Innocenzio cardinale Cibo, e Giovanni cardinale Salviati, e Niccolò cardinale Ridolfi, insieme con Messer Baldassarre Turini da Pescia, erano essecutori del testamento di papa Clemente e dovevano allogare le due sepolture di marmo di Leone e di Clemente da porsi nella Minerva, delle quali egli aveva già per addietro fatto i modelli. Queste sepolture erano state nuovamente promesse ad Alfonso Lombardi scultore ferrarese, per favore del cardinale de' Medici, del quale egli era servitore. Costui per consiglio di Michelagnolo avendo mutato invenzione, di già ne aveva fatto i modelli, ma senza contratto alcuno dell'allogagione e solo alla fede standosi, aspettava d'andare di giorno in giorno a Carrara per cavare i marmi. Così consumando il tempo, avvenne che il cardinale Ippolito nell'andare a trovare Carlo V, per viaggio morì di veleno. Baccio inteso questo, e senza metter tempo in mezzo andato a Roma, fu prima da madonna Lucrezia Salviata de' Medici, sorella di papa Leone, alla quale si sforzò di mostrare che nessuno poteva fare maggiore onore all'ossa di que' gran pontefici che la virtù sua, et aggiunse che Alfonso scultore era senza disegno e senza pratica e giudicio ne' marmi, e che egli non poteva se non con l'aiuto d'altri condurre sì onorata impresa. Fece ancora molte altre pratiche e per diversi mezzi e vie operò tanto, che gli venne fatto di rivolgere l'animo di que' signori, i quali finalmente dettono il carico al cardinale Salviati di convenire con Baccio. Era in questo tempo arrivato a Napoli Carlo V imperadore et in Roma Filippo Strozzi, Antonfrancesco degli Albizi e gli altri fuorusciti trattavano col cardinale Salviati d'andare a trovare sua maestà contro al duca Alessandro, et erano col cardinale a tutte l'ore nelle sale e nelle camere del quale stava Baccio tutto il giorno aspettando di fare il contratto delle sepolture, né poteva venire a capo per gl'impedimenti del cardinale nella spedizione de' fuorusciti. Costoro vedendo Baccio tutto il giorno e la sera in quelle stanze, insospettiti di ciò e dubitando ch'egli stesse quivi per ispiare ciò che essi facevano per darne avviso al duca, s'accordorono alcuni de' loro giovani a codiarlo una sera e levarnelo dinanzi. Ma la fortuna soccorrendo in tempo, fece che gli altri due cardinali con Messer Baldassarre da Pescia presono a finire il negozio di Baccio. I quali conoscendo che nell'architettura Baccio valeva poco, avevano fatto fare a Antonio da S. Gallo un disegno che piaceva loro, et ordinato che tutto il lavoro di quadro da farsi di marmo lo dovesse far condurre Lorenzetto scultore, e che le statue di marmo e le storie s'allogassino a Baccio. Convenuti addunque in questo modo, feciono finalmente il contratto con Baccio, il quale non comparendo più intorno al cardinal Salviati e levatosene a tempo, i fuorusciti, passata quell'occasione, non pensorono ad altro del fatto suo. Dopo queste cose, fece Baccio due modelli di legno con le statue e storie di cera, i quali avevano i basamenti sodi senza risalti, sopra ciascuno de' quali e-rano quattro colonne ioniche storiate, le quali spartivano tre vani, uno grande nel mezzo, dove sopra un piedistallo era per ciascuna un papa a sedere in pontificale che dava la benedizzione e ne' vani minori una nicchia con una figura tonda in piè, per ciascuna alta quattro braccia, e dentro alcuni Santi che mettono in mezzo detti papi. L'ordine della composizione aveva forma d'arco trionfale, e sopra le colonne che reggevano la cornice era un quadro alto braccia tre e largo quattro e mezzo, entro al quale era una storia di mezzo rilievo in marmo, nella quale era l'abboccamento del re Francesco a Bologna, sopra la statua di papa Leone, la quale statua era messa in mezzo nelle due nicchie da S. Piero e da S. Paulo, e di sopra accompagnavano la storia del mezzo di Leone due altre storie minori, delle quali una era sopra S. Pie-ro e quando egli risuscita un morto, e l'altra sopra S. Paulo, quando e' predica a' popoli. Ne l'istoria di papa Clemente, che rispondeva a questa, era quando egli incorona Carlo imperadore a Bologna e la mettono in mezzo due storie minori, in una è S. Giovanni Batista che predica a' popoli, nell'altra S. Giovanni Evangelista che risuscita Drusiana, et hanno sotto nelle nicchie i medesimi Santi alti braccia quattro, che mettono in mezzo la statua di papa Clemente simile a quella di Leone. Mostrò in questa fabbrica Baccio o poca religione, o troppa adulazione, o l'uno e l'altro insieme, mentre che gli uomini deificati et i primi fondatori della nostra religione, dopo Cristo et i più grati a Dio, vuole che cedino a' nostri papi e gli pone in luogo a loro indegno, a Leone e Clemente inferiori. E certo sì come da dispiacere a' Santi et a Dio, così da non piacere a' papi et agli altri, fu questo suo disegno. Perciò che a me pare che la religione, e voglio dire la nostra sendo vera religione, debba esser dagli uomini a tutte l'altre cose e rispetti preposta. E dall'altra parte volendo lodare et onorare qualunche persona, giudico che bisogni raffrenarsi e temperarsi e talmente dentro a certi termini contenersi, che la lode e l'onore non diventi un'altra cosa, dico imprudenza et adulazione, la quale prima il lodator vituperi e poi al lodato, se egli ha sentimento, non piaccia tutta il contrario. Facendo Baccio di questo che io dico, fece conoscere a ciascuno che egli aveva assai affezzione sì bene e buona volontà verso i papi, ma poco giudicio nell'esaltargli et onorargli ne' loro sepolcri.
Furono i sopra detti modelli portati da Baccio a Monte Cavallo a Sant'Agata, al giardino del cardinale Ridolfi, dove sua signoria dava desinare a Cibo et a Salviati et a Messer Baldassarre da Pescia, ritirati quivi insieme per dar fine a quanto bisognava per le sepolture. Mentre addunque che erano a tavola, giunse il Solosmeo scultore, persona ardita e piacevole, e che diceva male d'ognuno volentieri et era poco amico di Baccio. Fu fatto l'imbasciata a que' signori che il Solosmeo chiedeva d'entrare, Ridolfi disse che gli si aprisse e volto a Baccio: “Io voglio”, disse, “che noi sentiamo ciò che dice il Solosmeo dell'allogagione di queste sepolture; alza Baccio quella portiera e stavvi sotto”. Subito ubbidì Baccio, et arrivato il Solosmeo e fattogli dare da bere, entrorono dipoi nelle sepolture allogate a Baccio, dove il Solosmeo riprendendo i cardinali che male l'avevano allogate, seguitò dicendo ogni male di Baccio, tassandolo d'ignoranza nel-l'arte e d'avarizia e d'arroganza, et a molti particulari venendo de' biasimi suoi. Non poté Baccio, che stava nascosto dietro alla portiera, sofferir tanto che 'l Solosmeo finisse, et uscito fuori in còllora e con mal viso, disse al Solosmeo: “Che t'ho io fatto, che tu parli di me con sì poco rispetto?”. Ammutolì all'apparire di Baccio il Solosmeo e volto a Ridolfi disse: “Che baie son queste, monsignore? Io non voglio più pratica di preti”, et andossi con Dio. Ma i cardinali ebbero da ridere assai dell'uno e dell'altro, dove Salviati disse a Baccio: “Tu senti il giudicio degli uomini dell'arte; fa tu con l'ope-rar tuo sì che tu gli faccia dire le bugie”. Cominciò poi Baccio l'opera delle statue e delle storie, ma già non riuscirono i fatti secondo le promesse e l'obbligo suo con que' papi, perché nelle figure e nelle storie usò poca diligenza e mal finite le lasciò e con molti difetti, sollecitando più il riscuotere l'argento che il lavorare il marmo. Ma poiché que' signori s'avveddono del procedere di Baccio, pentendosi di quel che avevano fatto, essendo rimasti due pezzi di marmi maggiori delle due statue che mancavano a farsi, una di Leone a sedere e l'altra di Clemente, pregandolo che si portasse meglio, ordinorono che le finisse; ma avendo Baccio levata già tutta la somma de' danari, fece pratica con Messer Giovambattista da Ricasoli, vescovo di Cortona, il quale era in Roma per negozii del duca Cosimo, di partirsi di Roma per andare a Firenze a servire il duca Cosimo nelle fonte di Castello sua villa, e nella sepoltura del signor Giovanni suo padre. Il duca avendo risposto che Baccio venisse, egli se n'andò a Firenze lasciando senza dir altro l'opera delle sepolture imperfetta e le statue in mano di due garzoni. I cardinali vedendo questo feciono allogagione di quelle due statue de' papi che erano rimaste a due scultori: l'uno fu Raffaello da Montelupo, che ebbe la statua di papa Leone, l'altro Giovanni di Baccio, al quale fu data la statua di Clemente. Dato di poi ordine che si murasse il lavoro di quadro e tutto quel che era fatto, si messe su l'opera, dove le statue e le storie non erano in molti luoghi né impomiciate né pulite, sì che dettono a Baccio più carico che nome.
Arrivato Baccio a Firenze, e trovato che 'l Duca aveva mandato il Tribolo scultore a Carrara per cavar marmi per le fonti di Castello e per la sepoltura del signor Giovanni, fece tanto Baccio col Duca, che levò la sepoltura del signor Giovanni delle mani del Tribolo, mostrando a sua eccellenza che i marmi per tale opera erano gran parte in Firenze; così a poco a poco si fece famigliare di sua eccellenza, sì che per questo e per la sua alterigia ognuno di lui temeva. Messe di poi innanzi al Duca che la sepoltura del signor Giovanni si facesse in San Lorenzo nella cappella de' Neroni, luogo stretto, affogato e meschino, non sapendo o non volendo proporre (sì come si conveniva) a un principe sì grande che facesse una cappella di nuovo a posta. Fece ancora sì che 'l Duca chiese a Michelagnolo per ordine di Baccio molti marmi, i quali egli aveva in Firenze, et ottenutigli il Duca da Michelagnolo e Baccio dal Duca, tra' quali marmi erano alcune bozze di figure et una statua assai tirata innanzi da Michelagnolo, Baccio preso ogni cosa, tagliò e tritò in pezzi ciò che trovò, parendogli in questo modo vendicarsi e fare a Michelagnolo dispiacere. Trovò ancora nella stanza medesima di San Lorenzo, dove Michelagnolo lavorava, dua statue in un marmo d'un Ercole che strigneva Anteo, le quali il Duca faceva fare a fra' Giovannagnolo scultore, et erano assai innanzi, e dicendo Baccio al Duca che il frate aveva guasto quel marmo, ne fece molti pezzi. In ultimo della sepoltura murò tutto l'imbasamento, il quale è un dado isolato di braccia quattro incirca per ogni verso, et ha da piè un zoccolo con una modanatura a uso di basa che gira intorno intorno e con una cimasa nella sua sommità, come si fa ordinariamente a' piedistalli, e sopra una gola alta tre quarti, che va in dentro sgusciata a rovescio a uso di fregio, nella quale sono intagliate alcune ossature di teste di cavalli legate con panni l'una all'altra, dove in cima andava un altro dado minore, con una statua a sedere armata all'antica di braccia quattro e mezzo con un bastone in mano da condottieri d'eserciti, la quale doveva essere fatta per la persona dell'invitto signor Giovanni de' Medici. Questa statua fu cominciata da lui in un marmo et assai condotta innanzi, ma non mai poi finita, né posta sopra il basamento murato. Vero è che nella facciata dinanzi finì del tutto una storia di mezzo rilievo di marmo, dove di figure alte due braccia incirca fece il signor Giovanni a sedere, al quale sono menati molti prigioni in-torno e soldati e femmine scapigliate et ignudi, ma senza invenzione e senza mostrare affetto alcuno. Ma pur nel fine della storia è una figura che ha un porco in su la spalla e dicono essere stata fatta da Baccio per Messer Baldassarre da Pescia in suo dispregio, il quale Baccio teneva per nimico, avendo Messer Baldassarre in questo tempo fatto l'alloga-gione (come s'è detto di sopra) delle due statue di Leone e Clemente ad altri scultori, e di più avendo di maniera operato in Roma, che Baccio ebbe per forza a rendere con suo disagio i danari, i quali aveva soprappresi per quelle statue e figure.
In questo mezzo non aveva Baccio atteso mai ad altro che a mostrare al duca Cosimo quanto fusse la gloria degli antichi vissuta per le statue e per le fabbriche, dicendo che sua eccellenza doveva pe' tempi a venire procacciarsi la memoria perpetua di se stesso e delle sue azzioni. Avendo poi già condotto la sepoltura del signor Giovanni vicino al fine, andò pensando di fare cominciare al Duca un'opera grande e di molta spesa e di lunghissimo tempo. Aveva il duca Cosimo lasciato d'abitare il palazzo de' Medici et era tornato ad abitare con la corte nel palazzo di piazza, dove già abitava la signoria, e quello ogni giorno andava accomodando et ornando, et avendo detto a Baccio che farebbe volentieri un'udienza pubblica, sì per gli ambasciadori forestieri come pe' suoi cittadini e sudditi dello stato, Baccio andò, insieme con Giuliano di Baccio d'Agnolo, pensando di mettergli innanzi da far un ornamento di pietre del Fossato e di marmi, di braccia trenta otto largo et alto diciotto. Questo ornamento volevano che servisse per l'udienza e fusse nella sala grande del palazzo in quella testa che è volta a tramontana. Questa udienza doveva avere un piano di quattordici braccia largo e salire sette scaglioni et essere nella parte dinanzi chiusa da balaustri, eccetto l'entrata del mezzo, e doveva avere tre archi grandi nella testa della sala, de' quali due servissino per finestre e fussino tramezzati drento da quattro colonne per ciascuno, due della pietra del Fossato e due di marmo, con un arco sopra con fregiatura di mensole che girasse in tondo: queste avevano a fare l'ornamento di fuori nella facciata del palazzo e di dentro ornare nel medesimo modo la facciata della sala. Ma l'arco del mezzo, che faceva non finestra ma nicchia, doveva essere accompagnato da due altre nicchie simili, che fussino nelle teste dell'udienza, una a levante e l'altra a ponente, ornate da quattro colonne tonde corinzie, che fussino braccia dieci alte e facessino risalto nelle teste. Nella facciata del mezzo avevano a essere quattro pilastri, che fra l'uno arco e l'altro facessino reggimento allo architrave e fregio e cornice, che rigirava intorno intorno e sopra loro e sopra le colonne. Questi pilastri avevano avere fra l'uno e l'altro un vano di braccia tre incirca, nel quale per ciascuno fusse una nicchia alta braccia quattro e mezzo da mettervi statue per accompagnare quella grande del mezzo nella faccia e le due dalle bande, nelle quali nicchie egli voleva mettere per ciacuna tre statue. Avevano in animo Baccio e Giuliano, oltre allo ornamento della facciata di dentro, un altro maggiore ornamento di grandezza e di terribile spesa per la facciata di fuora, il quale per lo sbieco della sala, che non è in squadra, dovesse mettere in squadra dalla banda di fuora; e fece un risalto di braccia sei intorno intorno alle facciate del palazzo vecchio, con un ordine di colon-ne di quattordici braccia alte, che reggessino altre colonne, fra le quale fussino archi e di sotto intorno intorno facesse loggia, dove è la ringhiera et i giganti, e di sopra avesse poi un altro spartimento di pilastri, fra' quali fussino archi nel medesimo modo e venisse attorno attorno le finestre del palazzo vecchio a far facciata intorno intorno al palazzo, e sopra questi pilastri fare a uso di teatro, con un altro ordine d'archi e di pilastri, tanto che il ballatoio di quel palazzo facesse cornice ultima a tutto questo edifizio. Conoscendo Baccio e Giuliano che questa era opera di grandissima spesa, consultorono insieme di non dovere aprire al Duca il lor concetto, se non dell'ornamento della udienza dentro alla sala e della facciata di pietre del Fossato di verso la piazza, per la lunghezza di ventiquattro braccia, che tanto è la larghezza della sala. Furono fatti di questa opera disegni e piante da Giuliano, e Baccio poi parlò, con essi in mano, al Duca: al quale mostrò che nelle nicchie maggiori dalle bande voleva fare statue di braccia quattro di marmo a sedere sopra alcuni basamenti, cioè Leone Decimo che mostrasse mettere la pace in Italia e Clemente Settimo che incoronasse Carlo Quinto, con due statue in nicchie minori drento alle grandi intorno a' papi, le quali significassino le loro virtù adoperate e messe in atto da loro. Nella facciata del mezzo, nelle nicchie di braccia quattro, fra i pilastri voleva fare statue ritte del signor Giovanni, del duca Alessandro e del duca Cosimo, con molti ornamenti di varie fantasie d'intagli et uno pavimento tutto di marmi di diversi colori mischiati. Piacque molto al Duca questo ornamento, pensando che con questa occasione si dovesse col tempo (come s'è fatto poi) ridurre a fine tutto il corpo di quella sala, col resto degli ornamenti e del palco, per farla la più bella stanza d'Italia. E fu tanto il desiderio di sua eccellenza che questa opera si facesse, che assegnò per condurla ogni settimana quella somma di danari che Baccio voleva e chiedeva; e fu dato principio che le pietre del Fossato si cavassino e si lavorassino, per farne l'ornamento del basamento e colonne e cornici, e tutto volle Baccio che si facesse e conducesse dagli scarpellini dell'Opera di Santa Maria del Fiore.
Fu certamente questa opera da que' maestri lavorata con diligenza, e se Baccio e Giuliano l'avessino sollecitata, arebbono tutto l'ornamento delle pietre finito e murato presto; ma perché Baccio non attendeva se non a fare abbozzare statue e finire poche del tutto, et a riscuotere la sua provvisione che ogni mese gli dava il Duca e gli pagava gli aiuti et ogni minima spesa che per ciò faceva, con dargli scudi cinquecento dell'una delle statue di marmo finite, perciò non si vedde mai di questa opera il fine. Ma se con tutto questo Baccio e Giuliano, in un lavoro di tanta importanza, avessino messo la testa di quella sala in isquadra come si poteva, che delle otto braccia che aveva di bieco si ritirorono appunto alla metà, et èvvi in qualche parte mala proporzione come la nicchia del mezzo e le due dalle bande maggiori che son nane, et i membri delle cornici gentili a sì gran corpo, e se, come potevano, si fussino tenuti più alti con le colonne, con dar maggior grandezza e maniera et altra invenzione a quella opera, e se pur con la cornice ultima andavano a trovare il piano del primo palco vecchio di sopra, eglino arebbono mostro maggior virtù e giudizio né si sarebbe tanta fatica spesa invano, fatta così inconsideratamente, come hanno visto poi coloro a chi è tocco a rassettarla, come si dirà, et a finirla, perché con tutte le fatiche e studii adoperati dappoi vi sono molti disordini et errori nella entrata della porta e nelle corrispondenze delle nicchie delle facce, dove poi a molte cose è bisognato mutare forma. Ma non s'è già potuto mai, se non si disfaceva il tutto, rimediare che ella non sia fuor di scquadra e non lo mostri nel pavimento e nel palco. Vero è che nel modo che essi la posono, così come ella si truova, vi è gran fattura e fatica e merita lode assai per molte pietre lavorate col calandrino che sfuggono a quartabuono per cagione dello sbiecare della sala; ma di diligenza e d'essere be-ne murate, commesse e lavorate non si può fare né veder meglio. Ma molto meglio sarebbe riuscito il tutto se Baccio, che non tenne mai conto dell'architettura, si fusse servito di qualche migliore giudizio che di Giuliano, il quale, se bene era buono maestro di legname et intendeva d'architettura, non era però tale che a sì fatta opera, come quella sera, egli fusse atto, come ha dimostrato l'esperienza. Imperò tutta questa opera s'andò per ispazio di molti anni lavorando e murando poco più che la metà, e Baccio finì e messe nelle nicchie minori la statua del signor Giovanni e quella del duca Alessandro nella facciata dinanzi amendue e nella nicchia maggiore, sopra un basamento di mattoni, la statua di papa Clemente e tirò al fine ancora la statua del duca Cosimo, dove egli s'affaticò assai sopra la testa, ma con tutto ciò il Duca e gli uomini di corte dicevano che ella non lo somigliava punto. Onde avendone Baccio già prima fatto una di marmo, la quale è oggi nel medesimo palazzo nelle camere di sopra, e fu la migliore testa che facesse mai, e stette benissimo, egli difendeva e ricuopriva l'errore e la cattività della presente testa con la bontà della passata. Ma sentendo da ognuno biasimare quella testa, un giorno in còllora la spiccò, con animo di farne un'altra e commetterla nel luogo di quella, ma non la fece poi altrimenti. Et aveva Baccio per costume nelle statue ch'e' faceva di mettere de' pezzi piccoli e grandi di marmo, non gli dando noia il fare ciò e ridendosene, il che egli fece nell'Orfeo a una delle teste di Cerbero, et a San Piero che è in Santa Maria del Fiore rimesse un pezzo di panno; nel gigante di piazza, come si vede, rimesse a Cacco et appiccò due pezzi, cioè una spalla et una gamba, et in molti altri suoi lavori fece il medesimo, tenendo cotali modi i quali sogliono grandemente dannare gli scultori. Finite queste statue, messe mano alla statua di papa Leone per questa opera e la tirò forte innanzi. Vedendo poi Baccio che questa opera riusciva lunga e che e' non era per condursi oramai al fine di quel suo primo disegno per le facciate attorno attorno al palazzo e che e' s'era speso gran somma di danari e passato molto tempo, e che quella opera con tutto ciò non era mezza finita e piaceva poco all'universale, andò pensando nuova fantasia et andava provando di levare il Duca dal pensiero del palazzo, parendogli che sua eccellenza ancora fusse di questa opera infastidita. Avendo egli addunque, nell'Opera di Santa Maria del Fiore che la comandava, fatto nimicizia co' provveditori e con tutti gli scarpellini, e poiché tutte le statue che andavan nell'udienza erano a suo modo quali finite e poste in opera e quali abbozzate e lo ornamento murato in gran parte, per occultare molti difetti che v'erano, et a poco a poco abbandonare quell'opera, messe innanzi Baccio al Duca che l'Opera di Santa Maria del Fiore gittava via i danari, né faceva più cosa di momento. Onde disse avere pensato che sua eccellenza farebbe bene a far voltare tutte quelle spese dell'opera inutili a fare il coro a otto facce della chiesa e l'ornamento dello altare, scale, residenze del Duca e magistrati, e delle sedie del coro pe' canonici e cappellani e clerici, secondo che a sì onorata chiesa si conveniva. Del quale coro Filippo di ser Brunellesco aveva lasciato il modello in quel semplice telaio di legno, che prima serviva per coro in chiesa, con intenzione di farlo col tempo di marmo con la medesima forma, ma con maggiore ornamento. Considerava Baccio, oltre alle cose sopra dette, che egli arebbe occasione in questo coro di fare molte statue e storie di marmo e di bronzo nell'altare maggiore et intorno al coro, et ancora in due pergami che dovevano essere di marmo nel coro, e che le otto facce nelle parti di fuora si potevano nel basamento ornare di molte storie di bronzo commesse nello ornamento di marmo. Sopra questo pensava di fare un ordine di colonne e di pilastri che reggessino attorno attorno le cornice e quattro archi; de' quali archi divisati secondo la crocera della chiesa, uno facesse l'entrata principale, col quale si riscontrasse l'arco dell'altare maggiore posto sopra esso altare, e gli altri due fussino da' lati, da man destra uno e l'altro da man sinistra, sotto i quali due da' lati dovevano essere posti i pergami; sopra la cornice uno ordine di balaustri in cima, che girassino le otto facce, e sopra i balaustri una grillanda di candelieri, per quasi incoronare di lumi il coro secondo i tempi, come sempre s'era costumato innanzi, mentre che vi fu il modello di legno del Brunellesco. Tutte queste cose mostrando Baccio al Duca, diceva che sua eccellenza con l'entrata dell'Opera, cioè di S. Maria del Fiore e delli Operai di quella, e con quello che ella per sua liberalità aggiugnerebbe, in poco tempo addornerebbe quel tempio e gli acquisterebbe molta grandezza e magnificenza e conseguentemente a tutta la città, per essere lui di quella il principale tempio e lascerebbe di sé in cotal fabbrica eterna et onorata memoria; et oltre a tutto questo (diceva) che sua eccellenza darebbe occasione a lui d'affaticarsi e di fare molte buone opere e belle, e mostrando la sua virtù, d'acquistarsi nome e fama ne' posteri, il che doveva essere caro a sua eccellenza, per essere lui suo servitore et allevato della casa de' Medici. Con questi disegni e parole mosse Baccio il Duca, sì che gl'impose che egli facesse un modello di tutto il coro, consentendo che cotal fabbrica si facesse. Partito Baccio dal Duca, fu con Giuliano di Baccio d'Agnolo suo architetto e, conferito il tutto seco, andorono in sul luogo, et esaminata ogni cosa diligentemente, si risolverono di non uscire della forma del modello di Filippo, ma di seguitare quello, aggiugnendogli solamente altri ornamenti di colonne e di risalti e d'arricchirlo quanto potevano più, mantenendogli il disegno e la figura di prima. Ma non le cose assai et i molti ornamenti son quelli che abbelliscono et arricchiscono le fabbriche, ma le buone, quantunque sieno poche, se sono ancora poste ne' luoghi loro e con la debita proporzione composte insieme; queste piacciono e sono ammirate e fatte con giudizio dall'artefice, ricevono di poi lode da tutti gli altri. Questo non pare che Giuliano e Baccio considerassino, né osservassino, perché presono un suggetto di molta opera e lunga fatica, ma di poca grazia, come ha l'esperienza dimostro. Il disegno di Giuliano (come si vede) fu di fare nelle cantonate di tutte le otto facce pilastri che piegavano in su gli angoli, e l'opera tutta di componimento ionico, e questi pilastri, perché nella pianta venivano insieme con tutta l'ope-ra a diminuire verso il centro del coro e non erano uguali, venivano necessariamente a essere larghi dalla parte di fuora e stretti di dentro, il che è sproporzione di misura. E ripiegando il pilastro secondo l'angolo delle otto facce di dentro, le linee del centro lo diminuivano tanto, che le due colonne, le quali mettevono in mezzo il pilastro da' canti, lo facevano parere sottile et accompagnavano con disgrazia lui e tutta quell'opera, sì nella parte di fuora e simile in quella di dentro, ancora che vi fosse la misura. Fece Giuliano parimente tutto il modello dello altare, discosto un braccio e mezzo dal-l'ornamento del coro, sopra il quale Baccio fece poi di cera un Cristo morto a giacere con due Angeli, de' quali uno gli teneva il braccio destro e con un ginocchio gli reggeva la testa, e l'altro teneva i misteri della Passione, et occupava la statua di Cristo quasi tutto lo altare, sì che appena celebrare vi si sarebbe potuto, e pensava di fare questa statua di circa quattro braccia e mezzo. Fece ancora un risalto d'uno piedistallo dietro all'altare appiccato con esso nel mezzo con un sedere, sopra il quale pose poi un Dio Padre a sedere, di braccia sei, che dava la benedizzione e veniva accompagnato da due altri Angeli di braccia quattro l'uno, che posavano ginocchione in su' canti e fine della predella dell'altare, al pari dove Dio Padre posava i piedi. Questa predella era alta più d'un braccio, nella quale erano molte storie della Passione di Gesù Cristo, che tutte dovevano essere di bronzo; in su' canti di questa predella erano gli Angeli sopra detti, tutti e due ginocchione e tenevano ciascuno in mano un candelliere, i quali candellieri delli Angeli accompagnavano otto candellieri grandi alti braccia tre e mezzo, che ornavano quello altare, posti fra gli Angeli, e Dio Padre era nel mezzo di loro; rimaneva un vano d'un mezzo braccio dietro al Dio Padre, per potere salire e accendere i lumi. Sotto l'arco, che faceva riscontro all'entrata principale del coro, sul basamento che girava intorno, dalla banda di fuora aveva posto nel mezzo sotto detto arco l'albero del peccato, al tronco del quale era avvolto l'antico serpente con la faccia umana in cima e due figure ignude erano intorno all'albero, che una era Adamo e l'altra Eva. Dalla banda di fuora del coro, dove dette figure voltavano le facce, era per lunghezza nell'imbasamento un vano lungo circa tre braccia, per farvi una storia o di marmo
o di bronzo della loro creazione; per seguitare nelle facce de' basamenti di tutta quell'opera insino al numero di ventuno storie tutte del Testamento Vecchio, e per maggiore ricchezza di questo basamento ne' zoccoli, dove posavano le colonne et i pilastri, aveva per ciascuno fatto una figura o vestita o nuda per alcuni Profeti per farli poi di marmo: opera certo et occasione grandissima e da poter mostrare tutto l'ingegno e l'arte d'un perfetto maestro, del quale non dovesse mai per tempo alcuno spegnersi la memoria. Fu mostro al Duca questo modello et ancora doppi disegni fatti da Baccio, i quali sì per la varietà e quantità, come ancora per la loro bellezza, perciò che Baccio lavorava di cera fieramente e disegnava bene, piacquero a sua eccellenza, et ordinò che si mettesse subito mano al lavoro di quadro, voltandovi tutte le spese che faceva l'Opera et ordinando che gran quantità di marmi si conducessino da Carrara. Baccio ancora egli cominciò a dare principio alle statue, e le prime furono uno Adamo che alzava un braccio et era grande quattro braccia in circa. Questa figura fu finita da Baccio, ma perché gli riuscì stretta ne' fianchi et in altre parti con qualche difetto, la mutò in uno Bacco, il quale dette poi al Duca et egli lo tenne in camera molti anni nel suo palazzo, e fu posto poi, non è molto, nelle stanze terrene, dove abita il principe la state, dentro a una nicchia. Aveva parimente fatto della medesima grandezza un'Eva che sedeva, la quale condusse fino alla metà e restò indietro per cagione dello Adamo, il quale ella doveva accompagnare. Et avendo dato principio a un altro Adamo di diversa forma et attitudine, gli bisognò mutare ancora Eva; e la prima che sedeva fu convertita da lui in una Cerere e la dette all'illustrissima duchessa Leonora in compagnia d'uno Appollo, che era un altro ignudo che egli aveva fatto, e sua eccellenza lo fece mettere nella facciata del vivaio che è nel giardino de' Pitti col disegno et architettura di Giorgio Vasari. Seguitò Baccio queste due figure di Adamo e d'Eva con grandissima volontà, pensando di satisfare all'universale et agli artefici, avendo satisfatto a se stesso, e le finì e lustrò con tutta la sua diligenza et affezzione; messe di poi queste figure d'Adamo e d'Eva nel luogo loro e scoperte ebbero la medesima fortuna che l'altre sue cose e furono con sonetti e con versi latini troppo crudelmente lacerate: avvenga che il senso di uno diceva che sì come Adamo et Eva, avendo con la loro disubbidienza vituperato il paradiso, meritorono d'essere cacciati, così queste figure vituperando la terra, meritano d'essere cacciate fuora di chiesa. Nondimeno le statue sono proporzionate et hanno molte belle parti, e se non è in loro quella grazia che altre volte s'è detto e che egli non poteva dare alle cose sue, hanno però arte e disegno tale, che meritano lode assai.
Fu domandata una gentildonna, la quale s'era posta a guardare queste statue, da alcuni gentiluomini, quello che le paresse di questi corpi ignudi. Rispose: “Degli uomini non posso dare giudizio”, et essendo pregata che della donna dicesse il parer suo, rispose che le pareva che quella Eva avesse due buone parti da essere commendata assai, perciò che ella è bianca e soda; ingegnosamente mostrando di lodare, biasimò copertamente e morse l'artefice e l'artifizio suo, dando alla statua quelle lode proprie de' corpi femminili, le quali è necessario intendere della materia del marmo e di lui son vere, ma dell'opera e dell'artifizio no, perciò che l'artifizio quelle lode non lodano. Mostrò addunque quella valente donna che altro non si poteva secondo lei lodare in quella statua se non il marmo.
Messe di poi mano Baccio alla statua di Cristo morto, il quale ancora non gli riuscendo come se l'era proposto, essendo già innanzi assai, lo lasciò stare, e preso un altro marmo ne cominciò un altro con attitudine diversa dal primo, et insieme con l'Angelo che con una gamba sostiene a Cristo la testa e con la mano un braccio, e' non restò che l'una e l'al-tra figura finì del tutto, e dato ordine di porlo sopra l'altare, riuscì grande di maniera che, occupando troppo del piano, non avanzava spazio all'operazioni del sacerdote. Et ancora che questa statua fusse ragionevole e delle migliori di Baccio, nondimeno non si poteva saziare il popolo di dirne male e di levarne i pezzi, non meno tutta l'altra gente che i preti.
Conoscendo Baccio che lo scoprire l'opere imperfette nuoce alla fama degli artefici nel giudizio di tutti coloro i quali o non sono della professione, o non se n'intendono, o non hanno veduto i modelli, per accompagnare la statua di Cristo e finire l'altare, si risolvé a fare la statua di Dio Padre, per la quale era venuto un marmo da Carrara bellissimo. Già l'ave-va condotto assai innanzi, e fatto mezzo ignudo a uso di Giove, quando non piacendo al Duca, et a Baccio parendo ancora che egli avesse qualche difetto, lo lasciò così come s'era e così ancora si truova nell'Opera.
Non si curava del dire delle genti, ma attendeva a farsi ricco et a comprare possessioni. Nel poggio di Fiesole comperò un bellissimo podere chiamato lo Spinello, e nel piano sopra San Salvi sul fiume d'Affrico un altro con bellissimo casamento, chiamato il Cantone, e nella via de' Ginori una gran casa, la quale il Duca con danari e favori gli fece avere; ma Baccio avendo acconcio lo stato suo, poco si curava oramai di fare, d'affaticarsi, et essendo la sepoltura del signor Giovanni imperfetta, e l'udienza della sala cominciata, et il coro, e l'altare addietro, poco si curava del dire altrui e del biasimo che per ciò gli fusse dato.
Ma pure avendo murato l'altare e posto l'imbasamento di marmo dove doveva stare la statua di Dio Padre, avendone fatto un modello, finalmente la cominciò, e tenendovi scarpellini andava lentamente seguitando. Venne in que' giorni di Francia Benvenuto Cellini, il quale aveva servito il re Francesco nelle cose dell'orefice, di che egli era ne' suoi tempi il più famoso, e nel getto di bronzo aveva a quel re fatto alcune cose; et egli fu introdotto al duca Cosimo, il quale desiderando d'ornare la città, fece a lui ancora molte carezze e favori. Dettegli a fare una statua di bronzo di cinque braccia incirca di uno Perseo ignudo, il quale posava sopra una femmina ignuda fatta per Medusa, alla quale aveva tagliato la testa, per porlo sotto uno degli archi della loggia di piazza. Benvenuto mentre che faceva il Perseo, ancora dell'altre cose faceva al Duca. Ma come avviene che il figulo sempre invidia e noia il figulo, e lo scultore l'altro scultore, non potette Baccio sopportare i favori varii fatti a Benvenuto. Parevagli ancora strana cosa che egli fusse così in un tratto di orefice riuscito scultore, né gli capiva nell'animo che egli, che soleva fare medaglie e figure piccole, potesse condur colossi ora e giganti. Né potette il suo animo occultare Baccio, ma lo scoperse del tutto e trovò chi gli rispose; perché dicendo Baccio a Benvenuto in presenza del Duca molte parole delle sue mordaci, Benvenuto, che non era manco fiero di lui, voleva che la cosa andasse del pari. E spesso ragionando delle cose dell'arte e delle loro proprie, notando i difetti di quelle, si dicevano l'uno all'altro parole vituperosissime in presenza del Duca; il quale, perché ne pigliava piacere, conoscendo ne' lor detti mordaci ingegno veramente et acutezza, gli aveva dato campo franco e licenza che ciascuno dicesse all'altro ciò che egli voleva dinanzi a lui, ma fuora non se ne tenesse conto. Questa gara, o più tosto nimicizia, fu cagione che Baccio sollecitò lo Dio Padre, ma non aveva egli già dal Duca que' favori che prima soleva, ma s'aiutava per ciò corteggiando e servendo la Duchessa. Un giorno fra gli altri, mordendosi al solito e scoprendo molte cose de' fatti loro, Benvenuto guardando e minacciando Baccio, disse: “Provvediti Baccio d'un altro mondo, che di questo ti voglio cavare io”. Rispose Baccio: “Fa che io lo sappia un dì innanzi, sì ch'io mi confessi e faccia testamento e non muoia come una bestia, come sei tu”. Per la qual cosa il Duca, perché molti mesi ebbe preso spasso del fatto loro, gli pose silenzio, temendo di qualche mal fine, e fece far loro un ritratto grande della sua testa fino alla cintura, che l'uno e l'altro si gettassi di bronzo, acciò che chi facesse meglio avesse l'onore. In questi travagli et emulazioni finì Baccio il suo Dio Padre, il quale ordinò che si mettesse in chiesa sopra la basa a canto all'altare. Questa figura era vestita et è braccia sei alta e la murò e finì del tutto. Ma per non la lasciare scompagnata, fatto venire da Roma Vincenzio de' Rossi scultore suo creato, volendo nell'altare tutto quello che mancava di marmo farlo di terra, si fece aiutare da Vincenzio a finire i due Angeli che tengono i candelieri in su' canti, e la maggior parte delle storie della predella e basamento; messo di poi ogni cosa sopra l'altare, acciò si vedesse come aveva a stare il fine del suo lavoro, si sforzava che 'l Duca lo venisse a vedere, innanzi che egli lo scoprisse. Ma il Duca non volle mai andare, et essendone pregato dalla Duchessa, la quale in ciò favoriva Baccio, non si lasciò però mai piegare il Duca, e non andò a vederlo, adirato perché di tanti lavori Baccio non aveva mai finitone alcuno, et egli pure l'aveva fatto ricco e gli aveva con odio de' cittadini fatto molte grazie et onoratolo molto. Con tutto questo andava sua eccellenza pensando d'aiutare Clemente figliuolo naturale di Baccio e giovane valente, il quale aveva acquistato assai nel disegno, perché e' dovesse toccare a lui col tempo a finire l'opere del padre.
In questo medesimo tempo, che fu l'anno 1554, venne da Roma, dove serviva papa Giulio Terzo, Giorgio Vasari aretino per servire sua eccellenza in molte cose che l'aveva in animo di fare e particularmente innovare di fabbriche et ornare il palazzo di piazza e fare la sala grande, come s'è di poi veduto. Giorgio Vasari di poi l'anno seguente condusse da Roma, et acconciò col Duca, Bartolommeo Ammannati scultore per fare l'altra facciata dirimpetto all'udienza cominciata da Baccio in detta sala et una fonte nel mezzo di detta facciata, e subito fu dato principio a fare una parte delle statue che vi andavano. Conobbe Baccio che 'l Duca non voleva servirsi più di lui, poi che adoperava altri, di che egli avendo grande dispiacere e dolore era diventato sì strano e fastidioso, che né in casa né fuora non poteva alcuno conversare con lui, et a Clemente suo figliuolo usava molte stranezze e lo faceva patire d'ogni cosa. Per questo Clemente avendo fatto di terra una testa grande di sua eccellenza per farla di marmo per la statua dell'udienza, chiese licenza al Duca di partirsi per andare a Roma per le stranezze del padre; il Duca disse che non gli mancherebbe. Baccio nella partita di Clemente, che gli chiese licenza, non gli volle dar nulla, benché egli fusse in Firenze di grande aiuto, che era quel giovane le braccia di Baccio in ogni bisogno, nondimeno non si curò che si gli levasse dinanzi. Arrivato il giovane a Roma contro a tempo, sì per gli studi e sì pe' disordini, il medesimo anno si morì, lasciando in Firenze di suo quasi finita una testa del duca Cosimo di marmo, la quale Baccio poi pose sopra la porta principale di casa sua nella via de' Ginori, et è bellissima. Lasciò ancora Clemente molto innanzi un Cristo morto, che è retto da Niccodemo, il quale Niccodemo è Baccio ritratto di naturale: le quali statue, che sono assai buone, Baccio pose nella chiesa de' Servi, come al suo luogo diremo. Fu di grandissima perdita la morte di Clemente a Baccio et all'arte, et egli lo conobbe poi che fu morto.
Scoperse Baccio l'altare di Santa Maria del Fiore e la statua di Dio Padre fu biasimata; l'altare s'è restato con quello che s'è racconto di sopra, né vi si è fatto poi altro, ma s'è atteso a seguitare il coro. Erasi molti anni innanzi cavato a Carrara un gran pezzo di marmo alto braccia dieci e mezzo e largo braccia cinque, del quale avuto Baccio l'avviso, cavalcò a Carrara e dette al padrone di chi egli era scudi cinquanta per arra, e fattone contratto tornò a Firenze, e fu tanto intorno al Duca, che per mezzo della Duchessa ottenne di farne un gigante, il quale dovesse mettersi in piazza sul canto dove era il lione, nel quale luogo si facesse una gran fonte che gittasse acqua, nel mezzo della quale fusse Nettunno sopra il suo carro tirato da cavagli marini e dovesse cavarsi questa figura di questo marmo. Di questa figura fece Baccio più d'uno modello e mostratigli a sua eccellenza, stettesi la cosa senza fare altro fino all'anno 1559, nel quale tempo il padrone del marmo venuto da Carrara, chiedeva d'essere pagato del restante o che renderebbe gli scudi 50 per romperlo in più pezzi e farne danari, perché aveva molte chieste. Fu ordinato dal Duca a Giorgio Vasari che facesse pagare il marmo. Il che intesosi per l'arte e che il Duca non aveva ancora dato libero il marmo a Baccio, si risentì Benvenuto e parimente l'Ammannato, pregando ciascheduno di loro il Duca di fare un modello a concorrenza di Baccio e che sua eccellenza si degnasse di dare il marmo a colui che nel modello mostrasse maggior virtù. Non negò il Duca a nessuno il fare il modello, né tolse la speranza che chi si portava meglio non potesse esserne il facitore. Conosceva il Duca che la virtù e 'l giudicio e 'l disegno di Baccio era ancora meglio di nessuno scultore di quelli che lo servivano, pure che egli avesse voluto durare fatica, et aveva cara questa concorrenza per incitare Baccio a portarsi meglio e fare quel che egli poteva. Il quale vedutasi addosso questa concorrenza ne ebbe grandissimo travaglio, dubitando più della disgrazia del Duca che d'altra cosa, e di nuovo si messe a fare modelli. Era intorno alla Duchessa assiduo, con la quale operò tanto Baccio, che ottenne d'andare a Carrara per dare ordine che il marmo si conducesse a Firenze. Arrivato a Carrara, fece scemare il marmo tanto, secondo che egli aveva disegnato di fare, che lo ridusse molto meschino e tolse l'occasione a sé et agli altri et il poter farne omai opera molto bella e magnifica. Ritornato a Firenze fu lungo combattimento tra Benvenuto e lui, dicendo Benvenuto al Duca che Baccio aveva guasto il marmo innanzi che egli l'avesse tocco. Finalmente la Duchessa operò tanto, che 'l marmo fu suo, e di già s'era ordinato che egli fusse condotto da Carrara alla marina e preparato gli ordini della barca che lo condusse su per Arno fino a Signa. Fece ancora Baccio murare nella loggia di piazza una stanza per lavorarvi dentro il marmo, et in questo mezzo aveva messo mano a fare cartoni, per fare dipignere alcuni quadri che dovevano ornare le stanze del palazzo de' Pitti. Questi quadri furono dipinti da un giovane chiamato Andrea del Minga, il quale maneggiava assai acconciamente i colori. Le storie dipinte ne' quadri furono la creazione d'Adamo e d'Eva e l'esser cacciati dall'Angelo di Paradiso; un Noè et un Moisè con le tavole, i quali finiti gli donò poi alla Duchessa cercando il favore di lei nelle sue difficultà e controversie. E nel vero se non fusse stata quella signora, che lo tenne in piè e lo amava per la virtù sua, Baccio sarebbe cascato affatto et arebbe persa interamente la grazia del Duca.
Servivasi ancora la Duchessa assai di Baccio nel giardino de' Pitti, dove ella aveva fatto fare una grotta piena di tartari e di spugne congelate dall'acqua, dentrovi una fontana, dove Baccio aveva fatto condurre di marmo a Giovanni Fancelli suo creato un pilo grande et alcune capre quanto il vivo, che gettano acqua, e parimente col modello fatto da se stesso per un vivaio un villano che vota un barile pieno d'acqua. Per queste cose la Duchessa di continovo aiutava e favoriva Baccio appresso al Duca, il quale aveva dato licenzia finalmente a Baccio che cominciasse il modello grande del Nettunno: per lo che egli mandò di nuovo a Roma per Vincenzio de' Rossi, che già s'era partito di Firenze, con intenzione che gli aiutasse condurlo. Mentre che queste cose si andavano preparando, venne volontà a Baccio di finire quella statua di Cristo morto tenuto da Niccodemo, il quale Clemente suo figliolo aveva tirato innanzi: perciò che aveva inteso che a Roma il Buonarroto ne finiva uno, il quale aveva cominciato in un marmo grande, dove erano cinque figure, per metterlo in S. Maria Maggiore alla sua sepoltura. A questa concorrenza Baccio si messe a lavorare il suo con ogni accuratezza e con aiuti, tanto che lo finì. Et andava cercando in questo mezzo per le chiese principali di Firenze d'un luogo dove egli potesse collocarlo e farvi per sé una sepoltura, ma non trovando luogo che lo contentasse per sepoltura, si risolvé a una cappella nella chiesa de' Servi, la quale è della famiglia de' Pazzi. I padroni di questa cappella pregati dalla Duchessa concessono il luogo a Baccio, senza spodestarsi del padronato e delle insegne che v'erano di casa loro e solamente gli concessono che egli facesse uno altare di marmo e sopra quello mettesse le dette statue e vi facesse la sepoltura a' piedi. Convenne ancora poi co' frati di quel convento dell'altre cose appartenenti allo ufiziarla. In questo mezzo faceva Baccio murare l'altare et il basamento di marmo, per mettervi su queste statue, e finitolo disegnò mettere in quella sepoltura, dove voleva esser messo egli e la sua moglie, l'ossa di Michelagnolo suo padre, le quali aveva nella medesima chiesa fatto porre, quando e' morì, in uno deposito; queste ossa di suo padre egli di sua mano volle pietosamente mettere in detta sepoltura, dove avvenne che Baccio, o che egli pigliasse dispiacere et alterazione d'animo nel maneggiar l'ossa di suo padre, o che troppo s'affaticasse nel tramutare quell'ossa con le proprie mani e nel murare i marmi, o l'uno o l'altro insieme, si travagliò di maniera, che sentendosi male et andatosene a casa et ogni dì più aggravando il male, in otto giorni si morì, essendo d'età d'anni settantadue, essendo stato fino allora robusto e fiero, senza aver mai provato molti mali mentre ch'e' visse. Fu sepolto con onorate essequie e posto allato all'ossa del padre nella sopra detta sepoltura da lui medesimo lavorata, nella quale è questo epitaffio:
D.O.M. BACCIUS BANDINELLUS DIVI IACOBI EQUES SUB HAC SERVATORIS IMAGINE, A SE EXPRESSA, CUM IACOBA DONIA UXORE QUIESCIT. ANNO SALUTIS MDLIX.
Lasciò figliuoli maschi e femmine, i quali furono eredi di molte facultà, di terreni, di case e di danari, le quali egli lasciò loro, et al mondo lasciò l'opere da noi descritte di scultura e molti disegni in gran numero, i quali sono appresso i figliuoli, e nel nostro libro ne sono di penna e di matita alcuni che non si può certamente far meglio.
Rimase il marmo del gigante in maggior contesa che mai, perché Benvenuto era sempre intorno al Duca e per virtù d'un modello piccolo, che egli aveva fatto, voleva che 'l Duca glielo desse; dall'altra parte l'Ammannato, come quello era scultore di marmi e sperimentato in quelli più che Benvenuto, per molte cagioni giudicava che a lui s'appartenesse questa opera. Avvenne che a Giorgio bisognò andare a Roma col cardinale figliuolo del Duca, quando prese il cappello, al quale avendo l'Ammannato dato un modelletto di cera, secondo che egli desiderava di cavare del marmo quella figura et uno legno, come era appunto grosso e lungo e largo e bieco quel marmo, acciò che Giorgio lo mostrasse a Roma a Michelagnolo Buonarroti perché egli ne dicesse il parere suo, e così movesse il Duca a dargli il marmo, il che tutto fece Giorgio volentieri, questo fu cagione che 'l Duca dette commessione che e' si turasse un arco della loggia di piazza e che l'Ammannato facesse un modello grande quanto aveva a essere il gigante. Inteso ciò Benvenuto, tutto in furia cavalcò a Pisa, dove era il Duca, dove dicendo lui che non poteva comportare che la virtù sua fusse conculcata da chi era da manco di lui e che desiderava di fare a concorrenza dell'Ammannato un modello grande nel medesimo luogo, volle il Duca contentarlo e gli concesse ch'e' si turasse l'altro arco della loggia, e fece dar a Benvenuto le materie, acciò facesse come egli voleva il modello grande a concorrenza dell'Ammannato. Mentre che questi maestri attendevano a fare questi modelli e che avevano serrato le loro stanze, sì che né l'uno né l'altro poteva vedere ciò che il compagno faceva, benché fussino appiccate insieme le stanze, si destò maestro Giovan Bologna fiammingo scultore, giovane di virtù e di fierezza non meno che alcuno degli altri. Costui stando col signor don Francesco principe di Firenze, chiese a sua eccellenza di poter fare un gigante, che servisse per modello, della medesima grandezza del marmo et il principe ciò gli concesse. Non pensava già maestro Giovan Bologna d'avere a fare il gigante di marmo, ma voleva almeno mostrare la sua virtù e farsi tenere quello che egli era; avuta la licenza dal principe, cominciò ancora egli il suo modello nel convento di S. Croce. Non volle mancare di concorrere con questi tre Vincenzio Danti perugino, scultore giovane di minore età di tutti, non per ottenere il marmo, ma per mostrare l'animosità e l'ingegno suo. Così messosi a lavorare di suo nelle case di Messer Alessandro di Messer Ottaviano de' Medici, condusse un modello con molte buone parti grande come gli altri. Finiti i modelli, andò il Duca a vedere quello dell'Ammannato e quello di Benvenuto, e piaciutogli più quello dell'Am-mannato che quello di Benvenuto, si risolvé che l'Ammannato avesse il marmo e facesse il gigante, perché era più giovane di Benvenuto e più pratico né marmi di lui. Aggiunse all'inclinazione del Duca Giorgio Vasari, il quale con sua eccellenza fece molti buoni ufizi per l'Ammannato, vedendolo oltre al saper suo pronto a durare ogni fatica e sperando che per le sue mani si vedrebbe un'opera eccellente finita in breve tempo. Non volle il Duca allora vedere il modello di maestro Giovan Bologna, perché non avendo veduto di suo lavoro alcuno di marmo, non gli pareva che si gli potesse per la prima fidare, così grande impresa, ancora che da molti artefici e da altri uomini di giudicio intendesse che 'l modello di costui era in molte parti migliore che gli altri. Ma se Baccio fusse stato vivo, non sarebbono state tra que' maestri tante contese, perché a lui senza dubbio sarebbe tocco a fare il modello di terra et il gigante di marmo. Questa opera addunque tolse a lui la morte, ma la medesima gli dette non piccola gloria, perché fece vedere in que' quattro modelli, de' quali fu cagione il non essere vivo Baccio ch'e' si facessino, quanto era migliore il disegno e 'l giudicio e la virtù di colui che pose Ercole e Cacco quasi vivi nel marmo in piazza; la bontà della quale opera molto più hanno scoperta et illustrata l'opere, le quali dopo la morte di Baccio hanno fatte questi altri, i quali benché si sieno portati laudabilmente, non però hanno potuto aggiugnere al buono et al bello che pose egli nell'opera sua.
Il duca Cosimo poi nelle nozze della reina Giovanna d'Austria sua nuora, dopo la morte di Baccio sette anni, ha fatto nella sala grande finire l'udienza della quale abbiamo ragionato di sopra, cominciata da Baccio, e di tal finimento ha voluto che sia capo Giorgio Vasari, il quale ha cerco con ogni diligenza di rimediare a molti difetti che sarebbero stati in lei, se ella si seguitava e si finiva secondo il principio e primo ordine suo. Così quell'opera imperfetta con l'aiuto d'Iddio s'è condotta ora al fine et èssi arricchita nelle sue rivolte con l'aggiunta di nicchie e di pilastri e di statue poste ne' luoghi loro, dove ancora, perché era messa bieca e fuor di squadra, siamo andati pareggiandola quanto è stato possibile e l'abbiamo alzata assai con un corridore sopra di colonne toscane; e la statua di Leone, cominciata da Baccio, Vincenzio de' Rossi suo creato l'ha finita. Oltre a ciò è stata quell'opera ornata di fregiature piene di stucchi, con molte figure grandi e piccole e con imprese et altri ornamenti di varie sorti, e sotto le nicchie ne' partimenti delle volte si sono fatti molti spartimenti varii di stucchi e molte belle invenzioni d'intagli, le quali cose tutte hanno di maniera arricchita quell'opera, che ha mutato forma et acquistato più grazia e bellezza assai. Imperò che dove secondo il disegno di prima, essendo il tetto della sala alto braccia ventuno, l'udienza non s'alzava più che diciotto braccia, sì che tra lei e 'l tetto vecchio era un vano in mezzo di braccia tre, ora secondo l'ordine nostro il tetto della sala s'è alzato tanto, che sopra il tetto vecchio è ito dodici braccia e sopra l'udienza di Baccio e di Giuliano braccia quindici: così trentatré braccia è alto il tetto ora della sala. E fu certamente grande animo quello del duca Cosimo a risolversi di fare finire per le nozze sopra dette tutta questa opera in tempo di cinque mesi, alla quale mancava più del terzo, volendola condurre a perfezzione, et insino a quel termine, dove ella era allora, era arrivata in più di quindici anni. Ma non solo sua eccellenza fece finire del tutto l'opera di Baccio, ma il resto ancora di quel che aveva ordinato Giorgio Vasari, ripigliando dal basamento, che ricorre sopra tutta quell'opera, con un ricinto di balaustri ne' vani che fa un corridore che passa sopra questo lavoro della sala e vede di fuori la piazza e di dentro tutta la sala; così potranno i principi e' signori stare a vedere senza essere veduti tutte le feste che vi si faranno con molto commodo loro e piacere, e ritirarsi poi nelle camere e camminare per le scale segrete e pubbliche per tutte le stanze del palazzo. Nondimeno a molti è dispiaciuto il non avere in un'opera sì bella e sì grande messo in isquadra quel lavoro, e molti arebbono voluto smurarlo e rimurarlo poi in isquadra, ma è stato giudicato ch'e' sia meglio il seguitare così quel lavoro, per non parere maligno contro a Baccio e prosuntuoso, et aremo dimostro che e' non ci bastasse l'animo di correggere gli errori e mancamenti trovati e fatti da altri.
Ma tornando a Baccio, diciamo che le virtù sue sono state sempre conosciute in vita, ma molto più saranno conosciute e desiderate dopo la morte. E molto più ancora sarebbe egli stato vivendo conosciuto quello che era et amato, se dalla natura avesse avuto grazia d'essere più piacevole e più cortese: perché l'essere il contrario e molto villano di paro-le gli toglieva la grazia delle persone et oscurava le sue virtù, e faceva che dalla gente erano con malanimo et occhio bieco guardate l'opere sue, e perciò non potevano mai piacere. Et ancora che egli servisse questo e quel signore e sapesse servire per la sua virtù, faceva nondimeno i servizii con tanta mala grazia, che niuno era che grado di ciò gli sapesse. Ancora il dire sempre male e biasimare le cose d'altri era cagione che nessuno lo poteva patire, e dove altri gli poteva rendere il cambio, gli era reso addoppio, e ne' magistrati senza rispetto a' cittadini diceva villania, e da loro ne ricevé parimente. Piativa e litigava d'ogni cosa volentieri e continovamente visse in piati, e di ciò pareva che trionfasse. Ma perché il suo disegnare, al che si vede che egli più che ad altro attese, fu tale e di tanta bontà, che supera ogni suo difetto di natura e lo fa conoscere per uomo raro di questa arte, noi perciò non solamente lo annoveriamo tra i maggiori, ma sempre abbiamo avuto rispetto all'opere sue e cerco abbiamo non di guastarle, ma di finirle e di fare loro onore: imperò che ci pare che Baccio veramente sia di quelli uno che onorata lode meritono e fama eterna. Abbiamo riservato nell'ul-timo di far menzione del suo cognome, perciò che egli non fu sempre uno, ma variò: ora de' Brandini, ora de' Bandinelli facendosi lui chiamare; prima il cognome de' Brandini si vede intagliato nelle stampe dopo il nome di Baccio; di poi più gli piacque questo de' Bandinelli, il quale insino al fine ha tenuto e tiene, dicendo che i suoi maggiori furono de' Bandinelli di Siena i quali già vennono a Gaiuole e da Gaiuole a Firenze.
IL FINE DELLA VITA DI BACCIO BANDINELLI, SCULTORE FIORENTINO
VITA DI GIULIANO BUGIARDINI
PITTORE FIORENTINO

Erano innanzi all'assedio di Fiorenza in sì gran numero multiplicati gl'uomini, che i borghi lunghissimi che erano fuori di ciascuna porta, insieme con le chiese, munisteri e spedali, erano quasi un'altra città abitata da molte orrevoli persone, e da buoni artefici di tutte le sorti, come che per lo più fussero meno agiati che quelli della città e là si stessero con manco spese di gabelle e d'altro. In uno di questi sobborghi adunque fuori della porta a Faenza nacque Giuliano Bugiardini, e sì come avevano fatto i suoi passati, vi abitò all'anno 1529, che tutti furono rovinati. Ma innanzi, essendo giovinetto, il principio de' suoi studii fu nel giardino de' Medici in sulla piazza di San Marco, nel quale seguitando d'imparare l'arte sotto Bertoldo scultore, prese amicizia e tanta stretta familiarità con Michelagnolo Buonarroti, che poi fu sempre da lui molto amato. Il che fece Michelagnolo non tanto perché vedesse in Giuliano una profonda maniera di disegnare, quanto una grandissima diligenza et amore che portava all'arte. Era in Giuliano oltre ciò una certa bontà naturale et un certo semplice modo di vivere senza malignità o invidia che infinitamente piaceva al Buonarroto, né alcun notabile difetto fu in costui se non che troppo amava l'opere che egli stesso faceva. E se bene in questo peccano comunemente tutti gl'uomini, egli nel vero passava il segno, o la molta fatica e diligenza che metteva in lavorarle o altra qual si fusse di ciò la cagione, onde Michelagnolo usava di chiamarlo beato, poi che pareva si contentasse di quello che sapeva, e se stesso infelice, che mai di niuna sua opera pienamente si sodisfaceva.
Dopo che ebbe un pezzo atteso al disegno Giuliano nel detto giardino, stette pur insieme col Buonarruoti e col Granacci, con Domenico Grillandai quando faceva la cappella di Santa Maria Novella. Dopo, cresciuto e fatto assai ragionevole maestro, si ridusse a lavorare in compagnia di Mariotto Albertinelli in Gualfonda, nel qual luogo finì una tavola che oggi è all'entrata della porta di Santa Maria Maggiore di Firenze, dentro la quale è un Santo Alberto frate carmelitano, che ha sotto i piedi il diavolo in forma di donna, che fu opera molto lodata. Solevasi in Firenze avanti l'assedio del 1530, nel sepellire i morti che erano nobili e di parentado, portare innanzi al cataletto, appiccati intorno a una tavola la quale portava in capo un facchino, una filza di drapelloni, i quali poi rimanevano alla chiesa per memoria del defunto e della famiglia. Quando dunque morì Cosimo Rucellai il vecchio, Bernardo e Palla suoi figliuoli pensarono per far cosa nuova di non far drapelloni, ma in quel cambio una bandiera quadra di quattro braccia larga e cinque alta, con alcuni drapelloni ai piedi con l'arme de' Rucellai. Dando essi addunque a fare quest'opera a Giuliano, egli fece nel corpo di detta bandiera quattro figuroni grandi, molto ben fatti, cioè San Cosimo e Damiano e San Piero e San Paulo, le quali furono pitture veramente bellissime e fatte con più diligenza che mai fusse stata fatta altra opera in drappo. Queste et altre opere di Giuliano avendo veduto Mariotto Albertinelli e conosciuto quanto fusse diligente in osservare i disegni che se gli mettevano innanzi, senza uscirne un pelo, in que' giorni che si dispose abbandonare l'arte, gli lasciò a finire una tavola che già fra' Bartolomeo di S. Marco suo compagno et amico avea lasciata solamente disegnata et aombrata con l'acquerello in sul gesso della tavola, sì come era di suo costume. Giuliano addunque messovi mano, con estrema diligenza e fatica condusse quest'opera, la quale fu allora posta nella chiesa di San Gallo fuor della porta, la quale chiesa e convento fu poi rovinato per l'assedio, e la tavola portata dentro e posta nello spedal de' preti in via di San Gallo; di lì poi nel convento di San Marco et ultimamente in San Iacopo tra' Fossi al canto agl'Alberti, dove al presente è collocata all'altare maggiore. In questa tavola è Cristo morto, la Madalena che gl'abbraccia i piedi e San Giovanni Evangelista che gli tiene la testa e lo sostiene sopra un ginocchio; èvvi similmente San Piero che piagne e San Paulo che aprendo le braccia contempla il suo signore morto. E per vero dire, condusse Giuliano questa tavola con tanto amore e con tanta avvertenza e giudizio, che come ne fu allora, così ne sarà sempre et a ragione sommamente lodato. E dopo questa finì a Cristofano Rinieri il rapimento di Dina in un quadro, stato lasciato similmente imperfetto dal detto fra' Bartolomeo, al quale quadro ne fece un altro simile che fu mandato in Francia. Non molto dopo, essendo tirato a Bologna da certi amici suoi, fece alcuni ritratti di naturale et in San Francesco dentro al coro nuovo in una capella una tavola a olio, dentrovi la Nostra Donna e due Santi, che fu allora tenuta in Bologna, per non esservi molti maestri, buona e lodevole opera. E dopo, tornato a Fiorenza, fece per non so chi cinque quadri della vita di Nostra Donna, i quali sono oggi in casa di maestro Andrea Pasquali medico di sua eccellenza et uomo singolarissimo.
Avendogli dato Messer Palla Rucellai a fare una tavola, che dovea porsi al suo altare in Santa Maria Novella, Giuliano incominciò a farvi entro il martirio di Santa Caterina vergine, ma è gran cosa, la tenne dodici anni fra mano, né mai la condusse in detto tempo a fine, per non avere invenzione, né sapere come farsi le tante varie cose che in quel martirio intervenivono; e se bene andava ghiribizzando sempre come potevono stare quelle ruote e come doveva fare la saetta et incendio che le abbruciò, tuttavia mutando quello che un giorno aveva fatto l'altro, in tanto tempo non le diede mai fine. Ben è vero che in quel mentre fece molte cose, e fra l'altre a Messer Francesco Guicciardini che allora, essendo tornato da Bologna, si stava in villa a Montici scrivendo la sua storia, il ritratto di lui, che somigliò assai ragionevolmente e piacque molto. Similmente ritrasse la signora Angela de' Rossi, sorella del conte di San Secondo, per lo signor Alessandro Vitelli suo marito, che allora era alla guardia di Firenze. E per Messer Ottaviano de' Medici, ricavandolo da uno di fra' Bastiano del Piombo, ritrasse in un quadro grande et in due figure intere papa Clemente a sedere e fra' Niccolò della Magna in piede. In un altro quadro ritrasse similmente papa Clemente a sedere et innanzi a lui inginocchioni Bartolomeo Valori che gli parla, con fatica e pazienza incredibile. Avendo poi segretamente il detto Messer Ottaviano pregato Giuliano che gli ritraesse Michelagnolo Buonarroti, egli messovi mano, poi che ebbe tenuto due ore fermo Michelagnolo, che si pigliava piacere de' ragionamenti di colui, gli disse Giuliano: “Michelagnolo, se volete vedervi state su, che già ho fermo l'aria del viso”. Michelagnolo, rizzatosi e veduto il ritratto, disse ridendo a Giuliano: “Che diavolo avete voi fatto! Voi mi avete dipinto con uno degl'occhi in una tempia, avertitevi un poco”. Ciò udito poi che fu alquanto stato sopra di sé Giuliano et ebbe molte volte guardato il ritratto et il vivo, rispose sul saldo: “A me non pare, ma ponetevi a sedere et io vedrò un poco meglio dal vivo s'egli è così”. Il Buonarruoto, che conosceva onde veniva il difetto et il poco giudizio del Bugiardino, si rimisse subito a sedere ghignando, e Giuliano riguardò molte volte ora Michelagnolo et ora il quadro, e poi levato finalmente in piede, disse: “A me pare che la cosa stia sì come io l'ho disegnata e che il vivo mi mostri così”. “Questo è dunque” soggiunse il Buonarruoto “difetto di natura: seguitate e non perdonate al pennello, né all'arte.” E così finito questo quadro, Giuliano lo diede a esso Messer Ottaviano, insieme col ritratto di papa Clemente di mano di fra' Bastiano, sì come volle il Buonarruoto che l'aveva fatto venire da Roma. Fece poi Giuliano per Innocenzio cardinal Cibo un ritratto del quadro nel quale già aveva Raffaello da Urbino ritratto papa Leone, Giulio cardinal de' Medici et il cardinale de' Rossi. Ma in cambio del detto cardinale de' Rossi fece la testa di esso cardinale Cibo, nella quale si portò molto bene e condusse il quadro tutto con molta fatica e diligenza. Ritrasse similmente allora Cencio Guasconi, giovane in quel tempo bellissimo. E dopo fece all'Olmo a Castello un tabernacolo a fresco, alla villa di Baccio Pedoni, che non ebbe molto disegno, ma fu ben lavorato con estrema diligenza. Intanto, sollecitandolo Palla Rucellai a finire la sua tavola, della quale si è di sopra ragionato, si risolvé a menare un giorno Michelagnolo a vederla, e così condottolo dove egli l'aveva, poi che gli ebbe raccontato con quanta fatica avea fatto il lampo che venendo dal cielo spezza le ruote et uccide coloro che le girano, et un sole che uscendo d'una nuvola libera Santa Caterina dalla morte, pregò liberamente Michelagnolo, il quale non poteva tenere le risa udendo le sciagure del povero Bugiardino, che volesse dirgli come farebbe otto o dieci figure principali dinanzi a questa tavola, di soldati che stessino in fila a uso di guardia et in atto di fuggire, cascati, feriti e morti, perciò che non sapeva egli come fargli scortare in modo che tutti potessero capire in sì stretto luogo, nella maniera che si era imaginato, per fila. Il Buonarruoti addunque, per compiacergli, avendo compassione a quel povero uomo, accostatosi con un carbone alla tavola contornò de' primi segni, schizzati solamente, una fila di figure ignude maravigliose, le quali in diversi gesti scortando, variamente casca-vano chi in dietro e chi innanzi, con alcuni morti e feriti fatti con quel giudizio et eccellenza che fu propria di Michelagnolo. E ciò fatto si partì ringraziato da Giuliano, il quale non molto dopo menò il Tribolo suo amicissimo a vedere quello che il Buonarruoto aveva fatto, raccontandogli il tutto. E perché come si è detto aveva fatto il Buonarruoto le sue figure solamente contornate, non poteva il Bugiardino metterle in opera, per non vi essere né ombre, né altro; quando si risolvé il Tribolo ad aiutarlo, per che, fatti alcuni modelli in bozze di terra, i quali condusse eccellentemente, dando loro quella fierezza e maniera che aveva dato Michelagnolo al disegno, con la gradina - che è un ferro intaccato - le gradinò acciò fussero crudette et avessino più forza, e così fatte le diede a Giuliano.
Ma perché quella maniera non piaceva alla pulitezza e fantasia del Bugiardino, partito che fu il Tribolo, egli con un pennello, intignendolo di mano in mano nell'acqua, le lisciò tanto che, levatone via le gradine, le pulì tutte, di maniera che, dove i lumi avevano a servire per ritratto e fare l'ombre più crude, si venne a levare via quel buono che faceva l'o-pera perfetta. Il che avendo poi inteso il Tribolo dallo stesso Giuliano, si rise della dapoca semplicità di quell'uomo, il quale finalmente diede finita l'opera in modo che non si conosce che Michelagnolo la guardasse mai.
In ultimo Giuliano, essendo vecchio e povero e facendo pochissimi lavori, si messe a una strana et incredibile fatica per fare una Pietà in un tabernacolo che aveva a ire in Ispagna, di figure non molto grandi, e la condusse con tanta diligenza, che pare cosa strana a vedere che un vecchio di quell'età avesse tanta pazienza in fare una sì fatta opera, per l'a-more che all'arte portava. Ne' portelli del detto tabernacolo, per mostrare le tenebre che furono nella morte del Salvatore, fece una Notte in campo nero ritratta da quella che è nella sagrestia di San Lorenzo, di mano di Michelagnolo. Ma perché non ha quella statua altro segno che un barbagianni, Giuliano, scherzando intorno alla sua pittura della Notte con l'invenzione de' suoi concetti, vi fece un frugnuolo da uccellare a tordi la notte, con la lanterna, un pentolino di quei che si portano la notte con una candela o moccolo, con altre cose simili e che hanno che fare con le tenebre e col buio, come dire berrettini, cuffie, guanciali e pipistregli. Onde il Buonarruoto quando vide quest'opera ebbe a smascellare delle risa, considerando con che strani capricci aveva il Bugiardino arricchita la sua Notte. Finalmente essendo sempre stato Giuliano un uomo così fatto, d'età d'anni settantacinque si morì e fu seppellito nella chiesa di San Marco di Firenze l'anno 1556. Raccondando una volta Giuliano al Bronzino d'avere veduta una bellissima donna, poi che l'ebbe infinitamente lodata, disse il Bronzino: “Conoscetela voi?”. “Non”, rispose “ma è bellissima; fate conto ch'ella sia una pittura di mia mano, e basta.”
IL FINE DELLA VITA DI GIULIANO BUGIARDINI, PITTORE
VITA DI CRISTOFANO GHERARDI DETTO DOCENO
DAL BORGO SAN SEPOLCRO, PITTORE

Mentre che Raffaello dal Colle del Borgo San Sepolcro, il quale fu discepolo di Giulio Romano e gli aiutò lavorare a fresco la sala di Gostantino nel palazzo del Papa in Roma et in Mantoa le stanze del T, dipigneva, essendo tornato al Borgo, la tavola della cappella di San Gilio et Arcanio, nella quale fece, imitando esso Giulio e Raffaello da Urbino, la ressurrezzione di Cristo, che fu opera molto lodata, et un'altra tavola d'un'Assunta ai frati de' Servi a Città di Castello; mentre (dico) Raffaello queste et altre opere lavorava nel Borgo sua patria, acquistandosi ricchezze e nome, un giovane d'anni sedici, chiamato Cristofano e per sopranome Doceno, figliuolo di Guido Gherardi, uomo d'orrevole famiglia in quella città, attendendo per naturale inclinazione con molto profitto alla pittura, disegnava e coloriva così bene e con tanta grazia, che era una maraviglia. Per che, avendo il sopra detto Raffaello veduto di mano di costui alcuni animali come cani, lupi, lepri e varie sorti d'uccelli e pesci molto ben fatti, e vedutolo di dolcissima conversazione e tanto faceto e motteggevole, come che fusse astratto nel vivere e vivesse quasi alla filosofica, fu molto contento d'avere sua amistà e che gli praticasse per imparare in bottega. Avendo dunque sotto la disciplina di Raffaello disegnato Cristofano alcun tempo, capitò al Borgo il Rosso, con quale avendo fatto amicizia et avuto de' suoi disegni, studiò Doceno sopra quelli con molta diligenza, parendogli (come quelli che non aveva veduto altri che di mano di Raffaello) che fussino, come erano in vero, bellissimi. Ma cotale studio fu da lui interrotto perché, andando Giovanni de' Turrini dal Borgo al-lora capitano de' fiorentini con una banda di soldati borghesi e da Città di Castello alla guardia di Firenze, assediata dal-l'esercito imperiale e di papa Clemente, vi andò fra gl'altri soldati Cristofano, essendo stato da molti amici suoi sviato; ben è vero che vi andò non meno con animo d'avere a studiare con qualche commodo le cose di Fiorenza che di milita-re, ma non gli venne fatto, perché Giovanni suo capitano ebbe in guardia non alcun luogo della città, ma i bastioni del monte di fuora. Finita quella guerra, essendo non molto dopo alla guardia di Firenze il signor Alessandro Vitelli da Città di Castello, Cristofano tirato dagl'amici e dal disiderio di vedere le pitture e sculture di quella città, si mise come sol-dato in detta guardia, nella quale mentre dimorava avendo inteso il signor Alessandro da Battista della Bilia, pittore e soldato da Città di Castello, che Cristofano attendeva alla pittura et avuto un bel quadro di sua mano, avea disegnato mandarlo con detto Battista della Bilia e con un altro Battista similmente da Città di Castello, a lavorare di sgraffito e di pitture un giardino e loggia che a Città di Castello avea cominciato. Ma essendosi mentre si murava il detto giardino morto quello et in suo luogo entrato l'altro Battista, per allora, che se ne fusse cagione, non se ne fece altro. Intanto essendo Giorgio Vasari tornato da Roma, e trattenendosi in Fiorenza col duca Alessandro insino a che il cardinale Ipolito suo signore tornasse d'Ungheria, aveva avuto le stanze nel convento de' Servi, per dar principio a fare certe storie in fresco de' fatti di Cesare nella camera del canto del palazzo de' Medici, dove Giovanni da Udine avea di stucchi e pitture fatta la volta, quando Cristofano, avendo conosciuto Giorgio Vasari nel Borgo l'anno 1528 quando andò a vedere colà il Rosso dove l'avea molto carezzato, si risolvé di volere ripararsi con esso lui, e con sì fatta comodità attendere al-l'arte molto più che non aveva fatto per lo passato. Giorgio dunque, avendo praticato con lui un anno che li stette seco e trovatolo suggetto da farsi valent'uomo e che era di dolce e piacevole conversazione e secondo il suo gusto, gli pose grandissimo amore. Onde avendo a ire non molto dopo, di commessione del duca Alessandro, a Città di Castello in compagnia d'Antonio da San Gallo e di Pier Francesco da Viterbo, i quali erano stati a Fiorenza per fare il castello, o vero cittadella, e tornandosene facevano la via di Città di Castello, per riparare le mura del detto giardino del Vitelli, che minacciavano rovina, menò seco Cristofano; acciò, disegnato che esso Vasari avesse e spartito gl'ordini de' fregi, che s'avevano a fare in alcune stanze e similmente le storie e partimenti d'una stufa et altri schizzi per le facciate delle loggie, egli e Battista sopra detto il tutto conducessero a perfezzione. Il che tutto fecero tanto bene e con tanta grazia, e massimamente Cristofano, che un ben pratico e nell'arte consumato maestro non arebbe fatto tanto; e, che è più, sperimentandosi in quell'opera, si fece pratico oltre modo e valente nel disegnare e colorire.
L'anno poi 1536 venendo Carlo V imperadore in Italia et in Fiorenza, come altre volte si è detto, si ordinò un onoratissimo apparato, nel quale al Vasari per ordine del duca Alessandro fu dato carico dell'ornamento della porta a S. Piero Gattolini, della facciata in testa di via Maggio a S. Felice in piazza e del frontone che si fece sopra la porta di S. Maria del Fiore, et oltre ciò d'uno stendardo di drappo per il castello alto braccia 15 e lungo 40, nella doratura del quale andorono 50 migliaia di pezzi d'oro. Ora, parendo ai pittori fiorentini et altri che in questo apparato s'adoperavano, che esso Vasari fusse in troppo favore del duca Alessandro, per farlo rimanere con vergogna nella parte che gli toccava di quello apparato, grande nel vero e faticosa, fecero di maniera che non si poté servire d'alcun maestro di mazzonerie, né di giovani o d'altri che gl'aiutassero in alcuna cosa, di quelli che erano nella città. Di che accortosi il Vasari, mandò per Cristofano, Raffaello dal Colle e per Stefano Veltroni dal Monte San Savino suo parente, e con il costoro aiuto e d'altri pittori d'Arezzo e d'altri luoghi, condusse le sopra dette opere; nelle quali si portò Cristofano di maniera, che fece stupire ognuno, facendo onore a sé et al Vasari, che fu nelle dette opere molto lodato; le quali finite dimorò Cristofano in Firenze molti giorni, aiutando al medesimo nell'apparato che si fece per le nozze del duca Alessandro nel palazzo di Mes-ser Ottaviano de' Medici, dove fra l'altre cose condusse Cristofano un'arme della duchessa Margherita d'Austria con le palle abbracciate da un'aquila bellissima, e con alcuni putti molto ben fatti.
Non molto dopo, essendo stato ammazzato il duca Alessandro, fu fatto nel Borgo un trattato di dare una porta della città a Piero Strozzi, quando venne a Sestino, e fu perciò scritto da alcuni soldati borghesi fuorusciti a Cristofano, pregandolo che in ciò volesse essere in aiuto loro. Le quali lettere ricevute, se ben Cristofano non acconsentì al volere di coloro, volle nondimeno per non far lor male più tosto stracciare, come fece, le dette lettere, che palesarle, come secondo le leggi e bandi doveva, a Gherardo Gherardi allora commessario per il signor duca Cosimo nel Borgo. Cessati dunque i rumori e risaputasi la cosa, fu dato a molti borghesi, et in fra gl'altri a Doceno, bando di ribello. Et il signor Alessandro Vitelli, che sapendo come il fatto stava arebbe potuto aiutarlo, nol fece perché fusse Cristofano quasi forzato a servirlo nell'opera del suo giardino a Città di Castello, del quale avemo di sopra ragionato. Nella qual servitù avendo consumato molto tempo senza utile e senza profitto, finalmente, come disperato, si ridusse con altri fuorusciti nella villa di San Iustino, lontana dal Borgo un miglio e mezzo, nel dominio della Chiesa, e pochissimo lontana dal confino de' fiorentini. Nel qual luogo, come che vi stesse un pericolo, dipinse all'abate Bufolini da Città di Castello, che vi ha bellissime e commode stanze, una camera in una torre con uno spartimento di putti e figure che scortano al di sotto in su molto bene e con grottesche, festoni e maschere bellissime e più bizzarre che si possino imaginare. La qual camera fornita, perché piacque all'abate, gliene fece fare un'altra, alla quale desiderando di fare alcuni ornamenti di stucco e non avendo marmo da fare polvere per mescolarla, gli servirono a ciò molto bene alcuni sassi di fiume, venati di bianco, la polvere de' quali fece buona e durissima presa; dentro ai quali ornamenti di stucchi fece poi Cristofano alcune storie de' fatti de' romani, così ben lavorate a fresco, che fu una maraviglia.
In que' tempi lavorando Giorgio il tramezzo della badia di Camaldoli a fresco di sopra e per da basso due tavole, e volendo far loro un ornamento in fresco pieno di storie, arebbe voluto Cristofano appresso di sé, non meno per farlo tornare in grazia del Duca che per servirsene. Ma non fu possibile, ancora che Messer Ottaviano de' Medici molto se n'adoperasse col Duca, farlo tornare, sì brutta informazione gli era stata data de' portamenti di Cristofano. Non essendo dunque ciò riuscito al Vasari, come quello che amava Cristofano, si mise a far opera di levarlo almeno da S. Iustino, dove egli con altri fuoriusciti stava in grandissimo pericolo. Onde avendo l'anno 1539 a fare per i monaci di Monte Oliveto nel monasterio di San Michele in Bosco, fuor di Bologna, in testa d'un refettorio grande tre tavole a olio, con tre storie lunghe braccia quattro l'una et un fregio intorno a fresco alto braccia tre con venti storie dell'Apocalisse di figure piccole, e tutti i monasterii di quella congregazione ritratti di naturale, con un partimento di grottesche et intorno a ciascuna finestra braccia quattordici di festoni con frutte ritratte di naturale, scrisse subito a Cristofano che da San Iustino andasse a Bologna insieme con Battista Cungii borghese e suo compatriota, il quale aveva anch'egli servito il Vasari sette anni. Costoro dunque arrivati a Bologna, dove non era ancora Giorgio arrivato per essere ancora a Camaldoli, do-ve fornito il tramezzo faceva il cartone d'un Deposto di croce, che poi fece e fu in quello stesso luogo messo all'altare maggiore, si misono a ingessare le dette tre tavole et a dar di mestica, insino a che arivasse Giorgio, il quale avea dato commessione a Dattero ebreo, amico di Messer Ottaviano de' Medici, il quale faceva banco in Bologna, che provedesse Cristofano e Battista di quanto facea lor bisogno. E perché esso Dattero era gentilissimo e cortese molto, facea loro mil-le commodità e cortesie, per che andando alcuna volta costoro in compagnia di lui per Bologna assai dimesticamente et avendo Cristofano una gran maglia in un occhio e Battista gl'occhi grossi, erano così loro creduti ebrei, come era Dattero veramente. Onde avendo una mattina un calzaiuolo a portare di commessione del detto ebreo un paio di calze nuove a Cristofano, giunto al monasterio disse a esso Cristofano il quale si stava alla porta a vedere far le limosine: “Messere, sapresti voi insegnare le stanze di que' due ebrei dipintori, che qua entro lavorano?”. “Che ebrei e non ebrei”, disse Cristofano “che hai da fare con esso loro?”. “Ho a dare”, rispose colui, “queste calze a uno di loro chiamato Cristofano.” “Io sono uomo da bene e migliore cristiano che non sei tu.” “Sia come volete voi”, replicò il calzolaio, “io diceva così perciò che, oltre che voi sete tenuti e conosciuti per ebrei da ognuno, queste vostre arie, che non sono del paese, mel raffermavano.” “Non più”, disse Cristofano, “ti parrà che noi facciamo opere da cristiani.” Ma per tornare all'opera, arrivato il Vasari in Bologna, non passò un mese che egli disegnando e Cristofano e Battista abbozzando le tavole con i colori, elle furono tutte e tre fornite d'abbozzare con molta lode di Cristofano, che in ciò si portò benissimo. Finite di abbozzare le tavole, si mise mano al fregio, il quale se bene doveva tutto da sé lavorare Cristofano, ebbe compagnia: perciò che, venuto da Camaldoli a Bologna Stefano Veltroni dal Monte San Savino, cugino del Vasari, che avea abbozzata la tavola del Deposto, fecero ambidue quell'opera insieme e tanto bene, che riuscì maravigliosa.
Lavorava Cristofano le grottesche tanto bene, che non si poteva veder meglio, ma non dava loro una certa fine che avesse perfezzione. E per contrario Stefano mancava d'una certa finezza e grazia, perciò che le pennellate non facevano a un tratto restare le cose ai luoghi loro, onde perché era molto paziente, se ben durava più fatica, conduceva finalmente le sue grottesche con più diligenza e finezza. Lavorando dunque costoro a concorrenza l'opera di questo fregio, tanto faticarono l'uno e l'altro, che Cristofano imparò a finire da Stefano e Stefano imparò da lui a essere più fino e lavorare da maestro. Mettendosi poi mano ai festoni grossi, che andavano a mazzi intorno alle finestre, il Vasari ne fece uno di sua mano, tenendo innanzi frutte naturali per ritrarle dal vivo, e ciò fatto, ordinò che tenendo il medesimo modo, Cristofano e Stefano seguitassono il rimanente, uno da una banda e l'altro dall'altra della finestra; e così a una a una l'an-dassono finendo tutte, promettendo a chi di loro meglio si portasse nel fine dell'opera un paio di calze di scarlatto. Per che, gareggiando amorevolmente costoro per l'utile e per l'onore, si misero dalle cose grande a ritrarre insino alle minutissime, come migli, panichi, ciocche di finocchio et altre simili, di maniera che furono que' festoni bellissimi et ambidue ebbero il premio delle calze di scarlatto dal Vasari, il quale si affaticò molto perché Cristofano facesse da sé parte di disegni delle storie, che andarono nel fregio, ma egli non volle mai. Onde mentre che Giorgio gli faceva da sé, condusse i casamenti di due tavole con grazia e bella maniera, a tanta perfezzione, che un maestro di gran iudizio, ancor che avesse avuto i cartoni innanzi, non arebbe fatto quello che fece Cristofano, e di vero, non fu mai pittore che facesse da sé, e senza studio, le cose che a costui venivano fatte. Avendo poi finito di tirare innanzi i casamenti delle due tavole, mentre che il Vasari conduceva a fine le venti storie dell'Apocalisse per lo detto fregio, Cristofano nella tavola dove San Gregorio (la cui testa è il ritratto di papa Clemente VII) mangia con que' dodici poveri, fece Cristofano tutto l'appa-recchio del mangiare molto vivamente e naturalissimo. Essendosi poi messo mano alla terza tavola, mentre Stefano facea mettere d'oro l'ornamento delle altre due, si fece sopra due capre di legno un ponte in sul quale, mentre il Vasari lavorava da una banda in un sole i tre Angeli che apparvero ad Abraam nella valle Mambre, faceva dall'altra banda Cristofano certi casamenti. Ma perché egli faceva sempre qualche trabiccola di predelle, deschi e tal volta di catinelle a rovescio e pentole, sopra le quali saliva, come uomo a caso che egli era, avvenne che, volendo una volta discostarsi per vedere quello che avea fatto, che mancatogli sotto un piede et andate sotto sopra le trabiccole, cascò d'alto cinque braccia e si pestò in modo, che bisognò trargli sangue e curarlo da dovero altrimenti si sarebbe morto. E, che fu peggio, essendo egli un uomo così fatto e trascurato, se gli sciolsero una notte le fasce del braccio, per lo quale si era tratto sangue, con tanto suo pericolo che, se di ciò non s'accorgeva Stefano che era a dormire seco, era spacciato; e con tutto ciò si ebbe che fare a rinvenirlo, avendo fatto un lago di sangue nel letto e se stesso condotto quasi all'estremo. Il Vasari, dunque, presone particulare cura, come se gli fusse stato fratello, lo fece curare con estrema diligenza e nel vero non bisognava meno, e con tutto ciò non fu prima guarito che fu finita del tutto quell'opera. Per che tornato Cristofano a San Giustino, finì alcuna delle stanze di quell'abate lasciate imperfette, e dopo fece a Città di Castello una tavola, che era stata allogata a Battista suo amicissimo, tutta di sua mano, et un mezzo tondo, che è sopra la porta del fianco di San Fiorido, con tre figure in fresco. Essendo poi, per mezzo di Messer Pietro Aretino, chiamato Giorgio a Vinezia a ordinare e fare per i gentiluomini e signori della Compagnia della Calza l'apparato d'una sontuosissima e molto magnifica festa e la scena d'una commedia, fatta dal detto Messer Pietro Aretino per i detti signori, egli, come quello che non po-tea da sé solo condurre una tanta opera, mandò per Cristofano e Battista Cungii sopra detti, i quali arrivati finalmente a Vinezia dopo essere stati trasportati dalla fortuna del mare in Schiavonia, trovarono che il Vasari non solo era là innanzi a loro arrivato, ma avea già disegnato ogni cosa, e non ci aveva se non a por mano a dipignere. Avendo dunque i detti signori della Calza presa nel fine di Canareio una casa grande che non era finita, anzi non aveva se non le mura principali et il tetto, nello spazio d'una stanza lunga settanta braccia e larga sedici, fece fare Giorgio due ordini di gradi di legname, alti braccia quattro da terra, sopra i quali avevano a stare le gentildonne a sedere. E le facciate delle bande divise ciascuna in quattro quadri di braccia dieci l'uno, distinti con nicchie di quattro braccia l'una per larghezza, dentro le quali erano figure, le quali nicchie erano in mezzo ciascuna a due termini di rilievo alti braccia nove, di maniera che le nicchie erano per ciascuna banda cinque et i termini dieci, che in tutta la stanza venivano a essere dieci nicchie, venti termini et otto quadri di storie. Nel primo de' quali quadri a man ritta a canto alla scena, che tutti erano di chiaro scuro, era figurata per Vinezia Adria finta bellissima in mezzo al mare e sedente sopra uno scoglio con un ramo di corallo in mano, et intorno a essa stavano Nettunno, Teti, Proteo, Nereo, Glauco, Palemone et altri dii e ninfe marine, che le presentavano gioie, perle et oro et altre ricchezze del mare. Et oltre ciò vi erano alcuni amori che tiravano saette, et altri che in aria volando spargevano fiori, et il resto del campo del quadro era tutto di bellissime palme; nel secondo quadro era il fiume della Drava e della Sava ignudi con i loro vasi; nel terzo era il Po finto grosso e curpulento con sette figliuoli fatti per i sette rami che di lui uscendo mettono, come fusse ciascuno di loro fiume regio, in mare. Nel [quarto] quadro era la Brenta, con altri fiumi del Friuli. Nell'altra faccia dirimpetto all'Adria era l'isola di Candia, dove si vedeva Giove essere allattato dalla capra, con molte ninfe intorno; a canto a questo, cioè dirimpetto alla Drava, era il fiume del Tagliamento et i monti di Cadoro, e sotto a questo, dirimpetto al Po, era il lago Benaco et il Mincio che entravano in Po; allato a questo e dirimpetto alla Brenta era l'Adice et il Tesino entranti in mare. I quadri dalla banda ritta erano tramezzati da queste virtù collocate nelle nicchie: Liberalità, Concordia, Pietà, Pace e Religione. Dirimpetto nell'altra faccia erano: la Fortezza, la Prudenza Civile, la Iustizia, una Vettoria con la guerra sotto et in ultimo una Carità. Sopra poi erano cornicione architrave et un fregio pieno di lumi e di palle di vetro piene d'acque stillate, acciò avendo dietro lumi rendessono tutta la stanza luminosa. Il cielo poi era partito in quattro quadri, larghi ciascuno dieci braccia per un verso e per l'altro otto, e tanto quanto teneva la larghezza delle nicchie di quattro braccia, era un fregio che rigirava intorno intorno alla cornice et alla dirittura delle nicchie, veniva nel mezzo di tutti vani un quadro di braccia tre per ogni verso. I quali quadri erano in tutto ventitré, senza uno che n'era doppio sopra la scena, che faceva il numero di ventiquattro. Et in quest'erano l'Ore, cioè dodici della notte e dodici del giorno. Nel primo de' quadri grandi dieci braccia, il quale era sopra la scena, era il Tempo che dispensava l'Ore ai luoghi loro, accompagnato da Eolo dio de' Venti, da Giunone e da Iride; in un altro quadro era all'entrare della porta il carro dell'Aurora, che uscendo delle braccia a Titone andava spargendo rose, mentre esso carro era da alcuni galli tirato; nell'altro era il carro del Sole, e nel quarto era il carro della Notte, tirato da barbagianni, la qual Notte aveva la luna in testa, alcune nottole innanzi e d'ogni intorno tenebre. De' quali quadri fece la maggior parte Cristofano, e si portò tanto bene, che ne restò ognuno maravigliato, e massimamente nel carro della Notte, dove fece di bozze a olio quello che in un certo modo non era possibile. Similmente nel quadro d'A-dria fece que' mostri marini con tanta varietà e bellezza, che chi gli mirava rimanea stupito come un par suo avesse sa-puto tanto. Insomma, in tutta quest'opera si portò oltre ogni credenza da valente e molto pratico dipintore, e massimamente nelle grottesche e fogliami. Finito l'apparato di quella festa, stettono in Vinezia il Vasari e Cristofano alcuni me-si, dipignendo al Magnifico Messer Giovanni Cornaro il palco o vero soffittato d'una camera, nella quale andarono no-ve quadri grandi a olio. Essendo poi pregato il Vasari da Michele San Michele architettore veronese di fermarsi in Vinezia, si sarebbe forse volto a starvi qualche anno, ma Cristofano ne lo dissuase sempre, dicendo che non era bene fermarsi in Vinezia, dove non si tenea conto del disegno, né i pittori in quel luogo l'usavano, senzaché i pittori sono cagione che non vi s'attende alle fatiche dell'arti, e che era meglio tornare a Roma, che è la vera scuola dell'arti nobili e vi è molto più riconosciuta la virtù che a Vinezia. Aggiunte adunque alla poca voglia che il Vasari aveva di starvi le disuasioni di Cristofano, si partirono amendue. Ma perché Cristofano, essendo ribello dello stato di Firenze, non poteva seguitare Giorgio, se ne tornò a San Giustino dove non fu stato molto, facendo sempre qualcosa per lo già detto abbate, che andò a Perugia la prima volta che vi andò papa Paulo Terzo, dopo le guerre fatte con i perugini, dove nell'apparato che si fece per ricevere Sua Santità, si portò in alcune cose molto bene, e particolarmente al portone detto di frate Rinieri, dove fece Cristofano, come volle monsignor della Barba allora quivi governatore, un Giove grande irato et un altro placato, che sono due bellissime figure, e dall'altra banda fece un Atlante col mondo addosso et in mezzo a due fe-mine, che avevano una la spada e l'altra le bilance in mano. Le quali opere, con molte altre che fece in quelle feste Cristofano, furono cagione che fatta poi murare dal medesimo pontefice in Perugia la cittadella, Messer Tiberio Crispo, che allora era governatore e castellano, nel fare dipignere molte stanze volle che Cristofano, oltre quello che vi avea lavorato Lattanzio pittore marchigiano insin allora, vi lavorasse anch'egli. Onde Cristofano non solo aiutò al detto Lattanzio, ma fece poi di sua mano la maggior parte delle cose migliori, che sono nelle stanze di quella fortezza dipinte. Nella quale lavorò anco Raffaello dal Colle et Adone Doni d'Ascesi, pittore molto pratico e valente, che ha fatto molte cose nella sua patria et in altri luoghi. Vi lavorò anco Tommaso del Papa Celio pittore cortonese; ma il meglio che fusse fra loro e vi acquistasse più lode, fu Cristofano, onde messo in grazia da Lattanzio del detto Crispo, fu poi sempre molto adoperato da lui.
Intanto avendo il detto Crispo fatto una nuova chiesetta in Perugia, detta Santa Maria del Popolo, e prima del Mercato, et avendovi cominciata Lattanzio una tavola a olio, vi fece Cristofano di sua mano tutta la parte di sopra, che invero è bellissima e molto da lodare. Essendo poi fatto Lattanzio, di pittore bargello di Perugia, Cristofano se ne tornò a San Giustino, vi si stette molti mesi pur lavorando per lo detto signor abate Bufolini. Venuto poi l'anno 1543 avendo Giorgio a fare per lo illustrissimo cardinal Farnese una tavola a olio per la Cancelleria grande et un'altra chiesa di Santo Agostino, per Galeotto da Girone, mandò per Cristofano, il quale andato ben volentieri, come quello che avea voglia di veder Roma, vi stette molti mesi facendo poco altro che andar veggendo, ma nondimeno acquistò tanto, che tornato di nuovo a S. Iustino fece per capriccio in una sala alcune figure tanto belle, che pareva che l'avesse studiate venti anni. Dovendo poi andare il Vasari l'anno 1545 a Napoli a fare ai frati di Monte Uliveto un refettorio di molto maggior opera che non fu quella di San Michele in Bosco di Bologna, mandò per Cristofano, Raffaello dal Colle e Stefano sopra detti, suoi amici e creati, i quali tutti si trovarono al tempo determinato in Napoli, eccetto Cristofano, che restò per essere ammalato. Tuttavia essendo sollecitato dal Vasari si condusse in Roma per andare a Napoli, ma ritenuto da Borgognone suo fratello, che era anch'egli fuoruscito, et il quale lo voleva condurre in Francia, si perdé quell'occasione; ma ritornando il Vasari l'anno 1546 da Napoli a Roma per fare ventiquattro quadri che poi furono mandati a Napoli e posti nella sagrestia di San Giovanni Carbonaro, nei quali dipinse in figure d'un braccio o poco più storie del Testamento Vecchio e della vita di San Giovanni Battista, e per dipignere similmente i portelli dell'organo del piscopio che erano alti braccia sei, si servì di Cristofano, che gli fu di grandissimo aiuto e condusse figure e paesi in quell'opere molto eccellentemente. Similmente aveva disegnato Giorgio servirsi di lui nella sala della Cancelleria, la quale fu dipinta con i cartoni di sua mano e del tutto finita in cento giorni, per lo cardinal Farnese, ma non gli venne fatto, perché amalatosi Cristofano, se ne tornò a San Giustino subito che fu cominciato a migliorare, et il Vasari senza lui finì la sala, aiutato da Raffaello dal Colle, da Gianbatista Bagna Cavallo bolognese, da Roviale e Bizzera spagnuoli, e da molti altri suoi amici e creati.
Da Roma tornato Giorgio a Fiorenza e di lì dovendo andare a Rimini, per fare all'abate Gian Matteo Faettani nella chiesa de' monaci di Monte Oliveto una cappella a fresco et una tavola, passò da San Giustino per menar seco Cristofano, ma l'abate Buffolino, al quale dipigneva una sala, non volle per allora lasciarlo partire, promettendo a Giorgio che presto gliela manderebbe fino in Romagna. Ma non ostanti cotali promesse stette tanto a mandarlo, che quando Cristofano andò trovò esso Vasari non solo aver finito l'opere di quell'abbate, ma aveva anco fatto una tavola all'altar maggiore di San Francesco d'Arimini per Messer Niccolò Marcheselli, et a Ravenna nella chiesa di Classi de' monaci di Camaldoli un'altra tavola al padre don Romualdo da Verona, abbate di quella badia. Aveva apunto Giorgio l'anno 1550 non molto innanzi fatto in Arezzo nella badia di Santa Fiore de' monaci Neri, cioè nel refettorio, la storia delle nozze d'Ester, et in Fiorenza nella chiesa di San Lorenzo alla cappella de' Martelli la tavola di San Gismondo quando, essendo creato papa Giulio Terzo, fu condotto a Roma al servigio di Sua Santità, là dove pensò al sicuro, col mezzo del cardinal Farnese che in quel tempo andò a stare a Fiorenza, di rimettere Cristofano nella patria e tornarlo in grazia del duca Cosimo. Ma non fu possibile, onde bisognò che il povero Cristofano si stesse così infino al 1554, nel qual tempo essendo chiamato il Vasari al servizio del duca Cosimo, se gli porse occasione di liberare Cristofano. Aveva il vescovo de' Ricasoli, perché sapeva di farne cosa grata a sua eccellenza, messo mano a fare dipignere di chiaro scuro le tre facciate del suo palazzo, che è posto in sulla coscia del ponte alla Carraia, quando Messer Sforza Almeni, coppiere e primo e più favorito cameriere del Duca, si risolvé di voler far anch'egli dipignere di chiaro scuro a concorrenza del vescovo la sua casa della via de' Servi. Ma non avendo trovato pittori a Firenze secondo il suo capriccio, scrisse a Giorgio Vasari, il quale non era anco venuto a Fiorenza, che pensasse all'invenzione e gli mandasse disegnato quello che gli pareva si dovesse dipignere in detta sua facciata. Per che Giorgio, il quale era suo amicissimo e si conoscevano insino quando ambidue stavano col duca Alessandro, pensato al tutto, secondo le misure della facciata, gli mandò un disegno di bellissima invenzione: il quale a dirittura da capo a piedi con ornamento vario rilegava et abelliva le finestre e riempieva con ricche storie tutti i vani della facciata. Il qual disegno, dico, che conteneva per dirlo brevemente tutta la vita dell'uomo dalla nascita per infino alla morte, mandato dal Vasari a Messer Sforza, gli piacque tanto, e parimente al Duca, che per fare egli avesse la sua perfezzione, si risolverono a non volere che vi si mettesse mano fino a tanto che esso Vasari non fusse venuto a Fiorenza. Il quale Vasari finalmente venuto e ricevuto da sua eccellenza illustrissima e dal detto Messer Sforza con molte carezze, si cominciò a ragionare di chi potesse essere il caso a condurre la detta facciata. Per che, non lasciando Giorgio fuggire l'occasione, disse a Messer Sforza che niuno era più atto a condurre quell'opera che Cristofano e che né in quella, né parimente nell'opere che si avevano a fare in palazzo, potea fare senza l'aiuto di lui. Laonde, avendo di ciò parlato Messer Sforza al Duca, dopo molte informazioni trovatosi che il peccato di Cristofano non era sì grave come era stato dipinto, fu da sua eccellenza il cattivello finalmente ribenedetto. La qual nuova avendo avuta il Vasari, che era in Arezzo a rivedere la patria e gl'amici, mandò subito uno a posta a Cristofano, che di ciò niente sapeva, a dargli sì fatta nuova. All'avuta della quale fu per allegrezza quasi per venir meno; tutto lieto adunque, confessando niuno avergli mai voluto meglio del Vasari, se n'andò la mattina vegnente da Città di Castello al Borgo, dove, presenta-te le lettere della sua liberazione al commessario, se n'andò a casa del padre, dove la madre, et il fratello che molto innanzi si era ribandito, stupirono. Passati poi due giorni se n'andò ad Arezzo, dove fu ricevuto da Giorgio con più festa che se fusse stato suo fratello, come quelli che da lui si conoscea tanto amato, che era risoluto voler fare il rimanente della vita con esso lui. D'Arezzo poi venuti ambidue a Firenze, andò Cristofano a baciar le mani al Duca, il quale lo vide volentieri e restò maravigliato, perciò che, dove avea pensato veder qualche gran bravo, vide un omicciatto il migliore del mondo. Similmente essendo molto stato carezzato da Messer Sforza, che gli pose amor grandissimo, mise mano Cristofano alla detta facciata, nella quale, perché non si poteva ancor lavorare in palazzo, gl'aiutò Giorgio, pregato da lui, a fare per le facciate alcuni disegni delle storie, disegnando anco tal volta nell'opera sopra la calcina di quelle figure che vi sono. Ma se bene vi sono molte cose ritocche dal Vasari, tutta la facciata nondimeno e la maggior parte delle figure e tutti gl'ornamenti, festoni et ovati grandi, sono di mano di Cristofano, il quale, nel vero, come si vede, va-leva tanto nel maneggiar i colori in fresco che si può dire, e lo confessa il Vasari, che ne sapesse più di lui. E se si fusse Cristofano, quando era giovanetto, essercitato continovamente negli studii dell'arte (perciò che non disegnava mai, se non quando aveva a mettere in opera) et avesse seguitato animosamente le cose dell'arte, non arebbe avuto pari, veggendosi che la pratica, il giudizio e la memoria gli facevano in modo condurre le cose senza altro studio, che egli superava molti che invero ne sapevano più di lui. Né si può credere con quanta pratica e prestezza egli conducesse i suoi lavori, e quando si piantava a lavorare e fusse di che tempo si volesse, sì gli dilettava, che non levava mai capo dal lavo-ro, onde altri si poteva di lui promettere ogni gran cosa. Era oltre ciò tanto grazioso nel conversare e burlare mentre che lavorava, che il Vasari stava tal volta dalla mattina fino alla sera in sua compagnia lavorando, senza che gli venisse mai a fastidio. Condusse Cristofano questa facciata in pochi mesi, senzaché tal volta stette alcune settimane senza lavorarvi, andando al Borgo a vedere e godere le cose sue. Né voglio che mi paia fatica raccontare gli spartimenti e figure di que-st'opera, la quale potrebbe non aver lunghissima vita, per esser all'aria e molto sottoposta ai tempi fortunosi: né era a fatica fornita, che da una terribile pioggia e grossissima grandine fu molto offesa, et in alcuni luoghi scalcinato il muro. Sono adunque in questa facciata tre spartimenti: il primo è, per cominciarmi, da basso, dove sono la porta principale e le due finestre; il secondo è dal detto davanzale insino a quello del secondo finestrato, et il terzo è dalle dette ultime finestre insino alla cornice del tetto. E sono oltre ciò in ciascun finestrato sei finestre, che fanno sette spazii, e secondo quest'ordine fu divisa tutta l'opera per dirittura dalla cornice del tetto infino a terra. A canto dunque alla cornice del tetto è in prospettiva un cornicione con mensole che risaltano sopra un fregio di putti, sei de' quali per la larghezza della facciata stanno ritti, cioè sopra il mezzo dell'arco di ciascuna finestra uno, e sostengono con le spalle festoni bellissimi di frutti, frondi e fiori che vanno da l'uno all'altro, i quali fiori e frutti sono di mano in mano secondo le stagioni e secondo l'età della vita nostra, quivi dipinta. Similmente in sul mezzo de' festoni, dove pendono, sono altri puttini in di-verse attitudini. Finita questa fregiatura, in fra i vani delle dette finestre di sopra in sette spazii che vi sono si feciono i sette pianeti con i sette segni celesti sopra loro per finimento et ornamento; sotto il davanzale di queste finestre, nel parapetto è una fregiatura in virtù che a due a due tengono sette ovati grandi, dentro ai quali ovati sono distinte in istorie le sette età dell'uomo. E ciascuna età accompagnata da due virtù a lei convenienti in modo, che sotto gl'ovati, fra gli spazii delle finestre di sotto, sono le tre virtù teologiche e le quattro morali; e sotto, nella fregiatura, che è sopra la porta e finestre inginocchiate, sono le sette arti liberali e ciascuna è alla dirittura dell'ovato in cui è la storia dell'età a quella virtù conveniente; et appresso nella medesima dirittura le virtù morale, pianeti, segni et altri corrispondenti. Fra le finestre inginocchiate poi è la vita attiva e la contemplativa con istorie e statue per insino alla morte, inferno et ultima resurrezzione nostra. E per dir tutto, condusse Cristofano quasi solo tutta la cornice, festoni e putti et i sette segni de' pianeti. Cominciando poi da un lato fece primieramente la luna e per lei fece una Diana che ha il grembo pieno di fiori, simili a Proserpina, con una luna in capo et il segno di Cancro sopra. Sotto nell'ovato, dove è la storia dell'infanzia, a la nascita dell'uomo sono alcune balie che lattano putti e donne di parto nel letto, condotte da Cristofano con molta grazia. E questo ovato è sostenuto dalla Volontà sola, che è una giovane vaga e bella, mezza nuda, la quale è retta dalla Carità, che anch'ella allatta putti. E sotto l'ovato, nel parapetto, è la Grammatica, che insegna leggere ad alcuni putti; segue, tornando da capo, Mercurio col caduceo e col suo segno, il quale ha nell'ovato la Puerizia con alcuni putti, parte de' quali vanno alla scuola e parte giuocano. E questo è sostenuto dalla Verità, che è una fanciulletta ignuda tutta pura e semplice, la quale ha da una parte un maschio per la Falsità con varii socinti, e viso bellissimo, ma con gl'occhi cavati in dentro. E sotto l'ovato [tra] le finestre [è] la Fede, che con la destra battezza un putto in una conca piena d'acqua e con la sinistra mano tiene una croce, e sotto è la Loica nel parapetto con un serpente e coperta da un velo; séguita poi il sole figurato in un Apollo che ha la testa in mano et il suo segno nell'ornamento di sopra. Nell'ovato è l'Adolescenza in due giovinetti che andando a paro, l'uno saglie con un ramo d'oliva un monte illuminato dal sole, e l'altro fermandosi a mezzo il camino a mirare le bellezze che ha la Fraude dal mezzo in su, senza accorgersi che le cuopre il viso bruttissimo una bella e pulita maschera, è da lei e dalle sue lusinghe fatto cadere in un precipizio. Regge questo ovato l'Ozio, che è un uomo grasso e corpolento, il quale si sta tutto sonnacchioso e nudo a guisa d'un sileno, e la Fatica, in persona d'un robusto e faticante villano, che ha d'attorno gl'instrumenti da lavorar la terra. E questi sono retti da quella parte del-l'ornamento ch'è fra le finestre dove è la Speranza che ha l'ancore a' piedi, e nel parapetto di sotto è la Musica con varii strumenti musicali attorno; séguita in ordine Venere la quale, avendo abbracciato Amore, lo bacia et ha anch'ella sopra il suo segno. Nell'ovato che ha sotto è la storia della Gioventù: cioè un giovane nel mezzo a sedere con libri, strumenti da misurare et altre cose appartenenti al disegno, et oltre ciò, apamondi, palle di cosmografia e sfere. Dietro a lui è una loggia, nella quale sono giovani che cantando, danzando e sonando si danno buon tempo; et un convito di giovani tutti dati a' piaceri. Dall'uno de' lati è sostenuto questo ovato dalla Cognizione di se stesso, la quale ha intorno seste, armille, quadrati e libri e si guarda in uno specchio, e dall'altro dalla Fraude, bruttissima vecchia magra e sdentata, la quale si ride di essa Cognizione, e con bella e pulita maschera si va ricoprendo il viso. Sotto l'ovato è la Temperanza con un freno da cavallo in mano, e sotto nel parapetto la Rettorica che è in fila con l'altre. Segue a canto questi Marte armato con molti trofei attorno col segno sopra del leone. Nel suo ovato, che è sotto, è la Virilità finta in un uomo maturo, messo in mezzo dalla Memoria e dalla Volontà che gli porgono innanzi un bacino d'oro dentrovi due ale, e gli mostrano la via della salute verso un monte. E questo ovato è sostenuto dall'Innocenza, che è una giovane con uno agnello a lato e dalla Ilarità, che tuta letiziante e ridente si mostra quello che è veramente. Sotto l'ovato tra le finestre è la Prudenza, che si fa bella allo specchio et ha sotto nel parapetto la Filosofia; séguita Giove con il fulmine e con l'aquila suo uccello e col suo segno sopra. Nell'ovato è la Vecchiezza, la quale è figurata in un vecchio vestito da sacerdote e ginocchioni dinanzi a un altare, sopra il quale pone il bacino d'oro con le due ale. E questo ovato è retto dalla Pietà, che ricuopre certi putti nudi, e dalla Religione ammantata di vesti sacerdotali. Sotto è la Fortezza armata, la quale posando con atto fiero l'una delle gambe sopra un rocchio di colonna, mette in bocca a un leone certe palle et ha nel parapetto di sotto l'Astrologia. L'ultimo de' sette pianeti è Saturno finto in un vecchio tutto malinconico che si mangia i figliuoli et un serpente grande che prende con i denti la coda, il quale Saturno ha sopra il segno del Capricorno. Nell'ovato è la Decrepità, nella quale è finto Giove in cielo ricevere un vecchio decrepito ignudo e ginocchioni, il quale è guardato dalla Felicità e dalla Immortalità, che gettano nel mondo le vestimenta. È questo ovato sostenuto dalla Beatitudine, la quale è retta sotto nell'ornamento dalla Iustizia, la quale è a sedere et ha in mano lo scetro e la cicogna, sopra le palle con l'arme e le leggi attorno, e di sotto nel parapetto è la Geometria. Nell'ultima parte da basso, che è intorno alle finestre inginocchiate et alla porta, è Lia in una nicchia per la Vita attiva e dall'altra banda del medesimo luogo l'Industria che ha un corno di dovizia e due stimoli in mano. Di verso la porta è una storia, dove molti fabricanti, architetti e scarpellini han-no innanzi la porta di Cosmopoli, città edificata dal signor duca Cosimo nell'isola dell'Elba, col ritratto di Porto Ferrai. Fra questa storia et il fregio, dove sono l'Arti liberali, è il lago Trasimeno, al quale sono intorno ninfe ch'escono dell'ac-qua, con tinche, lucci, anguille e lasche, et allato al lago è Perugia in una figura ignuda, avendo un cane in mano lo mostra a una Fiorenza ch'è dall'altra banda che corrisponde a questa, con un Arno a canto che l'abbraccia e gli fa festa. E sotto questa è la Vita contemplativa in un'altra storia, dove molti filosofi et astrologhi misurano il cielo e mostrano di fare la natività del Duca, et a canto, nella nicchia che è rincontro a Lia, è Rachel sua sorella, figliuola di Laban, figurata per essa Vita contemplativa. L'ultima storia, la quale anch'essa è in mezzo a due nicchie e chiude il fine di tutta l'inven-zione, è la Morte, la quale sopra un caval secco e con la falce in mano, avendo seco la guerra, la peste e la fame, corre addosso ad ogni sorte di gente. In una nicchia è lo dio Plutone et a basso Cerbero cane infernale, e nell'altra è una figura grande che resuscita il dì novissimo d'un sepolcro. Dopo le quali tutte cose fece Cristofano, sopra i frontespizii delle finestre inginocchiate, alcuni ignudi che tengono l'imprese di sua eccellenza, e sopra la porta un'arme ducale, le cui sei palle sono sostenute da certi putti ignudi, che volando s'intrecciano per aria. E per ultimo nei basamenti da basso, sotto tutte le storie, fece il medesimo Cristofano l'impresa di esso Messer Sforza, cioè alcune aguglie o vero piramidi triangolari che posano sopra tre palle, con un motto intorno che dice: “Inmobilis”. La quale opera finita fu infinitamente lodata da sua eccellenza e da esso Messer Sforza, il quale come gentilissimo e cortese, voleva con un donativo d'importanza ristorare la virtù e fatica di Cristofano, ma egli nol sostenne, contentandosi e bastandogli la grazia di quel signore, che sempre l'amò quanto più non saprei dire.
Mentre che quest'opera si fece, il Vasari, sì come sempre avea fatto per l'adietro, tenne con esso seco Cristofano in casa del signor Bernardetto de' Medici al quale, perciò che vedeva quanto si dilettava della pittura, fece esso Cristofano in un canto del giardino due storie di chiaro scuro: l'una fu il rapimento di Proserpina e l'altra Vertunno e Pomona dèi dell'agricoltura, et oltre ciò fece in quest'opera Cristofano alcuni ornamenti di termini e putti tanto belli e varii, che non si può veder meglio. Intanto essendosi dato ordine in palazzo di cominciare a dipignere, la prima cosa a che si mise mano fu una sala delle stanze nuove, la quale, essendo larga braccia venti e non avendo disfogo, secondo che l'aveva fatta il Tasso, più di nove braccia, con bella invenzione fu alzata tre, cioè insino a dodici in tutto, dal Vasari senza muovere il tetto, che era la metà a padiglione. Ma perché in ciò fare, prima che si potesse dipignere andava molto tempo in rifare i palchi et altri lavori di quella e d'altre stanze, ebbe licenza esso Vasari d'andare a starsi in Arezzo due mesi insieme con Cristofano, ma non gli venne fatto di potere in detto tempo riposarsi, conciò sia che non poté mancare di non andare in detto tempo a Cortona, dove nella Compagnia del Gesù dipinse la volta e le facciate in fresco insieme con Cristofano, che si portò molto bene, e massimamente in dodici sacrificii variati del Testamento Vecchio, i quali fe-cero nelle lunette fra i peducci delle volte. Anzi per meglio dire fu quasi tutta questa opera di mano di Cristofano, non avendovi fatto il Vasari che certi schizzi, disegnato alcune cose sopra la calcina e poi ritocco tal volta alcuni luoghi, secondo che bisognava. Fornita quest'opera che non è se non grande, lodevole e molto ben condotta, per la molta varietà delle cose che vi sono, se ne tornarono amendue a Fiorenza del mese di gennaio, l'anno 1555, dove, messo mano a dipignere la sala degl'Elementi, mentre il Vasari dipigneva i quadri del palco, Cristofano fece alcune imprese che rilegano i fregi delle travi per lo ritto, nelle quali sono teste di capricorno e testuggini con la vela, imprese di sua eccellenza. Ma quello in che si mostrò costui maraviglioso furono alcuni festoni di frutte, che sono nella fregiatura della trave dalla parte di sotto, i quali sono tanto belli, che non si può veder cosa meglio colorita né più naturale, essendo massimamente tramezzati da certe maschere, che tengono in bocca le legature di essi festoni, delle quali non si possono veder né le più varie né le più bizzarre; nella qual maniera di lavori si può dire che fusse Cristofano superiore a qualunque altro n'ha fatto maggiore e particulare professione. Ciò fatto, dipinse nelle facciate, ma con i cartoni del Vasari, dove è il nascimento di Venere, alcune figure grandi et in un paese molte figurine piccole, che furono molto ben condotte. Similmente nella facciata dove gl'amori, piccioli fanciulletti, fabbricano le saette a Cupido, fece i tre Ciclopi che battono i fulmini per Giove; e sopra sei porte condusse a fresco sei ovati grandi con ornamenti di chiaro scuro, e dentro storie di bronzo che furono bellissimi. E nella medesima sala colorì un Mercurio et un Plutone fra le finestre, che sono parimente bellissimi. Lavorandosi poi a canto a questa sala la camera della dea Opi, fece nel palco in fresco le quattro stagioni, et oltre alle figure alcuni festoni che per la loro varietà e bellezza furono maravigliosi; conciò sia che come erano quelli della Primavera pieni di mille sorti fiori, così quelli della State erano fatti con una infinità di frutti e biade; quelli dell'Autun-no erano d'uve e pampani, e quei del Verno di cipolle, rape, radici, carote, pastinache e foglie secche, senza che egli colorì a olio nel quadro di mezzo, dove è il carro d'Opi, quattro leoni che lo tirano, tanto belli, che non si può far meglio, et invero nel fare animali non aveva paragone. Nella camera poi di Cerere, che è a lato a questa, fece in certi angoli alcuni putti e festoni belli affatto, e nel quadro del mezzo, dove il Vasari aveva fatto Cerere cercante Proserpina con una face di pino accesa e sopra un carro tirato da due serpenti, condusse molte cose a fine Cristofano di sua mano, per esser in quel tempo il Vasari amalato et aver lasciato fra l'altre cose quel quadro imperfetto. Finalmente venendosi a fare un terrazzo, che è dopo la camera di Giove et allato a quella di Opi, si ordinò di farvi tutte le cose di Giunone, e così fornito tutto l'ornamento di stucchi con ricchissimi intagli e varii componimenti di figure, fatti secondo i cartoni del Vasari, ordinò esso Vasari che Cristofano conducesse da sé solo in fresco quell'opera, disiderando, per esser cosa che aveva a vedersi da presso e di figure non più grandi che un braccio, che facesse qualche cosa di bello in quello che era sua propria professione. Condusse dunque Cristofano in un ovato della volta uno sposalizio con Iunone in aria e dall'uno de' lati in un quadro Ebe, dea della gioventù, e nell'altro Iride, la quale mostra in cielo l'arco celeste. Nella medesima volta fece tre altri quadri, due per riscontro et un altro maggiore alla dirittura dell'ovato, dove è lo sposalizio, nel quale è Giunone sopra il carro a sedere tirato dai pavoni. In uno degl'altri due che mettono in mezzo questo è la dea della Potestà e nell'altro l'Abondanza col corno della copia a' piedi; sotto sono nelle faccie in due quadri, sopra l'entrare di due porte, due altre storie di Giunone: quando converte la figliuola d'Inaco fiume in vacca e Calisto in orsa. Nel fare della quale opera pose sua eccellenza grandissima affezzione a Cristofano veggendolo diligente e sollecito oltre modo a lavorare, perciò che non era la mattina a fatica giorno, che Cristofano era comparso in sul lavoro, del quale avea tanta cura e tanto gli dilettava, che molte volte non si forniva di vestire per andar via, e tal volta, anzi spesso, avvenne che si mise per la fretta un paio di scarpe (le quali tutte teneva sotto il letto) che non erano compagne, ma di due ragioni, et il più delle volte aveva la cappa a rovescio e la caperuccia dentro. Onde una mattina comparendo a buon'ora in sull'opera, do-ve il signor Duca e la signora Duchessa si stavano guardando et apparecchiandosi d'andare a caccia, mentre le dame e gli altri si mettevano a ordine, s'avvidero che Cristofano al suo solito aveva la cappa a rovescio et il cappuccio di dentro, per che ridendo ambidue, disse il Duca: “Cristofano, che vuol dir questo portar sempre la cappa a rovescio?”. Rispose Cristofano: “Signore, io nol so, ma voglio un dì trovare una foggia di cappe che non abbino né diritto né rovescio, e siano da ogni banda a un modo, perché non mi basta l'animo di portarla altrimenti, vestendomi et uscendo di casa la mattina le più volte al buio, senza che io ho un occhio in modo impedito, che non ne veggio punto. Ma guardi vostra eccellenza a quel che io dipingo e non a come io vesto”. Non rispose altro il signor Duca, ma di lì a pochi giorni gli fece fare una cappa di panno finissimo e cucire e rimendare i pezzi in modo, che non si vedeva né ritto né rovescio, et il collare da capo era lavorato di passamani nel medesimo modo dentro che di fuori e così il finimento che aveva intorno. E quella finita, la mandò per uno staffieri a Cristofano, imponendo che gliela desse da sua parte. Avendo dunque una mattina di buon'ora ricevuta costui la cappa, senza entrare in altre cirimonie, provata che se la fu, disse allo staffieri: “Il Duca ha ingegno, digli che la sta bene”. E perché era Cristofano della persona sua trascurato e non aveva alcuna cosa più in odio che avere a mettersi panni nuovi o andare troppo stringato e stretto, il Vasari, che conosceva quell'umore, quando conoscea che egli aveva d'alcuna sorte di panni bisogno, glieli facea fare di nascosto e poi una mattina di buo-n'ora porglieli in camera e levare i vecchi, e così era forzato Cristofano a vestirsi quelli che vi trovava. Ma era un sollazzo maraviglioso starlo a udire mentre era in còllora e si vestiva i panni nuovi: “Guarda”, diceva egli, “che assassinamenti son questi, non si può in questo mondo vivere a suo modo; può fare il diavolo che questi nimici delle commodità si dieno tanti pensieri?”. Una mattina fra l'altre essendosi messo un paio di calze bianche, Domenico Benci pittore, che lavorava anch'egli in palazzo col Vasari, fece tanto che in compagnia d'altri giovani menò Cristofano con esso seco alla Madonna dell'Impruneta, e così avendo tutto il giorno caminato, saltato e fatto buon tempo, se ne tornarono la sera dopo cena. Onde Cristofano, che era stracco, se n'andò subito per dormire in camera, ma essendosi messo a trarsi le calze, fra perché erano nuove et egli era sudato, non fu mai possibile che se ne cavasse se non una, per che, andato la sera il Vasari a vedere come stava, trovò che s'era adormentato con una gamba calzata e l'altra scalza, onde fece tanto, che tenendogli un servidore la gamba e l'altro tirando la calza, pur gliela trassero, mentre che egli malediva i panni, Giorgio, e chi trovò certe usanze che tengono (diceva egli) gl'uomini schiavi in catena. Che è più, egli gridava che voleva andarsi con Dio e per ogni modo tornarsene a S. Giustino, dove era lasciato vivere a suo modo, e dove non avea tante servitù. E fu una passione racconsolarlo. Piacevagli il ragionar poco et amava che altri in favellando fusse breve, in tanto che non che altro arebbe voluto i nomi proprii degl'uomini brevissimi, come quello d'uno schiavo che aveva Messer Sforza, il quale si chiamava M... “Oh questi”, dicea Cristofano, “son be' nomi, e non Giovan Francesco e Giovan Antonio, che si pena un'ora a pronunziarli.” E perché era grazioso di natura e diceva queste cose in quel suo linguaggio borghese, arebbe fatto ridere il pianto.
Si dilettava d'andare il dì delle feste dove si vendevono leggende e pitture stampate et ivi si stava tutto il giorno; e, se ne comperava alcuna, mentre andava l'altre guardando le più volte le lasciava in qualche luogo, dove si fusse appoggiato. Non volle mai, se non forzato, andare a cavallo ancor che fusse nato nella sua patria nobilmente e fusse assai ricco. Finalmente essendo morto Borgognone suo fratello e dovendo egli andare al Borgo, il Vasari, che aveva riscosso molti danari delle sue provisioni e serbatigli, gli disse: “Io ho tanti danari di vostro: è bene che gli portiate con esso voi, per servirvene ne' vostri bisogni”. Rispose Cristofano: “Io non vo' danari, pigliategli per voi, che a me basta la grazia di starvi appresso e di vivere e morire con esso voi”. “Io non uso”, replicò il Vasari, “servirmi delle fatiche altrui; se non gli volete, gli manderò a Guido vostro padre.” “Cotesto non fate voi”, disse Cristofano “perciò che gli manderebbe male, come è il solito suo.” In ultimo avendogli presi se n'andò al Borgo indisposto e con mala contenteza d'animo, dove giunto, il dolore della morte del fratello, il quale amava infinitamente, et una crudele scolatura di rene, in pochi giorni, avuti tutti i Sacramenti della chiesa, si morì, avendo dispensato a' suoi di casa et a molti poveri que' danari che aveva portato, affermando poco anzi la morte che ella per altro non gli doleva se non perché lasciava il Vasari in troppo gran-di impacci e fatiche, quanti erano quelli a che aveva messo mano nel palazzo del Duca. Non molto dopo avendo sua eccellenza intesa la morte di Cristofano, e certo con dispiacere, fece fare in marmo la testa di lui e con l'infrascritto epitaffio la mandò da Fiorenza al Borgo dove fu posta in San Francesco.
D.O.M. CHRISTOPHORO GHERARDO BURGENSI PINGENDI ARTE PRAESTANTISSIMO QUOD GEORGIUS VASARIUS ARETINUS HUIUS ARTIS FACILE PRINCEPS IN EXORNANDO COSMI FLORENTINORUM DUCIS PALATIO ILLIUS OPERAM QUAM MAXIME PROBAVERIT PICTORES HETRUSCI POSUERE OBIIT A. D. MDLVI. VIXIT AN. LVI. M. III. D. VI
VITA DI IACOPO DA PUNTORMO
PITTORE FIORENTINO

Gl'antichi, o vero maggiori di Bartolomeo di Iacopo di Martino, padre di Iacopo da Puntormo del quale al presente scriviamo la vita, ebbono, secondo che alcuni affermano, origine dall'Ancisa, castello del Valdarno di sopra, assai famoso per avere di lì tratta similmente la prima origine gl'antichi di Messer Francesco Petrarca. Ma o di lì o d'altronde che fussero stati i suoi maggiori, Bartolomeo sopra detto, il quale fu fiorentino e secondo che mi vien detto della famiglia de' Carucci, si dice che fu discepolo di Domenico del Ghirlandaio, e che avendo molte cose lavorato in Valdarno come pittore secondo que' tempi ragionevole, condottosi finalmente a Empoli a fare alcuni lavori e quivi e ne' luoghi vicini dimorando, prese moglie in Puntormo una molto virtuosa e da ben fanciulla, chiamata Alessandra, figliuola di Pasquale di Zanobi e di monna Brigida sua donna. Di questo Bartolomeo adunque nacque l'anno 1493 Iacopo, ma essendogli morto il padre l'anno 1499, la madre l'anno 1504 e l'avolo l'anno 1506, et egli rimaso al governo di monna Brigida sua avola, la quale lo tenne parecchi anni in Puntormo, e gli fece insegnare leggere e scrivere et i primi principii della grammatica latina, fu finalmente dalla medesima condotto di tredici anni in Firenze e messo ne' pupilli, acciò da quel magistrato, secondo che si costuma, fussero le sue poche facultà custodite e conservate, e lui posto che ebbe in casa d'un Battista calzolaio, un poco suo parente, si tornò monna Brigida a Puntormo e menò seco una sorella di esso Iacopo. Ma indi a non molto essendo anco essa monna Brigida morta, fu forzato Iacopo a ritirarsi la detta sorella in Fiorenza e metterla in casa d'un suo parente chiamato Nicolaio, il quale stava nella via de' Servi. Ma anche questa fanciulla, seguitando gl'altri suoi, avanti fusse maritata si morì l'anno 1512. Ma per tornare a Iacopo, non era anco stato molti mesi in Fiorenza, quando fu messo da Bernardo Vettori a stare con Lionardo da Vinci, e poco dopo con Mariotto Albertinelli, con Piero di Cosimo, e finalmente, l'anno 1512, con Andrea del Sarto, col quale similmente non stette molto perciò che, fatti che ebbe Iacopo i cartoni dell'archetto de' Servi, del quale si parlerà di sotto, non parve che mai dopo lo vedesse Andrea ben volentieri, qualunche di ciò fusse la cagione.
La prima opera dunque che facesse Iacopo in detto tempo, fu una Nunziata piccoletta per un suo amico sarto, ma essendo morto il sarto prima che fusse finita l'opera, si rimase in mano di Iacopo, che allora stava con Mariotto, il quale n'aveva vanagloria e la mostrava per cosa rara a chiunche gli capitava a bottega. Onde venendo di que' giorni a Firenze Raffaello da Urbino, vide l'opera et il giovinetto che l'avea fatta, con infinita maraviglia, profetando di Iacopo quello che poi si è veduto riuscire. Non molto dopo essendo Mariotto partito di Firenze et andato a lavorare a Viterbo la tavola che fra' Bartolomeo vi aveva cominciata, Iacopo, il quale era giovane malinconico e soletario, rimaso senza maestro andò da per sé a stare con Andrea del Sarto, quando a punto egli avea fornito nel cortile de' Servi le storie di San Filippo, le quale piacevano infinitamente a Iacopo, sì come tutte l'altre cose e la maniera e disegno d'Andrea. Datosi dunque Iacopo a far ogni opera d'immitarlo, non passò molto che si vide aver fatto acquisto maraviglioso nel disegnare e nel colorire, in tanto che alla pratica parve che fusse stato molti anni all'arte. Ora avendo Andrea di que' giorni finita una tavola d'una Nunziata per la chiesa de' frati di San Gallo oggi rovinata, come si è detto nella sua vita, egli diede a fare la predella di quella tavola a olio a Iacopo, il quale vi fece un Cristo morto con due Angioletti che gli fanno lume con due torce e lo piangono, e dalle bande in due tondi, due Profeti, i quali furono così praticamente lavorati, che non paiono fatti da giovinetto, ma da un pratico maestro. Ma può anco essere, come dice il Bronzino ricordarsi avere udito da esso Iacopo Puntormo, che in questa predella lavorasse anco il Rosso. Ma sì come a fare questa predella fu Andrea da Iacopo aiutato, così fu similmente in fornire molti quadri et opere che continuamente faceva Andrea.
In quel mentre, essendo stato fatto sommo pontefice il cardinale Giovanni de' Medici e chiamato Leone Decimo, si facevano per tutta Fiorenza dagl'amici e divoti di quella casa molte armi del Pontefice, in pietre, in marmi, in tele et in fresco. Per che volendo i frati de' Servi fare alcun segno della divozione e servitù loro verso la detta casa e Pontefice, fecero fare di pietra l'arme di esso Leone e porla in mezzo all'arco del primo portico della Nunziata, che è in sulla piazza, e poco appresso diedero ordine che ella fusse da Andrea di Cosimo pittore messa d'oro et adornata di grottesche, delle quali era egli maestro eccellente, e dell'imprese di casa Medici, et oltre ciò messa in mezzo da una Fede e da una Carità. Ma conoscendo Andrea di Cosimo che da sé non poteva condurre tante cose, pensò di dare a fare le due figure ad altri; e così chiamato Iacopo, che allora non aveva più che dicianove anni, gli diede a fare le dette due figure ancor che durasse non piccola fatica a disporlo a volere fare, come quello che essendo giovinetto non voleva per la prima mettersi a sì gran risico, né lavorare in luogo di tanta importanza; pure fattosi Iacopo animo ancor che non fusse così pratico a lavorare in fresco come a olio, tolse a fare le dette due figure. E ritirato (perché stava ancora con Andrea del Sarto) a fare i cartoni in Santo Antonio alla porta a Faenza, dove egli stava, gli condusse in poco tempo a fine. E ciò fatto menò un giorno Andrea del Sarto suo maestro a vederli, il quale Andrea vedutigli con infinita maraviglia e stupore gli lodò infinitamente; ma poi, come si è detto, che se ne fusse o l'invidia o altra cagione, non vide mai più Iacopo con buon viso. Anzi andando alcuna volta Iacopo a bottega di lui o non gl'era aperto o era uccellato dai garzoni, di maniera che egli si ritirò affatto e cominciò a fare sottilissime spese, perché era poverino, e studiare con grandissima assiduità. Finito dunque che ebbe Andrea di Cosimo di metter d'oro l'arme e tutta la gronda, si mise Iacopo da sé solo a finire il resto, e trasportato dal disio d'acquistare nome, dalla voglia del fare e dalla natura che l'avea dotato d'una grazia e fertilità d'ingegno grandissimo, condusse quel lavoro con prestezza incredibile a tanta perfezzione, quanta più non arebbe potuto fare un ben vecchio e pratico maestro eccellente; per che, cresciutogli per quella sperienza l'animo, pensando di poter fare molto miglior opera, aveva fatto pensiero, senza dirlo altrimenti a niuno, di gettar in terra quel lavoro e rifarlo di nuovo secondo un altro suo disegno, che egli aveva in fantasia. Ma in questo mentre avendo i frati veduta l'opera finita e che Iacopo non andava più al lavoro, trovato Andrea lo stimolarono tanto, che si risolvé di scoprirla. Onde, cercato di Iacopo per domandare se voleva farvi altro e non lo trovando, perciò che stava rinchiuso intorno al nuovo disegno e non rispondeva a niuno, fece levare la turata et il palco e scoprire l'opera; e la sera medesima, essendo uscito Iacopo di casa per andare ai Servi, e come fusse notte mandar giù il lavoro che aveva fatto e mettere in opera il nuovo disegno, trovò levato i ponti e scoperto ogni cosa con infiniti popoli attorno che guardavano. Per che, tutto in còllora, trovato Andrea si dolse che senza lui avesse scoperto, aggiugnendo quello che avea in animo di fare. A cui Andrea ridendo rispose: “Tu hai il torto a dolerti perciò che il lavoro che tu hai fatto sta tanto bene che se tu l'avessi a rifare, tengo per fermo che non potresti far meglio, e perché non ti mancherà da lavorare, serba cotesti disegni ad altre occasioni”. Quest'opera fu tale, come si vede, e di tanta bellezza, sì per la maniera nuova e sì per la dolcezza delle teste che sono in quelle due femine e per la bellezza de' putti vivi e graziosi, ch'ella fu la più bella in fresco che insino allora fusse stata veduta già mai; perché oltre ai putti della Carità, ve ne sono due altri in aria, i quali tengono all'arme del Papa un panno, tanto begli che non si può far meglio, sanza che tutte le figure hanno rilievo grandissimo e son fatte per colorito e per ogni altra cosa tali, che non si possono lodare a bastanza. E Michelagnolo Buonarroti, veggendo un giorno quest'opera e considerando che l'avea fatta un giovane d'anni 19, disse: “Questo giovane sarà anco tale per quanto si vede, che se vive e seguita porrà quest'arte in cielo”. Questo grido e questa fama sentendo gl'uomini di Puntormo, mandato per Iacopo gli fecero fare dentro nel castello sopra una porta, posta in sulla strada maestra, un'arme di papa Leone, con due putti, bellissima, come che dall'acqua sia già stata poco meno che guasta.
Il carnovale del medesimo anno, essendo tutta Fiorenza in festa ed in allegrezza per la creazione del detto Leone Decimo, furono ordinate molte feste e fra l'altre due bellissime e di grandissima spesa da due Compagnie di signori e gentiluomini della città, d'una delle quali, che era chiamata il Diamante, era capo il signor Giuliano de' Medici, fratello del Papa, il quale l'aveva intitolata così per essere stato il diamante impresa di Lorenzo il Vecchio suo padre, e dell'al-tra, che aveva per nome e per insegna il Broncone, era capo il signor Lorenzo figliuolo di Piero de' Medici, il quale dico aveva per impresa un broncone, cioè un tronco di lauro secco che rinverdiva le foglie, quasi per mostrare che rinfrescava e risurgeva il nome dell'avolo. Dalla compagnia dunque del Diamante fu dato carico a Messer Andrea Dazzi, che allora leggeva lettere greche e latine nello studio di Fiorenza, di pensare all'invenzione d'un trionfo. Onde egli ne ordinò uno simile a quelli che facevano i Romani trionfando, di tre carri bellissimi e lavorati di legname dipinti con bello e ricco artificio. Nel primo era la Puerizia con un ordine bellissimo di fanciulli, nel secondo era la Virilità con molte persone che nell'età loro virile avevano fatto gran cose, e nel terzo era la Senettù con molti chiari uomini che nella loro vecchiezza avevano gran cose operato, i quali tutti personaggi erano ricchissimamente adobati, in tanto che non si pensava potersi far meglio. Gl'architetti di questi carri furono Raffaello delle Vivuole, il Carota intagliatore, Andrea di Cosimo pittore et Andrea del Sarto, e quelli che feciono et ordinarono gl'abiti delle figure furono ser Piero da Vinci, padre di Lionardo, e Bernardino di Giordano, bellissimi ingegni. Et a Iacopo Puntormo solo toccò a dipignere tutti e tre i carri, nei quali fece in diverse storie di chiaro scuro molte transformazioni degli dii in varie forme, le quali oggi sono in mano di Pietro Paulo Galeotti orefice eccellente. Portava scritto il primo carro in note chiarissime “Erimus”, il secondo “Sumus”, et il terzo “Fuimus”, cioè “Saremo”, “Siamo”, “Fummo”. La canzone cominciava: “Volano gl'anni”, etc. Avendo questi trionfi veduto il signor Lorenzo, capo della compagnia del Broncone, e disiderando che fussero superati, dato del tutto carico a Iacopo Nardi gentiluomo nobile e literatissimo al quale, per quello che fu poi, è molto obligata la sua patria Fiorenza, esso Iacopo ordinò sei trionfi per radoppiare quelli stati fatti dal Diamante. Il primo, tirato da un par di buoi vestiti d'erba, rappresentava l'età di Saturno e di Iano, chiamata dell'oro, et aveva in cima del carro Saturno con la falce et Iano con le due teste e con la chiave del tempio della pace in mano e sotto i piedi legato il Furore, con infinite cose attorno pertinenti a Saturno, fatte bellissime e di diversi colori dall'ingegno del Puntormo. Accompagnavano que-sto trionfo sei coppie di pastori ignudi, ricoperti in alcune parti con pelle di martore e zibellini, con stivaletti all'antica di varie sorte e con i loro zaini e ghirlande in capo di molte sorti frondi. I cavalli sopra i quali erano questi pastori erano senza selle, ma coperti di pelle di leoni, di tigri e di lupi cervieri; le zampe de' quali, messe d'oro, pendevano dagli lati con bella grazia. Gl'ornamenti delle groppe e staffieri erano di corde d'oro; le staffe teste di montoni, di cane e d'altri simili animali, et i freni e redine fatti di diverse verzure e di corde d'argento. Aveva ciascun pastore quattro staffieri in abito di pastorelli, vestiti più semplicemente d'altre pelli e con torce fatte a guisa di bronconi secchi e di rami di pino che facevano bellissimo vedere. Sopra il secondo carro tirato da due paia di buoi vestiti di drappo ricchissimo, con ghirlande in capo e con paternostri grossi che loro pendevano dalle dorate corne, era Numa Pompilio secondo re de' Roma-ni con i libri della Religione e con tutti gl'ordini sacerdotali e cose appartenenti a' sacrifici, perciò che egli fu, appresso i Romani, autore e primo ordinatore della Relligione e de' sacrifizii. Era questo carro accompagnato da sei sacerdoti sopra bellissime mule, coperti il capo con manti di tela ricamati d'oro e d'argento a foglie d'ellera maestrevolmente lavorati; in dosso avevano vesti sacerdotali all'antica, con balzane e fregi d'oro attorno ricchissimi et in mano chi un turibolo e chi un vaso d'oro e chi altra cosa somigliante. Alle staffe avevano ministri a uso di leviti e le torce che questi avevano in mano erano a uso di candellieri antichi e fatti con bello artifizio. Il terzo carro rappresentava il consolato di Tito Manlio Torquato, il quale fu consolo dopo il fine della prima guerra cartaginese e governò di maniera che al tempo suo fiorirono in Roma tutte le virtù e prosperità. Il detto carro, sopra il quale era esso Tito con molti ornamenti fatti dal Puntormo, era tirato da otto bellissimi cavalli et innanzi gl'andavano sei coppie di senatori togati sopra cavalli coperti di teletta d'oro, accompagnati da gran numero di staffieri rappresentanti littori con fasci, securi et altre cose pertinenti al ministerio della iustizia. Il quarto carro tirato da quattro bufali, acconci a guisa d'elefanti, rappresentava Giulio Cesare trionfante per la vittoria avuta di Cleopatra, sopra il carro tutto dipinto dal Puntormo dei fatti di quello più famosi, il quale carro accompagnavano sei coppie d'uomini d'arme vestiti di lucentissime armi e ricche, tutte fregiate d'oro, con le lance in sulla coscia; e le torce, che portavano li staffieri mezzi armati, avevano forma di trofei in varii modi accomodati. Il quinto carro tirato da cavalli alati, che avevano forma di grifii, aveva sopra Cesare Augusto dominatore dell'uni-verso, accompagnato da sei coppie di poeti a cavallo, tutti coronati, sì come anco Cesare, di lauro e vestiti in varii abiti, secondo le loro provincie; e questi, perciò che furono i poeti sempre molto favoriti da Cesare Augusto il quale essi posero con le loro opere in cielo. Et acciò fussero conosciuti, aveva ciascun di loro una scritta a traverso a uso di banda, nella quale erano i loro nomi. Sopra il sesto carro tirato da quattro paia di giovenchi vestiti riccamente era Traiano imperatore giustissimo, dinanzi al quale, sedente sopra il carro molto bene dipinto dal Puntormo, andavano, sopra belli e ben guerniti cavalli, sei coppie di dottori legisti con toghe infino ai piedi e con mozzette di vai, secondo che anticamente costumavano i dottori di vestire; i staffieri che portavano le torce in gran numero erano scrivani, copisti e notai con libri e scritture in mano. Dopo questi sei veniva il carro, o vero trionfo dell'età e secol d'oro, fatto con bellissimo e ricchissimo artifizio, con molte figure di rilievo fatte da Baccio Bandinelli, e con bellissime pitture di mano del Puntormo, fra le quali di rilievo furono molto lodate le quattro virtù cardinali. Nel mezzo del carro surgeva una gran palla in forma d'apamondo, sopra la quale stava prostrato bocconi un uomo come morto, armato d'arme tutte ruginose, il quale avendo le schiene aperte e fesse, della fessura usciva un fanciullo tutto nudo e dorato, il quale rappresentava l'età dell'oro resurgente e la fine di quella del ferro, della quale egli usciva e rinasceva per la creazione di quel Pontefice. E questo medesimo significava il broncone secco, rimettente le nuove foglie, come che alcuni dicessero che la cosa del broncone alludeva a Lorenzo de' Medici, che fu duca d'Urbino. Non tacerò che il putto dorato, il quale era ragazzo d'un fornaio, per lo disagio che patì per guadagnare dieci scudi, poco appresso si morì. La canzone che si cantava da quella mascherata, secondo che si costuma, fu composizione del detto Iacopo Nardi, e la prima stanza diceva così:
Colui che dà le leggi alla natura,
e i varii stati, e secoli dispone,
d'ogni bene è cagione:
e il mal, quanto permette, al mondo dura:
onde questa figura,
contemplando, si vede
come con certo piede
l'un secol dopo l'altro al mondo viene
e muta il bene in male, e il male in bene.
Riportò dell'opere che fece in questa festa il Puntormo, oltre l'utile, tanta lode che forse pochi giovani della sua età n'ebbero mai altre tanta in quella città, onde, venendo poi esso papa Leone a Fiorenza, fu negl'apparati che si fecero molto adoperato, perciò che accompagnatosi con Baccio da Monte Lupo, scultore d'età, il quale fece un arco di legname in testa della via del Palagio dalle scalee di Badia, lo dipinse tutto di bellissime storie, le quali poi per la poca diligenza di chi n'ebbe cura, andarono male; solo ne rimase una nella qual Pallade accorda uno strumento in sulla lira d'A-pollo, con bellissima grazia; dalla quale storia si può giudicare di quanta bontà e perfezzione fussero l'altre opere e figure. Avendo nel medesimo apparato avuto cura Ridolfo Ghirlandaio di acconciare e d'abbellire la sala del papa, che è congiunta al convento di Santa Maria Novella ed è antica residenza de' pontefici in quella città, stretto dal tempo, fu forzato a servirsi in alcune cose dell'altrui opera, per che, avendo l'altre stanze tutte adornate, diede cura a Iacopo Puntormo di fare nella cappella, dove aveva ogni mattina a udir messa Sua Santità, alcune pitture in fresco. Laonde, mettendo mano Iacopo all'opera vi fece un Dio Padre con molti putti et una Veronica che nel sudario aveva l'effigie di Gesù Cristo, la quale opera da Iacopo fatta in tanta strettezza di tempo, gli fu molto lodata.
Dipinse poi dietro all'Arcivescovo di Fiorenza, nella chiesa di San Ruffello, in una cappella, in fresco la Nostra Donna col Figliuolo in braccio in mezzo a San Michelagnolo e Santa Lucia e due altri Santi inginocchioni, e nel mezzo tondo della cappella un Dio Padre con alcuni Serafini intorno. Essendogli poi, secondo che aveva molto disiderato, stato allogato da maestro Iacopo frate de' Servi a dipignere una parte del cortile de' Servi, per esserne andato Andrea del Sarto in Francia e lasciato l'opere di quel cortile imperfette, si mise con molto studio a fare i cartoni, ma perciò che era male agiato di roba e gli bisognava, mentre studiava per acquistarsi onore, aver da vivere, fece sopra la porta dello spedale delle donne, dietro la chiesa dello spedal de' preti, fra la piazza di San Marco e via di San Gallo, dirimpetto a punto al muro delle suore di Santa Caterina da Siena, due figure di chiaro scuro bellissime: cioè Cristo in forma di pellegrino che aspetta alcune donne ospiti per alloggiarle, la quale opera fu meritamente molto in que' tempi et è ancora oggi da-gl'uomini intendenti lodata. In questo medesimo tempo dipinse alcuni quadri e storiette a olio per i maestri di Zecca, nel carro della moneta che va ogni anno per S. Giovanni a processione; l'opera del qual carro fu di mano di Marco del Tasso. Et in sul poggio di Fiesole sopra la porta della Compagnia della Cecilia una Santa Cecilia colorita in fresco con alcune rose in mano, tanto belle, e tanto bene in quel luogo accomodata, che per quanto ell'è, delle buone opere che si possano vedere in fresco. Queste opere avendo veduto il già detto maestro Iacopo frate de' Servi et acceso maggiormente nel suo disiderio, pensò di fargli finire a ogni modo l'opera del detto cortile de' Servi, pensando che a concorrenza degl'altri maestri che vi avevano lavorato, dovesse fare in quello che restava a dipignersi qualche cosa straordinariamente bella. Iacopo, dunque, messovi mano, fece non meno per disiderio di gloria e d'onore, che di guadagno, la storia della visitazione della Madonna con maniera un poco più ariosa e desta che insino allora non era stato suo solito, la qual cosa accrebbe, oltre all'altre infinite bellezze, bontà all'opera infinitamente, perciò che le donne, i putti, i giovani et i vecchi sono fatti in fresco tanto morbidamente e con tanta unione di colorito, che è cosa maravigliosa; onde le carni d'un putto che siede in su certe scalee, anzi pur quelle insiememente di tutte l'altre figure, son tali, che non si possono in fresco far meglio né con più dolcezza, perché quest'opera, appresso l'altre che Iacopo avea fatto, diede certezza a gl'ar-tefici della sua perfezzione, paragonandole con quelle d'Andrea del Sarto e del Francia Bigio. Diede Iacopo finita que-st'opera l'anno 1516 e n'ebbe per pagamento scudi sedici e non più. Essendogli poi allogata da Francesco Pucci, se ben mi ricorda, la tavola d'una cappella che egli avea fatto fare in San Michele Bisdomini della via de' Servi, condusse Iacopo quell'opera con tanta bella maniera e con un colorito sì vivo, che par quasi impossibile a crederlo. In questa tavola la Nostra Donna che siede porge il putto Gesù a San Giuseppo, il quale ha una testa che ride con tanta vivacità e prontezza, che è uno stupore; è bellissimo similmente un putto fatto per San Giovanni Battista e due altri fanciulli nudi che tengono un padiglione; vi si vede ancora un San Giovanni Evangelista, bellissimo vecchio, et un San Francesco inginocchioni che è vivo, però che intrecciate le dita delle mani l'una con l'altra e stando intentissimo a contemplare con gl'occhi e con la mente fissi la Vergine et il figliuolo, par che spiri. Né è men bello il S. Iacopo che a canto agli altri si vede, onde non è maraviglia se questa è la più bella tavola che mai facesse questo rarissimo pittore.
Io credeva che dopo quest'opera e non prima avesse fatto il medesimo a Bartolomeo Lanfredini, lung'Arno fra il ponte Santa Trinita e la Carraia, dentro a un andito sopra una porta, due bellissimi e graziosissimi putti in fresco che sostengono un'arme; ma poi che il Bronzino, il quale si può credere che di queste cose sappia il vero, afferma che furo-no delle prime cose che Iacopo facesse, si dee credere che così sia indubitatamente e lodarne molto maggiormente il Puntormo, poiché son tanto belli, che non si possono paragonare, e furono delle prime cose che facesse. Ma seguitando l'ordine della storia, dopo le dette fece Iacopo agl'uomini di Puntormo una tavola, che fu posta in Sant'Agnolo lor chiesa principale alla capella della Madonna, nella quale sono un S. Michelagnolo et un San Giovanni Evangelista. In questo tempo l'uno di due giovani che stavano con Iacopo, cioè Giovanmaria Pichi dal Borgo a San Sepolcro, che si portava assai bene et il quale fu poi frate de' Servi, e nel Borgo e nella pieve a Santo Stefano fece alcune opere, dipinse, stando dico ancora con Iacopo, per mandarlo al Borgo, in un quadro grande un San Quintino ignudo e martirizzato, ma perché disiderava Iacopo, come amorevole di quel suo discepolo, che egli acquistasse onore e lode, si mise a ritoccarlo, e così non sapendone levare le mani e ritoccando oggi la testa, domani le braccia, l'altro il torso, il ritoccamento fu tale, che si può quasi dire che sia tutto di sua mano; onde non è maraviglia se è bellissimo questo quadro che è oggi al Borgo nella chiesa de' frati osservanti di San Francesco. L'altro dei due, Giovanni, il quale fu Giovan Antonio Lappoli aretino, di cui si è in altro luogo favellato, avendo come vano ritratto se stesso nello specchio, mentre anch'egli ancora si stava con Iacopo, parendo al maestro che quel ritratto poco somigliasse, vi mise mano e lo ritrasse egli stesso tanto bene, che par vivissimo; il quale ritratto è oggi in Arezzo in casa gl'eredi di detto Giovan Antonio. Il Puntormo similmente ritrasse in uno stesso quadro due suoi amicissimi: l'uno fu il genero di Becuccio Bichieraio, et un altro, del quale parimente non so il nome; basta, che i ritratti son di mano del Puntormo. Dopo fece a Bartolomeo Ginori, per dopo la morte di lui, una filza di drapelloni, secondo che usano i fiorentini, et in tutti dalla parte di sopra fece una Nostra Donna col Figliuolo nel taffetà bianco, e di sotto nella balzana di colorito fece l'arme di quella famiglia secondo che usa. Nel mezzo della filza, che è di ventiquattro drapelloni, ne fece due, tutti di taffetà bianco senza balzana, nei quali fece due San Bartolomei alti due braccia l'uno, la quale grandezza di tutti questi drappelloni e quasi nuova maniera, fece parere meschini e poveri tutti gl'altri stati fatti insino allora; e fu cagione che si cominciarono a fare della grandezza che si fanno oggi, leggiadra molto e di manco spesa d'oro. In testa all'orto e vigna de' frati di S. Gallo, fuor della porta che si chiama dal detto Santo, fece in una cappella, che era a dirittura dell'entrata nel mezzo, un Cristo morto, una Nostra Donna che piagneva e duo putti in aria, uno de' quali teneva il calice della Passione in mano e l'altro sosteneva la testa del Cristo cadente. Dalle bande erano da un lato San Giovanni Evangelista lacrimoso e con le braccia aperte e dall'altro Santo Agostino in abito episcopale, il quale apoggiatosi con la man manca al pastorale, si stava in atto veramente mesto e contemplante la mor-te del Salvatore. Fece anco a Messer... Spina, familiare di Giovanni Salviati, in un suo cortile dirimpetto alla porta principale di casa, l'arme di esso Giovanni stato fatto di que' giorni cardinale da papa Leone, col cappello rosso sopra e con due putti ritti, che per cosa in fresco sono bellissimi e molto stimati da Messer Filippo Spina, per esser di mano del Puntormo. Lavorò anco Iacopo nell'ornamento di legname che già fu magnificamente fatto, come si è detto altra volta, in alcune stanze di Pierfrancesco Borgherini, a concorrenza d'altri maestri, et in particulare vi dipinse di sua mano in due cassoni alcune storie de' fatti di Ioseffo in figure piccole, veramente bellissime. Ma chi vuol veder quanto egli facesse di meglio nella sua vita, per considerare l'ingegno e la virtù di Iacopo nella vivacità delle teste, nel compartimento delle figure, nella varietà dell'attitudini e nella bellezza dell'invenzione, guardi in questa camera del Borgherini, gentiluomo di Firenze, all'entrare della porta nel canto a man manca, un'istoria assai grande pur di figure piccole, nella quale è quando Iosef in Egitto, quasi re e principe, riceve Iacob suo padre con tutti i suoi fratelli e figliuoli di esso Iacob con amorevolezze incredibili; fra le quali figure ritrasse a' piedi della storia a sedere sopra certe scale Bronzino, allora fanciullo e suo discepolo, con una sporta, che è una figura viva e bella a maraviglia. E se questa storia fusse nella sua grandezza (come è piccola) o in tavola grande o in muro, io ardirei di dire che non fusse possibile vedere altra pittura fatta con tanta grazia, perfezzione e bontà, con quanta fu questa condotta da Iacopo, onde meritamente è stimata da tutti gl'artefici la più bella pittura che il Puntormo facesse mai. Né è maraviglia che il Borgherino la tenesse quanto faceva in pregio, né che fusse ricerco da grand'uomini di venderla per donarla a grandissimi signori e principi.
Per l'assedio di Firenze, essendosi Pierfrancesco ritirato a Lucca, Giovanbattista della Palla, il quale disiderava con altre cose che conduceva in Francia d'aver gl'ornamenti di questa camera e che si presentassero al re Francesco a nome della Signoria, ebbe tanti favori e tanto seppe fare e dire, che il gonfalonieri et i signori diedero commessione si togliesse e si pagasse alla moglie di Pierfrancesco. Per che, andando con Giovambattista alcuni ad essequire in ciò la volontà de' signori, arivati a casa di Pierfrancesco, la moglie di lui che era in casa, disse a Giovambattista la maggior villania che mai fusse detta ad altro uomo: “Adunque”, diss'ella, “vuoi essere ardito tu Giovambattista, vilissimo rigattiere, mercatantuzzo di quattro danari, di sconficcare gl'ornamenti delle camere de' gentiluomini e questa città delle sue più ricche et onorevoli cose spogliare, come tu hai fatto e fai tuttavia, per abbellirne le contrade straniere et i nimici nostri? Io di te non mi maraviglio, uomo plebeo e nimico della tua patria, ma dei magistrati di questa città, che ti comportano queste scelerità abominevoli. Questo letto, che tu vai cercando per lo tuo particolare interesse et ingordigia di danari, come che tu vada il tuo malanimo con finta pietà ricoprendo, è il letto delle mie nozze, per onor delle quali Salvi mio suocero fece tutto questo magnifico e regio apparato, il quale io riverisco per memoria di lui e per amore di mio marito, et il quale io intendo col proprio sangue e colla stessa vita difendere. Esci di questa casa con questi tuoi masnadieri, Giovambattista, e vadi a chi qua ti ha mandato comandando che queste cose si lievino dai luoghi loro, che io son quella che di qua entro non voglio che si muova alcuna cosa; e se essi, i quali credono a te uomo dappoco e vile, vogliono il re Francesco di Francia presentare, vadano e si gli mandino, spogliandone le proprie case, gl'ornamenti e letti delle camere loro; e se tu sei più tanto ardito che tu venghi per ciò a questa casa, quanto rispetto si debba dai tuoi pari avere alle case de' gentiluomini, ti farò con tuo gravissimo danno conoscere”. Queste parole adunque di madonna Margherita, moglie di Pierfrancesco Borgherini e figliuola di Ruberto Acciaiuoli nobilissimo e prudentissimo cittadino, donna nel vero valorosa e degna figliuola di tanto padre, col suo nobil ardire et ingegno fu cagione che ancor si serbano queste gioie nelle lor case.
Giovanmaria Benintendi, avendo quasi ne' medesimi tempi adorna una sua anticamera di molti quadri di mano di diversi valentuomini, si fece fare dopo l'opera del Borgherini, da Iacopo Puntormo, stimolato dal sentirlo infinitamente lodare, in un quadro l'adorazione de' Magi che andarono a Cristo in Betelem. Nella quale opera, avendo Iacopo messo molto studio e diligenza, riuscì nelle teste et in tutte l'altre parti varia, bella e d'ogni lode dignissima. E dopo fece a Messer Goro da Pistoia, allora segretario de' Medici, in un quadro la testa del Magnifico Cosimo vecchio de' Medici dalle ginocchia in su, che è veramente lodevole, e questa è oggi nelle case di Messer Ottaviano de' Medici nelle mani di Messer Alessandro suo figliuolo, giovane, oltre la nobiltà e chiarezza del sangue, di santissimi costumi, letterato e degno figliuolo del Magnifico Ottaviano e di madonna Francesca, figliuola di Iacopo Salviati e zia materna del signor duca Cosimo. Mediante quest'opera, e particolarmente questa testa di Cosimo, fatto il Puntormo amico di Messer Ottaviano, avendosi a dipignere al Poggio a Caiano la sala grande, gli furono date a dipignere le due teste, dove sono gl'occhi che danno lume - cioè le finestre - dalla volta infino al pavimento; per che Iacopo, disiderando più del solito farsi ono-re, sì per rispetto del luogo e sì per la concorrenza degl'altri pittori che vi lavoravano, si mise con tanta diligenza a studiare, che fu troppa; perciò che guastando e rifacendo oggi quello che avea fatto ieri, si travagliava di maniera il cervello, che era una compassione, ma tuttavia andava sempre facendo nuovi trovati con onor suo e bellezza dell'opera. Onde, avendo a fare un Vertunno con i suoi agricultori, fece un villano che siede con un pennato in mano, tanto bello e ben fatto, che è cosa rarissima, come anco sono certi putti che vi sono, oltre ogni credenza vivi e naturali. Dall'altra banda, facendo Pomona e Diana con altre dee, le aviluppò di panni forse troppo pienamente, nondimeno tutta l'opera è bella e molto lodata. Ma mentre che si lavorava quest'opera, venendo a morte Leone, così rimase questa imperfetta, come molte altre simili a Roma, a Firenze, a Loreto et in altri luoghi; anzi povero il mondo e senza il vero mecenate degl'uomini virtuosi.
Tornato Iacopo a Firenze, fece in un quadro a sedere Santo Agostino vescovo che dà la benedizione, con due putti nudi che volano per aria molto belli, il qual quadro è nella piccola chiesa delle suore di San Clemente in via di San Gallo, sopra un altare. Diede similmente fine a un quadro d'una pietà con certi Angeli nudi, che fu molto bell'opera e carissima a certi mercanti Raugei, per i quali egli la fece. Ma sopra tutto vi era un bellissimo paese, tolto per la maggior parte da una stampa d'Alberto Duro. Fece similmente un quadro di Nostra Donna col Figliuolo in collo e con alcuni putti intorno, la quale è oggi in casa d'Alessandro Neroni, et un altro simile, cioè d'una Madonna, ma diversa dalla sopra detta e d'altra maniera, ne fece a certi spagnuoli, il quale quadro essendo a vendersi a un rigattiere di lì a molti anni lo fece il Bronzino comperare a Messer Bartolomeo Panciatichi. L'anno poi 1522 essendo in Firenze un poco di peste e però partendosi molti per fuggire quel morbo contagiosissimo e salvarsi, si porse occasione a Iacopo d'alontanarsi alquanto e fuggire la città; per che, avendo un priore della Certosa, luogo stato edificato dagl'Acciaiuoli fuor di Firenze tre miglia, a far fare alcune pitture a fresco ne' canti d'un bellissimo e grandissimo chiostro che circonda un prato, gli fu messo per le mani Iacopo, per che, avendolo fatto ricercare et egli avendo molto volentieri in quel tempo accettata l'opera, se n'andò a Certosa menando seco il Bronzino solamente. E gustato quel modo di vivere, quella quiete, quel silenzio e quella solitudine (tutte cose secondo il genio e natura di Iacopo) pensò con quella occasione fare nelle cose dell'arti uno sforzo di studio e mostrare al mondo avere acquistato maggior perfezione e variata maniera da quelle cose che avea fatto prima. Et essendo non molto inanzi dell'Alemagna venuto a Firenze un gran numero di carte stampate e molto sottilmente state intagliate col bulino da Alberto Duro, eccellentissimo pittore tedesco e raro intagliatore di stampe in rame e legno, e fra l'altre molte storie grandi e piccole della Passione di Gesù Cristo, nelle quali era tutta quella perfezzione e bontà nell'intaglio di bulino, che è possibile far mai, per bellezza, varietà d'abiti et invenzione, pensò Iacopo, avendo a fare ne' canti di que' chiostri istorie della Passione del Salvatore, di servirsi dell'invenzioni sopra dette d'Alberto Duro, con ferma credenza d'avere non solo a sodisfare a se stesso, ma alla maggior parte degl'artefici di Firenze, i quali tutti a una voce, di comune giudizio e consenso, predicavano la bellezza di queste stampe e l'eccellenza d'Alberto. Messosi dunque Iacopo a imitare quella maniera, cercando dare alle figure sue, nell'aria delle teste, quella prontezza e varietà che avea dato loro Alberto, la prese tanto gagliardamente, che la vaghezza della sua prima maniera, la quale gli era stata data dalla natura tutta piena di dolcezza e di grazia, venne alterata da quel nuovo studio e fatica e cotanto offesa dal-l'accidente di quella tedesca, che non si conosce in tutte quest'opere, come che tutte sien belle, se non poco di quel buono e grazia che egli aveva insino allora dato a tutte le sue figure. Fece dunque all'entrare del chiostro in un canto Cristo nell'orto, fingendo l'oscurità della notte illuminata dal lume della luna tanto bene, che par quasi di giorno; e mentre Cristo ora, poco lontano si stanno dormendo Pietro, Iacopo e Giovanni, fatti di maniera tanto simile a quella del Duro, che è una maraviglia; non lungi è Giuda che conduce i giudei, di viso così strano anch'egli, sì come sono le cere di tutti que' soldati fatti alla tedesca, con arie stravaganti, ch'elle muovono a compassione chi le mira della semplicità di quell'uomo che cercò con tanta pacienza e fatica di sapere quello che dagl'altri si fugge e si cerca di perdere per lasciar quella maniera che di bontà avanzata tutte l'altre e piaceva ad ognuno infinitamente. Or non sapeva il Puntormo che i tedeschi e' fiaminghi vengono in queste parti per imparare la maniera italiana che egli con tanta fatica cercò, come cattiva, d'aban-donare? A lato a questa, nella quale è Cristo menato dai giudei inanzi a Pilato, dipinse nel Salvatore tutta quell'umiltà che veramente si può immaginare nella stessa innocenza tradita dagl'uomini malvagi, e nella moglie di Pilato la compassione e temenza che hanno di se stessi coloro che temono il giudizio divino; la qual donna, mentre raccomanda la causa di Cristo al marito, contempla lui nel volto con pietosa maraviglia. Intorno a Pilato sono alcuni soldati tanto propriamente nell'arie de' volti e negl'abiti tedeschi, che chi non sapesse di cui mano fusse quell'opera, la crederebbe vera-mente fatta da oltramontani. Bene è vero che nel lontano di questa storia è un coppieri di Pilato, il quale scende certe scale con un bacino et un bocale in mano, portando da lavarsi le mani al padrone, è bellissimo e vivo, avendo in sé un certo che della vecchia maniera di Iacopo. Avendo a far poi in uno degl'altri cantoni la ressurrezione di Cristo, venne capriccio a Iacopo, come quello che non avendo fermezza nel cervello andava sempre nuove cose ghiribizzando, di mutar colorito, e così fece quell'opera d'un colorito in fresco tanto dolce e tanto buono, che se egli avesse con altra maniera che con quella medesima tedesca condotta quell'opera, ella sarebbe stata certamente bellissima, vedendosi nelle teste di que' soldati, quasi morti e pieni di sonno in varie attitudini, tanta bontà, che non pare che sia possibile far meglio. Seguitando poi in uno degl'altri canti le storie della Passione, fece Cristo che va con la croce in spalla al monte Calvario e dietro a lui il popolo di Gierusalem che l'accompagna, et innanzi sono i due ladroni ignudi, in mezzo ai ministri della giustizia, che sono parte a piedi e parte a cavallo, con le scale, col titolo della croce, con martelli, chiodi, funi et altri sì fatti instrumenti; et al sommo, dietro a un monticello, è la Nostra Donna con le Marie che piangendo aspettano Cristo, il quale essendo in terra cascato nel mezzo della storia, ha intorno molti giudei che lo percuotono, mentre Veronica gli porge il sudario accompagnata da alcune femine vecchie e giovani, piangenti lo strazio che far veggiono del Salvatore. Questa storia, o fusse perché ne fusse avertito dagl'amici, o vero che pure una volta si accorgesse Iacopo, benché tardi, del danno che alla sua dolce maniera avea fatto lo studio della tedesca, riuscì molto migliore che l'altre fatte nel medesimo luogo. Conciò sia che certi giudei nudi et alcune teste di vecchi sono tanto ben condotte a fresco, che non si può far più; se bene nel tutto si vede sempre servata la detta maniera tedesca.
Aveva dopo queste a seguitare negl'altri canti la crucifissione e deposizione di croce, ma lasciandole per allora con animo di farle in ultimo, fece al suo luogo Cristo deposto di croce, usando la medesima maniera, ma con molta unione di colori. Et in questa, oltre che la Madalena, la quale bacia i pie' di Cristo, è bellissima, vi sono due vecchi fatti per Ioseffo da Baramazia e Nicodemo, che se bene sono della maniera tedesca, hanno le più bell'arie e teste di vecchi, con barbe piumose e colorite con dolcezza maravigliosa che si possano vedere. E perché, oltre all'essere Iacopo per ordinario lungo ne' suoi lavori, gli piaceva quella solitudine della Certosa, egli spese in questi lavori parecchi anni, e poi che fu finita la peste et egli tornatosene a Firenze, non lasciò per questo di frequentare assai quel luogo et andare e venire continuamente dalla Certosa alla città. E così seguitando sodisfece in molte cose a que' padri, e fra l'altre fece in chiesa, sopra una delle porte che entrano nelle capelle, in una figura dal mezzo in su, il ritratto d'un frate converso di quel monasterio, il quale allora era vivo et aveva centoventi anni, tanto bene e pulitamente fatta, con vivacità e prontezza, ch'el-la merita che per lei sola si scusi il Puntormo della stranezza e nuova ghiribizzosa maniera che gli pose adosso quella solitudine e lo star lontano dal comerzio degl'uomini. Fece oltre ciò, per la camera del priore di quel luogo, in un quadro la Natività di Cristo, fingendo che Giuseppo nelle tenebre di quella notte faccia lume a Gesù Cristo con una lanterna, e questo per stare in sulle medesime invenzioni e capricci che gli mettevano in animo le stampe tedesche; né creda niuno che Iacopo sia da biasimare perché egli imitasse Alberto Duro nell'invenzioni, perciò che questo non è errore e l'hanno fatto e fanno continuamente molti pittori, ma perché egli tolse la maniera stietta tedesca in ogni cosa, ne' panni, nell'aria delle teste e l'attitudini, il che doveva fuggire e servirsi solo dell'invenzioni, avendo egli interamente con grazia e bellezza la maniera moderna. Per la forestiera de' medesimi padri fece in un gran quadro di tela colorita a olio, senza punto affaticare o sforzare la natura, Cristo a tavola con Cleofas e Luca grandi quanto il naturale, e perciò che in que-st'opera seguitò il genio suo, ella riuscì veramente maravigliosa, avendo massimamente, fra coloro che servono a quella mensa, ritratto alcuni conversi di que' frati, i quali ho conosciuto io, in modo che non possono essere né più vivi né più pronti di quel che sono.
Bronzino intanto, cioè mentre il suo maestro faceva le sopra dette opere nella Certosa, seguitando animosamente i studi della pittura e tuttavia dal Puntormo, che era de' suoi discepoli amorevole, inanimito, fece, senza aver mai più veduto colorire a olio, in sul muro sopra la porta del chiostro che va in chiesa, dentro sopra un arco, un S. Lorenzo ignudo in sulla grata, in modo bello, che si cominciò a vedere alcun segno di quell'eccellenza nella quale è poi venuto, come si dirà a suo luogo; la qual cosa a Iacopo, che già vedeva dove quell'ingegno doveva riuscire, piacque infinitamente. Non molto dopo, essendo tornato da Roma Lodovico di Gino Capponi, il quale aveva compero in Santa Felicita la cappella che già i Barbadori feciono fare a Filippo di ser Brunellesco, all'entrare in chiesa a man ritta, si risolvé di far dipignere tutta la volta e poi farvi una tavola con ricco ornamento. Onde, avendo ciò conferito con Messer Niccolò Vespucci cavaliere di Rodi, in quale era suo amicissimo, il cavaliere, come quelli che era amico anco di Iacopo e da vantaggio conosceva la virtù e valore di quel valentuomo, fece e disse tanto, che Lodovico allogò quell'opera al Puntormo. E così, fatta una turata che tenne chiusa quella cappella tre anni, mise mano all'opera. Nel cielo della volta fece un Dio Padre che ha intorno quattro Patriarchi molto belli, e nei quattro tondi degl'angoli fece i quattro Evangelisti, cioè tre ne fece di sua mano et uno il Bronzino tutto da sé. Né tacerò con questa occasione che non usò quasi mai il Puntormo di farsi aiutare ai suoi giovani, né lasciò che ponessero mano in su quello che egli di sua mano intendeva di lavorare; e quando pur voleva servirsi d'alcun di loro, massimamente perché imparassero, gli lasciava fare il tutto da sé, come qui fece fare a Bronzino. Nelle quali opere che in sin qui fece Iacopo in detta cappella, parve quasi che fusse tornato alla sua maniera di prima, ma non seguitò il medesimo nel fare la tavola, perciò che, pensando a nuove cose, la condusse senz'ombre e con un colorito chiaro e tanto unito, che a pena si conosce il lume dal mezzo et il mezzo da gli scuri. In questa tavola è un Cristo morto, deposto di croce, il quale è portato alla sepoltura; èvvi la Nostra Donna che si vien meno e l'altre Marie fatte con modo tanto diverso dalle prime, che si vede apertamente che quel cervello andava sempre investigando nuovi concetti e stravaganti modi di fare, non si contentando e non si fermando in alcuno. Insomma il componimento di questa tavola è diverso affatto dalle figure delle volte e simile il colorito, et i quattro Evangelisti che sono nei tondi de' peducci delle volte sono molto migliori e d'un'altra maniera. Nella facciata dove è la finestra sono due figure a fresco, cioè da un lato la Vergine, dall'altro l'Agnolo che l'anunzia, ma in modo l'una e l'altra stravolte, che si conosce, come ho detto, che la bizzarra stravaganza di quel cervello di niuna cosa si contentava già mai. E per potere in ciò fare a suo modo, acciò non gli fusse da niuno rotta la testa, non volle mai, mentre fece quest'opera, che neanche il padrone stesso la vedesse. Di maniera, che avendola fatta a suo modo, senza che niuno de' suoi amici l'avesse potuto d'alcuna cosa avertire, ella fu finalmente con maraviglia di tutto Firenze scoperta e veduta. Al medesimo Lodovico fece un quadro di Nostra Donna per la sua camera della medesima maniera, e nella testa d'una Santa Maria Madalena ritrasse una figliuola di esso Lodovico, che era bellissima giovane. Vicino al monasterio di Boldrone, in sulla strada che va di lì a Castello et in sul canto d'un'altra che saglie al poggio e va a Cercina, cioè due miglia lontano da Fiorenza, fece in un tabernacolo a fresco un Crucifisso, la Nostra Donna che piange, San Giovanni Evangelista, Santo Agostino e San Giuliano, le qual tutte figure non essendo ancora sfogato quel capriccio e piacendogli la maniera tedesca, non sono gran fatto dissimili da quelle che fece alla Certosa. Il che fece ancora in una tavola che dipinse alle monache di Santa Anna, alla porta a S. Friano, nella qual tavola è la Nostra Donna col Putto in collo e Sant'Anna dietro, San Piero e San Benedetto con altri Santi, e nella predella è una storietta di figure piccole, che rappresentano la signoria di Firenze quando andava a processione con trombetti, pifferi, mazzieri, comandatori e tavolaccini e col rimanente della famiglia. E questo fece però che la detta tavola gli fu fatta fare dal capitano e famiglia di palazzo.
Mentre che Iacopo faceva quest'opera, essendo stati mandati in Firenze da papa Clemente Settimo, sotto la custodia del legato Silvio Passerini cardinale di Cortona, Alessandro et Ipolito de' Medici, ambi giovinetti, il Magnifico Ottaviano, al quale il Papa gli aveva molto raccomandati, gli fece ritrarre amendue dal Puntormo, il quale lo servì benissimo e gli fece molto somigliare, come che non molto si partisse da quella sua maniera appresa dalla tedesca. In quel d'Ipolito ritrasse insieme un cane molto favorito di quel signore, chiamato Rodon, e lo fece così proprio e naturale che pare vivissimo; ritrasse similmente il vescovo Ardinghelli che poi fu cardinale, et a Filippo del Migliore suo amicissimo dipinse a fresco nella sua casa di via Larga, al riscontro della porta principale in una nicchia, una femina figurata per Pomona, nella quale parve che cominciasse a cercare di volere uscire in parte di quella sua maniera tedesca. Ora, vedendo per molte opere Giovambattista della Palla farsi ogni giorno più celebre il nome di Iacopo, poiché non gl'era riuscito mandare le pitture dal medesimo e da altri state fatte al Borgherini, al re Francesco, si risolvé, sapendo che il re n'aveva disiderio, di mandargli a ogni modo alcuna cosa di mano del Puntormo, per che si adoperò tanto, che finalmente gli fece fare in un bellissimo quadro la ressurezzione di Lazzaro, che riuscì una delle migliori opere che mai facesse e che mai fusse da costui mandata (fra infinite che ne mandò) al detto re Francesco di Francia. E oltre che le teste erano bellissime, la figura di Lazzaro, il quale ritornando in vita ripigliava i spiriti nella carne morta, non poteva essere più maravigliosa, avendo anco il fradiciccio intorno a gl'occhi e le carni morte affatto nell'estremità de' piedi e delle mani là dove non era ancora lo spirito arrivato.
In un quadro d'un braccio e mezzo fece alle donne dello spedale degl'Innocenti in uno numero infinito di figure piccole l'istoria degl'undicimila martiri stati da Diocleziano condennati alla morte e tutti fatti crucifiggere in un bosco, dentro al quale finse Iacopo una battaglia di cavalli e d'ignudi molto bella et alcuni putti bellissimi, che volando in aria aventano saette sopra i crucifissori. Similmente intorno all'imperadore che gli condanna sono alcuni ignudi che vanno alla morte bellissimi. Il qual quadro, che è in tutte le parti da lodare, è oggi tenuto in gran pregio da don Vincenzio Borghini, spedalingo di quel luogo e già amicissimo di Iacopo. Un altro quadro simile al sopra detto fece a Carlo Neroni, ma con la battaglia de' martiri sola e l'Angelo che gli battezza, et appresso il ritratto di esso Carlo. Ritrasse similmente nel tempo dell'assedio di Fiorenza Francesco Guardi in abito di soldato, che fu opera bellissima, e nel coperchio poi di questo quadro dipinse Bronzino Pigmalione che fa orazione a Venere, perché la sua statua ricevendo lo spirito s'aviva e divenga (come fece secondo le favole di poeti) di carne e d'ossa. In questo tempo, dopo molte fatiche, venne fatto a Iacopo quello che egli aveva lungo tempo disiderato: perciò che avendo sempre avuto voglia d'avere una casa che fusse sua propria e non avere a stare a pigione, per potere abitare e vivere a suo modo, finalmente ne comperò una nella via della Colonna, dirimpetto alle monache di Santa Maria degl'Angeli.
Finito l'assedio, ordinò papa Clemente a Messer Ottaviano de' Medici che facesse finire la sala del Poggio a Caiano. Per che, essendo morto il Francia Bigio et Andrea del Sarto, ne fu data interamente la cura al Puntormo, il quale fatti fare i palchi e le turate, cominciò a fare i cartoni; ma perciò che se n'andava in ghiribizzi e considerazioni, non mise mai mano altrimenti all'opera. Il che non sarebbe forse avvenuto se fusse stato in paese il Bronzino, che allora lavorava al-l'imperiale luogo del duca d'Urbino vicino a Pesero; il quale Bronzino, se bene era ogni giorno mandato a chiamare da Iacopo, non però si poteva a sua posta partire, però che avendo fatto nel peduccio d'una volta all'imperiale un Cupido ignudo molto bello et i cartoni per gl'altri, ordinò il prencipe Guidobaldo, conosciuta la virtù di quel giovane, d'essere ritratto da lui. Ma perciò che voleva essere fatto con alcune arme che aspettava di Lombardia, il Bronzino fu forzato trattenersi più che non arebbe voluto con quel prencipe e dipignergli in quel mentre una cassa d'arpicordo, che molto piacque a quel prencipe; il ritratto del quale finalmente fece il Bronzino, che fu bellissimo e molto piacque a quel prencipe. Iacopo dunque scrisse tante volte e tanti mezzi adoperò, che finalmente fece tornare il Bronzino; ma non pertanto, non si poté mai indurre quest'uomo a fare di quest'opera altro che i cartoni, come che ne fusse dal Magnifico Ottavio e dal duca Alessandro sollecitato. In uno de' quali cartoni, che sono oggi per la maggior parte in casa di Lodovico Capponi, è un Ercole che fa scoppiare Anteo, in un altro una Venere et Adone, et in una carta una storia d'ignudi che giuocano al calcio.
In questo mezzo, avendo il signor Alfonso Davalo marchese del Guasto ottenuto, per mezzo di fra' Niccolò della Magna, di Michelagnolo Buonarroti un cartone d'un Cristo che appare alla Madalena nell'orto, fece ogni opera d'avere il Puntormo, che glielo conducesse di pittura, avendogli detto il Buonarroto che niuno poteva meglio servirlo di costui. Avendo dunque condotta Iacopo questa opera a perfezzione, ella fu stimata pittura rara per la grandezza del disegno di Michelagnolo e per lo colorito di Iacopo, onde avendola veduta il signor Alessandro Vitelli, il quale era allora in Fiorenza capitano della guardia de' soldati, si fece fare da Iacopo un quadro del medesimo cartone, il quale mandò e fé por-re nelle sue case a Città di Castello. Veggendosi adunque quanta stima facesse Michelagnolo del Puntormo e con quanta diligenza esso Puntormo conducesse a perfezzione e ponesse ottimamente in pittura i disegni e cartoni di Michelagnolo, fece tanto Bartolomeo Bettini, che il Buonarruoti suo amicissimo gli fece un cartone d'una Venere ignuda con un Cupido che la bacia, per farla fare di pittura al Pontormo e metterla in mezzo a una sua camera, nelle lunette della quale aveva cominciato a fare dipignere dal Bronzino Dante, Petrarca e Boccaccio, con animo di farvi gl'altri poeti che hanno con versi e prose toscane cantato d'amore. Avendo dunque Iacopo avuto questo cartone, lo condusse, come si dirà, a suo agio a perfezzione in quella maniera che sa tutto il mondo senza che io lo lodi altrimenti. I quali disegni di Michelagnolo furono cagione che considerando il Puntormo la maniera di quello artefice nobilissimo, se gli destasse l'animo e si risolvesse per ogni modo a volere secondo il suo sapere imitarla e seguitarla. Et allora conobbe Iacopo quanto avesse mal fatto a lasciarsi uscir di mano l'opera del Poggio a Caiano, come che egli ne incolpasse in gran parte una sua lunga e molto fastidiosa infermità, et in ultimo la morte di papa Clemente, che ruppe al tutto quella pratica.
Avendo Iacopo, dopo le già dette opere, ritratto di naturale in un quadro Amerigo Antinori, giovane allora molto favorito in Fiorenza, et essendo quel ritratto molto lodato da ognuno, il duca Alessandro avendo fatto intendere a Iacopo che voleva da lui essere ritratto in un quadro grande, Iacopo per più commodità lo ritrasse per allora in un quadretto grande quanto un foglio di carta mezzana con tanta diligenza e studio, che l'opere de' miniatori non hanno che fare al-cuna cosa con questa; perciò che, oltre al somigliare benissimo, è in quella testa tutto quello che si può disiderare in una rarissima pittura. Dal quale quadretto, che è oggi in guardaroba del duca Cosimo, ritrasse poi Iacopo il medesimo Duca in un quadro grande con uno stile in mano disegnando la testa d'una femina, il quale ritratto maggiore donò poi esso duca Alessandro alla signora Taddea Malespina sorella della marchesa di Massa. Per quest'opere disegnando il Duca di volere ad ogni modo riconoscere liberamente la virtù di Iacopo, gli fece dire da Niccolò da Montaguto suo servitore che dimandasse quello che voleva che sarebbe compiaciuto. Ma fu tanta, non so se io mi debba dire la pusillanimità o il troppo rispetto e modestia di quest'uomo, che non chiese se non tanti danari quanto gli bastassero a riscuotere una cappa che egl'aveva al presto impegnata. Il che avendo udito il Duca, non senza ridersi di quell'uomo così fatto, gli fece dare cinquanta scudi d'oro et offerire provisione, et anche durò fatica Niccolò a fare che gl'accettasse.
Avendo in tanto finito Iacopo di dipignere la Venere dal cartone del Bettino, la quale riuscì cosa miracolosa, ella non fu data a esso Bettino per quel pregio che Iacopo gliela avea promessa, ma da certi furagrazie, per far male a Bettino, levata di mano a Iacopo quasi per forza e data al duca Alessandro, rendendo il suo cartone al Bettino. La qual cosa avendo intesa Michelagnolo n'ebbe dispiacere per amor dell'amico a cui avea fatto il cartone, e ne volle male a Iacopo, il quale se bene n'ebbe dal Duca cinquanta scudi, non però si può dire che facesse fraude al Bettino, avendo dato la Venere per comandamento di chi gl'era signore, ma di tutto dicono alcuni, che fu in gran parte cagione, per volerne troppo, l'istesso Bettino. Venuta dunque occasione al Puntormo, mediante questi danari, di mettere mano ad acconciare la sua casa, diede principio a murare, ma non fece cosa di molta importanza. Anzi, se bene alcuni affermano che egli aveva animo di spendervi secondo lo stato suo grossamente e fare una abitazione comoda e che avesse qualche disegno, si vede nondimeno che quello che fece, o venisse ciò dal non avere il modo da spendere o da altra cagione, ha più tosto cera di casamento da uomo fantastico e soletario che di ben considerata abitura: conciò sia che alla stanza dove stava a dormire e tal volta a lavorare si saliva per una scala di legno, la quale entrato che egli era, tirava su con una carrucola, a ciò niuno potesse salire da lui senza sua voglia o saputa. Ma quello che più in lui dispiaceva agl'uomini si era che non voleva lavorare se non quando et a chi gli piaceva, et a suo capriccio; onde essendo ricerco molte volte da gentiluomini che disideravano avere dell'opere sue, et una volta particolarmente dal Magnifico Ottaviano de' Medici, non gli volle servire, e poi si sarebbe messo a fare ogni cosa per un uomo vile e plebeo e per vilissimo prezzo. Onde il Rossino muratore, persona assai ingegnosa secondo il suo mestiere, facendo il goffo, ebbe da lui per pagamento d'avergli mattonato alcune stanze e fatto altri muramenti, un bellissimo quadro di Nostra Donna, il quale facendo Iacopo, tanto sollecitava e lavorava in esso, quanto il muratore faceva nel murare. E seppe tanto ben fare il prelibato Rossino, che oltre il detto quadro cavò di mano a Iacopo un ritratto bellissimo di Giulio cardinal de' Medici, tolto da uno di mano di Raffaello, e da vantaggio un quadretto d'un Crucifisso molto bello, il quale, se bene comperò il detto Magnifico Ottaviano dal Ros-sino muratore per cosa di mano di Iacopo, nondimeno si sa certo che egli è di mano di Bronzino, il quale lo fece tutto da per sé, mentre stava con Iacopo alla Certosa, ancor che rimanesse poi, non so perché, appresso al Puntormo. Le quali tutte tre pitture cavate dall'industria del muratore di mano a Iacopo sono oggi in casa Messer Alessandro de' Medici figliuolo di detto Ottaviano. Ma ancor che questo procedere del Puntormo, e questo suo vivere soletario et a suo modo fusse poco lodato, non è però se chi che sia volesse scusarlo, che non si potesse. Conciò sia che di quell'opere che fece se gli deve avere obligo; e di quelle che non gli piacque di fare, non l'incolpare e biasimare. Già non è niuno artefice obligato a lavorare se non quando e per chi gli pare; e se egli ne pativa, suo danno. Quanto alla solitudine, io ho sempre udito dire ch'ell'è amicissima degli studi. Ma quando anco così non fusse, io non credo che si debba gran fatto biasimare chi senza offesa di Dio e del prossimo vive a suo modo, et abita e pratica secondo che meglio aggrada alla sua natura.
Ma per tornare (lasciando queste cose da canto) all'opere di Iacopo, avendo il duca Alessandro fatto in qualche parte racconciare la villa di Careggi, stata già edificata da Cosimo Vecchio de' Medici, lontana due miglia da Firenze, e condotto l'ornamento della fontana et il laberinto che girava nel mezzo d'uno cortile scoperto, in sul quale rispondono due logge, ordinò sua eccellenza che le dette logge si facessero dipignere da Iacopo, ma se gli desse compagnia acciò che le finisse più presto e la conversazione, tenendolo allegro, fusse cagione di farlo, senza tanto andare ghiribizzando e stillandosi il cervello, lavorare. Anzi il Duca stesso, mandato per Iacopo, lo pregò che volesse dar quell'opera quanto prima del tutto finita. Avendo dunque Iacopo chiamato il Bronzino, gli fece fare in cinque piedi della volta una figura per ciascuno, che furono la Fortuna, la Iustizia, la Vittoria, la Pace e la Fama. E nell'altro piede, che in tutto son sei, fece Iacopo di sua mano un amore. Dopo, fatto il disegno d'alcuni putti che andavano nell'ovato della volta, con diversi animali in mano che scortano al di sotto in su, gli fece tutti, da uno in fuori, colorire dal Bronzino, che si portò molto bene. E perché mentre Iacopo et il Bronzino facevano queste figure, fecero gl'ornamenti intorno Iacone, Pierfrancesco di Iacopo et altri, restò in poco tempo tutta finita quell'opera con molta sodisfazione del signor Duca, il quale voleva far dipignere l'altra loggia, ma non fu a tempo, perciò che essendosi fornito questo lavoro a dì 13 di dicembre 1536, alli sei di gennaio seguente fu quel signore illustrissimo ucciso dal suo parente Lorenzino, e così questa et altre opere rimasono senza la loro perfezzione. Essendo poi creato il signor duca Cosimo, passata felicemente la cosa di Monte Murlo e messosi mano all'opera di Castello, secondo che si è detto nella vita del Tribolo, sua eccellenza illustrissima per compiacere la signora donna Maria sua madre, ordinò che Iacopo dipignesse la prima loggia, che si truova entrando nel palazzo di Castello a man manca. Per che, messovi mano, primieramente disegnò tutti gl'ornamenti che v'andavano, e gli fece fare al Bronzino per la maggior parte et [a] coloro che avevano fatto quei di Careggi. Di poi rinchiusosi dentro da sé solo, andò facendo quell'opera a sua fantasia et a suo bell'agio, studiando con ogni diligenza, acciò ch'ella fusse molto migliore di quella di Careggi, la quale non avea lavorata tutta di sua mano, il che potea fare commodamente, avendo per ciò otto scudi il mese da sua eccellenza, la quale ritrasse così giovinetta come era nel principio di quel lavoro, e parimente la signora donna Maria sua madre. Finalmente essendo stata turata la detta loggia cinque anni, e non si potendo anco vedere quello che Iacopo avesse fatto, adiratasi la detta signora un giorno con esso lui, comandò che i palchi e la turata fusse gettata in terra. Ma Iacopo essendosi raccomandato et avendo ottenuto che si stesse anco alcuni giorni a scoprirla, la ritoccò prima dove gli parea che n'avesse di bisogno, e poi fatta fare una tela a suo modo, che tenesse quella loggia (quando que' signori non v'erano) coperta, acciò l'aria, come avea fatto a Careggi, non si divorasse quelle pitture lavorate a olio in sulla calcina secca, la scoperse con grande aspettazione d'ognuno, pensandosi che Iacopo avesse in quell'opera avanzato se stesso e fatto alcuna cosa stupendissima. Ma gl'effetti non corrisposero interamente all'opi-nione. Perciò che, se bene sono in questa molte parti buone, tutta la proporzione delle figure pare molto difforme, e certi stravolgimenti et attitudini che vi sono pare che siano senza misura e molto strane. Ma Iacopo si scusava con dire che non avea mai ben volentieri lavorato in quel luogo, perciò che essendo fuor di città par molto sottoposto alle furie de' soldati et ad altri simili accidenti. Ma non accadeva che egli temesse di questo, perché l'aria et il tempo (per essere lavorate nel modo che si è detto) le van consumando a poco a poco.
Vi fece dunque nel mezzo della volta un Saturno col segno del Capricorno e Marte ermafrodito nel segno del Leone e della Vergine et alcuni putti in aria che volano come quei di Careggi. Vi fece poi in certe feminone grandi, e quasi tutte ignude, la Filosofia, l'Astrologia, la Geometria, la Musica, l'Aritmetica et una Cerere et alcune medaglie di storiette fatte con varie tinte di colori et apropriate alle figure. Ma con tutto che questo lavoro faticoso e stentato non molto sodisfacesse, e se pur assai, molto meno che non s'aspettava, mostrò sua eccellenza che gli piacesse e si servì di Iacopo in ogni occorrenza, essendo massimamente questo pittore in molta venerazione appresso i popoli, per le molto belle e buon'opere che avea fatto per lo passato. Avendo poi condotto il signor Duca in Fiorenza maestro Giovanni Rosso e maestro Niccolò fiamminghi, maestri eccellenti di panni d'arazzo, perché quell'arte si esercitasse et imparasse dai fiorentini, ordinò che si facessero panni d'oro e di seta per la sala del consiglio de' Dugento, con spesa di sessantamila scudi, e che Iacopo e Bronzino facessero nei cartoni le storie di Ioseffo. Ma avendone fatte Iacopo due, in uno de' quali è quando a Iacob è annunziata la morte di Ioseffo e mostratogli i panni sanguinosi e nell'altro il fuggire di Ioseffo, lasciando la veste, dalla moglie di Putifaro, non piacquero né al Duca, né a que' maestri che gl'avevano a mettere in opera, parendo loro cosa strana e da non dover riuscire ne' panni tessuti et in opera. E così Iacopo non seguitò di fare più cartoni altrimenti. Ma tornando a' suoi soliti lavori, fece un quadro di Nostra Donna che fu dal Duca donato al signor Don... che lo portò in Ispagna. E perché sua eccellenza seguitando le vestigia de' suoi maggiori ha sempre cercato di abellire et adornare la sua città, essendole ciò venuto in considerazione, si risolvé di fare dipignere tutta la capella maggiore del magnifico tempio di San Lorenzo, fatta già dal gran Cosimo Vecchio de' Medici. Per che, datone il carico a Iacopo Puntormo, o di sua propria volontà o per mezzo (come si disse) di Messer Pierfrancesco Ricci maiorduomo, es-so Iacopo fu molto lieto di quel favore, perciò che se bene la grandezza dell'opera essendo egli assai bene in là con gl'anni gli dava che pensare, e forse lo sgomentava, considerava dall'altro lato quanto avesse il campo largo nella grandezza di tant'opera di mostrare il valore e la virtù sua. Dicono alcuni che veggendo Iacopo essere stata allogata a sé quell'opera, nonostante che Francesco Salviati pittore di gran nome fusse in Firenze et avesse felicemente condotta e di pittura la sala di palazzo, dove già era l'udienza della Signoria, ebbe a dire, che mostrarebbe come si disegnava e dipigneva, e come si lavora in fresco, et oltre ciò, che gl'altri pittori non erano se non persone da dozzina et altre simili parole altiere e troppo insolenti. Ma perché io conobbi sempre Iacopo persona modesta e che parlava d'ognuno onoratamente et in quel modo che dee fare un costumato e virtuoso artefice, come egli era, credo che queste cose gli fussero aposte e che non mai si lasciasse uscir di bocca sì fatti vantamenti, che sono per lo più cose d'uomini vani e che troppo di sé presumono; con la qual maniera di persone non ha luogo la virtù né la buona creanza. E se io arei potuto tacere queste cose, non l'ho voluto fare; però che il procedere come ho fatto mi pare ufficio di fedele e verace scrittore. Basta che se bene questi ragionamenti andarono attorno, e massimamente fra gl'artefici nostri, porto nondimeno ferma opinione che fussero parole d'uomini maligni, essendo sempre stato Iacopo nelle sue azzioni, per quello che appariva, modesto e costumato. Avendo egli adunque con muri, assiti e tende turata quella capella e datosi tutto alla solitudine, la tenne per ispazio d'undici anni in modo serrata che da lui infuori mai non vi entrò anima vivente, né amici né nessuno. Bene è vero che disegnando alcuni giovinetti nella sagrestia di Michelagnolo, come fanno i giovani, salirono per le chiocciole di quella in sul tetto della chiesa e levati i tegoli e l'asse del rosone di quelli che vi sono dorati, videro ogni cosa. Di che accortosi Iacopo l'ebbe molto per male, ma non ne fece altra dimostrazione che di turare con più diligenza ogni cosa, se bene dicono alcuni che egli perseguitò molto que' giovani, e cercò di fare loro poco piacere. Immaginandosi dunque in quest'opera di dovere avanzare tutti i pittori e forse, per quel che si disse, Michelagnolo, fece nella parte di sopra in più istorie la creazione di Adamo et Eva, il loro mangiare del pomo vietato e l'essere scacciati di Paradiso, il zappare la terra, il sacrifizio d'Abel, la morte di Caino, la benedizione del seme di Noè e quando egli disegna la pianta e misure dell'Arca. In una poi delle facciate di sotto, ciascuna delle quali è braccia quindici per ogni verso, fece la inondazione del Diluvio, nella quale sono una massa di corpi morti et affogati, e Noè che parla con Dio. Nell'altra faccia è dipinta la Ressurezione Universale de' morti, che ha da essere nell'ultimo e novissimo giorno, con tanta e varia confusione, ch'ella non sarà maggiore da dovero per aventura, né così viva, per modo di dire, come l'ha dipinta il Pontormo. Dirimpetto all'altare fra le finestre, cioè nella faccia del mezzo, da ogni banda è una fila d'ignudi che presi per mano et aggrappatisi su per le gambe e busti l'uno dell'altro, si fanno scala per salire in Paradiso, uscendo di terra, dove sono molti morti che gl'accompagnano; e fanno fine da ogni banda due morti vestiti, eccetto le gambe e le braccia, con le quali tengono due torce accese. A sommo del mezzo della facciata, sopra le finestre fece nel mezzo in alto Cristo nella sua maestà, il quale circondato da molti Angeli tutti nudi fa resuscitare que' morti per giudicare. Ma io non ho mai potuto intendere la dottrina di questa storia, se ben so che Iacopo aveva ingegno da sé e praticava con persone dotte e letterate, cioè quello volesse significare in quella parte dove è Cristo in alto, che risuscita i morti, e sotto i piedi ha Dio padre che crea Adamo et Eva. Oltre ciò in uno de' canti dove sono i quattro Evangelisti nudi con libri in mano, non mi pare, anzi in niun luogo, osservato né ordine di storia, né misura, né tempo, né varietà di teste, non cangiamento di colori di carni, et insimma non alcuna regola, né proporzione, né alcun ordine di prospettiva: ma pieno ogni cosa d'ignudi, con un ordine, disegno, invenzione, componimento, colorito e pittura fatta a suo modo, con tanta malinconia e con tanto poco piacere di chi guarda quell'opera, ch'io mi risolvo, per non l'intendere ancor io, se ben son pittore, di lasciarne far giudizio a coloro che la vedranno; perciò che io crederei impazzarvi dentro et avvilupparmi, come mi pare, che in undici anni di tempo che egli ebbe, cercass'egli di avviluppare sé e chiunque vede questa pittura con quelle così fatte figure. E se bene si vede in questa opera qualche pezzo di torso che volta le spalle o il dinanzi et alcune apiccature di fianchi, fatte con maraviglioso studio e molta fatica da Iacopo, che quasi di tutte fece i modelli di terra tondi e finiti, il tutto nondimeno è fuori della maniera sua, e come pare quasi a ognuno, senza misura, essendo nella più parte i torsi grandi e le gambe e braccia piccole, per non dir nulla delle teste, nelle quali non si vede punto punto di quella bontà e grazia singolare che soleva dar loro con pienissima sodisfazione di chi mira l'altre sue pitture. Onde pare che in questa non abbia stimato se non certe parti, e dell'altre più importanti non abbia tenuto conto niuno. Et insomma, dove egli aveva pensato di trapassare in questa tutte le pitture dell'arte, non arrivò a gran pezzo alle cose sue proprie fatte ne' tempi a dietro. Onde si vede che chi vuol strafare e quasi sforzare la natura, rovina il buono che da quella gli era stato largamente donato. Ma che si può o deve se non avergli compassione, essendo così gl'uomini delle nostre arti sottoposti al-l'errare come gl'altri? Et il buon Omero, come si dice, anch'egli tal volta s'adormenta. Né sarà mai che in tutte l'opere di Iacopo (sforzasse quanto volesse la natura) non sia del buono e del lodevole. E perché se morì poco avanti che al fine dell'opera, affermano alcuni che fu morto dal dolore, restando in ultimo malissimo sodisfatto di se stesso. Ma la verità che essendo vecchio e molto affaticato dal far ritratti, modelli di terra e lavorare tanto in fresco, diede in una idropisia che finalmente l'uccise d'anni 65. Furono dopo la costui morte trovati in casa sua molti disegni, cartoni e modelli di terra bellissimi, et un quadro di Nostra Donna stato da lui molto ben condotto, per quello che si vide, e con bella maniera molti anni inanzi, il quale fu venduto poi dagl'eredi suoi a Piero Salviati. Fu sepolto Iacopo nel primo chiostro della chiesa de' frati de' Servi, sotto la storia che egli già fece della Visitazione, e fu onoratamente accompagnato da tutti i pittori, scultori et architettori. Fu Iacopo molto parco e costumato uomo, e fu nel vivere e vestire suo più tosto misero che assegnato, e quasi sempre stette da sé solo, senza volere che alcuno lo servisse o gli cucinasse. Pure negl'ultimi anni tenne come per allevarselo Battista Naldini, giovane di buono spirito, il quale ebbe quel poco di cura della vita di Iacopo che egli stesso volle che se n'avesse, et il quale sotto la disciplina di lui fece non piccol frutto nel disegno, anzi tale che se ne spera ottima riuscita. Furono amici del Puntormo in particulare in questo ultimo della sua vita Pierfrancesco Vernacci, e don Vincenzio Borghini col quale si ricreava alcuna volta, ma di rado, mangiando con esso loro. Ma sopra ogni altro fu da lui sempre sommamente amato il Bronzino che amò lui parimente come grato e conoscente del benefizio da lui ricevuto. Ebbe il Puntormo di bellissimi tratti, e fu tanto pauroso della morte, che non voleva, non che altro, udirne ragionare, e fuggiva l'avere a incontrare morti. Non andò mai a feste, né in altri luoghi dove si ragunassero genti, per non essere stretto nella calca e fu oltre ogni credenza solitario. Alcuna volta, andando per lavorare, si mise così profondamente a pensare quello che volesse fare, che se ne partì senz'avere fatto altro in tutto quel giorno che stare in pensiero. E che questo gl'avvenisse infinite volte nell'opera di San Lorenzo, si può credere agevolmente, perciò che quando era risoluto, come pratico e valente, non istentava punto a far quello che voleva, o aveva deliberato di mettere in opera.
IL FINE DELLA VITA DI IACOPO DA PUNTORMO, PITTOR FIORENTINO
VITA DI SIMONE MOSCA
SCULTORE ET ARCHITETTO

Dagli scultori antichi greci e romani in qua, niuno intagliatore moderno ha paragonato l'opere belle e difficili che essi feciono nelle base, capitegli, fregiature, cornici, festoni, trofei, maschere, candellieri, uccelli, grottesche o altro corniciame intagliato, salvo che Simone Mosca da Settignano, il quale ne' tempi nostri ha operato in questa sorte di lavori talmente, che egli ha fatto conoscere con l'ingegno e virtù sua che la diligenza, e studio degl'intagliatori moderni, stati innanzi a lui, non aveva insino a lui saputo imitare il buono dei detti antichi, né preso il buon modo negl'intagli. Conciò sia che l'opere loro tengono del secco et il girare de' loro fogliami dello spinoso e del crudo, là dove gli ha fatti egli con gagliardezza et abondanti e ricchi di nuovi andari con foglie in varie maniere intagliate, con belle intaccature e con i più bei semi, fiori e vilucchi che si possano vedere, senza gl'uccegli che in fra i festoni e fogliame ha saputo graziosamente in varie guise intagliare. In tanto che si può dire che Simone solo (sia detto con pace degl'altri) abbia saputo cavar del marmo quella durezza che suol dar l'arte spesse volte alle sculture, e ridotte le sue cose con l'oprare dello scarpello a tal termine, ch'elle paiono palpabili e vere; et il medesimo si dice delle cornici et altri somiglianti lavori da lui condotti con bellissima grazia e giudizio. Costui avendo nella sua fanciullezza atteso al disegno con molto frutto e poi fattosi pratico nell'intagliare, fu da maestro Antonio da San Gallo, il quale conobbe l'ingegno e buono spirito di lui, condotto a Roma, dove e' gli fece fare, per le prime opere, alcuni capitegli e base e qualche fregio di fogliami, per la chiesa di San Giovanni de' Fiorentini, et alcuni lavori per lo palazzo d'Alessandro, primo cardinal Farnese. Attendendo in tanto Simone, e massimamente i giorni delle feste e quando poteva rubar tempo, a disegnare le cose antiche di quella città, non passò molto che disegnava e faceva piante con più grazia e nettezza che non faceva Antonio stesso; di maniera che, datosi tutto a studiare disegnando i fogliami della maniera antica et a girare gagliardo le foglie et a traforare le cose per condurle a perfezzione, togliendo dalle cose migliori il migliore, e da chi una cosa e da chi un'altra, fece in pochi anni una bella composizione di maniera e tanto universale, che faceva poi bene ogni cosa et insieme e da per sé, come si vede in alcun'armi che dovevano andare nella detta chiesa di San Giovanni in strada Giulia. In una delle quali armi facendo un giglio grande, antica insegna del comune di Firenze, gli fece addosso alcuni girari di foglie con vilucchi e semi così ben fatti, che fece stupefare ognuno. Né passò molto che, guidando Antonio da San Gallo per Messer Agnolo Cesis l'ornamento di marmo d'una cappella e sepoltura di lui e di sua famiglia, che fu murata poi l'anno 1550 nella chiesa di Santa Maria della Pace, fece fare parte d'alcuni pilastri e zoccoli pieni di fregiature che andavano in quell'opera a Simone, il quale gli condusse sì bene e sì begli, che senza ch'io dica quali sono, si fanno conoscere alla grazia e perfezzione loro in fra gl'altri. Né è possibile veder più belli e capricciosi altari da fare sacrifizii all'usanza antica di quelli che costui fece nel basamento di quell'opera. Dopo, il medesimo San Gallo, che facea condurre nel chiostro di San Pietro in Vincola la bocca di quel pozzo, fece fare al Mosca le sponde con alcuni mascheroni bellissimi. Non molto dopo, essendo una state tornato a Firenze et avendo buon nome fra gl'artefici, Baccio Bandinelli che faceva l'Or-feo di marmo, che fu posto nel cortile del palazzo de' Medici, fatta condurre la basa di quell'opera da Benedetto da Rovezzano, fece condurre a Simone i festoni et altri intagli bellissimi che vi sono, ancor che un festone vi sia imperfetto e solamente gradinato. Avendo poi fatto molte cose di macigno, delle quali non accade far memoria, disegnava tornare a Roma, ma seguendo in quel mentre il Sacco non andò altrimenti, ma preso donna, si stava a Firenze con poche faccende, perché, avendo bisogno d'aiutare la famiglia e non avendo entrate, si andava trattenendo con ogni cosa. Capitando adunque in que' giorni a Fiorenza Pietro di Subisso, maestro di scarpello aretino, il quale teneva di continuo sotto di sé buon numero di lavoranti, però che tutte le fabriche d'Arezzo passavano per le sue mani, condusse fra molti altri Simone in Arezzo, dove gli diede a fare per la casa degl'eredi di Pellegrino da Fossombrone, cittadino aretino, la qual casa avea già fatta fare Messer Piero Geri, astrologo eccellente, col disegno d'Andrea Sansovino, e dai nepoti era stata venduta, per una sala un camino di macigno et un acquaio di non molta spesa. Messovi dunque mano e cominciato Simone il cammino lo pose sopra due pilastri, facendo due nicchie nella grossezza di verso il fuoco e mettendo sopra i detti pilastri architrave, fregio e cornicione et un frontone di sopra con festoni e con l'arme di quella famiglia. E così continuando, lo condusse con tanti e sì diversi intagli e sottile magistero, che ancor che quell'opera fusse di macigno, diventò nelle sue mani più bella che se fusse di marmo e più stupenda, il che gli venne anco fatto più agevolmente, però che quella pietra non è tanto dura quanto il marmo e più tosto renosiccia che no. Mettendo dunque in questo lavoro un'e-strema diligenza, condusse ne' pilastri alcuni trofei, di mezzo tondo e basso rilievo, più belli e più bizzarri che si possano fare; con celate, calzari, targhe, turcassi et altre diverse armadure; vi fece similmente maschere, mostri marini et altre graziose fantasie, tutte in modo ritratte e traforate, che paiono d'argento. Il fregio poi, che è fra l'architrave et il cornicione, fece con un bellissimo girare di fogliami, tutto traforato e pien d'uccelli, tanto ben fatti, che paiano in aria volanti, onde è cosa maravigliosa vedere le piccole gambe di quelli, non maggiori del naturale, essere tutte tonde e staccate dalla pietra, in modo che pare impossibile. E nel vero, quest'opera pare più tosto miracolo che artifizio. Vi fece oltre ciò in un festone alcune foglie e frutte, così spiccate e fatte con tanta diligenza sottili, che vincono in un certo modo le naturali. Il fine poi di quest'opera sono alcune mascherone e candellieri veramente bellissimi; e se bene non dovea Simone in un'opera simile mettere tanto studio, dovendone essere scarsamente pagato da coloro che molto non potevano, nondimeno, tirato dall'amore che portava all'arte e dal piacere che si ha in bene operando, volle così fare; ma non fece già il medesimo nell'acquaio de' medesimi, però che lo fece assai bello, ma ordinario.
Nel medesimo tempo aiutò fare a Piero di Sobisso, che molto non sapea, molti disegni di fabriche, di piante di case, porte, finestre et altre cose attenenti a quel mestiero. In sulla cantonata degl'Albergotti, sotto la scuola e studio del comune, è una finestra fatta col disegno di costui assai bella. Et in Pelliceria ne son due nella casa di ser Bernardino Serragli, et in sulla cantonata del palazzo de' Priori è di mano del medesimo un'arme grande di macigno di papa Clemente Settimo. Fu condotta ancora di suo ordine e parte da lui medesimo una cappella di macigno d'ordine corinto, per Bernardino di Cristofano da Giuovi, che fu posta nella Badia di Santa Fiore, monasterio assai bello in Arezzo di monaci Neri. In questa cappella voleva il padrone far fare la tavola ad Andrea del Sarto e poi al Rosso, ma non gli venne fatto perché, quando da una cosa e quando da altra impediti, non lo poterono servire. Finalmente voltosi a Giorgio Vasari ebbe anco con esso lui delle difficultà e si durò fatica a trovar modo che la cosa si accomodasse. Perciò che, essendo quella cappella intitolata in San Iacopo et in San Cristofani, vi voleva colui la Nostra Donna col Figliuolo in collo e poi al San Cristofano gigante un altro Cristo piccolo sopra la spalla, la quale cosa, oltre che parea mostruosa, non si poteva accomodare né fare un gigante di sei in una tavola di quattro braccia. Giorgio adunque, disideroso di servire Bernardino, gli fece un disegno di questa maniera: pose sopra le nuvole la Nostra Donna con un sole dietro le spalle et in terra fece San Cristofano ginocchioni, con una gamba nell'acqua da uno de' lati della tavola, e l'altra in atto di moverla per rizzarsi, mentre la Nostra Donna gli pone sopra le spalle Cristo fanciullo con la palla del mondo in mano; nel resto della tavola poi aveva da essere accomodato in modo San Iacopo e gl'altri Santi, che non si sarebbono dati noia. Il quale disegno piacendo a Bernardino, si sarebbe messo in opera, ma perché in quello si morì, la cappella si rimase a quel modo agl'eredi, che non hanno fatto altro. Mentre dunque che Simone lavorava la detta cappella, passando per Arezzo Antonio da San Gallo, il quale tornava dalla fortificazione di Parma et andava a Loreto a finire l'opera della cappella della Madonna, dove aveva aviati il Tribolo, Raffaello Monte Lupo, Francesco giovane da San Gallo, Girolamo da Ferrara e Simon Cioli et altri intagliatori, squadratori e scarpellini, per finire quello che alla sua morte aveva lasciato Andrea Sansovino imperfetto, fece tanto che condusse là Simone a lavorare, dove gl'ordinò che non solo avesse cura agl'intagli, ma all'architettura ancora et altri ornamenti di quell'opera. Nelle quali commessioni si portò il Mosca molto bene, e, che fu più, condusse di sua mano perfettamente molte cose et in particolare alcuni putti tondi di marmo che sono in sui frontespizii delle porte, e, se bene ve ne sono anco di mano di Simon Cioli, i migliori, che sono rarissimi, son tutti del Mosca. Fece similmente tutti i festoni di marmo che sono a torno a tutta quell'opera, con bellissimo artifizio e con graziosissimi intagli e degni di ogni lode. Onde non è maraviglia se sono amirati et in modo stimati questi lavori, che molti artefici da' luoghi lontani si sono partiti per andargli a vedere.
Antonio da San Gallo adunque, conoscendo quanto il Mosca valesse in tutte le cose importanti, se ne serviva con animo. Un giorno, porgendosegli l'occasione di remunerarlo e fargli conoscere quanto amasse la virtù di lui, perché essendo, dopo la morte di papa Clemente, creato sommo pontefice Paulo Terzo Farnese, il quale ordinò, essendo rimasa la bocca del pozzo d'Orvieto imperfetta, che Antonio n'avesse cura, esso Antonio vi condusse il Mosca acciò desse fine a quell'opera, la quale aveva qualche difficultà et in particulare nell'ornamento delle porte, perciò che, essendo tondo il giro della bocca, colmo di fuori e dentro voto, que' due circoli contendevano insieme e facevano difficoltà nell'accomo-dare le porte quadre con l'ornamento di pietra. Ma la virtù di quell'ingegno pellegrino di Simone accomodò ogni cosa e condusse il tutto con tanta grazia e perfezzione, che niuno s'avede che mai vi fusse difficultà. Fece dunque il finimento di questa bocca e l'orlo di macigno et il ripieno di mattoni, con alcuni epitaffi di pietra bianca bellissimi et altri ornamenti, riscontrando le porte del pari; vi fece anco l'arme di detto papa Paulo Farnese di marmo, anzi, dove prima erano fatte di palle per papa Clemente che aveva fatto quell'opera, fu forzato il Mosca, e gli riuscì benissimo, a fare delle palle di rilievo, gigli, e così a mutare l'arme de' Medici in quella di casa Farnese, non ostante, come ho detto (così vanno le cose del mondo), che di cotanto magnifica opera e regia fusse stato autore papa Clemente Settimo, del quale non si fece, in quest'ultima parte e più importante, alcuna menzione. Mentre che Simone attendeva a finire questo pozzo, gl'O-perai di Santa Maria del Duomo d'Orvieto, disiderando far fine alla cappella di marmo, la quale con ordine di Michele San Michele veronese s'era condotta infino al basamento con alcuni intagli, ricercorno Simone che volesse attendere a quella, avendolo conosciuto veramente eccellente: per che, rimasi d'accordo e piacendo a Simone la conversazione de-gl'orvietani, vi condusse, per stare più comodamente, la famiglia, e poi si mise con animo quieto e posato a lavorare, essendo in quel luogo da ognuno grandemente onorato. Poi dunque che ebbe dato principio, quasi per saggio, ad alcuni pilastri e fregiature, essendo conosciuta da quegl'uomini l'eccellenza e virtù di Simone, gli fu ordinata una provisione di dugento scudi d'oro l'anno, con la quale continuando di lavorare condusse quell'opera a buon termine. Perché nel mezzo andava, per ripieno di questi ornamenti, una storia di marmo, cioè l'adorazione de' Magi di mezzo rilievo, vi fu condotto, avendolo proposto Simone suo amicissimo, Raffaello da Monte Lupo scultore fiorentino, che condusse quella storia, come si è detto, infino a mezzo bellissima. L'ornamento dunque di questa cappella sono certi basamenti che mettono in mezzo l'altare di larghezza braccia dua e mezzo l'uno, sopra i quali sono due pilastri per banda alti cinque e questi mettono in mezzo la storia de' Magi. E nei due pilastri di verso la storia, che se ne veggiono due faccie, sono intagliati alcuni candellieri con fregiature di grottesche, maschere, figurine e fogliami, che sono cosa divina. E da basso nella predella che va ricignendo sopra l'altare fra l'uno e l'altro pilastro, è un mezzo Angioletto che con le mani tiene un'inscri-zione con festoni sopra, e fra i capitegli de' pilastri, dove risalta l'architrave, il fregio e cornicione tanto quanto sono larghi i pilastri. E sopra quelli del mezzo, tanto quanto son larghi, gira un arco che fa ornamento alla storia detta de' Magi, nella quale, cioè in quel mezzo tondo, sono molti Angeli. Sopra l'arco è una cornice che viene da un pilastro al-l'altro, cioè da quegl'ultimi di fuori che fanno frontespizio a tutta l'opera, et in questa parte è un Dio Padre di mezzo rilievo; e dalle bande dove gira l'arco sopra i pilastri, sono due Vettorie di mezzo rilievo. Tutta quest'opera adunque è tanto ben composta e fatta con tanta ricchezza d'intaglio, che non si può fornire di vedere le minuzie degli strafori, l'ec-cellenza di tutte le cose che sono in capitelli, cornici, maschere, festoni e ne' candellieri tondi, che fanno il fine di quella certo degno di essere come cosa rara amirato.
Dimorando adunque Simone Mosca in Orvieto, un suo figliuolo di quindici anni, chiamato Francesco e per sopranome il Moschino, essendo stato dalla natura prodotto quasi con gli scarpelli in mano e di sì bell'ingegno, che qualunque cosa voleva facea con somma grazia, condusse sotto la disciplina del padre in quest'opera, quasi miracolosamente, gl'Angeli che fra i pilastri tengono l'inscrizioni, poi il Dio Padre del frontespizio e finalmente gl'Angeli che sono nel mezzo tondo dell'opera, sopra l'Adorazione de' Magi fatta da Raffaello, et ultimamente le Vittorie dalle bande del mezzo tondo, nelle quali cose fé stupire e maravigliare ognuno. Il che fu cagione che finita quella cappella, a Simone fu da-gl'Operai del Duomo dato a farne un'altra a similitudine di questa, dall'altra banda, acciò meglio fusse accompagnato il vano della cappella dell'altare maggiore, con ordine che, senza variare l'architettura, si variassono le figure, e nel mezzo fusse la visitazione di Nostra Donna, la quale fu allogata al detto Moschino. Convenuti dunque del tutto, misero il padre et il figliuolo mano all'opera, nella quale, mentre si adoperarono, fu il Mosca di molto giovamento et utile a quella città, facendo a molti disegni d'architettura per case et altri edifizii. E fra l'altre cose fece in quella città la pianta e la facciata della casa di Messer Raffaello Gualtieri, padre del vescovo di Viterbo, e di Messer Felice, ambi gentiluomini e signori onorati e virtuosissimi; et alli signori conti della Cervara similmente le piante d'alcune case. Il medesimo fece in molti de' luoghi a Orvieto vicini et in particolare il signor Pirro Colonna da Stripicciano, i modelli di molte fabriche e muraglie. Facendo poi fare il Papa in Perugia la fortezza dove erano state le case de' Baglioni, Antonio San Gallo, mandato per il Mosca, gli diede carico di fare gl'ornamenti, onde furono con suo disegno condotte tutte le porte, finestre, camini et altre sì fatte cose, et in particolare due grandi e bellissime armi di Sua Santità. Nella quale opera avendo Simone fatto servitù con Messer Tiberio Crispo che vi era castellano, fu da lui mandato a Bolsena dove, nel più alto luogo di quel castello riguardante il lago, accomodò parte in sul vecchio e parte fondando di nuovo, una grande e bella abitazione con una salita di scale bellissima e con molti ornamenti di pietra. Né passò molto che, essendo detto Messer Tiberio fatto castellano di Castel Santo Agnolo, fece andare il Mosca a Roma, dove si servì di lui in molte cose nella rinovazione delle stanze di quel castello. E fra l'altre cose gli fé fare sopra gl'archi che imboccano la loggia nuova, la quale volta verso i prati, due armi del detto Papa di marmo, tanto ben lavorate e traforate nella mitra o vero regno, nelle chiavi et in certi festoni e mascherine, ch'elle sono maravigliose. Tornato poi ad Orvieto per finire l'opera della cappella, vi lavorò continuamente tutto il tempo che visse papa Paulo, conducendola di sorte, ch'ella riuscì, come si vede, non meno eccellente che la prima e forse molto più. Perciò che portava il Mosca, come s'è detto, tanto amore all'arte e tanto si compiaceva nel lavorare, che non si faticava mai di fare, cercando quasi l'impossibile, e ciò per disiderio di gloria che d'accu-mulare oro, contentandosi più di bene operare nella sua professione che d'acquistare roba.
Finalmente, essendo l'anno 1550 creato papa Giulio Terzo, pensandosi che dovesse metter mano da dovero alla fabrica di San Piero, se ne venne il Mosca a Roma e tentò con i deputati della fabrica di S. Piero di pigliare in somma alcuni capitelli di marmo, più per accomodare Giandomenico suo genero che per altro. Avendo dunque Giorgio Vasari, che portò sempre amore al Mosca, trovatolo in Roma dove anch'egli era stato chiamato al servizio del Papa, pensò ad ogni modo d'avergli a dare da lavorare, perciò che avendo il cardinal vecchio di Monte, quando morì, lasciato agl'eredi che se gli dovesse fare in San Piero a Montorio una sepoltura di marmo, et avendo il detto papa Giulio suo erede e ni-pote ordinato che si facesse e datone cura al Vasari, egli voleva che in detta sepoltura facesse il Mosca qualche cosa d'intaglio straordinaria. Ma avendo Giorgio fatti alcuni modelli per detta sepoltura, il Papa conferì il tutto con Michelagnolo Buonarruoti prima che volessi risolversi; onde, avendo detto Michelagnolo a Sua Santità che non s'impacciasse con intagli perché, se bene aricchiscono l'opere, confondono le figure, là dove il lavoro di quadro, quando è fatto bene, è molto più bello che l'intaglio e meglio accompagna le statue, perciò che le figure non amano altri intagli attorno, così ordinò Sua Santità che si facesse. Per che il Vasari non potendo dare che fare al Mosca in quell'opera, fu licenziato e si finì senza intagli la sepoltura che tornò molto meglio che con essi non arebbe fatto. Tornato dunque Simone a Orvieto, fu dato ordine col suo disegno di fare nella crocera a sommo della chiesa due tabernacoli grandi di marmo, e certo con bella grazia e proporzione; in uno de' quali fece in una nicchia Raffaello Monte Lupo un Cristo ignudo di marmo con la croce in ispalla e nell'altro fece il Moschino un S. Bastiano similmente ignudo. Seguitandosi poi da far per la chiesa gl'Apostoli, il Moschino fece della medesima grandezza S. Piero e S. Paulo, che furono tenute ragionevoli statue. Intanto non si lasciando l'opera della detta cappella della Visitazione, fu condotta tanto inanzi vivendo il Mosca, che non mancava a farvi se non due uccelli, et anco questi non sarebbono mancati, ma Messer Bastiano Gualtieri, vescovo di Viterbo, come s'è detto, tenne occupato Simone in un ornamento di marmo di quattro pezzi, il quale finito mandò in Francia al cardinale di Loreno che l'ebbe carissimo, essendo bello a maraviglia e tutto pieno di fogliami e lavorato con tanta diligenza, che si crede questa essere stata delle migliori che mai facesse Simone; il quale non molto dopo che ebbe fatto questo si morì, l'anno 1554, d'anni 58, con danno non piccolo di quella chiesa d'Orvieto, nella quale fu onorevolmente sotterrato. Dopo, essendo Francesco Moschino dagl'Operai di quel medesimo Duomo eletto in luogo del padre, non se ne curando, lo lasciò a Raffaello Monte Lupo e, andato a Roma, finì a Messer Ruberto Strozzi due molto graziose figure di marmo, cioè il Marte e la Venere che sono nel cortile della sua casa in Banchi. Dopo, fatta una storia di figurine piccole, quasi di tondo rilievo, nella quale è Diana che con le sue ninfe si bagna e converte Atteon in cervio, il quale è mangiato da' suoi proprii cani, se ne venne a Firenze e la diede al signor duca Cosimo, il quale molto disiderava di servire, onde sua eccellenza avendo accettata e molto commendata l'opera, non mancò al disiderio del Moschino, come non ha mai mancato a chi ha voluto in alcuna cosa virtuosamente operare. Per che, messolo nell'Opera del Duomo di Pisa, ha insino a ora con sua molta lode fatto nella cappella della Nunziata, stata fatta da Stagio da Pietrasanta, con gl'intagli et ogni altra cosa l'Angelo e la Madonna in figure di quattro braccia; nel mezzo Adamo ed Eva che hanno in mezzo il pomo et un Dio Padre grande con certi putti nella volta della detta cappella tutta di marmo, come so-no anco le due statue che al Moschino hanno acquistato assai nome et onore. E perché la detta cappella è poco meno che finita, ha dato ordine sua eccellenza che si metta mano alla cappella [che] è dirimpetto a questa, detta dell'Incorona-ta, cioè subito all'entrare di chiesa a man manca. Il medesimo Moschino, nell'apparato della serenissima reina Giovanna e dell'illustrissimo prencipe di Firenze, si è portato molto bene in quell'opere che gli furono date a fare.
IL FINE DELLA VITA DI SIMONE DETTO IL MOSCA DA SETTIGNANO
VITA DI GIROLAMO E DI BARTOLOMEO GENGA E DI GIOVAMBATTISTA SAN MARINO GENERO DI GIROLAMO PITTORI FIORENTINI

Girolamo Genga, il quale fu da Urbino, essendo da suo padre di dieci anni messo all'Arte della Lana, perché l'esser-citava malissimo volentieri, come gli era dato luogo e tempo di nascosto con carboni e con penne da scrivere andava disegnando. La qual cosa vedendo alcuni amici di suo padre, l'essortarono a levarlo da quell'arte e metterlo alla pittura, onde lo mise in Urbino appresso di certi maestri di poco nome, ma veduta la bella maniera che avea e ch'era per far frutto, come'egli fu di quindici anni lo accomodò con maestro Luca Signorelli da Cortona, in quel tempo nella pittura maestro eccellente, col quale stette molti anni e lo seguitò nella Marca d'Ancona in Cortona et in molti altri luoghi, do-ve fece opere e particolarmente ad Orvieto, nel Duomo della qual città fece, come s'è detto, una cappella di Nostra Donna con infinito numero di figure, nella quale continuamente lavorò detto Girolamo e fu sempre de' migliori discepoli ch'egli avesse. Partitosi poi da lui, si mise con Pietro Perugino, pittore molto stimato, col quale stette tre anni circa et attese assai alla prospettiva, che da lui fu tanto ben capita e bene intesa, che si può dire che ne divenisse eccellentissimo, sì come per le sue opere di pittura e di architettura si vede, e fu nel medesimo tempo che con il detto Pietro stava il divino Raffaello da Urbino, che di lui era molto amico. Partitosi poi da Pietro se n'andò da sé a stare in Fiorenza, do-ve studiò tempo assai; dopo, andato a Siena vi stette appresso di Pandolfo Petrucci anni e mesi, in casa del quale dipinse molte stanze, che per essere benissimo disegnate e vagamente colorite meritorno essere viste e lodate da tutti i senesi e particolarmente dal detto Pandolfo, dal quale fu sempre benissimo veduto et infinitamente accarezzato. Morto poi Pandolfo, se ne tornò a Urbino, dove Guidobaldo duca Secondo lo trattenne assai tempo, facendogli dipignere barde da cavallo che si usavano in que' tempi, in compagnia di Timoteo da Urbino pittore di assai buon nome e di molta esperienzia, insieme col quale fece una cappella di S. Martino nel Vescovado per Messer Giovampiero Arivabene mantovano, allora vescovo d'Urbino, nella quale l'uno e l'altro di loro riuscì di bellissimo ingegno sì come l'opera istessa dimostra, nella qual è ritratto il detto Vescovo che pare vivo. Fu anco particolarmente trattenuto il Genga da detto Duca, per far scene et apparati di commedie, le quali perché aveva bonissima intelligenza di prospettiva e gran principio di architettura, faceva molto mirabili e belli. Partitosi poi da Urbino, se n'andò a Roma, dove in strada Giulia, in Santa Caterina da Siena, fece di pittura una Resurrezzione di Cristo, nella quale si fece cognoscere per raro et eccellente maestro, avendola fatta con disegno, bell'attitudine di figure, scorti e ben colorita, sì come quelli che sono della professione che l'hanno veduta ne possono far bonissima testimonianza. E stando in Roma attese molto a misurare di quelle anticaglie, sì come ne sono scritti appresso de' suoi eredi.
In questo tempo, morto il duca Guido e successo Francesco Maria duca Terzo d'Urbino, fu da lui richiamato da Roma e constretto a ritornare a Urbino in quel tempo che 'l predetto Duca tolse per moglie e menò nel stato Leonora Gonzaga, figliuola del marchese di Mantova, e da sua eccellenza fu adoperato in far archi trionfali, apparati e scene di commedie, che tutto fu da lui tanto ben ordinato e mezzo in opera, che Urbino si poteva assimigliare a una Roma trionfante; onde ne riportò fama et onore grandissimo. Essendo poi col tempo il Duca cacciato di stato, da l'ultima volta che se ne andò a Mantova, Girolamo lo seguitò sì come prima avea fatto nelli altri esilii, correndo una medesima fortuna e riducendosi con la sua famiglia in Cesena, dove fece in Sant'Agostino all'altare maggiore una tavola a olio, in cima del-la quale è una Annunziata e poi di sotto un Dio Padre e più a basso una Madonna con un Putto in braccio in mezzo ai quattro Dottori della Chiesa, opera veramente bellissima e da essere stimata. Fece poi in Forlì a fresco, in San Francesco, una cappella a man dritta, dentrovi l'Assunzione della Madonna con molti Angeli e figure a torno, cioè Profeti et Apostoli, che in questa anco si cognosce in quanto mirabile ingegno fusse, perché l'opera fu giudicata bellissima. Fecevi anco la storia dello Spirito Santo per Messer Francesco Lombardi, medico, che fu l'anno 1512 ed egli la finì, et altre opere per la Romagna, delle quali ne riportò onore e premio. Essendo poi ritornato il Duca nello stato, se ne tornò anco Girolamo e da esso fu trattenuto ed adoperato per architetto e nel restaurare un palazzo vecchio e farli giunta d'altra torre nel monte dell'Imperiale sopra Pesaro. Il qual palazzo per ordine e disegno del Genga fu ornato di pittura d'istorie e fatti del Duca, da Francesco da Forlì, da Raffael dal Borgo, pittori di buona fama, e da Cammillo Mantovano, in far paesi e verdure rarissimo, e fra li altri vi lavorò anco Bronzino fiorentino giovinetto, come si è detto nella vita del Puntormo. Essendovi anco condotti i Dossi ferraresi, fu allogata loro una stanza a dipignere; ma perché finita che l'ebbero non piacque al Duca, fu gittata a terra e fatta rifare dalli sopra nominati. Fecevi poi la torre alta 120 piedi con 13 scale di legno da salirvi sopra, accomodate tanto bene e nascoste nelle mura che si ritirano di solaro in solaro agevolmente, il che rende quella torre fortissima e maravigliosa. Venendo poi voglia al Duca di voler fortificare Pesaro et avendo fatto chiamare Pierfrancesco da Viterbo, architetto molto eccellente, nelle dispute che si facevano sopra la fortificazione, sempre Girolamo v'intervenne et il suo discorso e parere fu tenuto buono e pieno di giudizio. Onde, se m'è lecito così dire, il disegno di quella fortezza fu più di Girolamo che d'alcun altro, se bene questa sorte di architettura da lui fu sempre stimata poco, parendoli di poco pregio e dignità. Vedendo dunque il Duca di aver un così raro ingegno, deliberò di fare al detto luogo dell'Imperiale vicino al palazzo vecchio un altro palazzo nuovo, e così fece quello che oggi vi si vede, che per esser fabrica bellissima e bene intesa, piena di camere, di colonnati e di cortili, di logge, di fontane e di amenissimi giardini, da quella banda non passano prencipi che non la vadino a vedere; onde meritò che papa Paulo Terzo, andando a Bologna con tutta la sua corte, l'andasse a vedere e ne restasse pienamente sodisfatto.
Col disegno del medesimo il Duca fece restaurare la corte di Pesaro et il Barchetto facendovi dentro una casa che, rappresentando una ruina, è cosa molto bella a vedere; e fra le altre cose vi è una scala, simile a quella di Belvedere di Roma, che è bellissima. Mediante [lui] fece restaurare la rocca di Gradara e la corte di Castel Durante in modo che tutto quello che vi è di buono venne da questo mirabile ingegno. Fece similmente il corridore della corte d'Urbino, sopra il giardino, et un altro cortile ricinse da una banda con pietre traforate con molta diligenza. Fu anco cominciato col disegno di costui il convento de' Zoccolanti a Monte Baroccio e Santa Maria delle Grazie a Senigaglia, che poi restarono imperfette per la morte del Duca. Fu ne' medesimi tempi con suo onore ordine e disegno cominciato il Vescovado di Sinigaglia, che se ne vede anco il modello fatto da lui. Fece anco alcune opere di scultura e figure tonde di terra e di cera, che sono in casa de' nipoti in Urbino, assai bene. All'Imperiale fece alcuni Angeli di terra, i quali fece poi gettar di gesso e mettergli sopra le porte delle stanze lavorate di stucco nel palazzo nuovo, che sono molto belli. Fece al vescovo di Sinigaglia alcune bizzarrie di vasi di cera da bere per farli poi d'argento, e con più diligenzia ne fece al Duca per la sua credenza alcuni altri bellissimi. Fu bellissimo inventore di mascherate e d'abiti, come si vidde al tempo del detto Duca, dal quale meritò per le sue rare virtù e buone qualità essere assai remunerato. Essendo poi successo il duca Guidobaldo suo figliuolo, che regge oggi, fece principiare dal detto Genga la chiesa di San Giovambattista in Pesaro, che essendo stata condotta secondo quel modello da Bartolomeo suo figliuolo, è di bellissima architettura in tutte le parti, per avere assai immitato l'antico e fattala in modo ch'ell'è il più bel tempio che sia in quelle parti, sì come l'opera stessa apertamente dimostra, potendo stare al pari di quelle di Roma più lodate. Fu similmente per suo disegno et opera fatto da Bartolomeo Ammannati fiorentino scultore, allora molto giovane, la sepoltura del duca Francesco Maria in Santa Chiara d'Urbino, che per cosa semplice e di poca spesa riuscì molto bella. Medesimamente fu condotto da lui Battista Franco, pittore veniziano, a dipignere la cappella grande del Duomo d'Urbino, quando per suo disegno si fece l'orna-mento dell'organo del detto Duomo che ancor non è finito. E poco dappoi, avendo scritto il cardinale di Mantova al Duca che gli dovesse mandare Girolamo perché voleva rassettare il suo Vescovado di quella città, egli vi andò e rassettollo molto bene di lumi e di quanto disiderava quel signore; il quale oltre ciò, volendo fare una facciata bella al detto Duomo, gliene fece fare un modello che da lui fu condotto di tal maniera, che si può dire che avanzasse tutte l'architetture del suo tempo; perciò che si vede in quello grandezza, proporzione, grazia e composizione bellissima. Essendo poi ritornato da Mantova già vecchio, se n'andò a stare a una sua villa nel territorio d'Urbino, detta la Valle, per riposarsi e godersi le sue fatiche; nel qual luogo, per non stare in ozio fece di matita una conversione di San Paolo con figure e cavalli assai ben grandi e con bellissime attitudini, la quale da lui con tanta pazienza e diligenza fu condotta, che non si può dire né vedere la maggiore, sì come appresso delli suoi eredi si vede, da' quali è tenuta per cosa preziosa e carissima. Nel qual luogo stando con l'animo riposato, oppresso da una terribile febbre, ricevuti ch'egli ebbe tutti i sacramenti della chiesa, con infinito dolore di sua moglie e de' suoi figliuoli finì il corso di sua vita nel 1551, agli 11 di luglio, di età d'anni 75 incirca, dal qual luogo essendo portato a Urbino fu sepolto onoratamente nel Vescovado innanzi alla cap-pella di San Martino già stata dipinta da lui, con incredibile dispiacere de' suoi parenti e di tutti i cittadini. Fu Girolamo uomo sempre da bene, in tanto che mai di lui non si sentì cosa mal fatta; fu non solo pittore, scultore et architettore, ma ancora buon musico. Fu bellissimo ragionatore et ebbe ottimo trattenimento; fu pieno di cortesia e di amorevolezza verso i parenti et amici, e quello di che merita non piccola lode, egli diede principio alla casa dei Genghi in Urbino con onore, nome e facultà. Lasciò due figliuoli, uno de' quali seguitò le sue vestigia et attese alla architettura nella quale, se da la morte non fusse stato impedito, veniva eccellentissimo, sì come dimostravano li suoi principii, e l'altro, che attese alla cura famigliare, ancor oggi vive.
Fu, come s'è detto, suo discepolo Francesco Menzochi da Furlì, il quale prima cominciò, essendo fanciulletto, a disegnare da sé, immitando e ritraendo in Furlì nel Duomo una tavola di mano di Marco Parmigiano da Forlì, che vi fé dentro una Nostra Donna, San Ieronimo et altri Santi, tenuta allora, delle pitture moderne, la migliore, e parimente andava immitando l'opere di Rondinino da Ravenna, pittore più eccellente di Marco, il quale aveva poco innanzi messo allo altar maggiore il detto Duomo una bellissima tavola, dipintovi dentro Cristo che comunica gli Apostoli et in un mezzo tondo sopra un Cristo morto, e nella predella di detta tavola storie di figure piccole de' fatti di Santa Elena, molto graziose, le quali lo ridussono in maniera, che venuto come abbiàn detto Girolamo Genga a dipignere la cappella di
S. Francesco di Furlì per Messer Bartolomeo Lombardino, andò Francesco allora a star col Genga e da quella comodità d'imparare; e non restò di servirlo mentre che visse; dove, et a Urbino et a Pesero nell'opera dell'Imperiale, lavorò come s'è detto continuamente, stimato et amato dal Genga, perché si portava benissimo come ne fa fede molte tavole di sua mano in Furlì, sparse per quella città e particolarmente tre, che ne sono in San Francesco, oltre che in palazzo nella sala v'è alcune storie a fresco di suo.
Dipinse per la Romagna molte opere; lavorò ancora in Vinezia per il reverendissimo patriarca Grimani quattro quadri grandi a olio posti in un palco d'un salotto in casa sua, attorno a uno ottangolo che fece Francesco Salviati, ne' quali sono le storie di Psiche tenuti molto belli. Ma dove egli si sforzò di fare ogni diligenza e poter suo, fu nella chiesa di Loreto, alla cappella del Santissimo Sagramento, nella quale fece intorno a un tabernacolo di marmo, dove sta il corpo di Cristo, alcuni Angeli e nelle facciate di detta cappella dua storie, una di Melchisedec, l'altra quando piove la manna, lavorate a fresco, e nella volta spartì con varii ornamenti di stucco quindici storiette della Passione di Gesù Cristo, che ne fé di pittura nove, e sei ne fece di mezzo rilievo, cosa ricca e bene intesa, e ne riportò tale onore, che non si partì altrimenti che nel medesimo luogo fece una altra cappella della medesima grandezza di rincontro a quella intitolata nella Concezione, con la volta tutta di bellissimi stucchi, con ricco lavoro, nella quale insegnò a Pietro Paulo suo figliuolo a lavorargli, che gli ha poi fatto onore e di quel mestiero è diventato pratichissimo. Francesco adunque nella facciate fece a fresco la natività e la presentazione di Nostra Donna, e sopra lo altare fece Santa Anna e la Vergine con Figliuolo in collo e dua Angeli che l'ancoronano, e nel vero l'opere sue sono lodate dagl'artefici e parimente i costumi e la vita sua; molto cristianamente è vissuto con quiete, godutosi quel ch'egli ha provisto con le sue fatiche. Fu ancora creato del Genga Baldassarri Lancia da Urbino, il quale avendo egli atteso a molte cose d'ingegno, s'è poi essercitato nelle fortificazioni, dove e per la Signoria di Lucca provisionato da loro, nel qual luogo sté alcun tempo, e poi è coll'illustrissimo duca Cosimo de' Medici venuto a servirlo nelle sue fortificazioni dello stato di Fiorenza e di Siena, e l'ha adoperato et adopera a molte cose ingegnose, et affaticatosi onoratamente e virtuosamente Baldassarri, dove n'ha riportato grate remunerazioni da quel signore. Molti altri servirono Girolamo Genga, de' quali per non essere venuti in molta grande eccellenza, non iscade ragionarne.
Di Girolamo sopra detto essendo nato in Cesana l'anno 1518 Bartolomeo mentre che il padre seguitava nell'esilio il Duca suo signore, fu da lui molto costumatamente allevato e posto poi, essendo già fatto grandicello, ad apprendere gramatica, nella quale fece più che mediocre profitto. Dopo, essendo all'età di 18 anni pervenuto, vedendolo il padre più inclinato al disegno che alle lettere, lo fece attendere al disegno appresso di sé circa due anni, i quali finiti lo mandò a studiare il disegno e la pittura a Fiorenza, là dove sapeva che è il vero studio di quest'arte per l'infinite opere che vi sono di maestri eccellenti così antichi come moderni. Nel qual luogo dimorando Bartolomeo et attendendo al disegno et all'architettura fece amicizia con Giorgio Vasari pittore et architetto aretino e con Bartolomeo Amannati scultore, da' quali imparò molte cose appartenenti all'arte. Finalmente, essendo stato tre anni in Fiorenza, tornò al padre che allora attendeva in Pesaro alla fabrica di S. Giovanni Battista, là dove il padre, veduti i disegni di Bartolomeo, gli parve che si portasse molto meglio nell'architettura che nella pittura, [e] che vi avesse molto buona inclinazione; per che, trattenendolo appresso di sé alcuni mesi, gl'insegnò i modi della prospettiva, e dopo lo mandò a Roma, acciò che là vedesse le mirabili fabriche che vi sono antiche e moderne, delle quali tutte in quattro anni che vi stette, prese le misure e vi fece grandissimo frutto. Nel tornarsene poi a Urbino, passando per Firenze per vedere Francesco San Marino suo cognato, il quale stava per ingegnero col signor duca Cosimo, il signor Stefano Colonna da Palestina, allora generale di quel signo-re, cercò, avendo inteso il suo valore, di tenerlo appresso di sé con buona provisione, ma egli, che era molto ubligato al duca d'Urbino, non volle mettersi con altri. Ma tornato a Urbino, fu da quel Duca ricevuto al suo servizio e poi sempre avuto molto caro, né molto dopo, avendo quel Duca presa per donna la signora Vettoria Farnese, Bartolomeo ebbe carico dal Duca di fare gl'apparati di quelle nozze, i quali egli fece veramente magnifici et onorati. E fra l'altre cose fece un arco trionfale nel borgo di Valbuona tanto bello e ben fatto, che non si può vedere né il più bello, né il maggiore, onde fu conosciuto quanto nelle cose d'architettura avesse acquistato in Roma. Dovendo poi il Duca, come generale della Signoria di Vinezia, andare in Lombardia a rivedere le fortezze di quel dominio, menò seco Bartolomeo, del quale si servì molto in fare siti e disegni di fortezze e particolarmente in Verona, alla porta S. Felice. Ora, mentre che era in Lombardia, passando per quella provincia il re di Boemia che tornava di Spagna al suo regno, et essendo dal Duca onorevolmente ricevuto in Verona, vide quelle fortezze, e perché gli piacquero, avuta cognizione di Bartolomeo lo volle condurre al suo regno per servirsene con buona provisione in fortificare le sue terre, ma non volendogli dare il Duca licenza, la cosa non ebbe altrimenti effetto. Tornati poi a Urbino, non passò molto che Girolamo, suo padre, venne a morte; onde Bartolomeo fu dal Duca messo in luogo del padre sopra tutte le fabriche dello stato e mandato a Pesero, dove seguitò la fabrica di S. Giovanni Battista col modello di Girolamo. Et in quel mentre fece nella corte di Pesero un apartamento di stanze sopra la strada de' Mercanti, dove ora abita il Duca, molto bello, con bellissimi ornamenti di porte, di scale e di camini, delle qual cose fu eccellente architetto; il che avendo veduto il Duca volle che anco nella corte d'Urbino facesse un altro appartamento di camere, quasi tutto nella facciata che è volta verso San Domenico, il quale finito riuscì il più bello alloggiamento di quella corte, o vero palazzo, et il più ornato che vi sia.
Non molto dopo, avendolo chiesto i signori bolognesi per alcuni giorni al Duca, sua eccellenza lo concedette loro molto volentieri, et egli andato, gli servì in quello volevano di maniera che restarono sodisfattissimi et a lui fecero infinite cortesie. Avendo poi fatto al Duca, che disiderava di fare un porto di mare a Pesero, un modello bellissimo, fu por-tato a Vinezia in casa il conte Giovan Iacomo Leonardi, allora ambasciadore in quel luogo del Duca, acciò fusse veduto da molti della professione, che si riducevano spesso con altri begl'ingegni a disputare e far discorsi sopra diverse cose in casa il detto conte, che fu veramente uomo rarissimo. Quivi dunque essendo veduto il detto modello et uditi i bei discorsi del Genga, fu da tutti senza contrasto tenuto il modello artifizioso e bello et il maestro che l'aveva fatto di rarissimo ingegno. Ma tornato a Pesero non fu messo il modello altrimenti in opera perché nuove occasioni di molta importanza levarono quel pensiero al Duca.
Fece in quel tempo il Genga il disegno della chiesa di Monte l'Abbate e quello della chiesa di S. Piero in Mondavio, che fu condotta a fine da don Pier Antonio Genga in modo che per cosa piccola non credo si possa veder meglio. Fatte queste cose, non passò molto che essendo creato papa Giulio Terzo e da lui fatto il duca d'Urbino capitan generale di Santa Chiesa, andò sua eccellenza a Roma e con essa il Genga, dove volendo Sua Santità fortificar borgo, fece il Genga a richiesta del Duca alcuni disegni bellissimi che con altri assai sono appresso di sua eccellenza in Urbino. Per le quali cose divolgandosi la fama di Bartolomeo, i genovesi, mentre che egli dimorava col Duca in Roma, glielo chiesero per servirsene in alcune loro fortificazioni, ma il Duca non lo volle mai concedere loro, né allora, né altra volta che di nuovo ne lo ricercarono, essendo tornato a Urbino.
All'ultimo, essendo vicino il termine di sua vita, furono mandati a Pesero dal gran mastro di Rodi due cavalieri della loro Religione ierosolimitana a pregare sua eccellenza che volesse concedere loro Bartolomeo, acciò lo potessero condurre nell'isola di Malta, nella quale volevano fare non pure fortificazioni grandissime, per potere difendersi da' Turchi, ma anche due città, per ridurre molti villaggi che vi erano in uno o due luoghi; onde il Duca, il quale non avevano in due mesi potuto piegare i detti cavalieri a voler compiacere loro del detto Bartolomeo, ancor che si fussero serviti del mezzo della Duchessa e d'altri, ne gli compiacque finalmente per alcun tempo determinato a preghiera d'un buon padre capuccino, al quale sua eccellenza portava grandissima affezzione e non negava cosa che volesse; e l'arte che usò quel sant'uomo, il quale di ciò fece coscienza al Duca, essendo quello interesse della repubblica cristiana, non fu se non da molto lodare e comendare. Bartolomeo adunque, il quale non ebbe mai di questa la maggior grazia, si partì con in detti cavalieri di Pesero a dì 20 di genaio 1558, ma trattenendosi in Sicilia, dalla fortuna del mar impediti, non giunsero a Malta se non a undici di marzo, dove furono lietamente raccolti dal gran mastro. Essendogli poi mostrato quello che egli avesse da fare, si portò tanto bene in quelle fortificazioni, che più non si può dire, in tanto che al gran mastro e tutto que' signori cavalieri pareva d'avere avuto un altro Archimede, e ne fecero fede con fargli presenti onoratissimi e tenerlo, come raro, in somma venerazione. Avendo poi fatto il modello d'una città, d'alcune chiese e del palazzo e residenza di detto gran mastro, con bellissime invenzioni et ordine, si amalò dell'ultimo male, perciò che, essendosi messo un giorno del mese di luglio, per essere in quell'isola grandissimi caldi, a pigliar fresco fra due porte, non vi stette molto che fu assalito da insoportabili dolori di corpo e da un flusso crudele che in diciassette giorni l'uccisero con grandissimo dispiacere del gran mastro e di tutti quegl'onoratissimi e valorosi cavalieri ai quali pareva aver trovato un uomo secondo il loro cuore, quando gli fu dalla morte rapito. Della quale trista novella essendo avvisato il signor duca d'Ur-bino, n'ebbe incredibile dispiacere e pianse la morte del povero Genga; e poi risoltosi a dimostrare l'amore che gli portava a' cinque figliuoli che di lui erano rimasi, ne prese particolare et amorevole protezzione. Fu Bartolomeo bellissimo inventore di mascherate e rarissimo in fare apparati di commedie e scene; dilettossi di fare sonetti et altri componimenti di rime e di prose, ma niuno meglio gli riusciva che l'ottava rima, nella qual maniera di scrivere fu assai lodato componitore. Morì d'anni quaranta, nel 1558.
Essendo stato Giovambatista Bellucci da San Marino genero di Girolamo Genga, ho giudicato che sia ben fatto non tacere quello che io debbo di lui dire, dopo le vite di Girolamo e Bartolomeo Genghi, e massimamente per mostrare che [ai] belli ingegni (solo che vogliano) riesce ogni cosa, ancora che tardi si mettono ad imprese difficili et onorate, imperò che si è veduto avere lo studio, aggiunto all'inclinazioni di natura, aver molte volte cose maravigliose adoperato. Nacque adunque Giovambatista in San Marino a dì 27 di settembre 1506 di Bartolomeo Bellucci, persona in quella terra assai nobile, et imparato che ebbe le prime lettere d'umanità, essendo d'anni diciotto, fu dal detto Bartolomeo suo padre mandato a Bologna ad attendere alle cose della mercatura appresso Bastiano di Ronco, mercante d'arte di lana, do-ve, essendo stato circa due anni, se ne tornò a San Marino amalato d'una quartana che gli durò due anni. Dalla quale finalmente guarito, ricominciò da sé un'arte di lana, la quale andò continuando infino all'anno 1535. Nel qual tempo vedendo il padre Giovambatista bene avviato, gli diede moglie in Cagli una figliuola di Guido Peruzzi, persona assai ono-rata in quella città; ma essendosi ella non molto dopo morta, Giovambatista andò a Roma a trovare Domenico Peruzzi suo cognato, il quale era cavalerizzo del signor Ascanio Colonna. Col qual mezzo, essendo stato Giovambatista appresso quel signore due anni come gentiluomo, se ne tornò a casa; onde avvenne che, praticando a Pesero Girolamo Genga, conosciutolo virtuoso e costumato giovane, gli diede una figliuola per moglie e se lo tirò in casa. Laonde, essendo Giovambatista molto inclinato all'architettura et attendendo con molta diligenza a quell'opere che di essa faceva il suo suocero, cominciò a possedere molto bene le maniere del fabricare et a studiare Vetruvio, onde a poco a poco, fra quello che acquistato da se stesso e che gl'insegnò il Genga, si fece buono architettore e massimamente nelle cose delle fortificazioni et altre cose appartenenti alla guerra. Essendogli poi morta la moglie l'anno 1541 e lasciatogli due figliuoli, si stette insino al 1543 senza pigliare di sé altro partito, nel qual tempo capitando del mese di settembre a San Marino un signor Gustamante spagnuolo, mandato dalla maestà cesarea a quella repubblica per alcuni negozii, fu Giovambatista da colui conosciuto per eccellente architetto, onde per mezzo del medesimo venne non molto dopo al servizio dell'illu-strissimo signor duca Cosimo per ingegneri, e così giunto a Fiorenza se ne servì sua eccellenza in tutte le fortificazioni del suo dominio, secondo i bisogni che giornalmente accadevano. E fra l'altre cose, essendo stata molti anni innanzi cominciata la fortezza della città di Pistoia, il San Marino, come volle il Duca, la finì del tutto con molta sua lode, ancor che non sia cosa molto grande. Si murò poi, con ordine del medesimo, un molto forte baluardo a Pisa. Per che, piacendo il modo del fare di costui al Duca, gli fece fare, dove si era murato come s'è detto al poggio di San Miniato, fuor di Fiorenza, il muro che gira dalla porta San Niccolò alla porta San Miniato, la Forbiciaia che mette con due baluardi una porta in mezzo e serra la chiesa e monasterio di San Miniato, facendo nella sommità di quel monte una fortezza che domina tutta la città e guarda il difuori di verso levante e mezzogiorno; la quale opera fu lodata infinitamente.
Fece il medesimo molti disegni e piante per luoghi dello stato di sua eccellenza per diverse fortificazioni, e così di-verse bozze di terra e modelli che sono appresso il signor Duca. E perciò che era il San Marino di bello ingegno e molto studioso, scrisse un'operetta del modo di fortificare, la quale opera, che è bella et utile, è oggi appresso Messer Bernardo Puccini gentiluomo fiorentino, il quale imparò molte cose d'intorno alle cose d'architettura e fortificazione da esso San Marino suo amicissimo.
Avendo poi Giovambatista l'anno 1554 disegnato molti baluardi da farsi intorno alle mura della città di Fiorenza, alcuni de' quali furono cominciati di terra, andò con l'illustrissimo signor don Grazia di Tolledo a Mont'Alcino dove, fatte alcune trincee, entrò sotto un baluardo e lo ruppe di sorte che gli levò il parapetto, ma nell'andare quello a terra toccò il San Marino un'archibusata in una coscia. Non molto dopo, essendo guarito, andato segretamente a Siena, levò la pianta di quella città e della fortificazione di terra che i sanesi avevano fatto a porta Camolia, la qual pianta di fortificazione mostrando egli poi al signor Duca et al marchese di Marignano, fece loro toccar con mano che ella non era difficile a pigliarsi né a serrarla poi dalla banda di verso Siena; il che esser vero dimostrò il fatto la notte ch'ella fu presa dal detto Marchese, col quale era andato Giovambatista, d'ordine e commessione del Duca. Perciò dunque, avendogli posto amore il Marchese e conoscendo aver bisogno del suo giudizio e virtù in campo, cioè nella guerra di Siena, operò di maniera col Duca, che sua eccellenza lo spedì capitano d'una grossa compagnia di fanti, onde servì da indi in poi in campo come soldato di valore et ingegnoso architetto. Finalmente essendo mandato dal Marchese all'Aiuola, fortezza nel Chianti, nel piantare l'artiglieria fu ferito d'una archibusata nella testa. Per che, essendo portato dai soldati alla pieve di San Polo del vescovo da Ricasoli, in pochi giorni si morì e fu portato a San Marino, dove ebbe dai figliuoli onorata sepoltura. Merita Giovambatista di essere molto lodato, perciò che oltre all'essere stato eccellente nella sua professione, è cosa maravigliosa che, essendosi messo a dare opera a quella tardi, cioè d'anni trentacinque, egli vi facessi il profitto che fece, e si può credere, se avesse cominciato più giovane, che sarebbe stato rarissimo. Fu Giovambatista alquanto di sua testa, onde era dura impresa voler levarlo di sua openione; si dilettò fuor di modo di leggere storie e ne faceva grandissimo capitale, scrivendo con sua molta fatica le cose di quelle più notabili. Dolse molto la sua morte al Duca et ad infiniti amici suoi, onde venendo a baciar le mani a sua eccellenza Giannandrea suo figliuolo, fu da lei benignamente raccolto e veduto molto volentieri, e con grandissime offerte per la virtù e fedeltà del padre, il quale morì d'anni quarantotto.
VITA DI MICHELE SAN MICHELE
ARCHITETTORE VERONESE

Essendo Michele San Michele nato l'anno 1484 in Verona et avendo imparato i primi principii dell'architettura da Giovanni suo padre e da Bartolomeo suo zio, ambi architettori eccellenti, se n'andò di sedici anni a Roma, lasciando il padre e due suoi fratelli di bell'ingegno, l'uno de' quali, che fu chiamato Iacomo, attese alle lettere e l'altro, detto don Camillo, fu canonico regolare e generale di quell'Ordine; e giunto quivi studiò di maniera le cose d'architettura antiche e con tanta diligenza, misurando e considerando minutamente ogni cosa, che in poco tempo divenne, non pure in Roma, ma per tutti i luoghi che sono all'intorno, nominato e famoso. Dalla quale fama mossi, lo condussero gl'orvietani con onorati stipendi per architettore di quel loro tanto nominato tempio. In servigio de' quali mentre si adoperava, fu per la medesima cagione condotto a Monte Fiascone, cioè per la fabrica del loro tempio principale, e così servendo all'uno e l'altro di questi luoghi, fece quanto si vede in quelle due città di buona architettura. Et noltre all'altre cose in San Domenico di Orvieto fu fatta con suo disegno una bellissima sepoltura, credo per uno de' Petrucci nobile sanese, la quale costò grossa somma di danari e riuscì maravigliosa. Fece oltre ciò ne' detti luoghi infinito numero di disegni per case private e si fece conoscere per di molto giudizio et eccellente, onde papa Clemente pontefice Settimo, disegnando servirsi di lui nelle cose importantissime di guerra che allora bollivano per tutta Italia, lo diede con bonissima provisione per compagno ad Antonio San Gallo, acciò insieme andassero a vedere tutti i luoghi di più importanza dello stato ecclesiastico e dove fusse bisogno dessero ordine di fortificare, ma sopra tutte Parma e Piacenza, per essere quelle due città più lontane da Roma e più vicine et esposte ai pericoli delle guerre. La qual cosa avendo essequito Michele et Antonio con molta sodisfazione del Pontefice, venne disiderio a Michele dopo tanti anni di rivedere la patria et i parenti e gl'a-mici, ma molto più le fortezze de' viniziani. Poi dunque che fu stato alcuni giorni in Verona, andando a Trevisi per vedere quella fortezza e di lì a Padova pel medesimo conto, furono di ciò avvertiti i signori viniziani e messi in sospetto non forse il San Michele andasse a loro danno rivedendo quelle fortezze. Per che, essendo di loro commessione stato preso in Padova e messo in carcere, fu lungamente essaminato, ma trovandosi lui essere uomo da bene, fu da loro non pure liberato, ma pregato che volesse con onorata provisione e grado andare al servigio di detti signori viniziani. Ma scusandosi egli di non potere per allora ciò fare, per essere ubligato a Sua Santità, diede buone promesse e si partì da loro; ma non istette molto (in guisa, per averlo, adoperarono detti signori) che fu forzato a partirsi da Roma e con buona grazia del Pontefice, al qual prima in tutto sodisfece, andare a servire i detti illustrissimi signori suoi naturali. Appresso de' quali dimorando, diede assai tosto saggio del giudizio e saper suo nel fare in Verona, dopo molte difficultà che parea che avesse l'opera, un bellissimo e fortissimo bastione, che infinitamente piacque a quei signori et al signor duca d'Urbino loro capitano generale. Dopo le quali cose avendo i medesimi deliberato di fortificare Lignago e Porto, luoghi importantissimi al loro dominio e posti sopra il fiume dell'Adice, cioè uno da uno e l'altro dall'altro lato, ma congiunti da un ponte, comisero al San Michele che dovesse mostrare loro, mediante un modello, come a lui pareva che si potessero e dovessero detti luoghi fortificare. Il che essendo da lui stato fatto, piacque infinitamente il suo disegno a que' signori et al duca d'Urbino. Per che, dato ordine di quanto s'avesse a fare, condusse il San Michele le fortificazioni di que' due luoghi di maniera, che per simil opera non si può veder meglio, né più bella, né più considerata, né più forte, come ben sa chi l'ha veduta. Ciò fatto, fortificò nel bresciano, quasi da' fondamenti, Orzinuovo, castello e porto simile a Legnago. Essendo poi con molta instanza chiesto il San Michele dal signor Francesco Sforza ultimo duca di Milano, furo-no contenti que' signori dargli licenza, ma per tre mesi soli; laonde, andato a Milano, vide tutte le fortezze di quello stato et ordinò in ciascun luogo quanto gli parve che si dovesse fare, e ciò con tanta sua lode e sodisfazione del Duca, che quel signore oltre al ringraziarne i signori viniziani, donò cinquecento scudi al San Michele, il quale con quella occasione, prima che tornasse a Vinezia, andò a Casale di Monferrato per vedere quella bella e fortissima città e castello, stati fatti per opera e con l'architettura di Matteo San Michele, eccellente architetto e suo cugino, et una onorata e bellissima sepoltura di marmo fatta in San Francesco della medesima città pur con ordine di Matteo. Dopo tornatosene a casa non fu sì tosto giunto che fu mandato col detto signor duca d'Urbino a vedere la Chiusa, fortezza e passo molto importante sopra Verona, e dopo tutti i luoghi del Friuli, Bergamo, Vicenza, Peschera et altri luoghi, de' quali tutti e di quanto gli parve bisognasse, diede ai suoi signori in iscritto minutamente notizia. Mandato poi dai medesimi in Dalmazia per fortificare le città e luoghi di quella provincia, vide ogni cosa e restaurò con molta diligenza dove vide il bisogno esser maggiore, e perché non potette egli spedirsi del tutto vi lasciò Gian Girolamo suo nipote, il quale avendo ottimamente fortificata Zara, fece dai fondamenti la maravigliosa fortezza di San Niccolò, sopra la bocca del porto di Sebenico. Michele in tanto, essendo stato con molta fretta mandato a Corfù, ristaurò in molti luoghi quella fortezza et il simigliante fece in tutti i luoghi di Cipri e di Candia, se bene indi a non molto gli fu forza, temendosi di non perdere quell'isola per le guerre turchesche che soprastavano, tornarvi, dopo avere rivedute in Italia le fortezze del dominio vinisiano, a fortificare con incredibile prestezza la Cania, Candia, Retimo e Settia, ma particolarmente la Cania e Candia, la quale riedificò dai fondamenti e fece inespugnabile. Essendo poi assediata dal turco Napoli di Romania, fra per diligenza del San Michele in fortificarla e bastionarla et il valore d'Agostino Clusoni veronese, capitano valorosissimo, in difenderla con l'arme, non fu altrimenti presa dai nemici, né superata; le quali guerre finite, andato che fu il San Michele col Magnifico Messer Tomaso Monzenigo, capitan generale di mare, a fortificare di nuovo Corfù, tornarono a Sebenico, dove molto fu comendata la diligenza di Giangirolamo, usata nel fare la detta fortezza di San Niccolò. Ritornato poi il San Michele a Vinezia, dove fu molto lodato per l'opere fatte in levante in servigio di quella republica, deliberarono di fare una fortezza sopra il Lito, cioè alla bocca del porto di Vinezia. Per che, dandone cura al San Michele, gli dissero che se tanto aveva operato lontano di Vinezia, che egli pensasse quanto era suo debito di fare in cosa di tanta importanza e che in eterno aveva da essere in su gl'occhi del senato e di tanti signori; e che oltre ciò si aspettava da lui, oltre alla bellezza e fortezza dell'opera, singolare industria nel fondare sì veramente in luogo paludoso, fasciato d'ogni intorno dal mare e bersaglio de' flussi e riflussi, una machina di tanta importanza. Avendo dunque il San Michele non pure fatto un bellissimo e sicurissimo modello, ma anco pensato il modo da porlo in effetto e fondarlo, gli fu commesso che senz'indugio si mettesse mano a lavorare, onde egli, avendo avuto da que' signori tutto quello che bisognava e preparata la materia e ripieno de' fondamenti e fatto oltre ciò molti pali ficcati con doppio ordine, si mise con grandissimo numero di persone perite in quell'acque a fare le cavazioni et a fare che con trombe et altri instrumenti si tenessero ca-vate l'acque che si vedevano sempre di sotto risorgere per essere il luogo in mare. Una mattina poi, per fare ogni sforzo di dar principio al fondare, avendo quanti uomini a ciò atti si potettono avere e tutti i facchini di Vinezia e presenti molti de' signori, in un sùbito con prestezza e sollecitudine incredibile si vinsero per un poco l'acque di maniera, che in un tratto si gettarono le prime pietre de' fondamenti sopra le palificcate fatte, le quali pietre essendo grandissime pigliarono gran spazio e fecero ottimo fondamento; e così continuandosi senza perder tempo a tenere l'acque cavate, si fecero qua-si in un punto que' fondamenti contra l'openione di molti che avevano quella per opera del tutto impossibile. I quali fondamenti fatti, poi che furono lasciati riposare abastanza, edificò Michele sopra quelli una terribile fortezza e maravigliosa, murandola tutta di fuori alla rustica con grandissime pietre d'Istria, che sono d'estrema durezza e reggono ai ven-ti, al gielo et a tutti i cattivi tempi, onde la detta fortezza, oltre all'essere maravigliosa rispetto al sito nel quale è edificata, è anco, per bellezza di muraglia e per la incredibile spesa, delle più stupende che oggi siano in Europa e rappresenta la maestà e grandezza delle più famose fabriche fatte dalla grandezza de' romani. Imperò che oltre all'altre cose, ella pare tutta fatta d'un sasso e che intagliatosi un monte di pietra viva, se gli sia data quella forma, cotanto sono grandi i massi di che è murata e tanto bene uniti e commessi insieme, per non dire nulla degl'altri ornamenti, né dell'altre cose che vi sono, essendo che non mai se ne potrebbe dir tanto che bastasse. Dentro poi vi fece Michele una piazza con partimenti di pilastri et archi d'ordine rustico, che sarebbe riuscita cosa rarissima se non fusse rimasa imperfetta. Essendo questa grandissima machina condotta al termine che si è detto, alcuni maligni et invidiosi dissero alla Signoria che ancor che ella fusse bellissima e fatta con tutte le considerazioni, ella sarebbe nondimeno in ogni bisogno inutile e forse anco dannosa; perciò che nello scaricare dell'artiglieria, per la gran quantità e di quella grossezza che il luogo richiedeva, non poteva quasi essere che non s'aprisse tutta e rovinasse. Onde, parendo alla prudenza di que' signori che fusse ben fatto di ciò chiarirsi, come di cosa che molto importava, fecero condurvi grandissima quantità d'artiglieria e delle più smisurate che fussero nell'arsenale, et empiute tutte le canoniere di sotto e di sopra e caricatole anco più che l'ordi-nario, furono scaricate tutte in un tempo; onde fu tanto il rumore, il tuono et il terremoto che si sentì, che parve che fusse rovinato il mondo, e la fortezza con tanti fuochi pareva un Mongibello et un inferno, ma non per tanto, rimase la fabrica nella sua medesima sodezza e stabilità, il senato chiarissimo del molto valore del San Michele, et i maligni scornati e senza giudizio, i quali avevano tanta paura messa in ognuno, che le gentildonne gravide, temendo di qualche gran cosa, s'erano allontanate da Vinezia.
Non molto dopo, essendo ritornato sotto il dominio viniziano un luogo detto Marano di non piccola importanza ne' liti vicini a Vinezia, fu rassettato e fortificato con ordine del San Michele con prestezza e diligenza. E quasi ne' medesimi tempi, divolgandosi tuttavia più la fama di Michele e di Giovan Girolamo suo nipote, furono ricerchi più volte l'u-no e l'altro d'andare a stare con l'imperatore Carlo Quinto e con Francesco re di Francia, ma eglino non vollono mai, anco che fussero chiamati con onoratissime condizioni, lasciare i loro proprii signori per andare a servire gli stranieri, anzi, continuando nel loro uffizio, andavano rivedendo ogni anno e rassettando dove bisognava tutte le città e fortezze dello stato viniziano. Ma più di tutti gl'altri fortificò Michele et adornò la sua patria Verona: facendovi, oltre all'altre cose, quelle bellissime porte della città che non hanno in altro luogo pari: cioè la Porta Nuova, tutta di opera dorica rustica, la quale nella sua sodezza e nell'essere gagliarda e massiccia corrisponde alla fortezza del luogo, essendo tutta murata di tufo e pietra viva, et avendo dentro stanze per i soldati che stanno alla guardia et altri molti commodi, non più stati fatti in simile maniera di fabriche. Questo edifizio, che è quadro e di sopra scoperto e con le sue canoniere, servendo per cavaliere difende due gran bastioni, o vero torrioni, che con proporzionata distanza tengono nel mezzo la porta; et il tutto è fatto con tanto giudizio, spesa e magnificenza, che niuno pensava potersi fare per l'avenire, come non si era veduto per l'adietro, già mai altr'opera di maggior grandezza né meglio intesa, quando di lì a pochi anni il medesimo San Michele fondò e tirò in alto la porta detta volgarmente dal Palio, la quale non è punto inferiore alla già detta, ma anch'ella parimente o più bella, grande, maravigliosa et intesa ottimamente. E di vero in queste due porte si vede i signori viniziani, mediante l'ingegno di questo architetto, avere pareggiato gl'edifizii e fabriche degl'antichi romani. Que-sta ultima porta adunque è dalla parte di fuori d'ordine dorico, con colonne smisurate che risaltano, striate tutte secondo l'uso di quell'ordine, le quali colonne dico, che sono otto in tutto, sono poste a due a due: quattro tengono la porta in mezzo con l'arme de' rettori della città, fra l'una e l'altra da ogni parte, e l'altre quattro similmente a due a due, fanno finimento negl'angoli della porta, la quale è di facciata larghissima e tutta di bozze, o vero bugne, non rozze ma pulite e con bellissimi ornamenti; et il foro, o vero vano della porta, riman quadro, ma l'architettura nuova, bizzarra e bellissima. Sopra è un cornicione dorico ricchissimo con sue apartenenze, sopra cui doveva andare, come si vede nel modello, un frontespizio con suoi fornimenti, il quale faceva parapetto all'artiglieria, dovendo questa porta, come l'altra, servire per cavaliero. Dentro poi sono stanze grandissime per i soldati con altri commodi et appartamenti. Dalla banda che è volta verso la città, vi fece il San Michele una bellissima loggia, tutta di fuori d'ordine dorico e rustico e di dentro tutta lavorata alla rustica, con pilastri grandissimi, che hanno per ornamento colonne di fuori tonde e dentro quadre e con mezzo risalto, lavorate di pezzi alla rustica e con capitelli dorici senza base, e nella cima un cornicione pur dorico et intagliato che gira tutta la loggia, che è lunghissima, dentro e fuori. Insomma quest'opera è maravigliosa, onde ben disse il vero l'illustrissimo signor Sforza Pallavicino, governatore generale degl'esserciti viniziani, quando disse non potersi in Europa trovare fabrica alcuna che a questa possa in niun modo aguagliarsi; la quale fu l'ultimo miracolo di Michele, imperò che, avendo a pena fatto tutto questo primo ordine descritto, finì il corso di sua vita. Onde rimase imperfetta quest'opera, che non si finirà mai altrimenti, non mancando alcuni maligni (come quasi sempre nelle gran cose adiviene) che la biasimano, sforzandosi di sminuire l'altrui lodi con la malignità e maladicenza, poi che non possono con l'in-gegno pari cose a gran pezzo operare.
Fece il medesimo un'altra porta in Verona, detta di San Zeno, la quale è bellissima, anzi in ogni altro luogo sarebbe maravigliosa, ma in Verona è la sua bellezza et artifizio dall'altre due sopra dette offuscata. È similmente opera di Michele il bastione, o vero baluardo, che è vicino a questa porta, e similmente quello che è più a basso riscontro a S. Bernardino, et un altro mezzo che è riscontro al Campo Marzio, detto dell'Acquaio, e quello che di grandezza avanza tutti gl'altri, il quale è posto alla catena dove l'Adice entra nella città. Fece in Padova il bastione detto il Cornaro e quello parimente di Santa Croce, i quali amendue sono di maravigliosa grandezza e fabricati alla moderna, secondo l'ordine stato trovato da lui. Imperò che il modo di fare i bastioni a cantoni fu invenzione di Michele, per ciò che prima si facevano tondi. E dove quella sorte di bastioni erano molto difficili a guardarsi, oggi, avendo questi dalla parte di fuori un angolo ottuso, possono facilmente esser diffesi, o dal cavaliero edificato vicino fra due bastioni, o vero dall'altro bastione se sarà vicino e la fossa larga. Fu anco sua invenzione il modo di fare i bastioni con le tre piazze, però che le due dalle bande guardano e difendono la fossa e le cortine con le canoniere aperte et il molone del mezzo si difende et offende il nemico dinanzi. Il qual modo di fare è poi stato imitato da ognuno e si è lasciata quell'usanza antica delle canoniere sotterranee, chiamate case matte, nelle quali, per il fumo et altri impedimenti, non si potevano maneggiare l'arti-glierie, senzaché indebolivano molte volte il fondamento de' torrioni e delle muraglie. Fece il medesimo due molto belle porte a Legnago, fece lavorare in Peschiera nel primo fondare di quella fortezza e similmente molte cose in Brescia. E tutto fece sempre con tanta diligenza e con sì buon fondamento, che niuna delle sue fabriche mostrò mai un pelo. Ultimamente rassettò la fortezza della Chiusa sopra Verona, facendo commodo ai passeggeri di passare senza entrare per la fortezza, ma in tal modo però che levandosi un ponte da coloro che sono di dentro, non può passare contra lor voglia nessuno, né anco appresentarsi alla strada che è strettissima e tagliata nel sasso. Fece parimente in Verona, quando prima tornò da Roma, il bellissimo ponte sopra l'Adice, detto il Ponte nuovo, che gli fu fatto fare da Messer Giovanni Emo allora podestà di quella città, che fu ed è cosa maravigliosa per la sua gagliardezza.
Fu eccellente Michele non pure nelle fortificazioni, ma ancora nelle fabriche private, ne' tempii, chiese e monasterii, come si può vedere in Verona et altrove in molte fabriche, particolarmente nella bellissima et ornatissima cappella de' Guareschi in San Bernardino, fatta tonda a uso di tempio e d'ordine corinzio, con tutti quegli ornamenti di che è capace quella maniera. La quale cappella, dico, fece tutta di quella pietra viva e bianca che per lo suono che rende quando si lavora è in quella città chiamata bronzo, e nel vero questa è la più bella sorte di pietra che dopo il marmo fino sia stata trovata insino a' tempi nostri, essendo tutta soda e senza buchi o macchie che la guastino. Per essere adunque di dentro la detta cappella di questa bellissima pietra e lavorata da eccellenti maestri d'intaglio e benissimo commessa, si tiene che per opera simile non sia oggi altra più bella in Italia, avendo fatto Michele girare tutta l'opera tonda in tal modo, che tre altari che vi sono dentro con i loro frontespizii e cornici, e similmente il vano della porta, tutti girano a tondo perfetto, quasi a somiglianza degl'usci che Filippo Brunelleschi fece nelle cappelle del tempio degl'Angeli in Firenze, il che è cosa molto difficile a fare. Vi fece poi Michele dentro un ballatoio sopra il primo ordine che gira tutta la cappella, dove si veggiono bellissimi intagli di colonne, capitelli, fogliami, grottesche, pilastrelli et altri lavori intagliati con incredibile diligenza. La porta di questa cappella fece di fuori quadra, corinzia, bellissima e simile ad una antica che egli vide in un luogo, secondo che egli diceva, di Roma. Ben è vero che essendo quest'opera stata lasciata imperfetta da Michele, non so per qual cagione, ella fu o per avarizia, o per giudizio fatta finire a certi altri che la guastarono, con infinito dispiacere di esso Michele, che vivendo se la vide storpiare in su gl'occhi senza potervi riparare. Onde alcuna volta si doleva con gl'amici solo per questo, di non avere migliaia di ducati per comperarla dall'avarizia d'una donna, che per spendere men che poteva vilmente la guastava. Fu opera di Michele il disegno del tempio ritondo della Madonna di Campagna vicino a Verona, che fu bellissimo, ancor che la miseria, debolezza e pochissimo giudizio dei deputati sopra quella fabrica l'abbiano poi in molti luoghi storpiata, e peggio averebbono fatto, se non avesse avutone cura Bernardino Brugnuoli, parente di Michele, e fattone un compiuto modello, col quale va oggi inanzi la fabrica di questo tempio e molte altre. Ai frati di Santa Maria in Organa, anzi monaci di Monte Oliveto in Verona, fece un disegno che fu bellissimo del-la facciata della loro chiesa di ordine corinzio, la quale facciata essendo stata tirata un pezzo in alto da Paulo San Michele, si rimase, non ha molto, a quel modo, per molte spese che furono fatte da que' monaci in altre cose, ma molto più per la morte di don Cipriano veronese, uomo di santa vita e di molta autorità in quella Religione, della quale fu due vol-te generale, il quale l'aveva cominciata. Fece anco il medesimo in San Giorgio di Verona, convento de' preti regolari di San Giorgio in Alega, murare la cupola di quella chiesa, che fu opera bellissima e riuscì contra l'openione di molti, i quali non pensarono che mai quella fabrica dovesse reggersi in piedi per la debolezza delle spalle che avea: le quali poi furono in guisa da Michele fortificate, che non si ha più di che temere. Nel medesimo convento fece il disegno e fondò un bellissimo campanile di pietre lavorate, parte vive e parte di tufo, che fu assai bene da lui tirato inanzi, et oggi si se-guita dal detto Bernardino suo nipote, che lo va conducendo a fine.
Essendosi monsignor Luigi Lippomani, vescovo di Verona, risoluto di condurre a fine il campanile della sua chiesa, stato cominciato cento anni inanzi, ne fece fare un disegno a Michele, il quale lo fece bellissimo, avendo considerazione a conservare il vecchio et alla spesa che il vescovo vi potea fare, ma un certo Messer Domenico Porzio romano, suo vicario, persona poco intendente del fabricare, ancor che per altro uomo da bene, lasciatosi imbarcare da uno che ne sapea poco, gli diede cura di tirare inanzi quella fabrica. Onde colui murandola di pietre di monte non lavorate e facendo nella grossezza delle mura le scale, le fece di maniera, che ogni persona anco mediocremente intendente d'architettu-ra indovinò quello che poi successe, cioè che quella fabrica non istarebbe in piedi. E fra gl'altri il molto reverendo fra' Marco de' Medici veronese, che oltre alli altri suoi studii più gravi, si è dilettato sempre, come ancor fa, della architettura, predisse quello che di cotal fabrica avverrebbe, ma gli fu risposto: “Fra' Marco vale assai nella professione delle sue lettere di filosofia e teologia, essendo lettor publico, ma nell'architettura non pesca in modo a fondo, che se gli possa credere”. Finalmente arrivato quel campanile al piano delle campane, s'aperse in quattro parti di maniera, che dopo ave-re speso molte migliaia di scudi in farlo, bisognò dare trecento scudi a' smuratori che lo gettassono a terra, acciò cadendo da per sé, come in pochi giorni arebbe fatto, non rovinasse all'intorno ogni cosa. E così sta bene che avvenga a chi, lasciando i maestri buoni et eccellenti, s'impaccia con ciabattoni. Essendo poi il detto monsignor Luigi stato eletto vescovo di Bergamo et in suo luogo vescovo di Verona monsignor Agostino Lippomano, questi fece rifare a Michele il modello del detto campanile e cominciarlo; e dopo lui, secondo il medesimo, ha fatto seguitare quell'opera, che oggi camina assai lentamente, monsignor Girolamo Trivisani, frate di San Domenico, il quale nel Vescovado sucedette al-l'ultimo Lippomano. Il quale modello è bellissimo e le scale vengono in modo accomodate dentro, che la fabrica resta stabile e gagliardissima. Fece Michele ai signori conti della Torre veronesi una bellissima cappella a uso di tempio ton-do con l'altare in mezzo, nella lor villa di Fumane. E nella chiesa del Santo in Padoa fu con suo ordine fabricata una sepoltura bellissima per Messer Alessandro Contarini procuratore di San Marco e stato proveditore dell'armata viniziana; nella quale sepoltura pare che Michele volesse mostrare in che maniera si deono fare simil opere, uscendo d'un certo modo ordinario, che a suo giudizio ha più tosto dell'altare e cappella che di sepolcro. Questa dico, che è molto ricca per ornamenti e di composizione soda et ha proprio del militare, ha per ornamento una Tetis e due prigioni di mano di Alessandro Vittoria, che sono tenute buone figure, et una testa o vero ritratto di naturale del detto signore, col petto armato, stata fatta di marmo dal Danese da Carrara. Vi sono oltre ciò altri ornamenti assai di prigioni, di trofei e di spoglie militari et altri de' quali non accade far menzione.
In Vinezia fece il modello del monasterio delle monache di San Biagio Catoldo, che fu molto lodato. Essendosi poi deliberato in Verona di rifare il lazzaretto, stanza o vero spedale che serve agl'amorbati nel tempo di peste, essendo stato rovinato il vecchio con altri edifizii che erono nei sobborghi, ne fu fatto fare un disegno a Michele, che riuscì oltre ogni credenza bellissimo, acciò fusse messo in opera in luogo vicino al fiume, lontano un pezzo e fuori della spianata. Ma questo disegno veramente bellissimo, et ottimamente in tutte le parti considerato, il quale è oggi appresso gl'eredi di Luigi Brugnuoli nipote di Michele, non fu da alcuni, per il loro poco giudizio e meschinità d'animo, posto interamente in essecuzione, ma molto ristretto, ritirato e ridotto al meschino da coloro i quali spesero l'autorità, che intorno a ciò avevano avuta dal publico, in storpiare quell'opera, essendo morti anzitempo alcuni gentiluomini che erano da principio sopra ciò et avevano la grandezza dell'animo pari alla nobiltà. Fu similmente opera di Michele il bellissimo palazzo che hanno in Verona i signori conti di Canossa, il quale fu fatto edificare da monsignor reverendissimo di Baius, che fu il conte Lodovico Canossa, uomo tanto celebrato da tutti gli scrittori de' suoi tempi. Al medesimo monsignore edificò Michele un altro magnifico palazzo nella villa di Grezano sul veronese; di ordine del medesimo fu rifatta la facciata de' conti Bevilacqua, e rassettate tutte le stanze del castello di detti signori, detto la Bevilacqua. Similmente fece in Verona la casa e facciata de' Lavezoli, che fu molto lodata. Et in Vinezia murò dai fondamenti il magnifico e ricchissimo palazzo de' Cornari, vicino a San Polo, e rassettò un altro palazzo, pur di casa Cornara, che è a San Benedetto al Albore per Messer Giovanni Cornari, del quale era Michele amicissimo e fu cagione che in questo dipignesse Giorgio Vasari nove quadri a olio per lo palco d'una magnifica camera tutta di legnami intagliati e messi d'oro riccamente. Rassettò medesimamente la casa de' Bragadini riscontro a Santa Marina e la fece comodissima et ornatissima, e nella medesima città fondò e tirò sopra terra, secondo un suo modello e con spesa incredibile, il maraviglioso palazzo del nobilissimo Mes-ser Girolamo Grimani, vicino a San Luca sopra il canal grande, ma non poté Michele, sopragiunto dalla morte, condurlo egli stesso a fine, e gl'altri architetti presi in suo luogo da quel gentiluomo in molte parti alterarono il disegno e modello del San Michele. Vicino a Castel Franco, ne' confini fra il trivisano [e il] padovano, fu murato d'ordine dell'istesso Michele il famosissimo palazzo de' Soranzi, dalla detta famiglia detto la Soranza, il quale palazzo è tenuto, per abitura di villa, il più bello e più comodo che insino allora fusse stato fatto in quelle parti. Et a Piombino, in contado, fece la casa Cornara e tante altre fabriche private, che troppo lunga storia sarebbe volere di tutte ragionare; basta aver fatto menzione delle principali. Non tacerò già che fece le bellissime porte di due palazzi: l'una fu quella de' rettori e del capitano e l'altra quella del palazzo del podestà, amendue in Verona e lodatissime, se bene quest'ultima, che è d'ordine ionico con doppie colonne et intercolonnii ornatissimi et alcune Vittorie negl'angoli, pare per la bassezza del luogo do-ve è posta alquanto nana, essendo massimamente senza piedistallo e molto larga per la doppiezza delle colonne, ma così volle Messer Giovanni Delfini che la fé fare.
Mentre che Michele si godeva nella patria un tranquill'ozio e l'onore e riputazione che le sue onorate fatiche gl'ave-vano acquistate, gli sopravenne una nuova che l'accorò di maniera, che finì il corso della sua vita. Ma perché meglio s'intenda il tutto e si sappiano in questa vita tutte le bell'opere de' San Micheli, dirò alcune cose di Giangirolamo nipote di Michele.
Costui adunque, il quale nacque di Paulo, fratello cugino di Michele, essendo giovane di bellissimo spirito, fu nelle cose d'architettura con tanta diligenza instrutto da Michele e tanto amato, che in tutte l'imprese d'importanza e massimamente di fortificazione lo volea sempre seco. Per che, divenuto in brieve tempo con l'aiuto di tanto maestro in modo eccellente che si potea commettergli ogni difficile impresa di fortificazione, della quale maniera d'architettura si dilettò in particolare, fu dai signori viniziani conosciuta la sua virtù et egli messo nel numero dei loro architetti, ancor che fusse molto giovane, con buona provisione; e dopo mandato ora in un luogo et ora in altro a rivedere e rassettare le fortezze del loro dominio, e tallora a mettere in essecuzione i disegni di Michele suo zio. Ma oltre agl'altri luoghi si adoperò con molto giudizio e fatica nella fortificazione di Zara e nella maravigliosa fortezza di S. Niccolò, in Sebenico, come s'è detto, posta in sulla bocca del porto; la qual fortezza, che da lui fu tirata su dai fondamenti, è tenuta, per fortezza privata, una delle più forti e meglio intesa che si possa vedere. Riformò ancora con suo disegno e giudizio del zio la gran fortezza di Corfù, riputata la chiave d'Italia da quella parte. In questa, dico, rifece Giangirolamo i due torrioni che guardano verso terra, facendogli molto maggiori e più forti che non erano prima e con le canoniere e piazze scoperte che fiancheggiano la fossa alla moderna, secondo l'invenzione del zio. Fatte poi allargare le fosse molto più che non erano, fece abbassare un colle che essendo vicino alla fortezza parea che la soprafacesse. Ma oltre a molte altre cose che vi fece con molta considerazione, questa piacque estremamente, che in un cantone della fortezza fece un luogo assai grande e forte, nel quale in tempo d'assedio possono stare in sicuro i popoli di quell'isola, senza pericolo di essere presi da' nemici. Per le quali opere venne Giangirolamo in tanto credito appresso detti signori, che gli ordinarono una provisione equale a quella del zio, non lo giudicando inferiore a lui anzi, in questa pratica delle fortezze, superiore; il che era di somma contentezza a Michele, il quale vedeva la propria virtù avere tanto accrescimento nel nipote, quanto a lui toglieva la vecchiezza di poter più oltre caminare.
Ebbe Giangirolamo, oltre al gran giudizio di conoscere la qualità de' siti, molta industria in sapergli rappresentare con disegni e modelli di rilievo, onde faceva vedere ai suoi signori insino alle menomissime cose delle sue fortificazioni in bellissimi modelli di legname che facea fare, la qual diligenza piaceva loro infinitamente, vedendo essi, senza partirsi di Vinezia, giornalmente come le cose passavano ne' più lontani luoghi di quello stato; et a fine che meglio fussero veduti da ognuno, gli tenevano nel palazzo del principe in luogo dove que' signori potevano vedergli a lor posta. E perché così andasse Giangirolamo seguitando di fare, non pure gli rifacevano le spese fatte in condurre detti modelli, ma anco molte altre cortesie.
Potette esso Giangirolamo andare a servire molti signori con grosse provisioni, ma non volle mai partirsi dai suo' signori viniziani, anzi, per consiglio del padre e del zio tolse moglie in Verona una nobile giovanetta de' Fracastori con animo di sempre starsi in quelle parti, ma non essendo anco con la sua amata sposa, chiamata madonna Ortensia, dimorato se non pochi giorni, fu dai suoi signori chiamato a Vinezia e di lì con molta fretta mandato in Cipri a vedere tutti i luoghi di quell'isola, con dar commessione a tutti gli ufficiali che lo provedessino di quanto gli facesse bisogno in ogni cosa. Arivato dunque Giangirolamo in quell'isola, in tre mesi la girò e vide tutta diligentemente, mettendo ogni cosa in disegno e scrittura per potere di tutto dar ragguaglio a' suoi signori. Ma mentre che attendeva con troppa cura e sollecitudine al suo ufficio, tenendo poco conto della sua vita negl'ardentissimi caldi che allora erano in quell'isola, infermò d'una febre pestilente che in sei giorni gli levò la vita, se bene dissero alcuni che egli era stato avelenato; ma comunche si fusse, morì contento, essendo ne' servigi de' suoi signori et adoperato in cose importanti da loro, che più avevano creduto alla sua fede e professione di fortificare che a quella di qualunche altro. Subito che fu amalato, conoscendosi mortale, diede tutti i disegni e scritti che avea fatto delle cose di quell'isola in mano di Luigi Brugnuoli suo cognato et architetto, che allora attendeva alla fortificazione di Famagosta, che è la chiave di quel regno, acciò gli portasse a' suoi signori. Arivata in Vinezia la nuova della morte di Giangirolamo non fu niuno di quel senato che non sentisse incredibile dolore della perdita d'un sì fatt'uomo e tanto affezionato a quella repubblica.
Morì Giangirolamo di età di 45 anni et ebbe onorata sepoltura in S. Niccolò di Famagosta dal detto suo cognato, il quale poi tornato a Vinezia presentando i disegni e scritti di Giangirolamo, il che fatto fu mandato a dar compimento alla fortificazione di Legnago, là dove era stato molti anni ad essequire i disegni e modelli del suo zio Michele. Nel qual luogo non andò molto che si morì, lasciando due figliuoli che sono assai valenti uomini nel disegno e nella pratica d'architettura; con ciò sia che Bernardino, il maggiore, ha ora molte imprese alle mani, come la fabrica del campanile del Duomo e di quello di San Giorgio; la Madonna detta di Campagna, nelle quali et altre opere che fa in Verona et altrove riesce eccellente, e massimamente nell'ornamento e cappella maggiore di S. Giorgio di Verona, la quale è d'ordi-ne composito e tale che per grandezza, disegno e lavoro affermano i veronesi non credere che si truovi altra a questa pari in Italia; quest'opera dico, la quale va girando secondo che fa la nicchia, è d'ordine corinzio con capitelli composti, colonne doppie di tutto rilievo e con i suoi pilastri dietro; similmente il frontespizio, che la ricuopre tutta, gira anch'egli con gran maestria secondo che fa la nicchia et ha tutti gl'ornamenti che cape quell'ordine, onde monsignor Barbaro, eletto patriarca d'Aquileia, uomo di queste professioni intendentissimo e che n'ha scritto, nel ritornare dal Concilio di Trento, vide non senza maraviglia quello che di quell'opera era fatto e quello che giornalmente si lavorava; et avendola più volte considerata, ebbe a dire non aver mai veduta simile e non potersi far meglio. E questo basti per saggio di quello che si può dall'ingegno di Bernardino, nato per madre de' San Micheli, sperare.
Ma per tornare a Michele, da cui ci partimo non senza cagione poco fa, gl'arrecò tanto dolore la morte di Giangirolamo, in cui vide mancare la casa de' San Micheli, non essendo del nipote rimasi figliuoli, ancor che si sforzasse di vincerlo e ricoprirlo, che in pochi giorni fu da una maligna febre ucciso, con incredibile dolore della patria e de' suoi illustrissimi signori. Morì Michele l'anno 1559 e fu sepolto in San Tommaso de' frati carmelitani, dove è la sepoltura antica de' suoi maggiori; et oggi Messer Niccolò San Michele medico ha messo mano a fargli un sepolcro onorato, che si va tuttavia mettendo in opera. Fu Michele di costumatissima vita et in tutte le sue cose molto onorevole; fu persona allegra, ma però mescolato col grave; fu timorato di Dio e molto religioso, in tanto che non si sarebbe mai messo a fare la mattina alcuna cosa, che prima non avesse udito messa divotamente e fatte sue orazioni. E nel principio dell'imprese d'importanza faceva sempre la mattina innanzi ad ogni altra cosa cantar solennemente la messa dello Spirito Santo o della Madonna; fu liberalissimo e tanto cortese con gli amici, che così erano eglino delle cose di lui signori, come egli stesso. Né tacerò qui un segno della sua lealissima bontà, il quale credo che pochi altri sappiano, fuor che io. Quando Giorgio Vasari, del quale, come si è detto, fu amicissimo, partì ultimamente da lui in Vinezia, gli disse Michele: “Io voglio che voi sappiate, Messer Giorgio, che quando io stetti in mia giovanezza a Monte Fiascone, essendo innamorato della moglie d'uno scarpellino, come volle la sorte ebbi da lei cortesemente, senza che mai niuno da me lo risapesse, tutto quello che io desiderava. Ora, avendo io inteso che quella povera donna è rimasa vedova e con una figliuola da marito, la quale dice avere di me conceputa, voglio, ancor che possa agevolmente essere che ciò, come io credo, non sia vero, portatele questi cinquanta scudi d'oro e dategliele da mia parte per amor di Dio, acciò possa aiutarsi et accomodare secondo il grado suo la figliuola”. Andando dunque Giorgio a Roma, giunto in Monte Fiascone, ancor che la buona donna gli confessasse liberamente quella sua putta non essere figliuola di Michele, ad ogni modo, sì come egli avea commesso, gli pagò i detti danari, che a quella povera femina furono così grati come ad un altro sarebbono stati cinquecento. Fu dunque Michele cortese sopra quanti uomini furono mai, con ciò fusse che non sì tosto sapeva il bisogno e desiderio degl'amici, che cercava di compiacergli se avesse dovuto spendere la vita; né mai alcuno gli fece servizio che non ne fusse in molti doppii ristorato. Avendogli fatto Giorgio Vasari in Vinezia un disegno grande con quella diligenza che seppe maggiore, nel quale si vedeva il superbissimo Lucifero con i suo' seguaci vinti dall'Angelo Michele piovere rovinosamente di cielo in un orribile inferno, non fece altro per allora che ringraziarne Giorgio quando prese licenza da lui; ma non molti giorni dopo, tornando Giorgio in Arezzo, trovò il San Michele aver molto innanzi mandato a sua madre, che si stava in Arezzo, una soma di robe così belle et onorate come se fusse stato un ricchissimo signore, e con una lettera nella quale molto l'onorava per amore del figliuolo. Gli volleno molte volte i signori viniziani accrescere la provisione et egli ciò ricusando, pregava sempre che in suo cambio l'accrescessero ai nipoti. Insomma fu Michele in tutte le sue azzioni tanto gentile, cortese et amorevole, che meritò essere amato da infiniti signori: dal cardinal de' Medici, che fu papa Clemente Settimo, mentre che stette a Roma, dal cardinale Alessandro Farnese, che fu Paulo Terzo, dal divino Michelagnolo Buonarroti, dal signor Francesco Maria duca d'Urbino, e da infiniti gentiluomini e senatori viniziani. In Verona fu suo amicissimo fra' Marco de' Medici, uomo di letteratura e bontà infinita, e molti altri de' quali non accade al presente far menzione.
Ora, per non avere a tornare di qui a poco a parlare de' veronesi, con questa occasione dei sopra detti farò in questo luogo menzione d'alcuni pittori di quella patria che oggi vivono e sono degni di essere nominati, e non passati in niun modo con silenzio. Il primo de' quali è Domenico del Riccio, il quale in fresco ha fatto di chiaro scuro, et alcune cose colorite, tre facciate nella casa di Fiorio della Seta in Verona, sopra il ponte nuovo, cioè le tre che non rispondono sopra il ponte, essendo la casa isolata; in una sopra il fiume sono battaglie di mostri marini; in un'altra le battaglie de' centauri e molti fiumi; nella terza sono due quadri coloriti. Nel primo, che è sopra la porta, è la mensa degli dei, e nell'altro, sopra il fiume, sono le nozze finte fra il Benaco, detto il lago di Garda, e Caride, ninfa finta per Garda, de' quali nasce il Mincio fiume, il quale veramente esce del detto lago. Nella medesima casa è un fregio grande, dove sono alcuni trionfi coloriti e fatti con bella pratica e maniera. In casa Messer Pellegrino Ridolfi, pur in Verona, dipinse il medesimo la incoronazione di Carlo Quinto imperadore, e quando dopo essere coronato in Bologna cavalca con il Papa per la città con grandissima pompa. A olio ha dipinto la tavola principale della chiesa, che ha novamente edificata il duca di Mantoa vicina al castello, nella quale è la decollazione e martirio di Santa Barbara, con molta diligenza e giudizio lavorata. E quello che mosse il Duca a far fare quella tavola a Domenico, si fu l'aver veduta et essergli molto piaciuta la sua maniera in una tavola, che molto prima avea fatta Domenico nel Duomo di Mantoa, nella cappella di Santa Margherita, a concorrenza di Paulino, che fece quella di Santo Antonio, di Paulo Farinato, che dipinse quella di San Martino, e di Battista del Moro, che fece quella della Madalena. I quali tutti quattro veronesi furono là condotti da Ercole cardinale di Mantova per ornare quella chiesa da lui stata rifatta col disegno di Giulio Romano. Altre opere ha fatto Domenico in Verona, Vicenza, Vinezia, ma basti aver detto di queste. È costui costumato e virtuoso artefice, perciò che oltre la pittura è ottimo musico e de' primi dell'accademia nobilissima de' filarmonici di Verona; né sarà a lui inferiore Felice suo figliuolo, il quale, ancor che giovane, si è mostro più che ragionevole pittore in una tavola che ha fatto nella chiesa del-la Trinità, dentro la quale è la Madonna e sei altri Santi grandi quanto il naturale. Né è di ciò maraviglia avendo questo giovane imparato l'arte in Firenze, dimorando in casa Bernardo Canigiani, gentiluomo fiorentino e compare di Domenico suo padre. Vive anco nella medesima Verona Bernardino detto l'India, il quale, oltre a molte altre opere, ha dipinto in casa del conte Marcantonio del Tiene nella volta d'una camera in bellissime figure la favola di Psiche; et un'altra ca-mera ha con belle invenzioni e maniera di pitture dipinta al conte Girolamo da Canossa. È anco molto lodato pittore Elliodoro Forbicini, giovane di bellissimo ingegno et assai pratico in tutte le maniere di pitture, ma particolarmente nel far grottesche, come si può vedere nelle dette due camere et altri luoghi dove ha lavorato. Similmente Battista da Verona, il quale è così e non altrimenti fuor della patria chiamato, avendo avuto i primi principii della pittura da un suo zio in Verona, si pose con l'eccellente Tiziano in Vinezia, appresso il quale è divenuto eccellente pittore. Dipinse costui essendo giovane in compagnia di Paulino una sala a Tiene, sul vicentino, nel palazzo del Collaterale Portesco, dove fecero un infinito numero di figure che acquistarono all'uno e l'altro credito e riputazione. Col medesimo lavorò molte cose a fresco nel palazzo della Soranza a Castel Franco, essendovi amendue mandati a lavorare da Michele San Michele, che gl'amava come figliuoli. Col medesimo dipinse ancora la facciata della casa di Messer Antonio Cappello, che è in Vinezia sopra il canal grande. E dopo, pur insieme, il palco o vero soffittato della sala del consiglio de' Dieci dividendo i quadri fra loro. Non molto dopo, essendo Batista chiamato a Vicenza, vi fece molte opere dentro e fuori, et in ultimo ha dipinto la facciata del Monte della Pietà, dove ha fatto un numero infinito di figure nude maggiori del naturale, in di-verse attitudini, con bonissimo disegno et in tanti pochi mesi, che è stato una maraviglia. E se tanto ha fatto in sì poca età, che non passa trenta anni, pensi ognuno quello che di lui si può nel processo della vita sperare. È similmente veronese un Paulino pittore che oggi è in Vinezia in bonissimo credito, conciò sia che non avendo ancora più di trenta anni, ha fatto molte opere lodevoli. Costui essendo in Verona nato d'uno scarpellino o, come dicono in que' paesi, d'un tagliapietre, et avendo imparato i principii della pittura da Giovanni Caroto veronese, dipinse in compagnia di Battista sopra detto, in fresco, la sala del Collaterale Portesco a Tiene nel vicentino; e dopo col medesimo alla Soranza molte opere fatte con disegno, giudizio e bella maniera. A Masiera, vicino ad Asolo nel trivisano, ha dipinto la bellissima casa del signor Daniello Barbaro, eletto patriarca d'Aquileia; in Verona nel refettorio di San Nazzaro, monasterio de' monaci Neri, ha fatto in un gran quadro di tela la cena che fece Simon lebroso al Signore quando la peccatrice se gli gettò a' piedi, con molte figure, ritratti di naturale e prospettive rarissime, e sotto la mensa sono due cani tanto belli che paiono vivi e naturali, e più lontano certi storpiati, ottimamente lavorati. E di mano di Paulino in Vinezia, nella sala del consiglio de' Dieci, è in un ovato, che è maggiore d'alcuni altri che vi sono e nel mezzo del palco come principale, un Giove che scaccia i vizii per significare che quel supremo magistrato et assoluto scaccia i vizii e castiga i cattivi e viziosi uomini. Dipinse il medesimo il soffittato o vero palco della chiesa di San Sebastiano, che è opera rarissima, e la tavola della cappella maggiore con alcuni quadri che a quella fanno ornamento, e similmente le portelle dell'organo, che tutte sono pitture veramente lodevolissime. Nella sala del gran consiglio dipinse in un quadro grande Federigo Barbarossa che s'appresenta al Papa, con buon numero di figure varie d'abiti e di vestiti e tutte bellissime e veramente rappresentanti la corte d'un papa e d'un imperatore et un senato viniziano, con molti gentiluomini e senatori di quella republica ritratti di naturale; et insomma quest'opera è per grandezza, disegno e belle e varie attitudini tale che è meritamente lo-data da ognuno. Dopo questa storia dipinse Paulino in alcune camere, che servono al detto consiglio de' Dieci, i palchi di figure a olio, che scortano molto e sono rarissime; similmente dipinse per andare a San Maurizio, da San Moise, la facciata a fresco della casa d'un mercatante, che fu opera bellissima, ma il marino la va consumando a poco a poco. A Camillo Trivisani in Murano dipinse a fresco una loggia et una camera, che fu molto lodata; et in San Giorgio Maggiore di Vinezia fece in testa d'una gran stanza le nozze di Cana Galilea a olio, che fu opera maravigliosa per grandezza, per numero di figure e per varietà d'abiti e per invenzione, e se bene mi ricorda, vi si veggiono più di centocinquanta teste tutte variate e fatte con gran diligenza. Al medesimo fu fatto dipignere dai procuratori di San Marco certi tondi angulari, che sono nel palco della libreria Nicena, che alla signoria fu lasciata dal cardinale Bessarione con un tesoro grandissimo di libri greci. E perché detti signori, quando cominciarono a fare dipignere la detta libreria, promisero a chi meglio in dipignendola operasse un premio d'onore, oltre al prezzo ordinario, furono divisi i quadri fra i migliori pittori che allora fussero in Vinezia; finita l'opera, dopo essere state molto ben considerate le pitture de' detti quadri, fu posta una collana d'oro al collo a Paulino, come a colui che fu giudicato meglio di tutti gl'altri aver operato. Et il quadro che diede la vittoria et il premio dell'onore fu quello dove è dipinta la Musica, nel quale sono dipinte tre bellissime donne giovani: una delle quali, che è la più bella, suona un gran lirone da gamba, guardando a basso il manico dello strumento e stando con l'orecchio et attitudine della persona e con la voce attentissima al suono; dell'altre due, una suona un liuto e l'altra canta a libro; appresso alle donne è un Cupido senz'ale che suona un gravecembolo, dimostrando che dalla Musica nasce Amore, o vero che Amore è sempre in compagnia della Musica, e perché mai non se ne parte lo fece senz'a-le. Nel medesimo dipinse Pan, dio - secondo i poeti - de' pastori, con certi flauti di scorze d'albori a lui, quasi voti, consecrati da' pastori stati vittoriosi nel sonare. Altri due quadri fece Paulino nel medesimo luogo: in uno è l'Aritmetica con certi filosofi vestiti alla antica e nell'altro l'Onore, al quale, essendo in sedia, si offeriscono sacrificii e si porgono corone reali. Ma perciò che questo giovane è a punto in sul bello dell'operare, e non arriva a trentadue anni, non ne dirò altro per ora.
È similmente veronese Paulo Farinato, valente dipintore, il quale essendo stato discepolo di Nicola Ursino ha fatto molte opere in Verona, ma le principali sono una sala, nella casa de' Fumanelli, colorita a fresco e piena di varie storie, secondo che volle Messer Antonio gentiluomo di quella famiglia e famosissimo medico in tutta Europa, e due quadri grandissimi in Santa Maria in Organi nella cappella maggiore, in uno de' quali è la storia degl'innocenti e nell'altro è quando Gostantino imperatore si fa portare molti fanciugli innanzi per uccidergli, e bagnarsi del sangue loro, per guarir della lebbra. Nella nicchia poi della detta cappella sono due gran quadri, ma però minori de' primi; in uno è Cristo che riceve San Piero, che verso lui camina sopra l'acque, e nell'altro il desinare che fa San Gregorio a certi poveri. Nelle quali tutte opere, che molto sono da lodare, è un numero grandissimo di figure, fatte con disegno, studio e diligenza. Di mano del medesimo è una tavola di San Martino, che fu posta nel Duomo di Mantoa, la quale egli lavorò a concorrenza degl'altri suo' compatrioti, come s'è detto pur ora.
E questo sia il fine della vita dell'eccellente Michele San Michele e degl'altri valentuomini veronesi, degni certo d'ogni lode, per l'eccellenza dell'arti e per la molta virtù loro.
FINE DELLA VITA DI MICHELE S. MICHELE ARCHITETTO E D'ALTRI VERONESI
VITA DI GIOVANNANTONIO DETTO IL SODDOMA DA VERZELLI
PITTORE

Se gl'uomini conoscesseno il loro stato quando la fortuna porge loro occasione di farsi ricchi, favorendoli appresso gl'uomini grandi, e se nella giovanezza s'affaticassino per accompagnare la virtù con la fortuna, si vedrebbono maravigliosi effetti uscire dalle loro azzioni, là dove spesse volte si vede il contrario avenire; perciò che, sì come è vero che chi si fida interamente della fortuna sola resta le più volte ingannato, così è chiarissimo, per quello che ne mostra ogni giorno la sperienza, che anco la virtù sola non fa gran cose se non accompagnata dalla fortuna. Se Giovannantonio da Verzelli, come ebbe buona fortuna avesse avuto, come se avesse studiato poteva, pari virtù, non si sarebbe al fine della vita sua, che fu sempre stratta e bestiale, condotto pazzamente nella vecchiezza a stentare miseramente. Essendo adunque Giovannantonio condotto a Siena da alcuni mercatanti agenti degli Spannocchi, volle la sua buona sorte, e forse cattiva, che non trovando concorrenza per un pezzo in quella città, vi lavorasse solo, il che se bene gli fu di qualche utile, gli fu alla fine di danno, perciò che quasi adormentandosi, non istudiò mai, ma lavorò le più delle sue cose per pratica; e se pur studiò un poco, fu solamente in disegnare le cose di Iacopo dalla Fonte, ché erano in pregio, e poco altro.
Nel principio facendo molti ritratti di naturale con quella sua maniera di colorito acceso che egli avea recato di Lombardia, fece molte amicizie in Siena più per essere quel sangue amorevolissimo de' forestieri, che perché fusse buon pittore. Era oltre ciò uomo allegro, licenzioso, e teneva altrui in piacere e spasso, con vivere poco onestamente; nel che fare, però che aveva sempre attorno fanciulli e giovani sbarbati, i quali amava fuor di modo, si acquistò il sopranome di Soddoma, del quale, non che si prendesse noia o sdegno, se ne gloriava, facendo sopra esso stanze e capitoli e cantandogli in sul liuto assai commodamente. Dilettossi, oltre ciò, d'aver per casa di più sorte stravaganti animali: tassi, scoiattoli, bertucce, gatti mammoni, asini nani, cavalli barbari da correre palii, cavallini piccoli dell'Elba, ghiandaie, galline nane, tortole indiane et altri sì fatti animali, quanti gliene potevano venire alle mani, ma oltre tutte queste bestiacce aveva un corbo che da lui aveva così bene imparato a favellare, che contrafaceva in molte cose la voce di Giovannantonio, e particolarmente in rispondendo a chi picchiava la porta, tanto bene che pareva Giovannantonio stesso, come benissimo sanno tutti i sanesi. Similmente gl'altri animali erano tanto domestichi, che sempre stavano intorno altrui per casa, facendo i più strani giuochi et i più pazzi versi del mondo, di maniera che la casa di costui pareva proprio l'arca di Noè. Questo vivere adunque, la strattezza della vita e l'opere e pitture, che pur faceva qualcosa di buono, gli facevano avere tanto nome fra' sanesi, cioè nella plebe e nel volgo, perché i gentiluomini lo conoscevano da vantaggio, che egli era tenuto appresso di molti grand'uomo. Per che, essendo fatto generale de' monaci di Monte Oliveto fra' Domenico da Lecco lombardo, et andandolo il Soddoma a visitare a Monte Oliveto di Chiusuri, luogo principale di quella Relligione, lontano da Siena quindici miglia, seppe tanto dire e persuadere, che gli fu dato a finire le storie della vita di San Benedetto, delle quali aveva fatto parte in una facciata Luca Signorelli da Cortona. La quale opera egli finì per assai piccol prezzo e per le spese che ebbe egli et alcuni garzoni e pestacolori che gl'aiutarono, né si potrebbe dire lo spasso che mentre lavorò in quel luogo ebbero di lui que' padri, che lo chiamavano il Mattaccio, né le pazzie che vi fece. Ma tornando all'opera, avendovi fatte alcune storie tirate via di pratica senza diligenza e dolendosene il generale, disse il Mattaccio che lavorava a capricci e che il suo pennello ballava secondo il suono de' danari e che, se voleva spender più, gli bastava l'animo di far molto meglio; per che, avendogli promesso quel generale di meglio volerlo pagare per l'avenire, fece Giovannantonio tre storie che restavano a farsi ne' cantoni, con tanto più studio e diligenza che non avea fatto l'altre, che riuscirono molto migliori. In una di queste è quando S. Benedetto si parte da Norcia e dal padre e dalla madre per andare a studiare a Roma: nella seconda, quando San Mauro e S. Placido fanciulli gli sono dati et offerti a Dio dai padri loro, e nella terza quando i Gotti ardono Monte Casino. In ultimo fece costui, per far dispetto al generale et ai monaci, quando Fiorenzo prete e nimico di San Benedetto condusse intorno al monasterio di quel san-t'uomo molte meretrici a ballare e cantare, per tentare la bontà di que' padri, nella quale storia il Soddoma, che era così nel dipignere come nell'altre sue azzioni disonesto, fece un ballo di femine ignude disonesto e brutto affatto; e perché non gli sarebbe stato lasciato fare, mentre lo lavorò non volle mai che niuno de' monaci vedesse. Scoperta dunque che fu questa storia, la voleva il generale gettar per ogni modo a terra e levarla via, ma il Mattaccio, dopo molte ciance, vedendo quel padre in collora, rivestì tutte le femine ignude di quell'opera che è delle migliori che vi siano. Sotto le quali storie fece per ciascuna due tondi, et in ciascuno un frate, per farvi il numero de' generali che aveva avuto quella congregazione. E perché non aveva i ritratti naturali, fece il Mattaccio il più delle teste a caso, et in alcune ritrasse de' frati vecchi che allora erano in quel monasterio: tanto che venne a fare quella del detto fra' Domenico da Lecco, che era allora generale come s'è detto, et il quale gli faceva fare quell'opera. Ma perché ad alcune di queste teste erano stati cavati gl'occhi, altre erano state sfregiate, frate Antonio Bentivogli bolognese le fece tutte levar via per buone cagioni. Mentre dunque che il Mattaccio faceva queste storie, essendo andato a vestirsi lì monaco, un gentiluomo milanese che aveva una cappa gialla con fornimenti di cordoni neri, come si usava in quel tempo, vestito che colui fu da monaco, il genera-le donò la detta cappa al Mattaccio et egli con essa indosso si ritrasse dallo specchio in una di quelle storie dove S. Benedetto, quasi ancor fanciullo, miracolosamente racconcia e reintegra il capisterio o vero vassoio della sua balia, ch'ella avea rotto; et a' piè del ritratto vi fece il corbo, una bertuccia et altri suoi animali. Finita quest'opera dipinse nel refettorio del monasterio di Sant'Anna, luogo del medesimo Ordine e lontano a Monte Oliveto cinque miglia, la storia de' cinque pani e due pesci et altre figure. La qual opera fornita, se ne tornò a Siena, dove alla postierla dipinse a fresco la facciata della casa di Messer Agostino de' Bardi sanese, nella quale erano alcune cose lodevoli, ma per lo più sono state consumate dall'aria e dal tempo.
In quel mentre capitando a Siena Agostin Chigi, ricchissimo e famoso mercatante sanese, gli venne conosciuto, e per le sue pazzie e perché aveva nome di buon dipintore, Giovan Antonio. Per che, menatolo seco a Roma, dove allora faceva papa Giulio II dipigner nel palazzo di Vaticano le camere papali che già aveva fatto murare papa Niccolò V, si adoperò di maniera col Papa che anco a lui fu dato da lavorare. E perché Pietro Perugino che dipigneva la volta d'una camera, che è allato a torre Borgia, lavorava, come vecchio che egli era, adagio e non poteva, come era stato ordinato da prima, metter mano ad altro, fu data a dipignere a Giovan Antonio un'altra camera che è a canto a quella che dipigneva il Perugino. Messovi dunque mano, fece l'ornamento di quella volta di cornici e fogliami e fregii, e dopo in alcuni tondi grandi fece alcune storie in fresco assai ragionevoli. Ma perciò che questo animale, attendendo alle sue bestiuole et alle baie, non tirava il lavoro inanzi, essendo condotto Raffaello da Urbino a Roma da Bramante architetto e dal Papa conosciuto quanto gl'altri avanzasse, comandò Sua Santità che nelle dette camere non lavorasse più né il Perugino né Giovan Antonio, anzi che si buttasse in terra ogni cosa. Ma Raffaello, che era la stessa bontà e modestia, lasciò in piedi tutto quello che avea fatto il Perugino, stato già suo maestro, e del Mattaccio non guastò se non il ripieno e le figure de' tondi, e de' quadri lasciando le fregiature e gl'altri ornamenti che ancor sono intorno alle figure che vi fece Raffaello, le quali furno la Iustizia, la Cognizione delle cose, la Poesia e la Teologia. Ma Agostino, che era galantuomo, senza aver rispetto alla vergogna che Giovan Antonio avea ricevuto, gli diede a dipignere nel suo palazzo di Trastevere in una sua camera principale, che risponde nella sala grande, la storia d'Alessandro quando va a dormire con Rosana; nella quale opera, oltre all'altre figure, vi fece un buon numero d'Amori, alcuni de' quali dislacciano ad Alessandro la corazza, altri gli traggono gli stivali o vero calzari, altri gli lievano l'elmo e la veste e le rassettano, altri spargono fiori sopra il letto et altri fanno altri ufficii così fatti; e vicino al camino fece un Vulcano, il quale fabbrica saette, che allora fu tenuta assai buona e lodata opera. E se il Mattaccio, il quale aveva di bonissimi tratti et era molto aiutato dalla natura, avesse atteso in quella disdetta di fortuna, come averebbe fatto ogni altro, agli studii, averebbe fatto grandissimo frutto. Ma egli ebbe sempre l'animo alle baie e lavorò a capricci, di niuna cosa maggiormente curandosi che di vestire pomposamente, portando giuboni di brocato, cappe tutte fregiate di tela d'oro, cuffioni ricchissimi, collane et altre simili bagattelle e cose da buffoni e cantanbanchi, delle quali cose Agostino, al quale piaceva quell'umore, n'aveva il maggiore spasso del mondo.
Venuto poi a morte Giulio Secondo e creato Leon X, al quale piacevano certe figure stratte e senza pensieri come era costui, n'ebbe il Mattaccio la maggior allegrezza del mondo e massimamente volendo male a Giulio che gl'aveva fatto quella vergogna. Per che, messosi a lavorare per farsi cognoscere al nuovo Pontefice, fece in un quadro una Lucrezia romana ignuda che si dava con un pugnale; e perché la fortuna ha cura de' matti et aiuta alcuna volta gli spensierati, gli venne fatto un bellissimo corpo di femina et una testa che spirava. La quale opera finita, per mezzo d'Agostin Chigi che aveva stretta servitù col Papa, la donò a Sua Santità, dalla quale fu fatto cavaliere e rimunerato di così bella pittura. Onde Giovan Antonio, parendoli essere fatto grand'uomo, cominciò a non volere più lavorare, se non quando era cacciato dalla necessità. Ma essendo andato Agostino per alcuni suo' negozii a Siena et avendovi menato Giovan Antonio, nel dimorare là fu forzato, essendo cavaliere senza entrate, mettersi a dipignere, e così fece una tavola, dentrovi un Cristo deposto di croce, in terra la Nostra Donna tramortita, et un uomo armato, che voltando le spalle, mostra il dinanzi nel lustro d'una celata che è in terra, lucida come uno specchio; la quale opera, che fu tenuta et è delle migliori che mai facesse costui, fu posta in San Francesco a man destra entrando in chiesa. Nel chiostro poi che è allato alla detta chiesa, fece in fresco Cristo battuto alla colonna, con molti giudei d'intorno a Pilato e con un ordine di colonne tirate in prospettiva a uso di cortine. Nella qual opera ritrasse Giovan Antonio se stesso senza barba, cioè raso e con i capelli lunghi, come si portavano allora. Fece non molto dopo al signor Iacopo Sesto di Piombino alcuni quadri, e standosi con esso lui in detto luogo alcun'altre cose in tele, onde col mezzo suo, oltre a molti presenti e cortesie che ebbe da lui, cavò della sua isola dell'Elba molti animali piccoli di quelli che produce quell'isola, i quali tutti condusse a Siena. Capitando poi a Firenze un monaco de' Brandolini, abbate del monasterio di Monte Oliveto che è fuor della porta San Friano, gli fece dipignere a fresco nella facciata del refettorio alcune pitture; ma perché, come stracurato, le fece senza studio, riuscirono sì fatte, che fu uccellato e fatto beffe delle sue pazzie da coloro che aspettavano che dovesse fare qualche opera straordinaria. Mentre dunque che faceva quell'opera, avendo menato seco a Fiorenza un caval barbero, lo messe a correre il palio di San Bernaba, e come volle la sorte corse tanto meglio degl'altri, che lo guadagnò. Onde, a-vendo i fanciulli a gridare come si costuma dietro al palio et alle trombe il nome o cognome del padrone del cavallo che ha vinto, fu dimandato Giovan Antonio che nome si aveva gridare, et avendo egli risposto Soddoma, Soddoma, i fanciulli così gridavano. Ma avendo udito così sporco nome certi vecchi da bene, cominciarono a farne rumore et a dire: “Che porca cosa, che ribalderia è questa, che si gridi per la nostra città così vituperoso nome?”. Di maniera, che mancò poco, levandosi il rumore, che non fu dai fanciulli e dalla plebe lapidato il povero Soddoma, et il cavallo e la bertuccia che avea in groppa con esso lui.
Costui, avendo nello spazio di molti anni raccozzati molti palii stati a questo modo vinti dai suoi cavalli, n'aveva una vanagloria, la maggior del mondo, et a chiunche gli capitava a casa, gli mostrava, e spesso spesso ne faceva mostra alle finestre. Ma per tornare alle sue opere, dipinse per la Compagnia di San Bastiano in Camollia, dopo la chiesa de-gl'Umiliati, in tela a olio in un gonfalone che si porta a processione, un San Bastiano ignudo, legato a un albero, che si posa in sulla gamba destra e scortando con la sinistra, alza la testa verso un Angelo che gli mette una corona in capo. La quale opera è veramente bella e molto da lodare; nel rovescio è la Nostra Donna col Figliuolo in braccio, et a basso San Gismondo, San Rocco et alcuni battuti con le ginocchia in terra. Dicesi che alcuni mercatanti lucchesi vollono dare agl'uomini di quella Compagnia, per avere quest'opera, trecento scudi d'oro e non l'ebbono, perché coloro non vollono privare la loro Compagnia e la città di sì rara pittura. E nel vero in certe cose, o fusse lo studio, o la fortuna, o il caso, si portò il Soddoma molto bene, ma di sì fatte ne fece pochissime. Nella sagrestia de' frati del Carmine è un quadro di mano del medesimo, nel quale è una natività di Nostra Donna con alcune balie, molto bella, et in sul canto, vicino alla piazza de' Tolomei, fece a fresco per l'arte de' Calzolai una Madonna col Figliuolo in braccio, San Giovanni, San Francesco, San Rocco e San Crespino, avvocato degl'uomini di quell'arte, il quale ha una scarpa in mano; nelle teste delle quali figure e nel resto si portò Giovan Antonio benissimo. Nella Compagnia di San Bernardino da Siena, a canto alla chiesa di San Francesco, fece costui a concorrenza di Girolamo del Pacchia pittore sanese e di Domenico Beccafumi, alcune storie a fresco: cioè la presentazione della Madonna al tempio, quando ella va a visitare Santa Lisabetta, la sua assunzione e quando è coronata in cielo. Nei canti della medesima Compagnia fece un Santo in abito episcopale, San Lodovico e Santo Antonio da Padoa; ma la meglio figura di tutte è un San Francesco, che stando in piedi alza la testa in alto, guardando un Angioletto, il quale pare che faccia sembiante di parlargli, la testa del qual San Francesco è vera-mente maravigliosa. Nel palazzo de' Signori dipinse similmente in Siena in un salotto alcuni tabernacolini pieni di colonne e di puttini, con altri ornamenti, dentro ai quali tabernacoli sono diverse figure: in uno è San Vettorio armato al-l'antica con la spada in mano e vicino a lui è nel medesimo modo Sant'Ansano che battezza alcuni et in un altro è San Benedetto, che tutti sono molto belli. Da basso in detto palazzo, dove si vende il sale, dipinse un Cristo che risuscita con alcuni soldati intorno al sepolcro e due Angioletti, tenuti nelle teste assai belli. Passando più oltre, sopra una porta è una Madonna col Figliuolo in braccio dipinta da lui a fresco e due Santi. A Santo Spirito dipinse la cappella di San Iacopo, la quale gli feciono fare gl'uomini della nazione spagnuola che vi hanno la loro sepoltura; facendovi una imagine di Nostra Donna antica, da man destra San Nicola da Tolentino e dalla sinistra San Michele Arcangelo che uccide Lucifero; e sopra questi, in un mezzo tondo, fece la Nostra Donna che mette in dosso l'abito sacerdotale a un Santo, con alcuni Angeli a torno. E sopra tutte queste figure, le quali sono a olio in tavola, è nel mezzo circolo della volta dipinto in fresco San Iacopo armato sopra un cavallo che corre, e tutto fiero ha impugnato la spada, e sotto esso sono molti turchi morti e feriti. Da basso poi, ne' fianchi dell'altare, sono dipinti a fresco Sant'Antonio abate et un S. Bastiano ignudo alla colonna, che sono tenute assai buon'opere. Nel Duomo della medesima città, entrando in chiesa a man destra è di sua mano a un altare un quadro a olio, nel quale è la Nostra Donna col Figliuolo in sul ginocchio, San Giuseppo da un lato e dall'altro S. Calisto, la qual opera è tenuta anch'essa molto bella perché si vede che il Soddoma nel colorirla usò molto più diligenza che non soleva nelle sue cose. Dipinse ancora per la Compagnia della Trinita una bara da portar morti alla sepoltura, che fu bellissima. Et un'altra ne fece alla Compagnia della Morte, che è tenuta la più bella di Siena, et io credo ch'ella sia la più bella che si possa trovare, perché oltre all'essere veramente molto da lodare, rade volte si fanno fare simili cose con spesa o molta diligenza. Nella chiesa di S. Domenico, alla cappella di Santa Caterina da Siena, dove in un tabernacolo è la testa di quella Santa lavorata d'argento, dipinse Giovan Antonio due storie che mettono in mezzo detto tabernacolo: in una è a man destra quando detta Santa, avendo ricevuto le stimate da Gesù Cristo che è in aria, si sta tramortita in braccio a due delle sue suore che la sostengono, la quale opera considerando, Baldassarre Petrucci pittore sanese disse che non aveva mai veduto niuno esprimer meglio gl'affetti di persone tramortite e svenute, né più si-mili al vero di quello che avea saputo fare Giovan Antonio. E nel vero è così, come oltre all'opera stessa si può vedere nel disegno che n'ho io di mano del Soddoma proprio, nel nostro libro de' disegni. A man sinistra nell'altra storia è quando l'Angelo di Dio porta alla detta Santa l'ostia della Santissima Comunione, et ella che, alzando la testa in aria, vede Gesù Cristo e Maria Vergine, mentre due suore sue compagne le stanno dietro. In un'altra storia che è nella facciata a man ritta, è dipinto un scelerato, che andando a essere decapitato, non si voleva convertire né raccomandarsi a Dio, disperando della misericordia di quello: quando, pregando per lui quella Santa in ginocchioni, furono di maniera accetti i suoi prieghi alla bontà di Dio, che tagliata la testa al reo si vide l'anima sua salire in cielo, cotanto possono appresso la bontà di Dio le preghiere di quelle sante persone che sono in sua grazia. Nella quale storia, dico, è un molto gran numero di figure, le quali niuno dee maravigliarsi se non sono d'intera perfezzione, imperò che ho inteso per cosa certa che Giovan Antonio si era ridotto a tale per infingardagine e pigrizia, che non faceva né disegni, né cartoni, quando aveva alcuna cosa simile a lavorare, ma si riduceva in sull'opera a disegnare col pennello sopra la calcina, che era cosa strana: nel qual modo si vede essere stata da lui fatta questa storia. Il medesimo dipinse ancora l'arco dinanzi di detta cappella, dove fece un Dio Padre; l'altre storie della detta cappella non furono da lui finite, parte per suo difetto, che non voleva lavorare se non a capricci, e parte per non essere stato pagato da chi faceva fare quella cappella. Sotto a questa è un Dio Padre che ha sotto una Vergine antica in tavola, con San Domenico, San Gismondo, San Bastiano e Santa Caterina. In Santo Agostino dipinse in una tavola, che è nell'entrare in chiesa a man ritta, l'adorazione de' Magi, che fu tenuta et è buon'opera; perciò che, oltre la Nostra Donna che è lodata molto et il primo de' tre Magi e certi cavalli, vi è una testa d'un pastore fra due arbori che pare veramente viva. Sopra una porta della città, detta di S. Vienno, fece a fresco in un tabernacolo grande la natività di Gesù Cristo et in aria alcuni Angeli, e nell'arco di quella un putto in iscorto bellissimo e con gran rilievo, il quale vuole mostrare che il Verbo è fatto carne. In quest'opera si ritrasse il Soddoma con la barba, essendo già vecchio, e con un pennello in mano, il quale è volto verso un brieve che dice: “Feci”. Dipinse similmente a fresco in piazza a' piedi del palazzo la cappella del Comune, facendovi la Nostra Donna col Figliuolo in collo sostenuta da alcuni putti, Santo Ansano, San Vettorio, Sant'Agostino e San Iacopo; e sopra in un mezzo circolo piramidale fece un Dio Padre con alcuni Angeli a torno; nella quale opera si vede che costui quando la fece cominciava quasi a non a-ver più amore all'arte, avendo perduto un certo che di buono che soleva avere nell'età migliori, mediante il quale dava una certa bell'aria alle teste, che le faceva esser belle e graziose. E che ciò sia vero, hanno altra grazia et altra maniera alcun'opere che fece molto innanzi a questa, come si può vedere sopra la postierla in un muro a fresco, sopra la porta del capitan Lorenzo Mariscotti, dove un Cristo morto, che è in grembo alla madre, ha una grazia e divinità maravigliosa. Similmente un quadro a olio di Nostra Donna, che egli dipinse a Messer Enea Savini dalla Costerella, è molto lodato, et una tela che fece per Assuero Rettori da S. Martino, nella quale è una Lucrezia romana che si ferisce mentre è tenuta dal padre e dal marito, fatti con bell'attitudini e bella grazia di teste. Finalmente vedendo Giovan Antonio la divozione de' sanesi era tutta volta alla virtù et opere eccellenti di Domenico Beccafumi e non avendo in Siena né casa, né entrate, et avendo già quasi consumato ogni cosa e divenuto vecchio e povero, quasi disperato si partì da Siena e se n'andò a Volterra. E come volle la sua ventura, trovando quivi Messer Lorenzo di Galeotto de' Medici, gentiluomo ricco et onorato, si cominciò a riparare appresso di lui con animo di starvi lungamente. E così dimorando in casa di lui, fece a quel signore in una tela il carro del sole, il quale essendo mal guidato da Faetonte cade nel Po, ma si vede bene che fece quell'opera per suo passatempo e che la tirò di pratica senza pensare a cosa nessuna, in modo è ordinaria da dovero e poco considerata. Venutogli poi annoia lo stare a Volterra et in casa quel gentiluomo, come colui che era avezo a essere libero, si partì et andossene a Pisa, dove per mezzo di Battista del Cervelliera fece a Messer Bastiano della Seta, Operaio del Duomo, due quadri che furono posti nella nicchia dietro all'altare maggiore del Duomo a canto a quegli del Sogliano e del Beccafumi. In uno è Cristo morto con la Nostra Donna e con l'altre Marie e nell'altro il sacrifizio d'Abramo e d'Isac suo figliuolo. Ma perché questi quadri non riuscirono molto buoni, il detto Operaio, che aveva disegnato fargli fare alcune tavole per la chiesa, lo licenziò, conoscendo che gl'uomini che non studiano, perduto che hanno in vecchiezza un certo che di buono che in giovanezza avevano da natura, si rimangono con una pratica e maniera le più volte poco da lodare. Nel medesimo tempo finì Giovan Antonio una tavola che egli avea già cominciata a olio per Santa Maria della Spina, facendovi la Nostra Donna col Figliuolo e Santa Caterina, e ritti dagli lati San Giovanni, San Bastiano e San Giuseppo; nelle quali tutte figure si portò molto meglio che ne' due quadri del Duomo. Dopo, non avendo più che fare a Pisa, si condusse a Lucca, dove in San Ponziano, luogo de' frati di Monte Oliveto, gli fece fare un abate suo conoscente una Nostra Donna al salire di certe scale che vanno in dormentorio; la quale finita, stracco, povero e vecchio se ne tornò a Siena, dove non visse poi molto: perché amalato, per non avere né chi lo governasse, né di che essere governato, se n'andò allo spedal grande e quivi finì in poche settimane il corso di sua vita.
Tolse Giovan Antonio essendo giovane et in buon credito moglie in Siena una fanciulla nata di bonissime genti e n'ebbe il primo anno una figliuola, ma poi venutagli a noia, perché egli era una bestia, non la volle mai più vedere. Onde ella ritiratasi da sé visse sempre delle sue fatiche e dell'entrate della sua dote, portando con lunga e molta pacienza le bestialità e le pazzie di quel suo uomo, degno veramente del nome di Mattaccio, che gli posero come s'è detto que' padri di Monte Oliveto. Il Riccio sanese, discepolo di Giovan Antonio e pittore assai pratico e valente, avendo presa per moglie la figliuola del suo maestro, stata molto bene e costumatamente dalla madre allevata, fu erede di tutte le cose del suocero attenenti all'arte. Questo Riccio dico, il quale ha lavorato molte opere belle e lodevoli in Siena et altrove, e nel Duomo di quella città, entrando in chiesa a man manca, una cappella lavorata di stucchi e di pitture a fresco, si sta oggi in Lucca, dove ha fatto e fa tuttavia molte opere belle e lodevoli. Fu similmente creato di Giovan Antonio un giovane che si chiamava Giomo del Soddoma, ma perché morì giovane, né potette dar se non piccol saggio del suo ingegno e sapere, non accade dirne altro. Visse il Soddoma anni settantacinque e morì l'anno 1554.
FINE DELLA VITA DEL SODDOMA, PITTORE
VITA DI BASTIANO DETTO ARISTOTILE DA SAN GALLO
PITTORE ET ARCHITETTO FIORENTINO

Quando Pietro Perugino, già vecchio, dipigneva la tavola dell'altare maggiore de' Servi in Fiorenza, un nipote di Giuliano e d'Antonio da San Gallo, chiamato Bastiano, fu acconcio seco a imparare l'arte della pittura, ma non fu il giovanetto stato molto col Perugino, che veduta in casa Medici la maniera di Michelagnolo nel cartone della sala, di cui si è già tante volte favellato, ne restò sì amirato, che non volle più tornare a bottega con Piero parendoli che la maniera di colui a petto a quella del Buonarruoti fusse secca, minuta e da non dovere in niun modo essere imitata. E perché di coloro che andavano a dipignere il detto cartone, che fu un tempo la scuola di chi volle attendere alla pittura, il più va-lente di tutti era tenuto Ridolfo Grillandai, Bastiano se lo elesse per amico, per imparare da lui a colorire, e così divennero amicissimi. Ma non lasciando perciò Bastiano di attendere al detto cartone e fare di quelli ignudi, ritrasse in un cartonetto tutta insieme l'invenzione di quel gruppo di figure, la quale niuno di tanti che vi avevano lavorato aveva mai disegnato interamente. E perché vi attese con quanto studio gli fu mai possibile, ne seguì che poi ad ogni proposito seppe render conto delle forze, attitudini e muscoli di quelle figure e quali erano state le cagioni che avevano mosso il Buonarruoto a fare alcune positure difficili. Nel che fare, parlando egli con gravità, adagio e sentenziosamente gli fu da una schiera di virtuosi artefici posto il sopranome d'Aristotile, il quale gli stette anco tanto meglio, quanto pareva che secondo un antico ritratto di quel grandissimo filosofo e secretario della natura, egli molto il somigliasse. Ma per torna-re al cartonetto ritratto da Aristotile, egli il tenne poi sempre così caro che essendo andato male l'originale del Buonarruoto, nol volle mai dare né per prezzo, né per altra cagione, né lasciarlo ritrarre, anzi nol mostrava se non come le cose preziose si fanno ai più cari amici e per favore. Questo disegno poi l'anno 1542 fu da Aristotile a persuasione di Giorgio Vasari suo amicissimo ritratto in un quadro a olio di chiaro scuro che fu mandato per mezzo di monsignor Giovio al re Francesco di Francia, che l'ebbe carissimo e ne diede premio onorato al San Gallo. E ciò fece il Vasari, perché si conservasse la memoria di quell'opera, atteso che le carte agevolmente vanno male. E perché si dilettò dunque Aristotile nella sua giovanezza, come hanno fatto gl'altri di casa sua, delle cose d'architettura, attese a misurar piante di edifizii e con molta diligenza alle cose di prospettiva, nel che fare gli fu di gran comodo un suo fratello chiamato Giovan Francesco, il quale come architettore attendeva alla fabrica di S. Piero, sotto Giuliano Leni proveditore. Giovan Francesco dunque, avendo tirato a Roma Aristotile e servendosene a tener conti in un gran maneggio che avea di fornaci, di calcine, di lavori, pozzolane e tufi che gl'apportavano grandissimo guadagno, si stette un tempo a quel modo Bastiano senza far altro che disegnare nella cappella di Michelagnolo et andarsi trattenendo per mezzo di Messer Giannozzo Pandolfini vescovo di Troia, in casa di Raffaello da Urbino. Onde, avendo poi Raffaello fatto al detto Vescovo il disegno per un palazzo che volea fare in via di S. Gallo in Fiorenza, fu il detto Giovan Francesco mandato a metterlo in opera, sì come fece con quanta diligenza è possibile che un'opera così fatta si conduca. Ma l'anno 1530, essendo morto Giovan Francesco e stato posto l'assedio intorno a Fiorenza, si rimase come diremo imperfetta quell'opera; all'esecuzione della quale fu messo poi Aristotile suo fratello, che se n'era molti e molti anni innanzi tornato come si dirà a Fiorenza, avendo sotto Giuliano Leni sopra detto, avanzato grossa somma di danari nell'aviamento che gli aveva lasciato in Roma il fratello; con una parte de' quali danari comperò Aristotile, a persuasione di Luigi Alamanni e Zanobi Buondelmonti suoi amicissimi, un sito di casa dietro al convento de' Servi, vicino ad Andrea del Sarto, dove poi, con animo di tòr donna e riposarsi, murò un'assai commoda casetta. Tornato dunque a Fiorenza Aristotile, perché era molto inclinato alla prospettiva, alla quale aveva atteso in Roma sotto Bramante, non pareva che quasi si dilettasse d'altro, ma nondimeno, oltre al fare qualche ritratto di naturale, colorì a olio in due tele grandi il mangiare il pomo di Adamo e d'Eva, quando sono cacciati di paradiso. Il che fece secondo che avea ritratto dall'opere di Michelagnolo dipinte nella volta della cappella di Roma. Le quali due tele d'Aristotile gli furono, per averle tolte di peso dal detto luogo, poco lodate; ma all'incontro gli fu ben lodato tutto quello che fece in Fiorenza nella venuta di papa Leone, facendo in compagnia di Francesco Granacci un arco trionfale dirimpetto alla porta di Badia, con molte storie, che fu bellissimo. Parimente nelle nozze del duca Lorenzo de' Medici fu di grande aiuto in tutti gl'apparati e massimamente in alcune prospettive per comedie al Francia Bigio e Ridolfo Grillandaio, che avevan cura d'ogni cosa, Fece dopo molti quadri di Nostre Donne a olio, parte di sua fantasia e parte ritratte da opere d'altri, e fra l'altre ne fece una simile a quella che Raffaello dipinse al Popolo in Roma, dove la Madonna cuopre [il] putto con un velo, la quale ha oggi Filippo dell'Antella; un'altra ne hanno gl'eredi di Mes-ser Ottaviano de' Medici insieme col ritratto del detto Lorenzo, il quale Aristotile ricavò da quello che avea fatto Raffaello. Molti altri quadri fece ne' medesimi tempi, che furono mandati in Inghilterra. Ma conoscendo Aristotile di non avere invenzione, e quanto la pittura richieggia studio e buon fondamento di disegno, e che per mancar di queste parti non poteva gran fatto divenire eccellente, si risolvé di volere che il suo esercizio fusse l'architettura e la prospettiva facendo scene da comedie a tutte l'occasioni che se gli porgessero, alle quali aveva molta inclinazione. Onde avendo il già detto vescovo di Troia rimesso mano al suo palazzo in via di San Gallo, n'ebbe cura Aristotile, il quale col tempo lo condusse con molta sua lode al termine che si vede.
Intanto avendo fatto Aristotile grande amicizia con Andrea del Sarto suo vicino, dal quale imparò a fare molte cose perfettamente, attendendo con molto studio alla prospettiva, onde poi fu adoperato in molte feste che si fecero da alcune Compagnie di gentiluomini, che in quella tranquillità di vivere erano allora in Firenze. Onde avendosi a fare recitare dalla Compagnia della Cazzuola in casa di Bernardino di Giordano, al canto a Monteloro, la Mandragola, piacevolissima comedia, fecero la prospettiva, che fu bellissima, Andrea del Sarto et Aristotile. E non molto dopo alla porta San Friano fece Aristotile un'altra prospettiva in casa Iacopo Fornaciaio, per un'altra comedia del medesimo autore. Nelle quali prospettive e scene, che molto piacquero all'universale, et in particolare al signor Alessandro et Ipolito de' Medici, che allora erano in Fiorenza sotto la cura di Silvio Passerini cardinale di Cortona, acquistò di maniera nome Aristotile, che di quella fu poi sempre la sua principale professione, anzi come vogliono alcuni, gli fu posto quel sopranome parendo che veramente nella prospettiva fusse quello che Aristotile nella filosofia. Ma come spesso adiviene, che da una somma pace e tranquillità si viene alle guerre e discordie, venuto l'anno 1527, si mutò in Fiorenza ogni letizia e pace in dispiacere e travagli, perché, essendo allora cacciati i Medici e dopo venuta la peste e l'assedio, si visse molti anni poco lietamente; onde non si facendo allora dagl'artefici alcun bene, si stette Aristotile in que' tempi sempre a casa, attendendo a' suoi studii e capricci. Ma venuto poi al governo di Fiorenza il duca Alessandro, e cominciando alquanto a rischiarare ogni cosa, i giovani della Compagnia de' Fanciulli della Purificazione, dirimpetto a San Marco, ordinarono di fare una tragicomedia, cavata dei libri de' Re, delle tribolazioni che furono per la violazione di Tamar, la quale avea composta Giovan Maria Primerani. Per che, dato cura della scena e prospettiva ad Aristotile, egli fece una scena, la più bella (per quanto capeva il luogo) che fusse stata fatta già mai. E perché oltre al bell'apparato, la tragicomedia fu bella per sé e ben recitata, e molto piacque al duca Alessandro et alla sorella che l'udirono, fecero loro eccellenze liberare l'autore di essa, che era in carcere, con questo che dovesse fare un'altra comedia a sua fantasia. Il che avendo fatto, Aristotile fece nella loggia del giardino de' Medici in sulla piazza di San Marco una bellissima scena e prospettiva, piena di colonnati, di nicchie, di tabernacoli, statue e molte altre cose capricciose, che in sin'allora in simili apparati non erano state usate, le quali tutte piacquero infinitamente et hanno molto arrichito quella maniera di pitture. Il soggetto della comedia fu Ioseffo accusato falsamente d'avere voluto violare la sua padrona, e per ciò incarcerato e poi liberato per l'interpreta-zione del sogno del re. Essendo dunque anco questa scena molto piaciuta al Duca, ordinò quando fu el tempo, che nelle sue nozze e di madama Margherita d'Austria si facesse una comedia e la scena da Aristotile in via di San Gallo nella Compagnia de' Tessitori congiunta alle case del Magnifico Ottaviano de' Medici. Al che avendo messo mano Aristotile con quanto studio, diligenza e fatica gli fu mai possibile, condusse tutto quell'apparato a perfezione. E perché Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, avendo egli composta la comedia che si aveva da recitare, avea cura di tutto l'apparato e delle musiche, come quegli che andava sempre pensando in che modo potesse uccidere il Duca, dal quale era cotanto amato e favorito, pensò di farlo capitar male nell'apparato di quella comedia. Costui dunque, là dove terminavano le scale della prospettiva et il palco della scena, fece da ogni banda delle cortine delle mura gettate in terra diciotto braccia di muro per altezza, per rimurare dentro una stanza a uso di scarsella che fusse assai capace et un palco alto quanto quello della scena, il quale servisse per la musica di voci; e sopra il primo volea fare un altro palco per gravicemboli, organi et altri simili instrumenti, che non si possono così facilmente muovere, né mutare; et il vano dove avea rovinato le mura dinanzi volea che fusse coperto di tele dipinte in prospettiva e di casamenti. Il che tutto piaceva ad Aristotile, perché arrichiva la scena e lasciava libero il palco di quella dagl'uomini della musica; ma non piaceva già ad esso Aristotile che il cavallo che sosteneva il tetto, il quale era rimaso senza le mura di sotto che il reggevano, si accomodasse altrimenti che con un arco grande e doppio che fusse gagliardissimo, là dove voleva Lorenzo che fusse retto da certi puntelli e non da altro che potesse in niun modo impedire la musica. Ma conoscendo Aristotile che quella era una trappola da rovinare addosso a una infinità di persone, non si voleva in questo accordare in modo veruno con Lorenzo, il quale in verità non aveva altro animo che d'uccidere in quella rovina il Duca. Per che, vedendo Aristotile di non poter mettere nel capo a Lorenzo le sue buone ragioni, avea deliberato di volere andarsi con Dio, quando Giorgio Vasari, il quale allora benché giovanetto stava al servizio del duca Alessandro et era creatura d'Ottaviano de' Medici, sentendo mentre dipigneva in quella scena le dispute e dispiaceri che erano fra Lorenzo et Aristotile, si mise destramente di mezzo, et udito l'uno e l'altro et il pericolo che seco portava il modo di Lorenzo, mostrò che senza fare l'arco o impedire in altra guisa il palco delle musiche, si poteva il detto cavallo del tetto assai facilmente accomodare, mettendo due legni doppii di quindici braccia l'uno per la lunghezza del muro; e quelli bene allacciati con spranghe di ferro allato agl'altri cavalli, sopra essi posare sicuramente il cavallo di mezzo, perciò che vi stava sicurissimo come sopra l'arco arebbe fatto né più né meno. Ma non volendo Lorenzo credere né ad Aristotile, che l'approvava, né a Giorgio che il proponeva, non faceva altro che contraporsi con sue cavillazioni che facevano conoscere il suo cattivo animo ad ognuno, per che, veduto Giorgio che disordine grandissimo poteva di ciò seguire e che questo non era altro che un volere amazzare trecento persone, disse che volea per ogni modo dirlo al Duca, acciò mandasse a vedere e provedere al tutto. La qual cosa sentendo Lorenzo e dubitando di non scoprirsi, dopo molte parole diede licenzia ad Aristotile che seguisse il parere di Giorgio e così fu fatto. Questa scena dunque fu la più bella che non solo insino allora avesse fatto Aristotile, ma che fusse stata fatta da altri già mai, avendo in essa fatto molte cantonate di rilievo e contrafatto nel mezzo del foro un bellissimo arco trionfale, finto di marmo, pieno di storie e di statue; senza le strade che sfuggivano e molte altre cose fatte con bellissime invenzioni et incredibile studio e diligenza.
Essendo poi stato morto dal detto Lorenzo il duca Alessandro e creato il duca Cosimo l'anno 1536, quando venne a marito la signora donna Leonora di Tolledo, donna nel vero rarissima e di cioè sì grande et incomparabile valore, che può a qual sia più celebre e famosa nell'antiche storie senza contrasto aguagliarsi e per aventura preporsi, nelle nozze che si fecero a dì 27 di giugno l'anno 1539, fece Aristotile nel cortile grande del palazzo de' Medici, dove è la fonte, u-n'altra scena che rappresentò Pisa, nella quale vinse se stesso, sempre migliorando e variando. Onde non è possibile mettere insieme mai né la più variata sorte di finestre e porte, né facciate di palazzi più bizzarre e capricciose, né strade
o lontani che meglio sfuggano e facciano tutto quello che l'ordine vuole della prospettiva. Vi fece oltra di questo il campanile torto del Duomo, la cupola et il tempio tondo di S. Giovanni con altre cose di quella città. Delle scale che fece in questa non dirò altro, né quanto rimanessero ingannati, per non parere di dire il medesimo che s'è detto altre vol-te; dirò bene che questa, la quale mostrava salire da terra in su quel piano, era nel mezzo a otto facce e dalle bande qua-dra, con artifizio nella sua semplicità grandissimo, perché diede tanta grazia alla prospettiva di sopra, che non è possibile in quel genere veder meglio. Appresso ordinò con molto ingegno una lanterna di legname a uso d'arco, dietro a tutti i casamenti, con un sole alto un braccio fatto con una palla di cristallo piena d'acqua stillata, dietro la quale erano due torchi accesi che la facevano in modo risplendere, che ella rendeva luminoso il cielo della scena e la prospettiva in guisa che pareva veramente il sole vivo e naturale. E questo sole dico, avendo intorno un ornamento di razzi d'oro che coprivano la cortina, era di mano in mano per via d'un arganetto, che era tirato con sì fatt'ordine, che a principio della comedia pareva che si levasse il sole, e che salito infino al mezzo dell'arco, scendesse in guisa, che al fine della comedia entrasse sotto e tramontasse. Compositore della comedia fu Anton Landi gentiluomo fiorentino, e sopra gl'intermedii e la musica fu Giovan Batista Strozzi allora giovane e di bellissimo ingegno. Ma perché dell'altre cose che adornarono questa comedia, gl'intermedii e le musiche, fu scritto allora a bastanza, non dirò altro se non chi furono coloro che fecero alcune pitture, bastando per ora sapere che l'altre cose condussero il detto Giovan Batista Strozzi, il Tribolo et Aristotile. Erano sotto la scena della comedia le facciate dalle bande spartite in sei quadri dipinti e grandi braccia otto l'uno e larghi cinque, ciascuno de' quali aveva intorno un ornamento largo un braccio e due terzi, il quale faceva fregiatura intorno et era scorniciato verso le pitture, facendo quattro tondi in croce con due motti latini per ciascuna storia, e nel resto erano imprese a proposito; sopra girava un fregio di rovesci azzurri a torno a torno, salvo che dove era la prospettiva, e sopra questo era un cielo pur di rovesci, che copriva tutto il cortile, nel quale fregio di rovesci, sopra ogni quadro di storia era l'arme d'alcuna delle famiglie più illustri, con le quali avevano avuto parentado la casa de' Medici. Cominciandomi dunque dalle parte di levante, a canto alla scena nella prima storia, la quale era di mano di Francesco Ubertini detto il Bachiacca, era la tornata d'esilio del Magnifico Cosimo de' Medici, l'impresa erano due colombe sopra un ramo d'oro, e l'arme che era nel fregio era quella del duca Cosimo; nell'altro, il quale era di mano del medesimo, era l'andata a Napoli del Magnifico Lorenzo, l'impresa un pellicano, e l'arme quella del duca Lorenzo, cioè Medici e Savoia; nel terzo quadro, stato dipinto da Pierfrancesco di Iacopo di Sandro, era la venuta di papa Leone X a Fiorenza, portato dai suoi cittadini sotto il baldacchino: l'impresa era un braccio ritto, e l'arme quella del duca Giuliano, cioè Medici e Savoia; nel quarto quadro, di mano del medesimo, era Biegrassa presa dal signor Giovanni, che di quella si vedeva uscire vettorioso: l'impresa era il fulmine di Giove, e l'arme del fregio era quella del duca Alessandro, cioè Austria e Medici; nel quinto, papa Clemente coronava in Bologna Carlo V: l'impresa era un serpe che si mordeva la coda, e l'arme era di Francia e Medici, e questa era di mano di Domenico Conti, discepolo d'Andrea del Sarto, il quale mostrò non valere molto, mancatogli l'aiuto d'alcuni giovani de' quali pensava servirsi, perché tutti i buoni e cattivi erano in opera. Onde fu riso di lui, che molto presumendosi, si era altre volte con poco giudizio riso d'altri. Nella sesta storia et ultima da quella banda era di mano del Bronzino la disputa che ebbono tra loro in Napoli et innanzi all'imperatore, il duca Alessandro et i fuoriusciti fiorentini, col fiume Sebeto e molte figure, e questo fu bellissimo quadro e migliore di tutti gl'al-tri: l'impresa era una palma, e l'arme quella di Spagna. Dirimpetto alla tornata del Magnifico Cosimo, cioè dall'altra banda, era il felicissimo natale del duca Cosimo: l'impresa era una fenice, e l'arme quella della città di Fiorenza, cioè un giglio rosso. A canto a questo era la creazione o vero elezzione del medesimo alla degnità del ducato: l'impresa il caduceo di Mercurio, e nel fregio l'arme del castellano della fortezza. E questa storia, essendo stata disegnata da Francesco Salviati, perché ebbe a partirsi in que' giorni di Fiorenza, fu finita eccellentemente da Carlo Portelli da Loro. Nella terza erano i tre superbi oratori campani cacciati del senato romano per la loro temeraria dimanda, secondo che racconta Tito Livio nel ventesimo libro della sua storia, i quali in questo luogo significavano tre cardinali venuti invano al duca Cosimo con animo di levarlo del governo: l'impresa era un cavallo alato, e l'arme quella de' Salviati e Medici. Nell'altro era la presa di Monte Murlo: l'impresa un assiuolo egizzio sopra la testa di Pirro, e l'arme quella di casa Sforza e Medici, nella quale storia, che fu dipinta da Antonio di [Donnino di] Domenico pittore fiero nelle movenze, si vedeva nel lontano una scaramuccia di cavalli tanto bella, che quel quadro, di mano di persona riputata debole, riuscì molto migliore che l'opere d'alcuni altri che erano valentuomini solamente in openione. Nell'altro si vedeva il duca Cosimo essere investito dalla maestà cesarea di tutte l'insegne et imprese ducali: l'impresa era una pica con foglie d'alloro in bocca, e nel fregio era l'arme de' Medici e di Tolledo, e questa era di mano di Battista Franco viniziano. Nell'ultimo di tutti questi quadri erano le nozze del medesimo duca Cosimo fatte in Napoli: l'impresa erano due cornici, simbolo antico delle nozze, e nel fregio era l'arme di don Petro di Tolledo viceré di Napoli, e questa, che era di mano del Bronzino, era fatta con tanta grazia, che superò come la prima tutte l'altre storie. Fu similmente ordinato dal medesimo Aristotile, sopra la loggia, un fregio con altre storiette et arme che fu molto lodato e piacque a sua eccellenza che di tutto il remunerò largamente. E dopo, quasi ogni anno, fece qualche scena e prospettiva per le comedie che si facevano per carnovale, avendo in quella maniera di pitture tanta pratica et aiuto dalla natura, che aveva disegnato volere scriverne et insegnare, ma perché la cosa gli riuscì più difficile che non s'aveva pensato, se ne tolse giù, e massimamente essendo poi stato da altri che governarono il palazzo fatto fare prospettive dal Bronzino e Francesco Salviati, come si dirà a suo luogo.
Vedendo adunque Aristotile essere passati molti anni, ne' quali non era stato adoperato, se n'andò a Roma a trovare Antonio da San Gallo suo cugino, il quale subito che fu arivato, dopo averlo ricevuto e veduto ben volentieri, lo mise a sollecitare alcune fabriche con provisione di scudi dieci il mese, e dopo lo mandò a Castro, dove stette alcuni mesi di commessione di papa Paulo Terzo a condurre gran parte di quelle muraglie secondo il disegno et ordine d'Antonio. E conciò fusse che Aristotile, essendosi alevato con Antonio da piccolo et avezzatosi a procedere seco troppo familiarmente, dicono che Antonio lo teneva lontano, perché non si era mai potuto avezare a dirgli voi, di maniera che gli dava del tu, se ben fussero stati dinanzi al Papa non che in un cerchio di signori e gentiluomini, nella maniera che ancor fanno altri fiorentini avezzi all'antica et a dar del tu ad ognuno, come fussero da Norcia, senza sapersi accomodare al vive-re moderno secondo che fanno gl'altri, e con l'usanza portano di mano in mano. La qual cosa quanto paresse strana ad Antonio, avezzo a essere onorato da cardinali et altri grand'uomini, ognuno se lo pensi. Venuta dunque a fastidio ad Aristotile la stanza di Castro, pregò Antonio che lo facesse tornare a Roma, di che lo compiacque Antonio molto volentieri, ma gli disse che procedesse seco con altra maniera e miglior creanza, massimamente là dove fussero in presenza di gran personaggi.
Un anno di carnovale, facendo in Roma Ruberto Strozzi banchetto a certi signori suoi amici, et avendosi a recitare una comedia nelle sue case, gli fece Aristotile nella sala maggiore una prospettiva (per quanto si poteva in stretto luogo) bellissima e tanto vaga e graziosa, che fra gl'altri il cardinal Farnese, non pure ne restò maravigliato, ma gliene fece fare una nel suo palazzo di San Giorgio, dove è la cancelleria, in una di quelle sale mezzane che rispondono in sul giardino, ma in modo, che vi stesse ferma, per poter ad ogni sua voglia e bisogno servirsene. Questa dunque fu da Aristotile condotta con quello studio che seppe e poté maggiore, di maniera, che sodisfece al cardinale e gl'uomini dell'arte infinitamente. Il quale cardinale avendo commesso a Messer Curzio Frangipane che sodisfacesse Aristotile, e colui volendo come discreto, fargli il dovere, et anco non soprapagare, disse a Perino del Vaga et a Giorgio Vasari che stimassero quell'opera. La qual cosa fu molto cara a Perino, perché portando odio ad Aristotile et avendo per male che avesse fatto quella prospettiva, la quale gli pareva dovere che avesse dovuto toccare a lui come a servitore del cardinale, stava tutto pieno di timore e gelosia, e massimamente essendosi, non pure d'Aristotile, ma anco del Vasari servito in que' giorni il cardinale e donatogli mille scudi per avere dipinto a fresco in cento giorni la sala di Parco Maiori nella cancelleria. Disegnava dunque Perino per queste cagioni di stimare tanto poco la detta prospettiva d'Aristotile, che s'avesse a pentire d'averla fatta; ma Aristotile avendo inteso chi erano coloro che avevano a stimare la sua prospettiva, andato a trovare Perino, alla bella prima gli cominciò secondo il suo costume a dare per lo capo del tu, per essergli colui stato amico in giovanezza. Laonde Perino, che già era di mal animo, venne in collera, e quasi scoperse non se n'aveggendo quello che in animo aveva malignamente di fare. Per che, avendo il tutto raccontato Aristotile al Vasari, gli disse Giorgio che non dubitasse, ma stesse di buona voglia, che non gli sarebbe fatto torto. Dopo trovandosi insieme per terminare quel negozio Perino e Giorgio, cominciando Perino, come più vecchio, a dire, si diede a biasimare quella prospettiva et a dire ch'ell'era un lavoro di pochi baiocchi, e che avendo Aristotile avuto danari a buon conto e statogli pagati coloro che l'a-vevano aiutato, egli era più che soprapagato, aggiugnendo: “S'io l'avessi avuta a far io, l'arei fatta d'altra maniera e con altre storie et ornamenti che non ha fatto costui, ma il cardinal toglie sempre a favorire qualcuno che gli fa poco onore”. Delle quali parole et altre conoscendo Giorgio che Perino voleva più tosto vendicarsi dello sdegno, che avea col cardinale, con Aristotile, che con amorevole pietà far riconoscere le fatiche e la virtù d'un buono artefice, con dolci parole disse a Perino: “Ancor ch'io non m'intenda di sì fatte opere più che tanto, avendone nondimeno vista alcuna di mano di chi sa farle, mi pare che questa sia molto ben condotta e degna d'essere stimata molti scudi, e non pochi, come voi dite, baiocchi; e non mi pare onesto che chi sta per gli scrittoi a tirare in su le carte, per poi ridurre in grand'opere tante cose variate in prospettiva, debba essere pagato delle fatiche della notte e da vantaggio del lavoro di molte settimane, nella maniera che si pagano le giornate di coloro che non vi hanno fatica d'animo e di mane e poca di corpo, bastando imita-re, senza stillarsi altrimenti il cervello come ha fatto Aristotile. E quando l'aveste fatta voi, Perino, con più storie et ornamenti, come dite, non l'areste forse tirata con quella grazia che ha fatto Aristotile, il quale in questo genere di pittura è con molto giudizio stato giudicato dal cardinale miglior maestro di voi. Ma considerate che alla fine non si fa danno, giudicando male e non dirittamente, ad Aristotile, ma all'arte, alla virtù e molto più all'anima, e se vi partirete dall'one-sto per alcun vostro sdegno particolare, senza che chi la conosce per buona non biasimerà l'opera, ma il nostro debole giudizio e forse la malignità e nostra cattiva natura. E chi cerca di gratuirsi ad alcuno, d'aggrandire le sue cose o vendicarsi d'alcuna ingiuria col biasimare o meno stimare di quel che sono le buone opere altrui, è finalmente da Dio e da-gl'uomini conosciuto per quello che egli è, cioè per maligno, ignorante, cattivo. Considerate, voi che fate tutti i lavori di Roma, quello che vi parrebbe se altri stimasse le cose vostre quanto voi fate l'altrui, mettetevi di grazia ne' piè di questo povero vecchio, e vedrete quanto lontano siete dall'onesto e ragionevole”. Furono di tanta forza queste et altre parole che disse Giorgio amorevolmente a Perino, che si venne a una stima onesta e fu sodisfatto Aristotile, il quale con que' danari, con quelli del quadro mandato, come a principio si disse, in Franzia, e con gl'avanzi delle sue provisioni, se ne tornò lieto a Firenze, non ostante che Michelagnolo, il quale gl'era amico, avesse disegnato servirsene nella fabrica che i romani disegnavano di fare in Campidoglio. Tornato dunque a Firenze Aristotile l'anno 1547, nell'andare a baciar le mani al signor duca Cosimo, pregò sua eccellenza che volesse, avendo messo mano a molte fabriche, servirsi dell'opera sua et aiutarlo; il qual signore, avendolo benignamente ricevuto come ha fatto sempre gli uomini virtuosi, ordinò che gli fusse dato di provisione dieci scudi il mese, et a lui disse che sarebbe adoperato secondo l'occorrenze che venissero; con la quale provisione senza fare altro visse alcuni anni quietamente, e poi si morì d'anni settanta l'anno 1551, l'ultimo dì di maggio, e fu sepolto nella chiesa de' Servi.
Nel nostro libro sono alcuni disegni di mano d'Aristotile, et alcuni ne sono appresso Antonio Particini, fra i quali sono alcune carte tirate in prospettiva bellissime. Vissero ne' medesimi tempi che Aristotile e furono suoi amici, due pittori, de' quali farò qui menzione brievemente, però che furono tali che fra questi rari ingegni meritano d'aver luogo per alcune opere che fecero, degne veramente d'essere lodate. L'uno fu Iacone e l'altro Francesco Ubertini cognominato il Bacchiacca. Iacone adunque non fece molte opere, come quegli che se n'andava in ragionamenti e baie, e si contentò di quel poco che la sua fortuna e pigrizia gli providero, che fu molto meno di quello che arebbe avuto di bisogno. Ma perché praticò assai con Andrea del Sarto, disegnò benissimo e con fierezza, e fu molto bizzarro e fantastico nella positura delle sue figure, stravolgendole e cercando di farle variate, diferenziate dagl'altri in tutti i suoi componimenti: e nel vero ebbe assai disegno, e quando volle imitò il buono. In Fiorenza fece molti quadri di Nostre Donne, essendo anco giovane, che molti ne furono mandati in Francia da mercatanti fiorentini; in Santa Lucia della via de' Bardi fece in una tavola Dio Padre, Cristo e la Nostra Donna con altre figure, et a Montici in sul canto della casa di Lodovico Capponi due figure di chiaro scuro intorno a un tabernacolo; in San Romeo dipinse in una tavola la Nostra Donna e due Santi. Sentendo poi una volta molto lodare le facciate di Pulidoro e Maturino fatte in Roma e dove fece alcuni ritratti, senza che niuno il sapesse, se n'andò a Roma dove stette alcuni mesi acquistando nelle cose dell'arte in modo che riuscì poi in molte cose ragionevole dipintore. Onde il cavaliere Buondelmonti gli diede a dipignere di chiaro scuro una sua casa, che avea murata dirimpetto a Santa Trinita al principio di borgo Santo Apostolo, nella quale fece Iacone istorie della vita d'Alessandro Magno, in alcune cose molto belle e condotte con tanta grazia e disegno, che molti credono che di tutto gli fussero fatti i disegni da Andrea del Sarto. E per vero dire, al saggio che di sé diede Iacone in quest'opera, si pensò che avesse a fare qualche gran frutto, ma perché ebbe sempre più il capo a darsi buon tempo et altre baie et a sta-re in cene e feste con gl'amici che a studiare e lavorare, più tosto andò disamparando sempre che acquistando. Ma quello che era cosa non so se degna di riso, o di compassione, egli era d'una compagnia d'amici, o più tosto masnada, che sotto nome di vivere alla filosofica, viveano come porci e come bestie, non si lavavano mai né mani, né viso, né capo, né barba, non spazzavano la casa e non rifacevano il letto se non ogni due mesi una volta, apparecchiavano con i cartoni delle pitture le tavole e non beevano se non al fiasco et al boccale, e questa loro meschinità e vivere, come si dice, alla carlona, era da loro tenuta la più bella vita del mondo. Ma perché il di fuori suole essere indizio di quello di dentro, e dimostrare quali sieno gl'animi nostri, crederò, come s'è detto altra volta, che così fussero costoro lordi e brutti nell'a-nimo come di fuori apparivano.
Nella festa di San Felice in Piazza (cioè rappresentazione della Madonna quando fu anunziata, della quale si è ragionato in altro luogo) la quale fece la Compagnia dell'Orciuolo l'anno 1525, fece Iacone nell'apparato di fuori, secondo che allora si costumava, un bellissimo arco trionfale, tutto isolato, grande e doppio con otto colonne e pilastri, frontespizio molto alto, il quale fece condurre a perfezzione da Piero da Sesto, maestro di legname molto pratico, e dopo vi fece nove storie, parte delle quali dipinse egli, che furono le migliori, e l'altre Francesco Ubertini Bacchiacca; le quali storie furono tutte del Testamento Vecchio e per la maggior parte de' fatti di Moisè. Essendo poi condotto Iacone da un frate scopetino suo parente a Cortona, dipinse nella chiesa della Madonna, la quale è fuori della città, due tavole a olio: in una è la Nostra Donna con San Rocco, Santo Agostino et altri Santi, e nell'altra un Dio Padre che incorona la Nostra Donna con dua Santi da piè, e nel mezzo è San Francesco che riceve le stimate; le qual due opere furono molte belle. Tornatosene poi a Firenze, fece a Bongianni Caponi una stanza in volta in Fiorenza, et al medesimo ne accomodò nella villa di Montici alcun'altre; e finalmente, quando Iacopo Puntormo dipinse al duca Alessandro nella villa di Careggi quella loggia di cui si è nella sua vita favellato, gl'aiutò fare la maggior parte di quegl'ornamenti di grottesche et altre cose, dopo le quali si adoperò in certe cose minute, delle quali non accade far menzione. La somma è che Iacone spese il miglior tempo di sua vita in baie, andandosene in considerazioni et in dir male di questo e di quello, essendo in que' tempi ridotta in Fiorenza l'arte del disegno in una compagnia di persone che più attendevano a far baie et a godere che a lavorare, e lo studio de' quali era ragunarsi per le botteghe et in altri luoghi e quivi malignamente e con loro gerghi attendere a biasimare l'opere d'alcuni che erano eccellenti e vivevano civilmente e come uomini onorati. Capi di questi erano Iacone, il Piloto orefice et il Tasso legnaiuolo, ma il peggiore di tutti era Iacone, perciò che fra l'altre sue buone parti, sempre nel suo dire mordeva qualcuno di malasorte, onde non fu gran fatto che da cotal compagnia avessero poi col tempo, come si dirà, origine molti mali, né che fusse il Piloto, per la sua mala lingua, ucciso da un giovane; e perché le costoro operazioni e costumi non piacevano agl'uomini da bene, erano, non dico tutti, ma una parte di loro, sempre come i battilani et altri simili a fare alle piastrelle lungo le mura, o per le taverne a godere. Tornando un giorno Giorgio Vasari da Monte Oliveto, luogo fuor di Firenze, da vedere il reverendo e molto virtuoso don Miniato Pitti, abate allora di quel luogo, trovò Iacone con una gran parte di sua brigata in sul canto de' Medici, il quale pensò, per quanto intesi poi, di volere con qualche sua cantafavola, mezzo burlando e mezzo dicendo da dovero, dire qualche parola ingiuriosa al detto Giorgio. Per che, entrato egli così a cavallo fra loro gli disse Iacone: “Orbè, Giorgio”, disse, “come va ella?”. “Va bene, Iacone mio”, rispose Giorgio; “io era già povero come tutti voi et ora mi truovo tre mila scudi o meglio: ero tenuto da voi goffo, et i frati e preti mi tengono valentuomo; io già serviva voialtri, et ora questo famiglio, che è qui, serve me e governa questo cavallo; vestiva di que' panni che vestono i dipintori che son poveri, et ora son vestito di velluto; andava già a piedi et ora vo a cavallo, sì che, Iacon mio, ella va bene affatto; rimanti con Dio.” Quando il povero Iacone sentì a un tratto tante cose, perdé ogni invenzione e si rimase senza dir altro tutto stordito, quasi considerando la sua miseria, e che le più volte rimane l'ingannatore a' piè dell'ingannato. Finalmente essendo stato Iacone da una infermità mal condotto, essendo povero, senza governo e rattrappato delle gambe senza potere aiutarsi, si morì di stento in una sua casipola che aveva in una piccola strada o vero chiasso, detto Coda rimessa, l'anno 1553.
Francesco d'Ubertino detto Bacchiacca, fu diligente dipintore, et ancor che fusse amico di Iacone, visse sempre assai costumatamente e da uomo da bene; fu similmente amico d'Andrea del Sarto e da lui molto aiutato e favorito nelle cose dell'arte. Fu, dico, Francesco diligente pittore, e particolarmente in fare figure piccole, le quali conduceva perfette e con molta pacienza, come si vede in S. Lorenzo di Fiorenza, in una predella della storia de' Martiri, sotto la tavola di Giovan Antonio Sogliani, e nella cappella del Crucifisso, in un'altra predella molto ben fatta. Nella camera di Pier Francesco Borgherini, della quale si è già tante volte fatto menzione, fece il Bacchiacca in compagnia degl'altri molte figurine ne' cassoni e nelle spalliere, che alla maniera sono conosciute come differenti dall'altre; similmente nella già detta anticamera di Giovan Maria Benintendi, fece due quadri molto belli di figure piccole, in uno de' quali, che è il più bello e più copioso di figure, è il Battista che battezza Gesù Cristo nel Giordano. Ne fece anco molti altri per diversi, che furono mandati in Francia et in Inghilterra. Finalmente il Bacchiacca andato al servizio del duca Cosimo, perché era ottimo pittore in ritrarre tutte le sorti d'animali, fece a sua eccellenza uno scrittoio tutto pieno d'uccelli di diverse maniere e d'erbe rare, che tutto condusse a olio divinamente. Fece poi di figure piccole i cartoni di tutti i mesi dell'anno, che furono infinite messe in opera, di bellissimi panni d'arazzo di seta e d'oro, con tanta industria e diligenza, che in quel genere non si può veder meglio da Marco di maestro Giovanni Rosto fiamingo. Dopo le quali opere condusse il Bacchiacca a fresco la grotta d'una fontana d'acqua che è a Pitti, et in ultimo fece i disegni per un letto che fu fatto di ricami, tutto pieno di storie e di figure piccole che fu la più ricca cosa di letto che di simile opera possa vedersi, essendo stati condotti i ricami pieni di perle e d'altre cose di pregio da Antonio Bacchiacca fratello di Francesco, il quale è ottimo ricamatore. E perché Francesco morì avanti che fusse finito il detto letto, che ha servito per le felicissime nozze del-l'illustrissimo signor principe di Firenze, don Francesco Medici, e della serenissima reina Giovanna d'Austria, egli fu finito in ultimo con ordine e disegno di Giorgio Vasari.
Morì Francesco l'anno 1557 in Firenze.
VITA DI BENVENUTO GAROFALO E DI GIROLAMO DA CARPI
PITTORI FERRARESI E D'ALTRI LOMBARDI

In questa parte delle Vite, che noi ora scriviamo, si farà brievemente un raccolto di tutti i migliori e più eccellenti pittori, scultori et architetti che sono stati a' tempi nostri in Lombardia, dopo il Mantegna, il Costa, Boccaccino da Cremona et il Francia bolognese, non potendo fare la vita di ciascuno in particolare, e parendomi a bastanza raccontare l'o-pere loro; la qual cosa io non mi sarei messo a fare, né a dar di quelle giudizio se io non l'avessi prima vedute. E perché dall'anno 1542 insino a questo presente 1566 io non aveva, come già feci, scorsa quasi tutta l'Italia, né veduto le dette et altre opere, che in questo spazio di ventiquattro anni sono molto cresciute, io ho voluto, essendo quasi al fine di questa mia fatica, prima che io le scriva, vederle e con l'occhio farne giudizio. Per che, finite le già dette nozze dell'illustrissi-mo signor don Francesco Medici, prencipe di Fiorenza e di Siena, mio signore, e della serenissima reina Giovanna d'Austria, per le quali io era stato due anni occupatissimo nel palco della principale sala del loro palazzo, ho voluto senza perdonare a spesa o fatica veruna, rivedere Roma, la Toscana, parte della Marca, l'Umbria, la Romagna, la Lombardia e Vinezia, con tutto il suo dominio, per rivedere le cose vecchie e molte che sono state fatte dal detto anno 1542 in poi. Avendo io dunque fatto memoria delle cose più notabili e degne d'esser poste in iscrittura, per non far torto alla virtù di molti, né a quella sincera verità che si aspetta a coloro che scrivono istorie di qualunche maniera, senza passione d'animo verrò scrivendo quelle cose che in alcuna parte mancano alle già dette, senza partirmi dall'ordine della storia, e poi darò notizia dell'opere d'alcuni che ancora son vivi e che hanno cose eccellenti operato et operano, parendomi che così richieggia il merito di molti rari e nobili artefici.
Cominciandomi dunque dai ferraresi, nacque Benvenuto Garofalo in Ferrara l'anno 1481 di Piero Tisi, i cui maggiori erano stati per origine padoani. Nacque, dico, di maniera inclinato alla pittura, che ancor piccolo fanciulletto, mentre andava alla scuola di leggere, non faceva altro che disegnare, dal quale esercizio, ancor che crescesse, il padre, che avea la pittura per una baia, di distorlo non fu mai possibile. Per che, veduto il padre che bisognava secondare la natura di questo suo figliuolo, il quale non faceva altro giorno e notte che disegnare, finalmente l'acconciò in Ferrara con Domenico Laneto, pittore in quel tempo di qualche nome, se bene avea la maniera secca e stentata; col quale Domenico, essendo stato Benvenuto alcun tempo, nell'andare una volta a Cremona gli venne veduto nella cappella maggiore del Duomo di quella città, fra l'altre cose di mano di Boccaccino Boccacci pittore cremonese, che avea lavorata quella tribuna a fresco, un Cristo, che sedendo in trono et in mezzo a quattro Santi, dà la benedizione. Per che, piaciutagli quel-l'opera, si acconciò, per mezzo d'alcuni amici, con esso Boccaccino, il quale allora lavorava nella medesima chiesa pur a fresco alcune storie della Madonna, come si è detto nella sua vita, a concorrenza di Altobello pittore, il quale lavorava nella medesima chiesa dirimpetto a Boccaccino alcune storie di Gesù Cristo, che sono molto belle e veramente degne di essere lodate. Essendo dunque Benvenuto stato due anni in Cremona et avendo molto acquistato sotto la disciplina di Boccaccino, se n'andò d'anni diciannove a Roma l'anno 1500, dove postosi con Giovanni Baldini pittor fiorentino, assai pratico, et il quale aveva molti bellissimi disegni di diversi maestri eccellenti, sopra quelli, quando tempo gl'avanzava e massimamente la notte, si andava continuamente esercitando. Dopo, essendo stato con costui quindici mesi et avendo veduto con molto suo piacere le cose di Roma, scorso che ebbe un pezzo per molti luoghi d'Italia, si condusse finalmente a Mantova, dove appresso Lorenzo Costa pittore stette due anni, servendolo con tanta amorevolezza, che colui per rimunerarlo lo acconciò in capo a due anni con Francesco Gonzaga marchese di Mantoa, col quale anco stava esso Lorenzo. Ma non vi fu stato molto Benvenuto, che amalando Piero suo padre in Ferrara, fu forzato tornarsene là, dove stette poi del continuo quattro anni lavorando molte cose da sé solo et alcune in compagnia de' Dossi. Mandando poi l'anno 1505 per lui Messer Ieronimo Sagrato, gentiluomo ferrarese, il quale stava in Roma, Benvenuto vi tornò di bonissima voglia e massimamente per vedere i miracoli che si predicavano di Raffaello da Urbino e della cappella di Giulio stata dipinta dal Buonarroto. Ma giunto Benvenuto in Roma, restò quasi disperato, non che stupito nel vedere la grazia e la vivezza che avevano le pitture di Raffaello e la profondità del disegno di Michelagnolo, onde malediva le maniere di Lombardia e quella che avea con tanto studio e stento imparato in Mantoa, e volentieri, se avesse potuto, se ne sarebbe smorbato. Ma poi che altro non si poteva, si risolvé a volere disimparare e, dopo la perdita di tanti anni, di maestro divenire discepolo. Per che, cominciato a disegnare di quelle cose che erano migliori e più difficili, et a studiare con ogni possibile diligenza quelle maniere tanto lodate, non attese quasi ad altro per ispazio di due anni continui. Per lo che mutò in tanto la pratica e la maniera cattiva in buona, che n'era tenuto dagl'artefici conto; e, che fu più, tanto adoperò col sottomettersi e con ogni qualità d'amorevole ufficio, che divenne amico di Raffaello da Urbino, il quale, come gentilissimo e non ingrato, insegnò molte cose, aiutò e favorì sempre Benvenuto; il quale, se avesse seguitato la pratica di Roma, senz'alcun dubbio arebbe fatto cose degne del bell'ingegno suo. Ma perché fu costretto, non so per qual accidente, tornare alla patria, nel pigliare licenza da Raffaello gli promise, secondo che egli il consigliava, di tornare a Roma, dove l'assicurava Raffaello che gli darebbe più che non volesse da lavorare et in opere onorevoli. Arrivato dunque Benvenuto in Ferrara, assettato che egli ebbe le cose e spedito la bisogna che ve l'aveva fatto venire, si metteva in ordine per tornarsene a Roma, quando il signor Alfonso duca di Ferrara lo mise a lavorare nel castello, in compagnia d'altri pittori ferraresi, una cappelletta; la quale finita gli fu di nuovo interrotto il partirsi dalla molta cortesia di Messer Antonio Costabili, gentiluomo ferrarese di molta autorità, il quale gli diede a dipignere nella chiesa di Santo Andrea all'altar maggiore una tavola a olio. La quale finita, fu forzato farne un'altra in San Bertolo, convento de' monaci cistercensi, nella quale fece l'adorazione de' Magi, che fu bella e molto lodata. Dopo ne fece un'altra in Duomo piena di varie e molte figure, e due altre, che furono poste nella chiesa di Santo Spirito, in una delle quali è la Vergine in aria col Figliuolo in collo e di sotto alcun'altre figure, e nell'altra la Natività di Gesù Cristo. Nel fare delle quali opere, ricordandosi alcuna volta d'avere lasciato Roma, ne sentiva dolore estremo et era risoluto per ogni modo di tornarvi, quando sopravenendo la morte di Piero suo padre, gli fu rotto ogni disegno. Perciò che, trovandosi alle spalle una sorella da marito et un fratello di quattordici anni e le sue cose in disordine, fu forzato a posare l'animo et accomodarsi ad abitare la patria. E così, avendo partita la compagnia con i Dossi, i quali avevano insino allora con esso lui lavorato, dipinse da sé nella chiesa di San Francesco in una cappella la ressurezione di Lazzero, piena di varie e buone figure, colorita vagamente e con attitudini proprie e vivaci che molto gli furono comendate. In un'altra cappella della medesima chiesa dipinse l'uccisione de' fanciulli innocenti fatti crudelmente morire da Erode, tanto bene e con sì fiere movenze de' soldati e d'altre figure, che fu una maraviglia. Vi sono oltre ciò molto bene espressi nella varietà delle teste diversi affetti, come nelle madre e balie la paura, ne' fanciulli la morte, negl'uccisori la crudeltà et altre cose molte che piacquero infinitamente; ma egli è ben vero che in facendo quest'opera, fece Benvenuto quello che insin allora non era mai stato usato in Lombardia: cioè fece modelli di terra per veder meglio l'ombre et i lumi e si servì d'un modello di figura fatto di legname, gangherato in modo che si snodava per tutte le bande et il quale accomodava a suo modo, con panni addosso et in varie attitudini. Ma quello che importa più, ritrasse dal vivo e naturale ogni minuzia, come quelli che conosceva la diritta essere imitare et osservare il naturale. Finì per la medesima chiesa la tavola d'una cappella, et in una facciata dipinse a fresco Cristo preso dalle turbe nell'orto. In S. Domenico della medesima città dipinse a olio due tavole: in una è il miracolo della croce e Santa Elena, e nell'altra è San Piero martire con buon numero di bellissime figure; et in questa pare che Benvenuto variasse assai dalla sua prima maniera, essendo più fiera e fatta con manco affettazione. Fece alle monache di S. Salvestro in una tavola Cristo che in sul monte ora al Padre mentre i tre Apostoli più abbasso si stanno dormendo. Alle monache di San Gabriello fece una Nunziata, et a quelle di Santo Antonio, nella tavola dell'altare maggiore, la Ressurezione di Cristo. Ai frati ingesuati, nella chiesa di San Girolamo all'altare maggiore, Gesù Cristo nel presepio con un coro d'Angeli in una nuvola, tenuto bellissimo. In Santa Maria del Vado è di mano del medesimo, in una tavola molto bene intesa e colorita, Cristo ascendente in cielo e gli Apostoli che lo stanno mirando; nella chiesa di San Giorgio, luogo fuor della città de' monaci di Monte Oliveto, dipinse in una tavola a olio i Magi che adorano Cristo e gl'offeriscono mirra, incenso et oro. E questa è delle migliori opere che facesse costui in tutta sua vita, le quali tutte cose molto piacquero ai ferraresi e furono cagione che lavorò quadri per le case loro quasi senza numero e molti altri a' monasterii e fuori della città, per le castella e ville all'intorno, e fra l'altre al Bondeno dipinse in una tavola la Ressurezione di Cristo. E finalmente lavorò a fresco nel refettorio di Santo Andrea, con bella e capricciosa invenzione, molte figure che accordano le cose del Vecchio Testamento col Nuovo; ma perché l'opere di costui furono infinite, basti avere favellato di queste, che sono le migliori.
Avendo da Benvenuto avuto i primi principii della pittura Girolamo da Carpi, come si dirà nella sua vita, dipinsero insieme la facciata della casa de' Muzzarelli nel borgo nuovo, parte di chiaro scuro, parte di colori, con alcune cose fin-te di bronzo; dipinsero parimente insieme fuori e dentro il palazzo di Copara, luogo da diporto del Duca di Ferrara, al quale signore fece molte altre cose Benvenuto e solo et in compagnia d'altri pittori. Essendo poi stato lungo tempo in proposito di non voler pigliar donna, per essersi in ultimo diviso dal fratello e venutogli a fastidio lo star solo, la prese di quarantotto anni, né l'ebbe affatica tenuta un anno, che amalatosi gravemente perdé la vista dell'occhio ritto e venne in dubbio e pericolo dell'altro. Pure, raccomandandosi a Dio, e fatto voto di vestire, come poi fece sempre, di bigio, si conservò per la grazia di Dio in modo la vista dell'altr'occhio, che l'opere sue fatte nell'età di sessantacinque anni erano tanto ben fatte e con pulitezza e diligenza, che è una maraviglia; di maniera che mostrando una volta il Duca di Ferrara a papa Paulo Terzo un trionfo di Bacco a olio lungo cinque braccia e la calunnia d'Apelle, fatti da Benvenuto in detta età con i disegni di Raffaello da Urbino, i quali quadri sono sopra certi camini di sua eccellenza, restò stupefatto quel Pontefice che un vecchio di quell'età con un occhio solo avesse condotti lavori così grandi e così begli. Lavorò Benvenuto venti anni continui, tutti i giorni di festa, per l'amor di Dio, nel monasterio delle monache di San Bernardino, dove fece molti lavori d'importanza a olio, a tempera et a fresco; il che fu certo maraviglia e gran segno della sincera e sua buona natura, non avendo in quel luogo concorrenza et avendovi nondimeno messo non manco studio e diligenza di quello che arebbe fatto in qualsivoglia altro più frequentato luogo. Sono le dette opere di ragionevole componimento, con bell'arie di teste, non intrigate e fatte certo con dolce e buona maniera. A molti discepoli che ebbe Benvenuto, ancor che insegnasse tutto quello che sapeva più che volentieri per farne alcuno eccellente, non fece mai in loro frutto veruno, et in cambio di essere da loro della sua amorevolezza ristorato, almeno con gratitudine d'animo, non ebbe mai da essi se non dispiaceri, onde usava dire non avere mai avuto altri nemici che i suoi discepoli e garzoni. L'anno 1550, essendo già vecchio, ritornatogli il suo male degli occhi, rimase cieco del tutto, e così visse nove anni, la quale disaventura sopportò con paziente animo, rimettendosi al tutto nella volontà di Dio. Finalmente pervenuto all'età di 78 anni, parendogli pur troppo essere in quelle tenebre vivuto, e rallegrandosi della morte con speranza d'aver a godere la luce eterna, finì il corso della vita l'anno 1559, a dì 6 di settembre, laciando un figliuolo maschio chiamato Girolamo, che è persona molto gentile, et una femmina.
Fu Benvenuto persona molto da bene, burlevole, dolce nella conversazione e paziente e quieto in tutte le sue avversità; si dilettò in giovanezza della scherma e di sonare il liuto, e fu nell'amicizie ufficiosissimo et amorevole oltre misura; fu amico di Giorgione da Castel Franco pittore, di Tiziano da Cador e di Giulio Romano, et in generale affezionatissimo a tutti gl'uomini dell'arte, et io ne posso far fede, il quale due volte ch'io fui al suo tempo a Ferrara, ricevei da lui infinite amorevolezze e cortesie. Fu sepolto onorevolmente nella chiesa di Santa Maria del Vado, e da molti virtuosi con versi e prose, quanto la sua virtù meritava, onorato; e perché non si è potuto avere il ritratto di esso Benvenuto, si è messo nel principio di queste vite di pittori lombardi quello di Girolamo da Carpi, la cui vita sotto questa scriveremo.
Girolamo dunque, detto da Carpi, il quale fu ferrarese e discepolo di Benvenuto, fu a principio da Tommaso suo padre, il quale era pittore di scuderia, adoperato in bottega a dipignere forzieri, scabelli, cornicioni et altri sì fatti lavori di dozzina. Avendo poi Girolamo sotto la disciplina di Benvenuto fatto alcun frutto, pensava d'avere dal padre essere levato da que' lavori meccanici, ma non ne facendo Tommaso altro, come quegli che aveva bisogno di guadagnare, si risolvé Girolamo partirsi da lui ad ogni modo. E così, andato a Bologna, ebbe appresso i gentiluomini di quella città assai buona grazia, perciò che, avendo fatto alcuni ritratti che somigliarono assai, si acquistò tanto credito, che guadagnando bene, aiutava più il padre stando in Bologna che non avea fatto dimorando a Ferrara. In quel tempo, essendo stato por-tato a Bologna in casa de' signori conti Ercolani un quadro di man d'Antonio da Coreggio, nel quale Cristo in forma d'ortolano appare a Maria Maddalena, lavorato tanto bene e morbidamente quanto più non si può credere, entrò di modo nel cuore a Girolamo quella maniera, che non bastandogli avere ritratto quel quadro, andò a Modana per vedere l'al-tre opere di mano del Coreggio, là dove arrivato, oltre all'essere restato nel vederle tutto pieno di maraviglia, una fra l'altre lo fece rimanere stupefatto, e questa fu quel gran quadro, che è cosa divina, nel quale è una Nostra Donna che ha un Putto in collo, il quale sposa Santa Caterina, un San Bastiano, et altre figure con arie di teste tanto belle, che paiono fatte in paradiso; né è possibile vedere i più bei capegli, né le più belle mani o altro colorito più vago e naturale. Essendo stato dunque da Messer Francesco Grilenzoni dottore e padrone del quadro, il quale fu amicissimo del Coreggio, conceduto a Girolamo poterlo ritrarre, egli il ritrasse con tutta quella diligenza che maggiore si può imaginare; dopo fece il simile della tavola di San Piero martire, la quale avea dipinta il Coreggio a una compagnia di secolari che la tengono, sì come ella merita, in pregio grandissimo, essendo massimamente in quella, oltre all'altre figure, un Cristo fanciullo in grembo alla madre che pare che spiri, et un S. Piero martire bellissimo et un'altra tavoletta di mano del medesimo fatta alla Compagnia di San Bastiano, non men bella di questa. Le quali tutte opere essendo state ritratte da Girolamo, furono cagione che egli migliorò tanto la sua prima maniera, ch'ella non pareva più dessa, né quella di prima. Da Modana andato Girolamo a Parma, dove avea inteso esser alcune opere del medesimo Coreggio, ritrasse alcuna delle pitture della tribuna del Duomo, parendogli lavoro straordinario, cioè il bellissimo scorto d'una Madonna che saglie in cielo circondata da una multitudine d'Angeli, gl'Apostoli che stanno a vederla salire, e quattro Santi protettori di quella città che sono nelle nicchie: San Giovanni Battista che ha un agnello in mano, San Ioseffo sposo della Nostra Donna, San Bernardo degl'Uberti fiorentino, cardinale e vescovo di quella città, et un altro vescovo. Studiò similmente Girolamo in San Giovanni Evangelista le figure della cappella maggiore nella nicchia di mano del medesimo Coreggio, cioè la incoronazione di Nostra Donna, San Giovanni Evangelista, il Battista, San Benedetto, San Placido et una moltitudine d'Angeli che a questi sono intorno, e le maravigliose figure che sono nella chiesa di San Sepolcro, alla cappella di San Ioseffo, tavola di pittura divina. E perché è forza che coloro ai quali piace fare alcuna maniera e la studiano con amore, la imparino, almeno in qualche parte, onde aviene ancora che molti divengono più eccellenti che i loro maestri non so-no stati, Girolamo prese assai della maniera del Coreggio. Onde, tornato a Bologna, l'imitò sempre, non studiando altro che quella e la tavola, che in quella città dicemo essere di mano di Raffaello da Urbino. E tutti questi particolari seppi io dallo stesso Girolamo, che fu molto mio amico, l'anno 1550 in Roma et il quale meco si dolse più volte d'aver consumato la sua giovanezza et i migliori anni in Ferrara e Bologna e non in Roma o altro luogo, dove averebbe fatto senza dubbio molto maggiore acquisto.
Fece anco non piccol danno a Girolamo nelle cose dell'arte l'avere atteso troppo a' suoi amorosi et a sonare il liuto in quel tempo che arebbe potuto fare acquisto nella pittura. Tornato dunque a Bologna, oltre a molti altri, ritrasse Mes-ser Onofrio Bartolini fiorentino che allora era in quella città a studio, et il quale fu poi arcivescovo di Pisa, la quale testa, che è oggi appresso gli eredi di detto Messer Noferi, è molto bella e di graziosa maniera. Lavorando in quel tempo a Bologna un maestro Biagio pittore, cominciò costui, vedendo Girolamo venire in buon credito, a temere che non gli passasse inanzi e gli levasse tutto il guadagno. Per che, fatto seco amicizia con buona occasione, per ritardarlo dall'ope-rare, gli divenne compagno e dimestico di maniera, che cominciarono a lavorare di compagnia e così continuarono un pezzo. La qual cosa, come fu di danno a Girolamo nel guadagno, così gli fu parimente nelle cose dell'arte: perciò che seguitando le pedate di maestro Biagio che lavorava di pratica e cavava ogni cosa dai disegni di questo e di quello, non metteva anch'egli più alcuna diligenza nelle sue pitture. Ora, avendo nel monasterio di San Michele in Bosco, fuor di Bologna, un frate Antonio, monaco di quel luogo, fatto un San Bastiano grande quanto il vivo, a Scaricalasino in un convento del medesimo ordine di Monte Oliveto una tavola a olio et a Monte Oliveto Maggiore alcune figure in fresco nella cappella dell'Orto di Santa Scolastica, voleva l'abate Ghiaccino, che l'aveva fatto fermare quell'anno in Bologna, che egli dipignesse la sagrestia nuova di quella lor chiesa. Ma frate Antonio, che non si sentiva da fare sì grande opera et al quale forse non molto piaceva durare tanta fatica, come bene spesso fanno certi di così fatti uomini, operò di maniera, che quell'opera fu allogata a Girolamo et a maestro Biagio, i quali la dipinsero tutta a fresco, facendo negli spartimenti della volta alcuni putti et Angeli e nella testa, di figure grandi, la storia della Trasfigurazione di Cristo, servendosi del disegno di quella che fece in Roma a S. Pietro a Montorio Raffaello da Urbino, e nelle facciate feciono alcuni Santi, nei quali è pur qualche cosa di buono. Ma Girolamo, accortosi che lo stare in compagnia di maestro Biagio non faceva per lui, anzi, che era la sua espressa rovina, finita quell'opera disfece la compagnia e cominciò a far da sé. E la prima opera che fece da sé solo fu nella chiesa di San Salvadore, nella cappella di S. Bastiano, una tavola nella quale si portò molto bene; ma dopo, intesa da Girolamo la morte del padre, se ne tornò a Ferrara, dove per allora non fece altro che alcuni ritratti et opere di poca importanza. Intanto venendo Tiziano Vecellio a Ferrara a lavorare, come si dirà nella sua vita, alcune cose al duca Alfonso, in uno stanzino o vero studio, dove avea prima lavorato Gian Bellino alcune cose et il Dosso una baccanaria d'uomini tanto buona, che quando non avesse mai fatto altro, per questa merita lode e nome di pittore eccellente; Girolamo, mediante Tiziano et altri, cominciò a praticare in corte del Duca, dove ricavò, quasi per dar saggio di sé prima che altro facesse, la testa del duca Ercole di Ferrara da una di mano di Tiziano, e questa contrafece tanto bene, ch'ella pareva la medesima che l'originale, onde fu mandata come opera lodevole in Francia. Dopo, a-vendo Girolamo tolto moglie et avuto figliuoli, forse troppo prima che non doveva, dipinse in S. Francesco di Ferrara negl'angoli delle volte a fresco i quattro Evangelisti, che furono assai buone figure. Nel medesimo luogo fece un fregio intorno intorno alla chiesa, che fu copiosa e molto grande opera, essendo pieno di mezze figure e di puttini intrecciati insieme assai vagamente. Nella medesima chiesa fece in una tavola un Santo Antonio in Padoa con altre figure et in u-n'altra la Nostra Donna in aria con due Angeli, che fu posta all'altare della signora Giulia Muzzerella, che fu ritratta in essa da Girolamo molto bene. In Rovigo nella chiesa di S. Francesco dipinse il medesimo l'apparizione dello Spirito Santo in lingue di fuoco, che fu opera lodevole per lo componimento e bellezza delle teste; et in Bologna dipinse nella chiesa di S. Martino in una tavola i tre Magi con bellissime teste e figure, et a Ferrara, in compagnia di Benvenuto Garofalo, come si è detto, la facciata della casa del signor Battista Muzzarelli, e parimente il palazzo di Coppara, villa del Duca, appresso a Ferrara dodici miglia, et in Ferrara similmente la facciata di Piero Soncini nella piazza di verso le pescherie, facendovi la presa della Goletta da Carlo Quinto imperadore. Dipinse il medesimo Girolamo in San Polo, chiesa de' frati Carmelitani nella medesima città, in una tavoletta a olio un San Girolamo con due altri Santi grandi quanto il naturale, e nel palazzo del Duca un quadro grande con una figura quanto il vivo, finta, per una Occasione, con bella vivezza, movenza, grazia e buon rilievo. Fece anco una Venere ignuda a giacere e grande quanto il vivo, con Amore appresso, la quale fu mandata al re Francesco di Francia a Parigi, et io, che la vidi in Ferrara l'anno 1540, posso con verità affermare ch'ella fusse bellissima. Diede anco principio, e ne fece gran parte, agl'ornamenti del reffettorio di San Giorgio, luogo in Ferrara de' monaci di Monte Oliveto; ma perché lasciò imperfetta quell'opera, l'ha oggi finita Pellegrino Pellegrini, dipintore bolognese. Ma chi volesse far menzione di quadri particolari che Girolamo fece a molti signori e gentiluomini, farebbe troppo maggiore di quello che è il disiderio nostro la storia, però dico di due solamente, che sono bellissimi: da uno dunque che n'ha il cavalier Boiardo in Parma, bello a maraviglia, di mano del Correggio, nel quale la Nostra Donna mette una camicia indosso a Cristo fanciulletto, ne ritrasse Girolamo uno a quello tanto simile che pare desso veramente, et un altro ne ritrasse da uno del Parmigiano, il quale è nella Certosa di Pavia, nella cella del vicario, così bene e con tanta diligenza, che non si può veder minio più sottilmente lavorato et altri infiniti lavorati con molta diligenza. E perché si dilettò Girolamo e diede anco opera all'architettura, oltre molti disegni di fabriche che fece per servigio di molti privati, servì in questo particolarmente Ippolito cardinale di Ferrara, il quale avendo comperato in Roma a Monte Cavallo il giardino che fu già del cardinale di Napoli, con molte vigne di particolari all'intorno, condusse Girolamo a Roma, acciò lo servisse non solo nelle fabriche, ma negl'acconcimi di legname veramente regii del detto giardino. Nel che si portò tanto bene che ne restò ognuno stupefatto, e nel vero non so chi altri si fusse potuto portare meglio di lui in fare di legnami (che poi sono stati coperti di bellissime verzure) tante bell'opere e sì vagamente ridotte in diverse forme et in diverse maniere di tempii, nei quali si veggiono oggi accommodate le più belle e ricche statue antiche che sieno in Roma: parte intere e parte state restaurate da Valerio Cioli scultore fiorentino e da altri. Per le quali opere essendo in Roma venuto Girolamo in bonissimo credito, fu dal detto cardinale suo signore, che molto l'amava, messo l'anno 1550 al servizio di papa Giulio III, il quale lo fece architetto sopra le cose di Belvedere, dandogli stanze in quel luogo e buona provisione. Ma perché quel Pontefice non si poteva mai in simili cose contentare, e massimamente quando a principio s'intendeva pochissimo del disegno e non voleva la sera quello che gl'era piacciuto la mattina, e perché Girolamo avea sempre a contrastare con certi architetti vecchi, ai quali parea strano vedere un uomo nuovo e di poca fama essere stato preposto a loro, si risolvé, conosciuta l'invidia e forse malignità di quelli, essendo anco di natura più tosto freddo che altrimenti, a ritirarsi; e così per lo meglio se ne tornò a Monte Cavallo al servizio del cardinale. Della qual cosa fu Girolamo da molti lodato, essendo vita troppo disperata aver tutto il giorno e per ogni minima cosa a star a contendere con questo e quello; e come diceva egli, è tal volta meglio godere la quiete dell'animo con l'acqua e col pane, che stentare nelle grandezze e negl'onori. Fatto dunque che ebbe Girolamo al cardinale suo signore un molto bel quadro che a me, il quale il vidi, piacque sommamente, essendo già stracco se ne tornò con esso lui a Ferrara a godersi la quiete di casa sua con la moglie e con i figliuoli, lasciando le speranze e le cose della fortuna nelle mani de' suoi avversarii, che da quel Papa cavarono il medesimo che egli e non altro. Dimorandosi dunque in Ferrara, per non so che accidente essendo abruciata una parte del castello, il duca Ercole diede cura di rifarlo a Girolamo, il quale l'acco-modò molto bene e l'adornò secondo che si può in quel paese, che ha gran mancamento di pietre da far conci et ornamenti, onde meritò esser sempre caro a quel signore, che liberalmente riconobbe le sue fatiche.
Finalmente dopo aver fatto Girolamo queste e molte altre opere si morì d'anni 55 l'anno 1556 e fu sepolto nella chiesa degl'Angeli a canto alla sua donna. Lasciò due figliuole femine e tre maschi, cioè Giulio, Annibale et un altro. Fu Girolamo lieto uomo e nella conversazione molto dolce e piacevole, nel lavorare alquanto agiato e lungo; fu di mezzana statura e si dilettò oltre modo della musica e de' piaceri amorosi più forse che non conviene. Ha seguitato dopo lui le fabriche di que' signori Galasso ferrarese architetto, uomo di bellissimo ingegno, e di tanto giudizio nelle cose d'ar-chitettura, che per quanto si vede nell'ordine de' suoi disegni averebbe mostro molto più che non ha il suo valore, se in cose grandi fusse stato adoperato.
È stato parimente ferrarese e scultore eccellente, maestro Girolamo, il quale abitando in Ricanati ha, dopo Andrea Contucci suo maestro, lavorato molte cose di marmo a Loreto e fatti molti ornamenti intorno a quella cappella e casa della Madonna. Costui dico, dopo che di là si partì il Tribolo che fu l'ultimo, avendo finito la maggiore storia di marmo, che è dietro alla detta cappella, dove gl'Angeli portano di Schiavonia quella casa nella selva di Loreto, ha in quel luogo continuamente dal 1534 insino all'anno 1560 lavorato, e vi ha fatto di molte opere; la prima delle quali fu un profeta di braccia tre e mezzo a sedere, il quale fu messo, essendo bella e buona figura, in una nicchia che è volta verso ponente; la quale statua essendo piaciuta, fu cagione che egli fece poi tutti gl'altri profeti, da uno in fuori che è verso levante e dalla banda di fuori verso l'altare, il quale è di mano di Simone Cioli da Settignano, discepolo anch'egli d'Andrea Sansovino. Il restante dico de' detti profeti sono di mano di maestro Girolamo e sono fatti con molta diligenza, studio e buona pratica. Alla cappella del Sagramento ha fatto il medesimo li candelieri di bronzo, alti tre braccia in circa, pieni di fogliami, figure tonde di getto, tanto ben fatte che sono cosa maravigliosa. Et un suo fratello, che in simili cose di getto è valentuomo, ha fatto in compagnia di maestro Girolamo in Roma molte altre cose, e particolarmente un taberna-colo grandissimo di bronzo per papa Paulo Terzo, il quale doveva essere posto nella cappella del palazzo di Vaticano, detta la Paulina.
Fra i modanesi ancora sono stati in ogni tempo artefici eccellenti nelle nostre arti, come si è detto in altri luoghi e come si vede in quattro tavole, delle quali non si è fatto al suo luogo menzione per non sapersi il maestro, le quali, cento anni sono, furono fatte a tempera in quella città e sono secondo que' tempi bellissime e lavorate con diligenza; la prima è all'altare maggiore di San Domenico, e l'altre alle cappelle, che sono nel tramezzo di quella chiesa. Et oggi vive della medesima patria un pittore chiamato Niccolò, il quale fece in sua giovanezza molti lavori a fresco intorno alle beccherie, che sono assai belli, et in S. Piero luogo de' monaci Neri, all'altar maggiore in una tavola, la decollazione di San Piero e San Paulo, imitando nel soldato che taglia loro la testa una figura simile che è in Parma di mano d'Antonio da Coreggio, in San Giovanni Evangelista, lodatissima. E perché Niccolò è stato più raro nelle cose a fresco che nell'al-tre maniere di pittura, oltre a molte opere che ha fatto in Modana et in Bologna, intendo che ha fatto in Francia, dove ancora vive, pitture rarissime, sotto Messer Francesco Primaticcio abbate di San Martino, con i disegni del quale ha fatto Niccolò in quelle parti molte opere, come si dirà nella vita di esso Primaticcio.
Giovambattista, parimente emulo di detto Niccolò, ha molte cose lavorato in Roma et altrove, ma particolarmente in Perugia, dove ha fatto in San Francesco, alla cappella del signor Ascanio della Cornia, molte pitture della vita di Santo Andrea Apostolo, nelle quali si è portato benissimo. A concorrenza del quale Niccolò, Arrigo fiamingo, maestro di finestre di vetro, ha fatto nel medesimo luogo una tavola a olio, dentrovi la storia de' Magi, che sarebbe assai bella se non fusse alquanto confusa e troppo carica di colori, che s'azuffano insieme e non la fanno sfuggire; ma meglio si è portato costui in una finestra di vetro disegnata e dipinta, da lui fatta in San Lorenzo della medesima città alla cappella di San Bernardino. Ma tornando a Battista, essendo ritornato dopo queste opere a Modana, ha fatto nel medesimo San Piero, dove Niccolò fece la tavola, due grandi storie dalle bande de' fatti di San Piero e San Paulo, nelle quali si è portato bene oltre modo.
Nella medesima città di Modana sono anco stati alcuni scultori degni d'essere fra i buoni artefici annoverati, perciò che oltre al Modanino, del quale si è in altro luogo ragionato, vi è stato un maestro chiamato il Modana, il quale in figure di terra cotta, grandi quanto il vivo e maggiori, ha fatto bellissime opere e fra l'altre una cappella in San Domenico di Modana, et in mezzo del dormentorio di San Piero a' monaci Neri pure in Modana, una Nostra Donna, San Benedetto, Santa Iustina et un altro Santo, alle quali tutte figure ha dato tanto bene il colore di marmo, che paiono proprio di quella pietra, senzaché tutte hanno bell'aria di teste, bei panni et una proporzione mirabile. Il medesimo ha fatto in San Giovanni Vangelista di Parma nel dormentorio le medesime figure, et in San Benedetto di Mantova ha fatto buon numero di figure tutte tonde e grandi quanto il naturale, fuor della chiesa, per la facciata e sotto il portico in molte nicchie, tanto belle, che paiono di marmo. Similmente Prospero Clemente, scultore modanese, è stato ed è valentuomo nel suo esercizio, come si può vedere nel Duomo di Reggio nella sepoltura del vescovo Rangone di mano di costui, nella quale è la statua di quel prelato, grande quanto il naturale, a sedere con due putti molto ben condotti, la quale sepoltura gli fece fare il signor Ercole Rangone. Parimente in Parma nel Duomo sotto le volte è di mano di Prospero la sepoltura del beato Bernardo degl'Uberti fiorentino, cardinale e vescovo di quella città, che fu finita l'anno 1548 e molto lodata.
Parma similmente ha avuto in diversi tempi molti eccellenti artefici e begl'ingegni come si è detto di sopra, perciò che oltre a un Cristofano Castelli, il quale fece una bellissima tavola in Duomo l'anno 1499, et oltre a Francesco Mazzuoli del quale si è scritto la vita, vi sono stati molti altri valentuomini. Il quale avendo fatto come si è detto alcune cose nella Madonna della Steccata e lasciato alla morte sua quell'opera imperfetta, Giulio Romano, fatto un disegno colorito in carta, il quale in quel luogo si vede per ognuno, ordinò che un Michelagnolo Anselmi sanese per origine, ma fatto parmigiano, essendo buon pittore, mettesse in opera quel cartone, nel quale è la coronazione di Nostra Donna: il che fece colui certo ottimamente, onde meritò che gli fusse allogata una nicchia grande di quattro grandissime che ne sono in quel tempio, dirimpetto a quella dove avea fatto la sopra detta opera col disegno di Giulio; per che, messovi mano, vi condusse a buon termine l'adorazione de' Magi con buon numero di belle figure, facendo nel medesimo arco piano, come si disse nella vita del Mazzuoli, e le vergini prudenti e lo spartimento de' rosoni di rame. Ma restandogli anche a fare quasi un terzo di quel lavoro, si morì, onde fu fornito da Bernardo Soiaro cremonese, come diremo poco appresso. Di mano del detto Michelagnolo è nella medesima città in San Francesco la capella della Concezzione, et in San Pier martire alla capella della croce una gloria celeste.
Ieronimo Mazzuoli, cugino di Francesco, come s'è detto, seguitando l'opera nella detta chiesa della Madonna, stata lasciata dal suo parente imperfetta, dipinse un arco con le vergini prudenti e l'ornamento de' rosoni; e dopo nella nicchia di testa, dirimpetto alla porta principale, dipinse lo Spirito Santo discendente in lingue di fuoco sopra gl'Apostoli, e nel-l'altro arco piano et ultimo la Natività di Gesù Cristo, la quale, non essendo ancor scoperta, ha mostrata a noi questo anno 1566 con molto nostro piacere, essendo per opera a fresco bellissima veramente. La tribuna grande di mezzo della medesima Madonna della Steccata, la quale dipigne Bernardo Soiaro pittore cremonese, sarà anch'ella, quando sarà finita, opera rara e da poter star con l'altre che sono in quel luogo; delle quali non si può dire che altri sia stato cagione, che Francesco Mazzuola, il quale fu il primo che cominciasse con bel giudizio il magnifico ornamento di quella chiesa stata fatta, come si dice, con disegno et ordine di Bramante.
Quanto agl'artefici delle nostre arti mantoani, oltre quello che se n'è detto insino a Giulio Romano, dico che egli seminò in guisa la sua virtù in Mantoa e per tutta Lombardia, che sempre poi vi sono stati di valentuomini e l'opere sue sono più l'un giorno che l'altro conosciute per buone e laudabili. E se bene Giovambattista Bertano, principale architetto delle fabriche del Duca di Mantoa, ha fabricato nel castello, sopra dove son l'acque et il corridore molti appartamenti magnifici e molto ornati di stucchi e di pitture, fatte per la maggior parte da Fermo Guisoni, discepolo di Giulio e da altri, come si dirà, non però paragonano quelle fatte da esso Giulio. Il medesimo Giovambattista in Santa Barbara, chiesa del castello del Duca, ha fatto fare col suo disegno a Domenico Brusasorzi una tavola a olio nella quale, che è vera-mente da essere lodata, è il martirio di quella Santa; costui, oltre ciò, avendo studiato Vitruvio, ha sopra la voluta ionica, secondo quell'autore, scritta e mandata fuori un'opera come ella si volta; et alla casa sua di Mantoa nella porta principale ha fatto una colonna di pietra intera, et il modano dell'altra in piano con tutte le misure segnate di detto ordine ionico, e così il palmo, l'once, il piede et il braccio antichi, acciò chi vuole possa vedere se le dette misure son giuste o no. Il medesimo, nella chiesa di San Piero, Duomo di Mantoa, che fu opera et architettura di detto Giulio Romano, perché rinovandolo gli diede forma nuova e moderna, ha fatto fare una tavola per ciascuna capella di mano di diversi pittori, e due n'ha fatte fare con suo disegno al detto Fermo Guisoni: cioè una a Santa Lucia, dentrovi la detta Santa con due putti, et un'altra a San Giovanni Evangelista. Un'altra simile ne fece fare a Ippolito Costa mantoano, nella quale è San-t'Agata con le mani legate et in mezzo a due soldati che le tagliano e lievano le mammelle. Battista d'Agnolo del Moro veronese fece, come s'è detto, nel medesimo Duomo la tavola che è all'altare di Santa Maria Maddalena; e Ieronimo parmigiano quella di Santa Tecla. A Paulo Farinato veronese fece fare quella di San Martino, et al detto Domenico Brusasorzi quella di Santa Margherita; Giulio Campo cremonese fece quella di San Ieronimo. Et una, che fu la migliore dell'altre, come che tutte siano bellissime, nella quale è Santo Antonio abbate battuto dal demonio in vece di femina che lo tenta, è di mano di Paulo Veronese. Ma quanto ai mantovani, non ha mai avuto quella città il più valentuomo nella pittura di Rinaldo, il quale fu discepolo di Giulio, di mano del quale è una tavola in Santa Agnese di quella città, nella quale è una Nostra Donna in aria, Sant'Agostino e San Girolamo, che sono bonissime figure, il quale troppo presto la morte lo levò del mondo. In un bellissimo antiquario e studio, che ha fatto il signore Cesare Gonzaga, pieno di statue e di teste antiche di marmo, ha fatto dipignere per onorarlo a Fermo Guiscioni la geneologia di casa Gonzaga, che si è portato benissimo in ogni cosa e specialmente nell'aria delle teste; vi ha messo, oltre di questo il detto signore, alcuni quadri che certo son rari: come quello della Madonna, dove è la gatta che già fece Raffaello da Urbino, et un altro, nel quale la Nostra Donna con grazia maravigliosa lava Gesù putto. In un altro studiuolo fatto per le medaglie, il quale ha ottimamente d'ebano e d'avorio lavorato un Francesco da Volterra, che in simili opere non ha pari, ha alcune figure di bronzo antiche, che non potrieno essere più belle di quel che sono.
Insomma, da che io vidi altra volta Mantoa a questo anno 1566 che l'ho riveduta, ell'è tanto più adornata e più bella, che se io non l'avessi veduta nol crederei; e, che è più, vi sono multiplicati gl'artefici e vi vanno tuttavia multiplicando. Conciò sia che di Giovambattista mantoano, intagliator di stampe e scultore eccellente, del quale abbiam favellato nella vita di Giulio Romano et in quella di Marcantonio Bolognese, sono nati due figliuoli che intagliano stampe di rame divinamente; e, che è cosa più maravigliosa, una figliuola, chiamata Diana, intaglia anch'ella tanto bene, che è cosa maravigliosa, et io che ho veduto lei, che è molto gentile e graziosa fanciulla, e l'opere sue che sono bellissime, ne sono restato stupefatto. Non tacerò ancora che in San Benedetto di Mantoa, celebratissimo monasterio de' monaci Neri, stato rinovato da Giulio Romano con bellissimo ordine, hanno fatto molte opere i sopra detti artefici mantoani et altri lombardi; oltre quello che si è detto nella vita del detto Giulio. Vi sono adunque opere di Fermo Guiscioni, cioè una Natività di Cristo, due tavole di Girolamo Mazzuola, tre di Latanzio Gambaro da Brescia et altre tre di Paulo Veronese, che sono le migliori. Nel medesimo luogo è di mano d'un frate Girolamo, converso di S. Domenico, nel reffetorio in testa, come altrove s'è ragionato, in un quadro a olio ritratto il bellissimo cenacolo che fece in Milano a Santa Maria delle Grazie Lionardo da Vinci, ritratto dico tanto bene, che io ne stupii; della qual cosa fo volentieri di nuovo memoria a-vendo veduto questo anno 1566 in Milano l'originale di Lionardo tanto male condotto, che non si scorge più se non una macchia abbagliata; onde la pietà di questo buon padre rendea sempre testimonianza di questa parte della virtù di Lionardo. Di mano del medesimo frate ho veduto nella medesima casa della Zecca di Milano un quadro ritratto da un di Lionardo, nel quale è una femina che ride et un San Giovanni Battista giovinetto molto bene imitato.
Cremona altresì, come si disse nella vita di Lorenzo di Credi et in altri luoghi, ha avuto in diversi tempi uomini che hanno fatto nella pittura opere lodatissime; e già abbiam detto che quando Boccaccino Boccacci dipigneva la nicchia del Duomo di Cremona e per la chiesa le storie di Nostra Donna, che Bonifazio Bembi fu buon pittore e che Altobello fece molte storie a fresco di Gesù Cristo con molto più disegno che non sono quelle del Boccaccino. Dopo le quali dipinse Altobello in Santo Agostino della medesima città una cappella a fresco con graziosa e bella maniera, come si può vedere da ognuno. In Milano in corte vecchia, cioè nel cortile o vero piazza del palazzo, fece una figura in piedi armata all'antica, migliore di tutte l'altre che da molti vi furono fatte quasi ne' medesimi tempi.
Morto Bonifazio, il quale lasciò imperfette nel Duomo di Cremona le dette storie di Cristo, Giovan Antonio Licino da Pordenone, detto in Cremona de' Sacchi, finì le dette storie state cominciate da Bonifazio, facendovi in fresco cinque storie della Passione di Cristo, con una maniera di figure grandi, colorito terribile e scorti che hanno forza e vivacità, le quali tutte cose insegnarono il buon modo di dipignere ai cremonesi, e non solo in fresco, ma a olio parimente, conciò sia che nel medesimo Duomo appoggiata a un pilastro è una tavola a mezzo la chiesa di mano del Pordenone, bellissima. La quale maniera imitando poi Cammillo figliuolo del Boccaccino nel fare in San Gismondo fuori della città la cappella maggiore in fresco et altre opere, riuscì da molto più che non era stato suo padre; ma perché fu costui largo et alquanto agiato nel lavorare, non fece molte opere, se non piccole e di poca importanza. Ma quegli che più imitò le buone maniere et a cui più giovarono le concorrenze di costoro, fu Bernardo de' Gatti, cognominato di Soiaro, di chi s'è ragionato, di Parma, il quale dicono alcuni esser stato da Verzelli et altri cremonese; ma sia stato donde si voglia, egli dipinse una tavola molto bella all'altare maggiore di San Piero, chiesa de' canonici regolari e nel refettorio la storia o vero miracolo che fé Gesù Cristo de' cinque pani e due pesci, saziando moltitudine infinita; ma egli la ritoccò tanto a secco, ch'ell'ha poi perduta tutta la sua bellezza. Fece anco costui in San Gismondo fuor di Cremona sotto una volta, l'Ascensione di Gesù Cristo in cielo, che fu cosa vaga e di molto bel colorito. In Piacenza nella chiesa di Santa Maria di Campagna, a concorrenza del Pordenone e dirimpetto al Sant'Agostino che s'è detto, dipinse a fresco un San Giorgio armato a cavallo che ammazza il serpente, con prontezza, movenza et ottimo rilievo. E ciò fatto, gli fu dato a finire la tribuna di quella chiesa che avea lasciata imperfetta il Pordenone, dove dipinse a fresco tutta la vita della Madonna. E se bene i profeti e le sibille che vi fece il Pordenone con alcuni putti son belli a maraviglia, si è portato nondimeno tanto bene il Soiaro, che pare tutta quell'opera d'una stessa mano. Similmente alcune tavolette d'altari che ha fatte in Vigevano sono da essere per la bontà loro assai lodate. Finalmente ridottosi in Parma a lavorare nella Madonna della Steccata, [fu] finita la nicchia e l'arco, che lassò imperfetta per la morte Michelagnolo sanese, per le mani del Soiaro; al quale, per essersi portato bene, hanno poi dato a dipignere i parmigiani la tribuna maggiore che è in mezzo di detta chiesa, nella quale egli va tuttavia lavorando a fresco l'Assunzione di Nostra Donna, che si spera debba essere opera lodatissima. Essendo anco vivo Roccaccino, ma vecchio, ebbe Cremona un altro pittore, chiamato Galeazzo Campo, il quale nella chiesa di San Domenico, in una cappella grande dipinse il rosario della Madonna e la facciata di dietro di San Francesco con altre tavole, opere che sono di mano di costui in Cremona ragionevoli. Di costui nacquero tre figliuoli, Giulio, Antonio e Vincenzio; ma Giulio, se bene imparò i primi principi dell'arte di Galeazzo suo padre, seguitò poi, nondimeno, come migliore, la maniera del Soiaro e studiò assai alcune tele colorite fatte in Roma di mano di Francesco Salviati, che furono dipinte per fare arazzi e mandate a Piacenza al duca Pier Luigi Farnese. Le prime opere che costui fece in sua giovanezza in Cremona furono nel coro della chiesa di Santa Agata quattro storie grandi del martirio di quella vergine, che riuscirono tali, che sì fatte non l'arebbe per aventura fatte un maestro ben pratico. Dopo, fatte alcune cose in Santa Margherita, dipinse molte facciate di palazzi di chiaro scuro con buon disegno. Nella chiesa di San Gismondo fuor di Cremona fece la tavola dell'altar maggiore a olio, che fu molto bella per la moltitudine e diversità delle figure, che vi dipinse a paragone di tanti pittori che innanzi a lui avevano in quel luogo lavorato. Dopo la tavola vi lavorò in fresco molte cose nelle volte, e particolarmente la venuta dello Spirito Santo sopra gl'Apostoli, i quali scortano al di sotto in su con buona grazia e molto artifizio. In Milano dipinse nella chiesa della Passione, convento de' canonici regolari, un Crucifisso in tavola a olio con certi Angeli, la Madonna, San Giovanni Evangelista e l'altre Marie. Nelle monache di San Paulo converso, pur di Milano, fece in quattro storie la conversione et altri fatti di quel Santo, nella quale opera fu aiutato da Antonio Campo suo fratello, il quale dipinse similmente in Milano alle monache di Santa Ca-terina alla porta Ticinese, in una capella della chiesa nuova, la quale è architettura del Lombardino, Santa Elena, a olio che fa cercare la croce di Cristo, che è assai buon'opera. E Vincenzio anch'egli, terzo dei detti tre fratelli, avendo assai imparato da Giulio, come anco ha fatto Antonio, è giovane d'ottima aspettazione. Del medesimo Giulio Campo sono stati discepoli non solo i detti suoi due fratelli, ma ancora Latanzio Gambaro bresciano et altri. Ma sopra tutti gli ha fatto onore et è stata eccellentissima nella pittura Sofonisba Angusciola cremonese con tre sue sorelle, le quali virtuosissime giovani sono nate del signor Amilcare Angusciola e della signora Bianca Punzona, ambe nobilissime famiglie in Cremona. Parlando dunque di essa signora Sofonisba, della quale dicemmo alcune poche cose nella vita di Properzia bolognese, per non saperne allora più oltre, dico aver veduto quest'anno in Cremona di mano di lei in casa di suo padre, et in un quadro fatto con molta diligenza, ritratte tre sue sorelle in atto di giocare a scacchi, e con esso loro una vecchia donna di casa, con tanta diligenza e prontezza, che paiono veramente vive e che non manchi loro altro che la parola. In un altro quadro si vede ritratto dalla medesima Sofonisba il signor Amilcare suo padre, che ha da un lato una figliuola di lui, sua sorella, chiamata Minerva, che in pitture et in lettere fu rara, e dall'altro Asdrubale figliuolo del medesimo et a loro fratello, et anche questi sono tanto ben fatti, che pare che spirino e sieno vivissimi. In Piacenza sono di mano del-la medesima in casa del signor Arcidiacono della chiesa maggiore, due quadri bellissimi: in uno è ritratto esso signore e nell'altro Sofonisba; l'una e l'altra delle quali figure non hanno se non a favellare. Costei essendo poi stata condotta, come si disse di sopra, dal signor duca d'Alva al servigio della reina di Spagna, dove si truova al presente con bonissima provisione e molto onorata, ha fatto assai ritratti e pitture che sono cosa maravigliosa. Dalla fama delle quali opere mosso papa Pio IIII, fece sapere a Sofonisba che disiderava avere di sua mano il ritratto della detta serenissima reina di Spagna. Per che, avendolo ella fatto con tutta quella diligenza che maggiore le fu possibile, glielo mandò a presentare in Roma, scrivendo a Sua Santità una lettera di questo preciso tenore:
“Padre Santo, dal reverendissimo Nunzio di Vostra Santità intesi ch'ella disiderava un ritratto di mia mano della maestà della reina mia signora. E come che io accettassi questa impresa in singolare grazia e favore, avendo a servire alla Beatitudine Vostra, ne dimandai licenza a sua maestà, la quale se ne contentò molto volentieri, riconoscendo in ciò la paterna affezione che Vostra Santità le dimostra, et io con l'occasione di questo cavaliero gliene mando. E se in que-sto averò sodisfatto al disiderio di Vostra Santità, io ne riceverò infinita consolazione, non restando però di dirle che se col pennello si potesse così rappresentare agl'occhi di Vostra Beatitudine le bellezze dell'animo di questa serenissima reina, non potria veder cosa più maravigliosa. Ma in quelle parti, le quali con l'arte si sono potute figurare, non ho mancato di usare tutta quella diligenza che ho saputo maggiore, per rappresentare alla Santità Vostra il vero. E con questo fine, con ogni reverenza et umiltà le bacio i santissimi piedi. Di Madrid, alli XVI di settembre 1561. Di Vostra Beatitudine umilissima serva, Sofonisba Angosciola”.
Alla quale lettera rispose Sua Santità con l'infrascritta, la quale, essendogli paruto il ritratto bellissimo e maraviglioso, accompagnò con doni degni della molta virtù di Sofonisba.
“Pius papa III. Dilecta in Cristo filia, avemo ricevuto il ritratto della serenissima reina di Spagna, nostra carissima figliuola, che ci avete mandato e ci è stato gratissimo, sì per la persona che si rappresenta, la quale noi amiamo paternamente, oltre agl'altri rispetti, per la buona religione et altre bellissime parti dell'animo suo, e sì ancora per essere fatto di man vostra molto bene e diligentemente. Ve ne ringraziamo, certificandovi che lo terremo fra le nostre cose più care, comendando questa vostra virtù, la quale ancora che sia maravigliosa, intendiamo però ch'ell'è la più piccola tra molte che sono in voi. E con tal fine vi mandiano di nuovo la nostra benedizione. Che Nostro Signore Dio vi conservi. Data Romae, die XV octobris 1561.”
E questa testimonianza basti a mostrare quanta sia la virtù di Sofonisba. Una sorella della quale, chiamata Lucia, morendo ha lasciato di sé non minor fama che si sia quella di Sofonisba, mediante alcune pitture di sua mano, non men belle e pregiate che le già dette della sorella, come si può vedere in Cremona in un ritratto ch'ella fece del signor Pietro Maria, medico eccellente, ma molto più in un altro ritratto, fatto da questa virtuosa vergine, del duca di Sessa, da lei stato tanto ben contrafatto, che pare che non si possa far meglio, né fare che con maggior vivacità alcun ritratto rassomigli. La terza sorella Angosciola, chiamata Europa, che ancora è in età puerile et alla quale, che è tutta grazia e virtù, ho parlato questo anno, non sarà, per quello che si vede nelle sue opere e disegni, inferiore né a Sofonisba, né a Lucia sue sorelle. Ha costei fatto molti ritratti di gentiluomini in Cremona, che sono naturali e belli affatto, et uno ne mandò in Ispagna della signora Bianca sua madre, che piacque sommamente a Sofonisba et a chiunche lo vide di quella corte. E perché Anna, quarta sorella, ancora piccola fanciulletta, attende anch'ella con molto profitto al disegno, non so che altro mi dire, se non che bisogna avere da natura inclinazione alla virtù, e poi a quella aggiugnere l'esercizio e lo studio come hanno fatto queste quattro nobili e virtuose sorelle, tanto innamorate d'ogni più rara virtù et in particolare delle cose del disegno, che la casa del signor Amilcare Angosciuola (perciò felicissimo padre d'onesta et onorata famiglia) mi parve l'albergo della pittura, anzi di tutte le virtù. Ma se le donne sì bene sanno fare gl'uomini vivi, che maraviglia che quelle che vogliono sappiano anco fargli sì bene dipinti?
Ma tornando a Giulio Campo, del quale ho detto che queste giovani donne sono discepole, oltre all'altre cose, una tela che ha fatto per coprimento dell'organo della chiesa cattedrale, è lavorata con molto studio e gran numero di figure a tempera delle storie d'Ester e Assuero, con la crocifissione d'Aman. E nella medesima chiesa è di sua mano all'altare di San Michele una graziosa tavola; ma perché esso Giulio ancor vive, non dirò al presente altro dell'opere sue. Furono cremonesi parimente Geremia scultore, del quale facemmo menzione nella vita del Filareto, et il quale ha fatto una grande opera di marmo in San Lorenzo, luogo de' monaci di Monte Oliveto, e Giovanni Pedoni, che ha fatto molte cose in Cremona et in Brescia, e particolarmente, in casa del signor Eliseo Raimondo, molte cose che sono belle e laudabili.
In Brescia ancora sono stati e sono persone eccellentissime nelle cose del disegno, e fra gl'altri Ieronimo Romanino ha fatte in quella città infinite opere e la tavola che è in San Francesco all'altar maggiore che, assai buona pittura, è di sua mano; e parimente i portegli che la chiudono, i quali sono dipinti a tempera di dentro e di fuori. È similmente sua opera un'altra tavola lavorata a olio, che è molto bella e vi si veggiono forte imitate le cose naturali. Ma più valente di costui fu Alessandro Moretto, il quale dipinse a fresco, sotto l'arco di porta Brusciata, la traslazione de' corpi di San Faustino et Iuvita con alcune macchie di figure, che accompagnano que' corpi molto bene. In San Nazzaro pur di Brescia fece alcun'opere et altre in San Celso, che sono ragionevoli, et una tavola in San Piero in Oliveto, che è molto vaga; in Milano nelle case della Zecca è di mano del detto Alessandro in un quadro la conversione di San Paulo, et altre teste molto naturali e molto bene abbigliati di drappi e vestimenti; perciò che si dilettò molto costui di contrafare drappi d'oro, i quali usò di porre con molta diligenza addosso alle figure. Le teste di mano di costui sono vivissime e tengono della maniera di Raffaello da Urbino, e più ne terrebbono, se non fusse da lui stato tanto lontano.
Fu genero d'Alessandro, Lattanzio Gambaro pittore bresciano, il quale avendo imparato, come s'è detto, l'arte sotto Giulio Campo veronese, è oggi il miglior pittore che sia in Brescia. È di sua mano ne' monaci Neri di San Faustino la tavola dell'altar maggiore e la volta e le facce lavorate a fresco, con altre pitture che sono in detta chiesa. Nella chiesa ancora di San Lorenzo è di sua mano la tavola dell'altar maggiore, due storie che sono nelle facciate e la volta, dipinte a fresco quasi tutte di maniera. Ha dipinta ancora oltre a molte altre, la facciata della sua casa con bellissime invenzioni, e similmente il didentro; nella qual casa, che è da San Benedetto al Vescovado, vidi, quando fui ultimamente a Brescia, due bellissimi ritratti di sua mano, cioè quello d'Alessandro Moretto suo suocero, che è una bellissima testa di vecchio, e quello della figliuola di detto Alessandro, sua moglie. E se simili a questi ritratti fussero l'altre opere di Lattanzio, egli potrebbe andar al pari de' maggiori di quest'arte; ma perché infinite son l'opere di man di costui, essendo ancor vivo basti per ora aver di queste fatto menzione. Di mano di Giangirolamo bresciano si veggiono molte opere in Vinezia et in Milano, e nelle dette case della Zecca sono quattro quadri di notte e di fuochi, molto belli. Et in casa Tomaso da Empoli in Vinezia è una Natività di Cristo finta di notte molto bella, e sono alcune altre cose di simili fantasie delle quali era maestro. Ma perché costui si adoperò solamente in simili cose e non fece cose grandi, non si può dire altro di lui, se non che fu capriccioso e sofistico, e che quello che fece merita di essere molto comendato.
Girolamo Mosciano da Brescia, avendo consumato la sua giovanezza in Roma, ha fatto di molte bell'opere di figure e paesi, et in Orvieto nella principal chiesa di Santa Maria ha fatto due tavole a olio et alcuni Profeti a fresco, che son buon'opere; e le carte, che son fuori di sua mano stampate, son fatte con buon disegno. E perché anco costui vive e ser-ve il cardinale Ippolito da Este nelle sue fabriche et acconcimmi che fa a Roma, a Tigoli et in altri luoghi, non dirò in questo luogo altro di lui. Ultimamente è tornato di Lamagna Francesco Richino, anch'egli pittor bresciano, il quale, oltre a molte altre pitture fatte in diversi luoghi, ha lavorato alcune cose di pittura a olio nel detto San Piero Oliveto di Brescia, che sono fatte con studio e molta diligenza. Cristofano e Stefano fratelli e pittori bresciani hanno appresso gl'artefici gran nome nella facilità del tirare di prospettiva, avendo fra l'altre cose in Vinezia, nel palco piano di Santa Maria dell'Orto, finto di pittura un corridore di colonne doppie atorte e simili a quelle della porta santa di Roma in San Piero, le quali, posando sopra certi mensoloni che sportano in fuori, vanno facendo in quella chiesa un superbo corrido-re con volte a crocera intorno intorno, et ha quest'opera la sua veduta nel mezzo della chiesa con bellissimi scorti, che fanno restar chiunche la vede maravigliato e parere che il palco, che è piano, sia sfondato, essendo massimamente accompagnata con bella varietà di cornici, maschere, festoni et alcuna figura, che fanno ricchissimo ornamento a tutta l'o-pera, che merita d'essere da ognuno infinitamente lodata per la novità e per essere stata condotta con molta diligenza ottimamente a fine. E perché questo modo piacque assai a quel serenissimo senato, fu dato a fare ai medesimi un altro palco simile, ma piccolo, nella libreria di San Marco, che per opera di simili andari fu lodatissimo; et i medesimi finalmente sono stati chiamati alla patria loro Brescia a fare il medesimo a una magnifica sala, che già molti anni sono fu cominciata in piazza con grandissima spesa e fatta condurre sopra un teatro di colonne grandi, sotto il quale si passeggia. È lunga questa sala a sessantadue passi andanti, larga trentacinque et alta similmente nel colmo della sua maggiore altezza braccia trentacinque, ancor ch'ella paia molto maggiore, essendo per tutti i versi isolata e senza alcuna stanza o altro edifizio intorno. Nel palco adunque di questa magnifica et onoratissima sala si sono i detti due fratelli molto adoperati e con loro grandissima lode, avendo a' cavagli di legname che son di pezzi con spranghe di ferri i quali sono grandissimi e bene armati, e fatto centina al tetto che è coperto di piombo, e fatto tornare il palco con bell'artifizio a uso di volta a schifo, che è opera ricca; ma è ben vero che in sì gran spazio non vanno se non tre quadri di pitture a olio di braccia dieci l'uno, i quali dipigné Tiziano vecchio, dove ne sarebbono potuti andar molti più con più bello e proporzionato e ricco spartimento, che arebbono fatto molto più bella, ricca e lieta la detta sala, che è in tutte l'altre parti stata fatta con molto giudizio.
Ora, essendosi in questa parte favellato insin qui degl'artefici del disegno delle città di Lombardia, non fia se non bene, ancor che se ne sia in molti altri luoghi di questa nostr'opera favellato, dire alcuna cosa di quelli della città di Milano, capo di quella provincia, de' quali non si è fatta menzione. Adunque, per cominciarmi da Bramantino, del quale si è ragionato nella vita di Piero della Francesca dal Borgo, io truovo che egli ha molte più cose lavorato di quelle che abbiamo raccontato di sopra; e nel vero, non mi pareva possibile che un artefice tanto nominato et il quale mise in Milano il buon disegno, avesse fatto sì poche opere quante quelle erano che mi erano venute a notizia. Poi, dunque, che ebbe dipinto in Roma, come s'è detto, per papa Nicola Quinto alcune camere e finito in Milano sopra la porta di San Sepolcro il Cristo in iscorto, la Nostra Donna che l'ha in grembo, la Maddalena e San Giovanni, che fu opera rarissima, dipinse nel cortile della Zecca di Milano a fresco in una facciata la Natività di Cristo nostro Salvatore e nella chiesa di Santa Maria di Bara, nel tramezzo, la natività della Madonna et alcuni Profeti negli sportelli dell'organo che scortano al di sotto in su molto bene, et una prospettiva che sfugge con bell'ordine ottimamente; di che non mi fo maraviglia, essendosi costui dilettato et avendo sempre molto ben posseduto le cose d'architettura. Onde mi ricordo aver già veduto in mano di Valerio Vicentino un molto bel libro d'antichità, disegnato e misurato di mano di Bramantino, nel quale erano le cose di Lombardia e le piante di molti edifizii notabili, le quali io disegnai da quel libro essendo giovinetto. Eravi il tempio di Santo Ambrogio di Milano, fatto da' longobardi e tutto pieno di sculture e pitture di maniera greca, con una tribuna tonda assai grande, ma non bene intesa quanto all'architettura, il qual tempio fu poi al tempo di Bramantino rifatto col suo disegno con un portico di pietra da un de' lati e con colonne a tronconi a uso d'alberi tagliati che hanno del nuovo e del vario. Vi era parimente disegnato il portico antico della chiesa di San Lorenzo della medesima città, stato fatto dai romani, che è grand'opera, bella e molto notabile, ma il tempio che vi è della detta chiesa è della maniera de' Gotti. Nel medesimo libro era disegnato il tempio di Santo Ercolino, che è antichissimo e pieno d'incrostature di marmi e di stucchi molto ben conservatisi, et alcune sepolture grandi di granito. Similmente il tempio di San Piero in Ciel d'O-ro di Pavia, nel qual luogo è il corpo di Santo Agostino in una sepoltura che è in sagrestia piena di figure piccole, la quale è di mano, secondo che a me pare, d'Agnolo e d'Agostino scultori sanesi. Vi era similmente disegnata la torre di pietre cotte, fatta dai Gotti, che è cosa bella, veggendosi in quella, oltre l'altre cose, formate di terra cotta e dall'antico, alcune figure di sei braccia l'una che si sono insino a oggi assai bene mantenute. Et in questa torre si dice che morì Boezio, il quale fu sotterrato in detto San Piero in Ciel d'Oro, chiamato oggi Santo Agostino, dove si vede insino a oggi la sepoltura di quel sant'uomo con la inscrizione che vi fece Aliprando, il quale la riedificò e restaurò l'anno 1222. Et oltre questi, nel detto libro era disegnato di mano dell'istesso Bramantino l'antichissimo tempio di Santa Maria in Pertica, di forma tonda e fatto di spoglie dai longobardi, nel qual sono oggi l'ossa della mortalità de' franzesi e d'altri che furono rotti e morti sotto Pavia, quando vi fu preso il re Francesco Primo di Francia dagl'eserciti di Carlo Quinto imperatore. Lasciando ora da parte i disegni, dipinse Bramantino in Milano la facciata della casa del signor Giovambattista Latuate, con una bellissima Madonna, messa in mezzo da' duoi Profeti, e nella facciata del signor Bernardo Scacalarozzo dipinse quattro giganti che son finti di bronzo e sono ragionevoli, con altre opere che sono in Milano, le quali gl'apportarono lode per essere stato egli il primo lume della pittura che si vedesse di buona maniera in Milano e cagione che dopo lui Bramante divenisse, per la buona maniera che diede a' suoi casamenti e prospettive, eccellente nelle cose d'architettura, essendo che le prime cose che studiò Bramante furono quelle di Bramantino. Con ordine del quale fu fatto il tempio di San Satiro, che a me piace sommamente per essere opera ricchissima e dentro e fuori ornata di colonne, corridori doppii et altri ornamenti et accompagnata da una bellissima sagrestia tutta piena di statue. Ma sopratutto merita lode la tribuna del mezzo di questo luogo, la bellezza della quale fu cagione, come s'è detto nella vita di Bramante, che Bernardino da Trevio seguitasse quel modo di fare nel Duomo di Milano et attendesse all'architettura, se bene la sua prima e principal arte fu la pittura, avendo fatto, come s'è detto, a fresco nel monasterio delle Grazie quattro storie della Passione in un chiostro et alcun'altre di chiaro scuro.
Da costui fu tirato innanzi e molto aiutato Agostino Busto scultore, cognominato Bambaia, del quale si è favellato nella vita di Baccio da Monte Lupo, et il quale ha fatto alcun'opere in Santa Marta, monasterio di donne in Milano. Fra le quali ho veduto io, ancor che si abbia con difficultà licenza d'entrare in quel luogo, la sepoltura di monsignor di Fois, che morì a Pavia, in più pezzi di marmo; nei quali sono da dieci storie di figure piccole sculpite con molta diligenza de' fatti, battaglie, vittorie et espugnazioni di torre, fatte da quel signore, e finalmente la morte e sepoltura sua. E per dirlo brevemente, ell'è tale quest'opera che mirandola con stupore stetti un pezzo pensando se è possibile che si facciano con mano e con ferri sì sottili e maravigliose opere, veggendosi in questa sepoltura, fatti con stupendissimo intaglio, fregiature di trofei, d'arme di tutte le sorti, carri, artiglierie e molti altri instrumenti da guerra, e finalmente il corpo di quel signore armato e grande quanto il vivo, quasi tutto lieto nel sembiante così morto, per le vittorie avute. E certo è un peccato che quest'opera, la quale è degnissima di essere annoverata fra le più stupende dell'arte, sia imperfetta e lasciata stare per terra in pezzi, senza essere in alcun luogo murata, onde non mi maraviglio che ne siano state rubate alcune figure e poi vendute e poste in altri luoghi. E pur è vero che tanta poca umanità o più tosto pietà oggi fra gl'uomini si ritruova che a niun, di tanti che furono da lui beneficati et amati, è mai incresciuto della memoria di Fois, né della bontà et eccellenza dell'opera. Di mano del medesimo Agostino Busto sono alcun'opere nel Duomo, et in San Francesco, come si disse, la sepoltura de' Biraghi, et alla Certosa di Pavia molte altre che son bellissime. Concorrente di costui fu un Cristofano Gobbo, che lavorò anch'egli molte cose nella facciata della detta Certosa et in chiesa tanto bene, che si può mettere fra i migliori architettori che fussero in quel tempo in Lombardia. E l'Adamo et Eva che sono nella facciata del Duomo di Milano verso levante, che sono di mano di costui, sono tenute opere rare e tali che possono stare a paragone di quante ne sieno state fatte in quelle parti da altri maestri.
Quasi ne' medesimi tempi fu in Milano un altro scultore, chiamato Angelo e per sopranome il Ciciliano, il quale fece dalla medesima banda e della medesima grandezza, una Santa Maria Maddalena elevata in aria da quattro putti, che è opera bellissima e non punto meno che quelle di Cristofano, il quale attese anco all'architettura e fece fra l'altre cose il portico di San Celso in Milano, che dopo la morte sua fu finito da Tofano detto il Lombardino, il quale come si disse nella vita di Giulio Romano, fece molte chiese e palazzi per tutto Milano et in particolare il monasterio, facciata e chiesa delle monache di Santa Caterina alla porta Ticinese, e molte altre fabriche a queste somiglianti.
Per opera di costui, lavorando Silvio da Fiesole nell'opera di quel Duomo, fece nell'ornamento d'una porta che è volta fra ponente e tramontana, dove sono più storie della vita di Nostra Donna, quella dove ell'è sposata, che è molto bella, e dirimpetto a questa, quella di simile grandezza, in cui sono le nozze di Cana Galilea, è di mano di Marco da Gra assai pratico scultore. Nelle quali storie seguita ora di lavorare un molto studioso giovane, chiamato Francesco Brambilari, il quale ne ha quasi che a fine condotta una, nella quale gl'Apostoli ricevono lo Spirito Santo, che è cosa bellissima. Ha oltre ciò fatto una gocciola di marmo tutta traforata e con un gruppo di putti e fogliami stupendi, sopra la quale (che ha da essere posta in Duomo) va una statua di marmo di papa Pio IIII de' Medici milanese. Ma se in quel luogo fusse lo studio di quest'arti che è in Roma et in Firenze, arebbono fatto e farebbono tuttavia questi valentuomini cose stupende. E nel vero hanno al presente grand'obligo al cavaliere Leone Leoni aretino, il quale, come si dirà, ha speso assai danari a tempo in condurre a Milano molte cose antiche, formate di gesso per servizio suo e degl'altri artefici.
Ma tornando ai pittori milanesi, poiché Lionardo da Vinci vi ebbe lavorato il cenacolo sopra detto, molti cercarono d'imitarlo, e questi furono Marco Uggioni et altri, de' quali si è ragionato nella vita di lui. Et oltre quelli lo imitò molto bene Cesare da Sesto, anch'egli milanese, e fece, più di quel che s'è detto nella vita di Dosso, un gran quadro che è nelle case della Zecca di Milano, dentro al quale, che è veramente copioso e bellissimo, Cristo è battezzato da Giovanni. È anco di mano del medesimo del detto luogo una testa d'una Erodiade con quella di San Giovanni Battista in un bacino fatte con bellissimo artificio; e finalmente dipinse costui in San Rocco fuor di porta Romana una tavola, dentrovi quel santo, molto giovane, et alcuni quadri che son molto lodati.
Gaudenzio pittor milanese, il quale mentre visse si tenne valentuomo, dipinse in San Celso la tavola dell'altar maggiore, et a fresco, in Santa Maria delle Grazie in una capella, la Passione di Gesù Cristo in figure quanto il vivo, con strane attitudini, e dopo fece sotto questa capella una tavola a concorrenza di Tiziano, nella quale, ancor che egli molto si persuadesse, non passò l'opere degl'altri che avevano in quel luogo lavorato. Bernardino del Lupino, di cui si disse alcuna cosa poco di sopra, dipinse già in Milano vicino a San Sepolcro la casa del signor Gianfrancesco Rabbia, cioè la facciata, le loge, sale e camere, facendovi molte trasformazioni d'Ovidio et altre favole con belle e buone figure e lavorate dilicatamente; et al munisterio maggiore dipinse tutta la facciata grande dell'altare con diverse storie, e similmente in una capella Cristo battuto alla colonna e molte altre opere che tutte sono ragionevoli. E questo sia il fine delle sopradette vite di diversi artefici lombardi.
VITA DI RIDOLFO, DAVIT E BENEDETTO GRILLANDAI
PITTORI FIORENTINI

Ancor che non paia in un certo modo possibile che chi va imitando e seguita le vestigia d'alcun uomo eccellente nelle nostre arti, non debba divenire in gran parte a colui simile, si vede nondimeno che molte volte i frategli e' figliuoli delle persone singolari non seguitano in ciò i loro parenti e stranamente tralignano da loro; la qual cosa non penso già io che avenga perché non vi sia, mediante il sangue, la medesima prontezza di spirito et il medesimo ingegno, ma sì be-ne da altra cagione: cioè dai troppi agi e commodi e dall'abondanza delle facultà, che non lascia divenir molte volte gl'uomini solleciti agli studii et industriosi. Ma non però questa regola è così ferma che anco non avenga alcuna volta il contrario.
Davit e Benedetto Ghirlandai, se bene ebbono bonissimo ingegno et arebbono potuto farlo, non però seguitarono nelle cose dell'arte Domenico lor fratello, perciò che dopo la morte di detto lor fratello si sviarono dal bene operare; conciò sia che l'uno, cioè Benedetto, andò lungo tempo vagabondo e l'altro s'andò stillando il cervello vanamente dietro al musaico.
Davit adunque, il quale era stato molto amato da Domenico e lui amò parimente e vivo e morto, finì dopo lui, in compagnia di Benedetto suo fratello, molte cose cominciate da esso Domenico e particolarmente la tavola di Santa Maria Novella all'altar maggiore, cioè la parte di dietro, che oggi è verso il coro; et alcuni creati del medesimo Domenico finirono la predella di figure piccole, cioè Nicolaio, sotto la figura di Santo Stefano, fece una disputa di quel Santo con molta diligenza; e Francesco Granacci, Iacopo del Tedesco e Benedetto fecero la figura di Santo Antonino arcivescovo di Fiorenza e Santa Caterina da Siena, et in chiesa in una tavola Santa Lucia con la testa d'un frate, vicino al mezzo del-la chiesa, con molte altre pitture e quadri che sono per le case de' particolari.
Essendo poi stato Benedetto parecchi anni in Francia, dove lavorò, guadagnò assai e se ne tornò a Firenze con molti privilegii e doni avuti da quel re in testimonio della sua virtù, e finalmente avendo atteso non solo alla pittura, ma anco alla milizia, si morì d'anni 50. E Davitte, ancora che molto disegnasse e lavorasse, non però passò di molto Benedetto, e ciò potette avenire, dallo star troppo bene e dal non tenere fermo il pensiero all'arte, la quale non è trovata se non da chi la cerca, e trovata non vuole essere abbandonata, perché si fugge. Sono di mano di Davitte nell'orto de' monaci de-gl'Angeli di Firenze, in testa della viottola, che è dirimpetto alla porta che va in detto orto, due figure a fresco a' piè d'un Crucifisso, cioè San Benedetto e San Romualdo, et alcun'altre cose simili poco degne che di loro si faccia alcuna memoria. Ma non fu poco, poiché non volle Davitte attendere all'arte, che vi facesse attendere con ogni studio e per quella incaminasse Ridolfo, figliuolo di Domenico e suo nipote; conciò fusse che, essendo costui, il quale era a custodia di Davitte, giovinetto di bell'ingegno, fugli messo a esercitare la pittura e datogli ogni commodità di studiare dal zio, il quale si pentì tardi di non avere egli studiatola, ma consumato il tempo dietro al musaico.
Fece Davit sopra un grosso quadro di noce, per mandarla al re di Francia, una Madonna di musaico con alcuni Angeli attorno, che fu molto lodata; e dimorando a Montaione, castello di Valdelsa, per aver quivi commodità di vetri, di legnami e di fornaci, vi fece molte cose di vetri e musaici, e particolarmente alcuni vasi che furono donati al Magnifico Lorenzo Vecchio de' Medici, e tre teste, cioè di San Piero e San Lorenzo e quella di Giuliano de' Medici in una tegghia di rame, le quali son oggi in guardaroba del Duca. Rifoldo intanto, disegnando al cartone di Michelagnolo, era tenuto de' migliori disegnatori che vi fussero e perciò molto amato da ognuno, e particolarmente da Raffaello Sanzio da Urbino, che in quel tempo, essendo anch'egli giovane di gran nome, dimorava in Fiorenza, come s'è detto, per imparare l'ar-te.
Dopo aver Ridolfo studiato al detto cartone, fatto che ebbe buona pratica nella pittura sotto fra' Bartolomeo di San Marco, ne sapea già tanto, a giudizio de' migliori, che dovendo Raffaello andare a Roma, chiamato da papa Giulio Secondo, gli lasciò a finire il panno azzurro et altre poche cose che mancavano al quadro d'una Madonna che egli avea fatta per alcuni gentiluomini sanesi, il qual quadro, finito che ebbe Ridolfo con molta diligenza, lo mandò a Siena. E non fu molto dimorato Raffaello a Roma, che cercò per molte vie di condurre là Ridolfo, ma non avendo mai perduta colui la cupola di veduta (come si dice), né sapendosi arrecare a vivere fuor di Fiorenza, non accettò mai partito che diverso o contrario al suo vivere di Firenze gli fusse proposto.
Dipinse Ridolfo nel monasterio delle monache di Ripoli due tavole a olio: in una la coronazione di Nostra Donna e nell'altra una Madonna in mezzo a certi Santi; nella chiesa di San Gallo fece in una tavola Cristo che porta la croce, con buon numero di soldati e la Madonna et altre Marie che piangono insieme con Giovanni, mentre Veronica porge il sudario a esso Cristo, con prontezza e vivacità. La quale opera, in cui sono molte teste bellissime, ritratte dal vivo e fatte con amore, acquistò gran nome a Ridolfo: vi è ritratto suo padre et alcuni garzoni che stavano seco, e de' suoi amici il Poggino, lo Scheggia et il Nunziata che è una testa vivissima. Il quale Nunziata, se bene era dipintore di fantocci, era in alcune cose persona rara e massimamente nel fare fuochi lavorati e le girandole che si facevano ogni anno per San Giovanni; e perché era costui persona burlevole e faceta, aveva ognuno gran piacere in conversando con esso lui. Dicendogli una volta un cittadino che gli dispiacevano certi dipintori che non sapevano fare se non cose lascive e che perciò desiderava, che gli facesse un quadro di Madonna che avesse l'onesto, fusse attempata e non movesse a lascivia, il Nunziata gliene dipinse una con la barba; un altro volendogli chiedere un Crucifisso per una camera terrena, dove abitava la state, e non sapendo dire se non: “Io vorrei un Crucifisso per la state”, il Nunziata, che lo scorse per un goffo, gliene fece uno in calzoni. Ma tornando a Ridolfo, essendogli dato a fare per il monasterio di Cestello in una tavola la Natività di Cristo, affaticandosi assai per superare gl'emuli suoi, condusse quell'opera con quella maggior fatica e diligenza che gli fu possibile, facendovi la Madonna che adora Cristo fanciullo, San Giuseppo e due figure in ginocchioni, cioè San Francesco e San Ieronimo; fecevi ancora un bellissimo paese molto simile al Sasso della Vernia, dove San Francesco ebbe le stimmate, e sopra la capanna alcuni Angeli che cantano, e tutta l'opera fu di colorito molto bello e che ha assai rilievo.
Nel medesimo tempo, fatta una tavola che andò a Pistoia, mise mano a due altre per la Compagnia di S. Zanobi, che è a canto alla canonica di Santa Maria del Fiore, le quali avevano a mettere in mezzo la Nunziata che già vi fece, come si disse nella sua vita, Mariotto Albertinelli. Condusse dunque Ridolfo a fine con molta sodisfazione degl'uomini di quella Compagnia le due tavole, facendo in una San Zanobi che risuscita nel borgo degl'Albizi di Fiorenza un fanciullo, che è storia molto pronta e vivace, per esservi teste assai ritratte di naturale et alcune donne che mostrano vivamente allegrezza e stupor nel vedere risuscitare il putto e tornargli lo spirito, e nell'altra è quando da sei vescovi è portato il detto San Zanobi morto da San Lorenzo, dove era prima sotterrato, a Santa Maria del Fiore e che, passando per la piazza di San Giovanni, un olmo che vi era secco, dove è oggi per memoria del miracolo una colonna di marmo con una croce sopra, rimise subito, che fu per voler di Dio tocco dalla cassa dove era il corpo santo, le frondi e fece fiori. La quale pittura non fu men bella che l'altre sopra dette di Ridolfo; e perché queste opere furono da questo pittore fatte vi-vendo ancor Davit suo zio, n'aveva quel buon vecchio grandissimo contento e ringraziava Dio d'esser tanto vivuto, che vedea la virtù di Domenico quasi risorgere in Ridolfo. Ma finalmente essendo d'anni settantaquattro, mentre si apparecchiava così vecchio per andare a Roma a prendere il santo giubileo, s'ammalò e morì l'anno 1525, e da Ridolfo ebbe sepoltura in Santa Maria Novella, dove gl'altri Ghirlandai. Avendo Ridolfo un suo fratello negl'Angeli di Firenze, luogo de' monaci di Camaldoli, chiamato don Bartolomeo, il quale fu religioso veramente costumato e da bene, Ridolfo, che molto l'amava, gli dipinse nel chiostro che risponde in sull'orto, cioè nella loggia dove sono di mano di Paulo Ucello dipinte di verdaccio le storie di San Benedetto, entrando per la porta dell'orto a man ritta, una storia dove il medesimo santo sedendo a tavola con due Angeli a torno, aspetta che da Romano gli sia mandato il pane nella grotta, et il diavolo ha spezzato la corda co' sassi; et il medesimo che mette l'abito a un giovane. Ma la miglior figura di tutte quelle che so-no in quell'archetto è il ritratto d'un nano, che allora stava alla porta di quel monastero; nel medesimo luogo, sopra la pila dell'acqua santa, all'entrare in chiesa, dipinse a fresco di colori una Nostra Donna col Figliuolo in collo et alcuni Angioletti a torno bellissimi. E nel chiostro, che è dinanzi al capitolo, sopra la porta d'una capelletta dipinse a fresco in un mezzo tondo San Romualdo con la chiesa dell'eremo di Camaldoli in mano, e non molto dopo, un molto bel cenacolo che è in testa del refettorio dei medesimi monaci, e questo gli fece fare don Andrea Doffi abbate, il quale era stato monaco di quel monasterio e vi si fece ritrarre da basso in un canto. Dipinse anco Ridolfo nella chiesina della Misericordia in sulla piazza di San Giovanni in una predella tre bellissime storie della Nostra Donna, che paiono miniate, et a Matio Cini in sull'angolo della sua casa, vicino alla piazza di Santa Maria Novella in un tabernacoletto la Nostra Donna, San Matia apostolo, San Domenico e due piccioli figliuoli di esso Matio ginocchioni, ritratti di naturale; la qual opera, ancor che piccola, è molto bella e graziosa. Alle monache di San Girolamo dell'Ordine di San Francesco de' zoccoli, sopra la costa di San Giorgio, dipinse due tavole: in una è San Girolamo in penitenza molto bello, e sopra nel mezzo tondo una Natività di Gesù Cristo, e nell'altra, che è dirimpetto a questa, è una Nunziata, e sopra nel mezzo ton-do Santa Maria Madalena che si comunica. Nel palazzo che è oggi del Duca, dipinse la capella dove udivano messa i signori, facendo nel mezzo della volta la Santissima Trinità e negl'altri spartimenti alcuni putti che tengono i misterii della Passione et alcune teste fatte per i dodici Apostoli; nei quattro canti fece gl'Evangelisti di figure intere et in testa l'Angelo Gabriello che annunzia la Vergine, figurando in certi paesi la piazza della Nunziata di Firenze fino alla chiesa di San Marco, la quale tutta opera è ottimamente condotta e con molti e belli ornamenti. E questa finita, dipinse in una tavola, che fu posta nella Pieve di Prato, la Nostra Donna che porge la cintola a San Tomaso, che è insieme con gl'altri Apostoli; et in Ognisanti fece per monsignor de' Bonafé, spedalingo di Santa Maria Nuova e vescovo di Cortona, in una tavola la Nostra Donna, San Giovanni Battista e San Romualdo, et al medesimo, avendolo ben servito, fece alcun'al-tr'opere, delle quali non accade far menzione. Ritrasse poi le tre forze d'Ercole, che già dipinse nel palazzo de' Medici Anton Pollaiolo, per Giovambattista della Palla che le mandò in Francia. Avendo fatto Ridolfo queste e molte altre pitture e trovandosi in casa tutte le masserizie da lavorare il musaico, che furono di Davit suo zio e di Domenico suo padre, et avendo anco da lui imparato alquanto a lavorare, deliberò voler provarsi a far alcuna cosa di musaico di sua mano; e così fatto, veduto che gli riusciva, tolse a far l'arco che è sopra la porta della chiesa della Nunziata, nel quale fece l'Angelo che annunzia la Madonna; ma perché non poteva aver pacienza a commettere que' pezzuoli, non fece mai più altro di quel mestiere. Alla Compagnia de' Battilani a sommo il Campaccio, a una loro chiesetta, fece in una tavola l'Assunzione di Nostra Donna con un coro d'Angeli e gl'Apostoli intorno al sepolcro; ma essendo per disaventura la stanza dove ell'era, stata piena di scope verdi da far bastioni l'anno dell'assedio, quell'umidità rintenerì il gesso e la scortecciò tutta, onde Ridolfo l'ebbe a rifare e vi si ritrasse dentro. Alla pieve di Giogoli, in un tabernacolo che è in sulla strada, fece la Nostra Donna con due Angeli, e dirimpetto a un mulino de' padri romiti di Camaldoli, che è di là dalla Certosa in sull'Ema, dipinse in un altro tabernacolo a fresco molte figure, per le quali cose veggendosi Ridolfo essere adoperato a bastanza e standosi bene e con buone entrate, non volle altrimenti stillarsi il cervello a fare tutto quello che arebbe potuto nella pittura, anzi andò pensando di vivere da galantuomo e pigliarsela come veniva. Nella venuta di papa Leone a Firenze, fece in compagnia di suoi amici e garzoni quasi tutto l'apparato di casa Medici, acconciò la sala del papa e l'altre stanze, facendo dipignere al Puntormo, come si è detto, la capella. Similmente nelle nozze del duca Giuliano e del duca Lorenzo fece gl'apparati delle nozze et alcune prospettive di comedie, e perché fu da que' signori per la sua bontà molto amato, ebbe molti ufficii per mezzo loro e fu fatto di collegio come cittadino onorato. Non si sdegnò anco Ridolfo di far drapelloni, stendardi et altre cose simili assai, e mi ricorda avergli sentito dire che tre volte fece le bandiere delle potenze che solevano ogni anno armeggiare e tenere in festa la città. Et insomma si lavorava in bottega sua di tutte le cose, onde molti giovani la frequentavano, imparando ciascuno quello che più gli piaceva. Onde Antonio del Ceraiolo, essendo stato con Lorenzo di Credi e poi con Ridolfo, ritiratosi da per sé fece molte opere e ritratti di naturale. In San Iacopo tra' Fossi è di mano di questo Antonio in una tavola San Francesco e Santa Madalena a' piè d'un crucifisso, e ne' Servi, dietro all'altar maggiore, un San Michelagnolo ritratto dal Ghirlandaio nell'ossa di Santa Maria Nuova. Fu anche discepolo di Ridolfo, e si portò benissimo, Mariano da Pescia, di mano del quale è un quadro di Nostra Donna con Cristo fanciullo, Santa Lisabeta e San Giovanni, molto ben fatti, nella detta cappella di palazzo, che già dipinse Ridolfo alla signoria. Il medesimo dipinse di chiaro scuro tutta la casa di Carlo Ginori nella strada che ha da quella famiglia il nome, facendovi storie de' fatti di Sansone, con bellissima maniera; e se costui avesse avuto più lunga vita che non ebbe, sarebbe riuscito eccellente. Discepolo parimente di Ridolfo fu Toto del Nunziata, il quale fece in S. Piero Scheraggio con Ridolfo una tavola di Nostra Donna col Figliuolo in braccio e due Santi; ma sopra tutti gl'altri, fu carissimo a Ridolfo un discepolo di Lorenzo di Credi, il quale stette anco con Antonio del Ceraiolo, chiamato Michele, per essere d'ottima natura e giovane che conduc[ev]a le sue opere con fierezza e senza stento. Costui dunque, seguitando la maniera di Ridolfo, lo ragiunse di maniera, che dove avea da lui a principio il terzo dell'utile, si condussero a fare insieme l'opere a metà del guadagno. Osservò sempre Michele Ridolfo come padre e l'amò e fu da lui amato di maniera, che come cosa di lui è stato sempre et è ancora, non per altro cognome conosciuto, che per Michele di Ridolfo. Costoro dico, che s'amarono come padre e figliuolo, lavorarono infinite opere insieme e di compagnia; e prima per la chiesa di S. Felice in Piazza, luogo allora de' monaci di Camaldoli, dipinsero in una tavola Cristo e la Nostra Donna in aria, che pregano Dio Padre per il popolo da basso, dove sono ginocchioni alcuni Santi. In Santa Felicita fecero due capelle a fresco, tirate via praticamente: in una è Cristo morto con le Marie e nell'altra l'Assunta con alcuni Santi. Nella chiesa delle monache di San Iacopo dalle Murate feciono un tavola per il vescovo di Cortona de' Bonafé; e dentro al monasterio delle donne di Ripoli, in un'altra tavola la Nostra Donna e certi Santi; alla capella de' Segni sotto l'organo, nella chiesa di Santo Spirito, fecero similmente in una tavola la Nostra Donna, Sant'Anna e molti altri Santi. Alla Compagnia de' Neri, in un quadro, la decollazione di S. Giovanni Battista, et in borgo S. Friano alle monachine, in una tavola, la Nunziata. A Prato in S. Rocco, in un'altra, dipinsero S. Rocco, San Bastiano e la Nostra Donna in mezzo. Parimente nella Compagnia di S. Bastiano, a lato a S. Iacopo sopr'Arno, fecero una tavola, dentrovi la Nostra Donna, S. Bastiano e S. Iacopo; et a S. Martino alla Palma un'altra, e finalmente al signor Alessandro Vitelli, in un quadro che fu mandato a Città di Castello, una Sant'Anna che fu posta in San Fiordo alla capella di quel signore. Ma perché furono infinite l'ope-re et i quadri che uscirono dalla bottega di Ridolfo e molto più i ritratti di naturale, dirò solo che da lui fu ritratto il signor Cosimo de' Medici quando era giovinetto, che fu bellissima opera e molto somigliante al vero; il qual quadro si serba ancor oggi nella guardaroba di sua eccellenza. Fu Ridolfo spedito e presto dipintore in certe cose e particolarmente in apparati di feste; onde fece nella venuta di Carlo V imperadore a Fiorenza, in dieci giorni, un arco al canto alla Cuculia, et un altro arco in brevissimo tempo alla porta al Prato nella venuta dell'illustrissima signora duchessa Leonora, come si dirà nella vita di Battista Franco. Alla Madonna di Vertigli, luogo de' monaci di Camaldoli fuor della terra del Monte San Savino, fece Ridolfo, avendo seco il detto Battista Franco e Michele, in un chiostretto tutte le storie del-la vita di Giosef di chiaro scuro; in chiesa le tavole dell'altar maggiore et a fresco una visitazione di Nostra Donna che è bella quanto altra opera in fresco che mai facesse Ridolfo. Ma sopra tutto fu bellissima figura nell'aspetto venerando del volto il San Romualdo che è al detto altar maggiore; vi fecero anco altre pitture, ma basti avere di queste ragionato. Dipinse Ridolfo nel palazzo del duca Cosimo nella camera verde una volta di grottesche e nelle facciate alcuni paesi, che molto piacquero al Duca. Finalmente invecchiato Ridolfo si viveva assai lieto avendo le figliuole maritate e veggendo i maschi assai bene aviati nelle cose della mercatura in Francia et in Ferrara. E se bene si trovò poi in guisa oppresso dalle gotte, che e' stava sempre in casa o si facea portare sopra una seggiola, nondimeno portò sempre con molta pacienza quella indisposizione et alcune disaventure de' figliuoli. E portando così vecchio grande amore alle cose dell'arte, voleva intendere et alcuna volta vedere quelle cose che sentiva molto lodare di fabbriche, di pitture et altre cose simili che giornalmente si facevano. Et un giorno che il signor Duca era fuor di Fiorenza, fattosi portare sopra la sua seggiola in palazzo, vi desinò e stette tutto quel giorno a guardare quel palazzo tanto avolto e rimutato da quello che già era, che egli non lo riconosceva; e la sera nel partirsi disse: “Io moro contento però che potrò portar nuova di là ai nostri artefici d'avere veduto risuscitare un morto, un brutto divenir bello et un vecchio ringiovenito”.
Visse Ridolfo anni settantacinque e morì l'anno 1560, e fu sepolto, dove i suoi maggiori, in Santa Maria Novella. E Michele suo creato, il quale come ho detto, non è chiamato altrimenti che Michele di Ridolfo, ha fatto dopo che Ridolfo lasciò l'arte, tre grandi archi a fresco sopra alcune porte della città di Firenze, a S. Gallo la Nostra Donna, S. Giovanni Battista e San Cosimo, che son fatte con bellissima pratica; alla porta al Prato altre figure simili, et alla porta alla Croce la Nostra Donna, S. Giovanni Battista e Santo Ambrogio, e tavole e quadri senza fine, fatti con buona pratica. Et io per la sua bontà e sufficienza l'ho adoperato più volte, insieme con altri, nell'opere di palazzo, con mia molta sodisfazione e d'ognuno; ma quello che in lui mi piace sommamente, oltre all'essere egli veramente uomo da bene, costumato e timorato di Dio, si è che ha sempre in bottega buon numero di giovinetti ai quali insegna con incredibile amorevolezza. Fu anco discepolo di Ridolfo Carlo Portegli da Loro di Valdarno disopra, di mano del quale sono in Fiorenza alcune tavole et infiniti quadri: in Santa Maria Maggiore, in Santa Felicita, nelle monache di Monticelli et in Cestello la tavola della capella de' Baldesi a man ritta all'entrare in chiesa, nella quale è il martirio di Santo Romolo vescovo di Fiesole.
IL FINE DELLA VITA DI RIDOLFO GRILLANDAI, PITTORE FIORENTINO
VITA DI GIOVANNI DA UDINE
PITTORE

In Udine, città del Friuli, un cittadino chiamato Giovanni, della famiglia di Nani, fu il primo che di loro attendesse all'esercizio del ricamare, nel quale il seguitarono poi i suoi discendenti con tanta eccellenza, che non più de' Nani fu detta la loro casata, ma de' Ricamatori. Di costoro dunque un Francesco che visse sempre da onorato cittadino, attendendo alle cacce et altri somiglianti esercizii, ebbe un figliuolo l'anno 1494 al quale pose nome Giovanni, il quale, essendo ancor putto, si mostrò tanto inclinato al disegno, che era cosa maravigliosa; perciò che seguitando la caccia e l'u-cellare dietro al padre, quando avea tempo ritraeva sempre cani, lepri, capri et insomma tutte le sorti d'animali e d'uc-celli che gli venivano alle mani. Il che faceva per sì fatto modo che ognuno ne stupiva. Questa inclinazione veggendo Francesco suo padre, lo condusse a Vinezia e lo pose a imparare l'arte del disegno con Giorgione da Castelfranco, col quale dimorando il giovane, sentì tanto lodare le cose di Michelagnolo e Raffaello, che si risolvé d'andare a Roma ad ogni modo. E così, avuto lettere di favore da Domenico Grimano amicissimo di suo padre a Baldassarri Castiglioni segretario del Duca di Mantoa et amicissimo di Raffaello da Urbino, se n'andò là dove da esso Castiglioni essendo accommodato nella scuola de' giovani di Raffaello, apprese ottimamente i principii dell'arte, il che è di grande importanza, perciò che quando altri nel cominciare piglia cattiva maniera, rade volte adiviene ch'ella si lasci senza difficultà per apprenderne una migliore. Giovanni adunque, essendo stato pochissimo in Vinezia sotto la disciplina di Giorgione, veduto l'andar dolce, bello e grazioso di Raffaello, si dispose come giovane di bell'ingegno a volere a quella maniera attenersi per ogni modo; onde, alla buona intenzione corrispondendo l'ingegno e la mano, fece tal frutto, che in brevissimo tempo seppe tanto bene disegnare e colorire con grazia e facilità, che gli riusciva contrafare benissimo, per dirlo in una parola, tutte le cose naturali, d'animali, di drappi, d'instrumenti, vasi, paesi, casamenti e verdure, in tanto che niun de' giovani di quella scuola il superava. Ma sopratutto si dilettò sommamente di fare uccelli di tutte le sorti, di maniera, che in poco tempo ne condusse un libro tanto vario e bello, che egli era lo spasso et il trastullo di Raffaello. Appresso il quale dimorando un fiamingo chiamato Giovanni, il quale era maestro eccellente di far vagamente frutti, foglie e fiori similissimi al naturale, se bene in maniera un poco secca e stentata, da lui imparò Giovanni da Udine a fargli belli come il maestro, e, che è più, con una certa maniera morbida e pastosa, la quale il fece in alcune cose, come si dirà, riuscire eccellentissimo. Imparò anco a far paesi con edifizii rotti, pezzi d'anticaglie e così a colorire in tele, paesi e verzure, nella maniera che si è dopo lui usato non pur dai fiaminghi, ma ancora da tutti i pittori italiani;
Raffaello adunque, che molto amò la virtù di Giovanni, nel fare la tavola della Santa Cecilia, che è in Bologna, fece fare a Giovanni un organo che ha in mano quella Santa, il quale lo contrafé tanto bene dal vero, che pare di rilievo, et ancora tutti gli strumenti musicali che sono a' piedi di quella Santa, e, quello che importò molto più, fece il suo dipinto così simile a quello di Raffaello, che pare d'una medesima mano. Non molto dopo cavandosi da San Piero in Vincola fra le ruine et anticaglie del palazzo di Tito per trovar figure, furono ritrovate alcune stanze sotterra, ricoperte tutte e piene di grotteschine, di figure piccole e di storie con alcuni ornamenti di stucchi bassi. Per che, andando Giovanni con Raffaello, che fu menato a vederle, restarono l'uno e l'altro stupefatti della freschezza, bellezza e bontà di quell'opere, parendo loro gran cosa ch'elle si fussero sì lungo tempo conservate; ma non era gran fatto non essendo state tocche né vedute dall'aria, la quale col tempo suole consumare, mediante la varietà delle stagioni, ogni cosa. Queste grottesche adunque (che grottesche furono dette dell'essere state entro alle grotte ritrovate) fatte con tanto disegno, con sì varii e bizzarri capricci e con quegli ornamenti di stucchi sottili, tramezzati di varii campi di colori, con quelle storiettine così belle e leggiadre, entrarono di maniera nel cuore e nella mente a Giovanni, che datosi a questo studio, non si contentò d'una sola volta o due disegnarle e ritrarle. E riuscendogli il farle con facilità e con grazia, non gli mancava se non ave-re il modo di fare quelli stucchi sopra i quali le grottesche erano lavorate, et ancor che molti innanzi a lui, come s'è detto, avessono ghiribizzatovi sopra, senza aver altro trovato che il modo di fare al fuoco lo stucco con gesso, calcina, pece greca, cera e matton pesto et a metterlo d'oro, non però avevano trovato il vero modo di fare gli stucchi simili a quelli che si erano in quelle grotte e stanze antiche ritrovati. Ma facendosi allora in S. Piero gl'archi e la tribuna di dietro, come si disse nella vita di Bramante, di calcina e pozzolana, gettando ne' cavi di terra tutti gl'intagli de' fogliami, degl'uo-voli et altre membra, cominciò Giovanni, dal considerare quel modo di fare con calcina e pozzolana, a provare se gli riusciva il far figure di basso rilievo, e così provandosi gli vennero fatte a suo modo in tutte le parti, eccetto che la pelle ultima non veniva con quella gentilezza e finezza che mostravano l'antiche, né anco così bianca. Per lo che andò pensando dovere essere necessario mescolare con la calcina di trevertino bianca, in cambio di pozzolana, alcuna cosa che fusse di color bianco, per che, dopo aver provato alcun'altre cose, fatto pestare scaglie di trevertino, trovò che facevano assai bene: ma tuttavia era il lavoro livido e non bianco, e ruvido e granelloso. Ma finalmente fatto pestare scaglie del più bianco marmo che si trovasse, ridottolo in polvere sottile e stacciatolo, lo mescolò con calcina di trevertino bianco, e trovò che così veniva fatto senza dubbio niuno il vero stucco antico con tutte quelle parti che in quello aveva disiderato. Della qual cosa molto rallegratosi, mostrò a Raffaello quello che avea fatto; onde egli, che allora facea, come s'è detto, per ordine di papa Leone X le logge del palazzo papale, vi fece fare a Giovanni tutte quelle volte di stucchi, con bellissimi ornamenti, ricinti di grottesche simili all'antiche, e con vaghissime e capricciose invenzioni, piene delle più varie e stravaganti cose che si possano imaginare. E condotto di mezzo e basso rilievo tutto quell'ornamento, lo tramezzò poi di storiette, di paesi, di fogliami e varie fregiature, nelle quali fece lo sforzo quasi di tutto quello che può far l'arte in quel genere; nella qual cosa egli non solo paragonò gl'antichi, ma per quanto si può giudicare dalle cose che si son vedute, gli superò. Perciò che quest'opere di Giovanni, per bellezza di disegno, invenzione di figure e colorito, o lavorate di stucco o dipinte, sono senza comparazione migliori che quell'antiche, le quali si veggiono nel Colosseo e dipinte alle Terme di Diocleziano et in altri luoghi. Ma dove si possono in altro luogo vedere uccelli dipinti che più sieno, per dir così, al colorito, alle piume et in tutte l'altre parti, vivi e veri, di quelli che sono nelle fregiature e pilastri di quelle logge? I quali vi sono di tante sorti di quante ha saputo fare la natura: alcuni in un modo et altri in altro, e molti posti sopra mazzi, ma di tutte le maniere biade, legumi e frutti che ha per bisogno e nutrimento degl'uccelli in tutti i tempi prodotti la terra. Similmente de' pesci e tutti animali dell'acqua e mostri marini che Giovanni fece nel medesimo luogo, per non potersi dir tanto che non sia poco, fia meglio passarla con silenzio, che mettersi a volere tentare l'impossibile. Ma che dirò delle varie sorti di frutti e di fiori che vi sono senza fine e di tutte le maniere, qualità e colori, che in tutte le parti del mondo sa produrre la natura in tutte le stagioni dell'anno? E che parimente di varii instrumenti musicali, che vi sono naturalissimi? E chi non sa, come cosa notissima, che avendo Giovanni in testa di questa loggia, dove anco non era risoluto il Papa che fare vi si dovesse, di muraglia, dipinto, per accompagnare i veri della loggia, alcuni balaustri e sopra quelli un tapeto, chi non sa, dico, bisognandone un giorno uno in fretta per il Papa che andava in Belvedere, che un palafreniero, il quale non sapeva il fatto, corse da lontano per levare uno di detti tapeti dipinti e rimase ingannato? Insomma si può dire, con pace di tutti gl'altri artifici, che per opera così fatta, questa sia la più bella, la più rara e più eccellente pittura che mai sia stata veduta da occhio mortale; et ardirò oltre ciò d'affermare questa essere stata cagione che non pure Roma, ma ancora tutte l'altre parti del mondo si sieno ripiene di questa sorte pitture. Perciò che, oltre all'essere stato Giovanni rinnovatore e quasi inventore degli stucchi e dell'altre grottesche, da questa sua opera, che è bellissima, hanno preso l'esempio chi n'ha voluto lavorare, senza che i giovani che aiutarono a Giovanni, i quali furono molti, anzi infiniti in diversi tempi, l'impararono dal vero maestro e ne riempierono tutte le provincie. Seguitando poi Giovanni di fare sotto queste logge il primo ordine da basso, fece con altro e diverso mo' gli spartimenti de' stucchi e delle pitture nelle facciate e volte dell'altre loggie, ma nondimeno anco quelle furon bellissime per la vaga invenzione de' pergolati finti di canne in varii spartimenti e tutti pieni di viti cariche d'uve, di vitalbe, di gelsomini, di rosai e di diverse sorti animali et uccelli. Volendo poi papa Leone far dipignere la sala dove sta la guardia de' Lanzi al piano di dette logge, Giovanni, oltre alle fregiature che sono intorno a quella sala, di putti, leoni, armi papali e grotesche, fece per le facce alcuni spartimenti di pietre mischie finte di varie sorti e simili all'incrostature antiche che usarono di fare i romani alle loro terme, tempi et altri luoghi, come si vede nella Ritonda e nel portico di S. Piero. In un altro salotto a canto a que-sto, dove stavano i cubicularii, fece Raffaello da Urbino in certi tabernacoli alcuni Apostoli di chiaro scuro grandi quanto il vivo e bellissimi, e Giovanni sopra le cornici di quell'opera ritrasse di naturale molti papagalli di diversi colori, i quali allora aveva Sua Santità, e così anco babuini, gatti mamoni, zibetti et altri bizzarri animali. Ma quest'opera ebbe poca vita, perciò che papa Paulo IV per fare certi suoi stanzini e busigattoli da ritirarsi, guastò quella stanza e privò quel palazzo d'un'opera singolare; il che non arebbe fatto quel sant'uomo, s'egli avesse avuto gusto nell'arti del disegno.
Dipinse Giovanni i cartoni di quelle spalliere e panni da camere che poi furono tessuti di seta e d'oro in Fiandra, nei quali sono certi putti che scherzano intorno varii festoni adorni dell'imprese di papa Leone e di diversi animali ritratti dal naturale, i quali panni, che sono cosa rarissima, sono ancora oggi in palazzo; fece similmente i cartoni di certi arazzi pieni di grottesche, che stanno nelle prime stanze del concistoro. Mentre che Giovanni s'affaticava in quest'opere, essendo stato fabricato in testa di Borgo Nuovo, vicino alla piazza di S. Piero, il palazzo di Messer Giovambattista dal-l'Aquila, fu lavorata di stucchi la maggior parte della facciata, per mano di Giovanni, che fu tenuta cosa singolare. Dipinse il medesimo e lavorò tutti gli stucchi che sono alla loggia della vigna, che fece fare Giulio cardinale de' Medici, sotto Monte Mario, dove sono animali, grottesche, festoni e fregiature tanto belle, che pare in questa Giovanni aver voluto vincere e superare se medesimo. Onde meritò da quel cardinale, che molto amò la virtù sua, oltre molti benefizii avuti per suoi parenti, d'aver per sé un canonicato di Civitale nel Friuli, che da Giovanni fu poi dato a un suo fratello. Avendo poi a fare al medesimo cardinale, pur in quella vigna, una fonte dove getta in una testa di liofante di marmo per il niffolo, imitò in tutto e per tutto il tempio di Nettunno (stanza poco avanti stata trovata fra l'antiche ruine di palazzo maggiore, adorna tutta di cose naturali marine, fatti ottimamente poi varii ornamenti di stucco) anzi superò di gran lunga l'artifizio di quella stanza antica col fare sì belli e bene accommodati quegl'animali, conchiglie et altre infinite cose somiglianti. E dopo questa fece un'altra fonte, ma selvatica, nella concavità d'un fossato circondato da un bosco, facendo cascare con bello artifizio da tartari e pietre di colature d'acqua, gocciole e zampilli che parevano veramente cosa naturale; e nel più alto di quelle caverne e di que' sassi spugnosi, avendo composta una gran testa di leone a cui facevano ghirlanda intorno fila di capelvenere et altre erbe artifiziosamente quivi accommodate, non si potria credere quanta grazia dessono a quel salvatico in tutte le parti bellissimo et oltre ad ogni credenza piacevole.
Finita quest'opera, poi che ebbe donato il cardinale a Giovanni un cavalierato di S. Piero, lo mandò a Fiorenza, acciò che, fatta nel palazzo de' Medici una camera, cioè in sul canto dove già Cosimo vecchio edificator di quello avea fatta una loggia per commodo e ragunanza de' cittadini, secondo che allora costumavano le famiglie più nobili, la dipignesse tutta di grottesche e di stucchi. Essendo stata adunque chiusa questa loggia con disegno di Michelagnolo Buonarroti e datole forma di camera, con due finestre inginocchiate, che furono le prime di quella maniera fuora de' palazzi ferrate, Giovanni lavorò di stucchi e pitture tutta la volta, facendo in un tondo le sei palle, arme di casa Medici, sostenute da tre putti di rilievo con bellissima grazia et attitudine. Oltra di questo vi fece molti bellissimi animali e molte bel-l'imprese degl'uomini e signori di quella casa illustrissima, con alcune storie di mezzo rilievo fatte di stucco; e nel campo fece il resto di pitture, fingendole di bianco e nero a uso di camei, tanto bene, che non si può meglio imaginare. Rimase sotto la volta quattro archi di braccia dodici l'uno et alti sei, che non furono per allora dipinti, ma molti anni poi da Giorgio Vasari, giovinetto di diciotto anni, quando serviva il duca Alessandro de' Medici suo primo signore l'anno 1535; il qual Giorgio vi fece storie de' fatti di Giulio Cesare, alludendo a Giulio cardinale sopra detto, che l'aveva fatta fare.
Dopo fece Giovanni a canto a questa camera in una volta piccola a mezza botte alcune cose di stucco, basse basse, e similmente alcune pitture che sono rarissime. Le quali ancor che piacessero a que' pittori che allora erano a Fiorenza, come fatte con fierezza e pratica maravigliosa e piene d'invenzioni terribili e capricciose, però che erano avezzi a una loro maniera stentata et a fare ogni cosa che mettevano in opera con ritratti tolti dal vivo, come non risoluti non le lodavano interamente, né si mettevano, non ne bastando per aventura loro l'animo, ad imitarle. Essendo poi tornato Giovanni a Roma, fece nella loggia d'Agostino Chigii, la quale avea dipinta Raffaello e l'andava tuttavia conducendo a fine, un ricinto di festoni grossi a torno a torno agli spigoli e quadrature di quella volta, facendovi stagione per istagione di tutte le sorti frutte, fiori e foglie con tanto artifizio lavorate, che ogni cosa vi si vede viva e staccata dal muro e naturalissima. E sono tante le varie maniere di frutte e biade che in quell'opera si veggiono, che per non raccontarle a una a una, dirò solo che vi sono tutte quelle che in queste nostre parti ha mai prodotto la natura. Sopra la figura d'un Mercurio che vola ha finto per Priapo una zucca, attraversata da vilucchi, che ha per testicoli due petronciani, e vicino al fiore di quella ha finto una ciocca di fichi brugiotti grossi dentro a uno de' quali, aperto e troppo fatto, entra la punta della zucca col fiore; il quale capriccio è espresso con tanta grazia, che più non si può alcuno imaginare. Ma che più? per finirla, ardisco d'af-fermare che Giovanni in questo genere di pitture ha passato tutti coloro che in simili cose hanno meglio imitata la natura, perciò che oltre all'altre cose, insino i fiori del sambuco, del finocchio e dell'altre cose minori vi sono veramente stupendissimi. Vi si vede similmente gran copia d'animali fatti nelle lunette che sono circondate da questi festoni, et alcuni putti che tengono in mano i segni degli dèi, ma fra gl'altri un leone et un cavallo marino, per essere bellissimi scorti, sono tenuti cosa divina.
Finita quest'opera veramente singolare fece Giovanni in Castel Sant'Agnolo una stufa bellissima, e nel palazzo del papa, oltre alle già dette, molte altre minuzie che per brevità si lasciano. Morto poi Raffaello, la cui perdita dolse molto a Giovanni, e così anco mancato papa Leone, per non avere più luogo in Roma l'arti del disegno, né altra virtù, si trattenne esso Giovanni molti mesi alla vigna del detto cardinale de' Medici in alcune cose di poco valore, e nella venuta a Roma di papa Adriano non fece altro che le bandiere minori del castello, le quali egli al tempo di papa Leone avea due volte rinovate, insieme con lo stendardo grande che sta in cima dell'ultimo torrione. Fece anco quattro bandiere quadre quando dal detto papa Adriano fu canonizzato santo il beato Antonino arcivescovo di Fiorenza e Sant'Uberto stato vescovo di non so quale città di Fiandra; de' quali stendardi, uno, nel quale è la figura di detto Santo Antonino, fu dato alla chiesa di San Marco di Firenze, dove riposa il corpo di quel Santo; un altro, dentro al quale è il detto Sant'Uberto, fu posto in Santa Maria de Anima, chiesa de' tedeschi in Roma, e gl'altri due furono mandati in Fiandra. Essendo poi creato sommo pontefice Clemente Settimo, col quale aveva Giovanni molta servitù, egli, che se n'era andato a Udine per fuggire la peste, tornò subito a Roma, dove giunto gli fu fatto fare nella coronazione di quel Papa un ricco e bell'or-namento sopra le scale di San Piero; e dopo fu ordinato che egli e Perino del Vaga facessero nella volta della sala vecchia, dinanzi alle stanze da basso che vanno dalle logge che già egli dipinse alle stanze di torre Borgia, alcune pitture. Onde Giovanni vi fece un bellissimo partimento di stucchi con molte grottesche e diversi animali, e Perino i carri de' sette pianeti. Avevano anco a dipignere le facciate della medesima sala, nelle quali già dipinse Giotto, secondo che scrive il Platina nelle vite de' pontefici, alcuni papi che erano stati uccisi per la fede di Cristo, onde fu detta un tempo quella stanza la sala de' Martiri; ma non fu a pena finita la volta, che succedendo l'infelicissimo Sacco di Roma, non si poté più oltre seguitare, per che Giovanni, avendo assai patito nella persona e nella roba, tornò di nuovo a Udine con animo di starvi lungamente, ma non gli venne fatto, perciò che tornato papa Clemente da Bologna, dove avea coronato Carlo Quinto, a Roma, fatto quivi tornare Giovanni, dopo avergli fatto di nuovo fare i stendardi di Castel Sant'Agnolo, gli fece dipignere il palco della capella maggiore e principale di San Piero, dove è l'altare di quel Santo.
Intanto, essendo morto fra' Mariano, che aveva l'uffizio del Piombo, fu dato il suo luogo a Bastiano viniziano, pittore di gran nome, et a Giovanni sopra quello una pensione di ducati ottanta di camera. Dopo, essendo cessati in gran parte i travagli del Pontefice e quietate le cose di Roma, fu da Sua Santità mandato Giovanni con molte promesse a Firenze a fare nella sagrestia nuova di San Lorenzo, stata adorna d'eccellentissime sculture da Michelagnolo, gl'ornamenti della tribuna piena di quadri sfondati che diminuiscono a poco a poco verso il punto del mezzo. Messovi dunque mano Giovanni, la condusse, con l'aiuto di molti suoi uomini, ottimamente a fine con bellissimi fogliami, rosoni et altri ornamenti di stucco e d'oro. Ma in una cosa mancò di giudizio: conciò sia che nelle fregiature piane che fanno le costole della volta et in quelle che vanno a traverso rigirando i quadri, fece alcuni fogliami, ucelli, maschere e figure che non si scorgono punto dal piano per la distanza del luogo, tuttoché siano bellissime, e perché sono tramezzate di colori; là dove, se l'avesse fatte colorite senz'altro, si sarebbono vedute e tutta l'opera stata più allegra e più ricca. Non restava a farsi di quest'opera se non quanto arebbe potuto finire in quindici giorni, riandandola in certi luoghi, quando venuta la nuova della morte di papa Clemente, venne manco a Giovanni ogni speranza, e di quello in particolare che da quel Pontefice aspettava per guiderdone di quest'opera. Onde accortosi, benché tardi, quanto siano le più volte fallaci le speranze delle corti e come restino ingannati coloro che si fidano nelle vite di certi prìncipi, se ne tornò a Roma, dove, se bene arebbe potuto vivere d'uffici e d'entrate e servire il cardinale Ippolito de' Medici et il nuovo pontefice Paulo Terzo, si risolvé a rimpatriarsi e tornare a Udine. Il quale pensiero avendo messo ad effetto, si tornò a stare nella patria con quel suo fratello a cui avea dato il canonicato, con proposito di più non voler adoperare pennelli. Ma neanche questo gli venne fatto, però che, avendo preso donna et avuto figliuoli, fu quasi forzato dall'istinto che si ha naturalmente d'allevare e lasciare benestanti i figliuoli, a rimettersi a lavorare.
Dipinse dunque a' prieghi del padre del cavalier Giovan Francesco di Spilimbergo un fregio d'una sala pieno di festoni, di putti, di frutte et altre fantasie, e dopo adornò di vaghi stucchi e pitture la capella di Santa Maria di Civitale, et ai canonici del Duomo di quel luogo fece due bellissimi stendardi, et alla Fraternita di Santa Maria di Castello in Udine dipinse in un ricco gonfalone la Nostra Donna col Figliuolo in braccio et un Angelo graziosissimo che gli porge il castello, che è sopra un monte nel mezzo della città.
In Vinezia fece nel palazzo del patriarca d'Aquileia, Grimani, una bellissima camera di stucchi e pitture, dove sono alcune storiette bellissime di mano di Francesco Salviati.
Finalmente l'anno millecinquecento e cinquanta, andato Giovanni a Roma a pigliare il Santissimo Giubileo a piedi e vestito da pellegrino poveramente et in compagnia di gente bassa, vi stette molti giorni senz'essere conosciuto da niuno. Ma un giorno andando a San Paulo, fu riconosciuto da Giorgio Vasari, che in cocchio andava al medesimo perdono in compagnia di Messer Bindo Altoviti suo amicissimo. Negò a principio Giovanni di esser desso, ma finalmente fu forzato a scoprirsi et a dirgli che avea gran bisogno del suo aiuto appresso al Papa per conto della sua pensione che aveva in sul Piombo, la quale gli veniva negata da un fra' Guglielmo scultore genovese, che aveva quell'ufficio avuto dopo la morte di fra' Bastiano. Della qual cosa parlando Giorgio al Papa, fu cagione che l'obligo si rinovò e poi si trattò di farne permuta in un canonicato d'Udine per un figliuolo di Giovanni; ma essendo poi di nuovo aggirato da quel fra' Guglielmo, se ne venne Giovanni da Udine a Firenze, creato che fu papa Pio, per essere da sua eccellenza appresso quel Pontefice, col mezzo del Vasari, aiutato e favorito.
Arrivato dunque a Firenze fu da Giorgio fatto conoscere a sua eccellenza illustrissima, con la quale andando a Siena e poi di lì a Roma, dove andò anco la signora duchessa Leonora, fu in guisa dalla benignità del Duca aiutato, che non solo fu di tutto quello disiderava consolato, ma dal Pontefice messo in opera con buona provisione a dar perfezione e fine all'ultima loggia, la quale è sopra quella che gli avea già fatta fare papa Leone. E quella finita, gli fece il medesimo Papa ritoccare tutta la detta loggia prima, il che fu errore e cosa poco considerata, perciò che il ritoccarla a secco le fece perdere tutti que' colpi maestrevoli che erano stati tirati dal pennello di Giovanni nell'eccellenza della sua migliore età a perdere quella freschezza e fierezza che la facea nel suo primo essere cosa rarissima. Finita quest'opera, essendo Giovanni di settanta anni, finì anco il corso della sua vita l'anno 1564, rendendo lo spirito a Dio in quella nobilissima città che l'avea molti anni fatto vivere con tanta eccellenza e sì gran nome. Fu Giovanni sempre, ma molto più negl'ultimi suoi anni, timorato di Dio e buon cristiano, e nella sua giovanezza si prese pochi altri piaceri che di cacciare et uccellare, et il suo ordinario era, quando era giovane, andarsene il giorno delle feste con un suo fante a caccia, allontanandosi tal volta da Roma dieci miglia per quelle campagne; e perché tirava benissimo lo scoppio e la balestra, rade volte tornava a casa che non fusse il suo fante carico d'oche selvatiche, colombacci, germani e di quell'altre bestiacce che si trovano in que' paduli. E fu Giovanni inventore, secondo che molti affermano, del bue di tela dipinto che si fa per addopparsi a quello e tirar senza essere dalle fiere veduto lo scoppio; e per questi esercizii d'ucellare e cacciare si dilettò di tener sempre cani et allevarne da se stesso.
Volle Giovanni, il quale merita di esser lodato fra i maggiori della sua professione, essere sepolto nella Ritonda, vicino al suo maestro Raffaello da Urbino, per non star, morto, diviso da colui dal quale vivendo non si separò il suo animo già mai. E perché l'uno e l'altro, come si è detto, fu ottimo cristiano, si può credere che anco insieme siano nell'e-terna beatitudine.
IL FINE DELLA VITA DI GIOVANNI DA UDINE
VITA DI BATTISTA FRANCO
PITTORE VINIZIANO

Battista Franco viniziano, avendo nella sua prima fanciullezza atteso al disegno come colui che tendeva alla perfezione di quell'arte, se n'andò di venti anni a Roma dove, poiché per alcun tempo con molto studio ebbe atteso al disegno e vedute le maniere di diversi, si risolvé non volere altre cose studiare, né cercare d'imitare, che i disegni, pitture e sculture di Michelagnolo; per che, datosi a cercare, non rimase schizzo, bozza o cosa non che altro stata ritratta da Michelagnolo, che egli non disegnasse. Onde non passò molto che fu de' primi disegnatori che frequentassino la capella di Michelagnolo, e, che fu più, stette un tempo senza volere dipignere o fare altra cosa che disegnare. Ma venuto l'anno 1536, mettendosi a ordine un grandissimo e sontuoso apparato da Antonio da San Gallo per la venuta di Carlo Quinto imperatore, nel quale furono adoperati tutti gl'artefici buoni e cattivi, come in altro luogo s'è detto, Raffaello da Monte Lupo, che avea a fare l'ornamento di ponte Sant'Agnolo e le dieci statue che sopra vi furono poste, disegnò di far sì che Battista fusse adoperato anch'egli, avendolo visto fino disegnatore e giovane di bell'ingegno e di fargli dare da lavorare ad ogni modo; e così parlatone col San Gallo, fece tanto, che a Battista furono date a fare quattro storie grandi a fresco di chiaro scuro nella facciata della porta Capena, oggi detta di San Bastiano, per la quale aveva ad entrare l'imperatore; nelle quali Battista, senz'avere mai più tocco colori, fece sopra la porta l'arme di papa Paulo Terzo e quella di esso Carlo imperatore et un Romulo che metteva sopra quella del Pontefice un regno papale e sopra quella di Cesare una corona imperiale; il quale Romulo, che era una figura di cinque braccia, vestita all'antica e con la corona in testa, aveva dalla destra Numa Pompilio e dalla sinistra Tullo Ostilio, e sopra queste parole: “Quirinus Pater”. In una delle storie, che erano nelle facciate de' torrioni che mettono in mezzo la porta, era il maggior Scipione che trionfava di Cartagine, la quale avea fatta tributaria del popolo romano, e nell'altra a man ritta era il trionfo di Scipione minore, che la medesima avea rovinata e disfatta. In uno di due quadri che erano fuori de' torrioni nella faccia dinanzi, si vedeva Annibale sotto le mura di Roma essere ributtato dalla tempesta, e nell'altro a sinistra Flacco entrare per quella porta al soccorso di Roma contra il detto Annibale. Le quali tutte storie e pitture, essendo le prime di Battista, e rispetto a quelle degl'altri furono assai buone e molto lodate; e se Battista avesse prima cominciato a dipignere et andare praticando tal volta i colori e maneggiare i pennegli, non ha dubbio che averebbe passato molti; ma lo stare ostinato in una certa openione che han-no molti, i quali si fanno a credere che il disegno basti a chi vuol dipignere, gli fece non piccolo danno. Ma con tutto ciò egli si portò molto meglio che non fecero alcuni di coloro che fecero le storie dell'arco di San Marco, nel quale furono otto storie, cioè quattro per banda, che le migliori di tutte furono parte fatte da Francesco Salviati e parte da un Martino et altri giovani tedeschi, che pur allora erano venuti a Roma per imparare; né lascerò di dire a questo proposito che il detto Martino, il quale molto valse nelle cose di chiaro scuro, fece alcune battaglie con tanta fierezza e sì belle invenzioni in certi affronti e fatti d'arme fra cristiani e turchi, che non si può far meglio. E, quello che fu cosa maravigliosa, fece il detto Martino e' suoi uomini quelle tele con tanta sollecitudine e prestezza, perché l'opera fusse finita a tempo, che non si partivano mai dal lavoro, e perché era portato loro continuamente da bere e di buon greco, fra lo stare sempre ubriachi e riscaldati dal furor del vino e la pratica del fare, feciono cose stupende. Quando dunque videro l'ope-ra di costoro il Salviati e Battista et il Calavrese, confessarono esser necessario che chi vuole esser pittore cominci ad adoperare i pennegli a buon'ora; la qual cosa avendo poi meglio discorsa da sé, Battista cominciò a non mettere tanto studio in finire i disegni, ma a colorire alcuna volta.
Venendo poi il Monte Lupo a Fiorenza, dove si faceva similmente grandissimo apparato per ricevere il detto imperatore, Battista venne seco, et arrivati trovarono il detto apparato condotto a buon termine. Pure, essendo Battista messo in opera, fece un basamento tutto pieno di figure e trofei, sotto la statua che al canto de' Carnesecchi avea fatta fra' Gio-vann'Agnolo Montorsoli. Per che, conosciuto fra gl'artefici per giovane ingegnoso e valente, fu poi molto adoperato nella venuta di madama Margherita d'Austria, moglie del duca Alessandro, e particolarmente nell'apparato che fece Giorgio Vasari nel palazzo di Messer Ottaviano de' Medici, dove avea la detta signora ad abitare. Finite queste feste, si mise Battista a disegnare con grandissimo studio le statue di Michelagnolo che sono nella sagrestia nuova di San Lorenzo; dove allora essendo volti a disegnare e fare di rilievo tutti i scultori e pittori di Firenze, fra essi acquistò assai Battista, ma fu nondimeno conosciuto l'error suo, di non aver mai voluto ritrarre dal vivo o colorire, né altro fare che imitare statue e poche altre cose, che gli avevano fatto in tal modo indurare et insecchire la maniera, che non se la potea levar da dosso, né fare che le sue cose non avessono del duro e del tagliente, come si vide in una tela dove fece con molta fatica e diligenza Lucrezia romana violata da Tarquinio.
Dimorando dunque Battista in fra gli altri e frequentando la detta sagrestia, fece amicizia con Bartolomeo Amannati scultore, che in compagnia di molti altri là studiavano le cose del Buonarroto; e fu sì fatta l'amicizia, che il detto Amanati si tirò in casa Battista et il Genga da Urbino, e di compagnia vissero alcun tempo insieme et attesero con molto frutto agli studii dell'arte. Essendo poi stato morto l'anno 1536 il duca Alessandro e creato in suo luogo il signor Cosimo de' Medici, molti de' servitori del Duca morto rimasero a' servigii del nuovo et altri no, e fra quelli che si partirono fu il detto Giorgio Vasari, il quale tornandosi ad Arezzo con animo di non più seguitare le corti, essendogli mancato il cardinale Ippolito de' Medici, suo primo signore, e poi il duca Alessandro, fu cagione che Battista fu messo al servizio del duca Cosimo et a lavorare in guardaroba, dove dipinse in un quadro grande, ritraendogli da uno di fra' Bastiano e da uno di Tiziano, papa Clemente et il cardinale Ippolito, e da un del Puntormo il duca Alessandro. Et ancor che questo quadro non fusse di quella perfezione che si aspettava, avendo nella medesima guardaroba veduto il cartone di Michelagnolo del Noli me tangere che aveva già colorito il Puntormo, si mise a far un cartone simile, ma di figure maggiori, e ciò fatto ne dipinse un quadro nel quale si portò molto meglio quanto al colorito; et il cartone che ritrasse, come stava apunto quel del Buonarroto, fu bellissimo e fatto con molta pacienza. Essendo poi seguita la cosa di Monte Murlo, dove furono rotti e presi i fuorusciti e rebelli del Duca, con bella invenzione fece Battista una storia della battaglia seguita, mescolata di poesia a suo capriccio, che fu molto lodata, ancor che in essa si riconoscessino nel fatto d'arme e far de' prigioni molte cose state tolte di peso dall'opere e disegni del Buonarroto; perciò che essendo nel lontano il fatto d'ar-me, nel dinanzi erano i cacciatori di Ganimede che stavano a mirar l'uccello di Giove che se ne portava il giovinetto in cielo; la quale parte tolse Battista dal disegno di Michelagnolo, per servirsene e mostrare che il Duca giovinetto, nel mezzo de' suoi amici, era per virtù di Dio salito in cielo, o altra cosa somigliante. Questa storia dico, fu prima fatta da Battista in cartone e poi dipinta in un quadro con estrema diligenza, et oggi è con l'altre dette opere sue nelle sale di sopra del palazzo de' Pitti, che ha fatto ora finire del tutto sua eccellenza illustrissima.
Essendosi dunque Battista con queste et alcun'altre opere trattenuto al servizio del Duca, insino a che egli ebbe presa per donna la signora donna Leonora di Tolledo, fu poi nell'apparato di quelle nozze adoperato all'arco trionfale della porta al Prato, dove gli fece fare Ridolfo Ghirlandaio alcune storie de' fatti del signor Giovanni padre del duca Cosimo. In una delle quali si vedeva quel signore passare i fiumi del Po e dell'Adda, presente il cardinale Giulio de' Medici che fu papa Clemente Settimo, il signor Prospero Colonna et altri signori, e nell'altro la storia del riscatto di San Secondo. Dall'altra banda fece Battista in un'altra storia la città di Milano et intorno a quella il campo della lega, che partendosi vi lascia il detto signor Giovanni; nel destro fianco dell'arco fece in un'altra da un lato l'Occasione, che avendo i capegli sciolti, con una mano gli porge al signor Giovanni, e dall'altro Marte che similmente gli porgeva la spada. In un'altra storia sotto l'arco era di mano di Battista il signor Giovanni che combatteva fra il Tesino e Biegrassa, sopra ponte Rozzo, difendendolo, quasi un altro Orazio, con incredibile bravura. Dirimpetto a questa era la presa di Caravaggio et in mezzo alla battaglia il signor Giovanni che passava fra ferro e fuoco per mezzo l'esercito nimico senza timore; fra le colonne a man ritta era in un ovato Garlasso preso dal medesimo con una sola compagnia di soldati, et a man manca fra l'altre due colonne il bastione di Milano tolto a' nemici. Nel frontone che rimaneva alle spalle di chi entrava era il detto signore Giovanni a cavallo sotto le mura di Milano, che giostrando a singolar battaglia con un cavaliere, lo passava da banda a banda con la lancia; sopra la cornice maggiore, che va a trovare il fine dell'altra cornice, dove posa il frontespizio, in un'altra storia grande fatta da Battista con molta diligenza, era nel mezzo Carlo Quinto imperadore, che coronato di lauro sedeva sopra uno scoglio con lo scetro in mano, et a' piedi gli giaceva il fiume Betis con un vaso che versava da due bocche, et a canto a questo era il fiume Danubio che con sette bocche versava le sue acque nel mare.
Io non farò qui menzione d'un infinito numero di statue che in questo arco accompagnavano le dette et altre pitture, perciò che bastandovi dire al presente quello che appartiene a Battista Franco, non è mio ufficio quello raccontare che da altri nell'apparato di quelle nozze fu scritto lungamente senza che, essendosi parlato dove facea bisogno de' maestri delle dette statue, superfluo sarebbe qualunche cosa qui se ne dicessi, e massimamente non essendo le dette statue in piedi, onde possano esser vedute e considerate. Ma tornando a Battista, la migliore cosa che facesse in quelle nozze fu uno dei dieci sopra detti quadri che erano nell'apparato del maggior cortile del palazzo de' Medici, nel quale fece di chiaro scuro il duca Cosimo investito di tutte le ducali insegne. Ma con tutto che vi usasse diligenza, fu superato, dal Bronzino e da altri che avevano manco disegno di lui, nell'invenzione, nella fierezza e nel maneggiare il chiaro scuro, atteso (come s'è detto altra volta) che le pitture vogliono essere condotte facili e poste le cose a' luoghi loro con giudizio e senza uno certo stento e fatica che fa le cose parere dure e crude; oltra che il troppo ricercarle le fa molte volte venir tinte e le guasta. Perciò che lo star loro tanto a torno toglie tutto quel buono che suole fare la facilità e la grazia e la fierezza; le quali cose, ancor che in gran parte vengano e s'abbiano da natura, si possono anco in parte acquistare dallo studio e dall'arte. Essendo poi Battista condotto da Ridolfo Ghirlandaio alla Madonna di Vertigli in Valdichiana, il qual luogo era già membro del monasterio degl'Angeli di Firenze dell'Ordine di Camaldoli et oggi è capo da sé in cambio del monasterio di San Benedetto, che fu per l'assedio di Firenze rovinato fuor della porta a Pinti, vi fece le già dette storie del chiostro, mentre Ridolfo faceva la tavola e gl'ornamenti dell'altar maggiore. E quelle finite, come s'è detto nella vita di Ridolfo, adornarno d'altre pitture quel santo luogo, che è molto celebre e nominato per i molti miracoli che vi fa la Vergine madre del Figliuol di Dio.
Dopo, tornato Battista a Roma, quando a punto s'era scoperto il Giudizio di Michelagnolo, come quelli che era studioso della maniera e delle cose di quell'uomo, il vide volentieri e con infinita maraviglia il disegnò tutto; e poi risolutosi a stare in Roma, a Francesco cardinale Cornaro, il quale aveva rifatto a canto a San Piero il palazzo che abitava e risponde nel portico verso Camposanto, dipinse sopra gli stucchi una loggia che guarda verso la piazza, facendovi una sorte di grottesche tutte piene di storiette e di figure; la qual opera, che fu fatta con molta fatica e diligenza, fu tenuta molto bella. Quasi ne' medesimi giorni, che fu l'anno 1538, avendo fatto Francesco Salviati una storia in fresco nella Compagnia della Misericordia, e dovendo dargli l'ultimo fine e mettere mano ad altre, ché molti particolari disegnavano farvi, per la concorrenza che fu fra lui et Iacopo del Conte, non si fece altro; la qual cosa intendendo Battista, andò cercando, con questo mezzo, occasione di mostrarsi da più di Francesco et il migliore maestro di Roma; perciò che adoperando amici e mezzi fece tanto, che monsignor della Casa, veduto un suo disegno, gliene allogò. Per che, messovi mano, vi fece a fresco San Giovanni Battista fatto pigliare da Erode e mettere in prigione. Ma con tutto che questa pittura fusse condotta con molta fatica, non fu a gran pezzo tenuta pari a quella del Salviati, per essere fatta con stento grandissimo e d'una maniera cruda e malinconica, che non aveva ordine nel componimento, né in parte alcuna punto di quella grazia e vaghezza di colorito che aveva quella di Francesco. E da questo si può fare giudizio, che coloro i quali seguitando quest'arte si fondano in far bene un torso, un braccio et una gamba o altro membro ben ricerco di muscoli, e che l'intendere bene quella parte sia il tutto, sono ingannati; perciò che una parte non è il tutto dell'opera, e quegli la conduce interamente perfetta e con bella e buona maniera, che fatte bene le parti sa farle proporzionatamente corrispondere al tutto, e che oltre ciò fa che la composizione delle figure esprime e fa bene quell'effetto che dee fare senza confusione. E sopra tutto si vuole avvertire che le teste siano vivaci, pronte, graziose e con bell'arte, e che la maniera non sia cruda, ma sia negl'ignudi tinta talmente di nero, ch'ell'abbiano rilievo, sfugghino e si allontanino secondo che fa bisogno, per non dir nulla delle prospettive de' paesi e dell'altre parti che le buone pitture richieggiono; né che nel servirsi delle cose d'altri si dee fare per sì fatta maniera, che non si conosca così agevolmente. Si accorse dunque tardi Battista d'aver perduto tempo fuor di bisogno dietro alle minuzie di muscoli et al disegnare con troppa diligenza, non tenendo conto del-l'altre parti dell'arte.
Finita quest'opera, che gli fu poco lodata, si condusse Battista, per mezzo di Bartolomeo Genga, a' servigi del duca d'Urbino, per dipignere nella chiesa e capella, che è unita col palazzo d'Urbino, una grandissima volta. E là giunto, si diede subito senza pensare altro a fare i disegni secondo l'invenzione di quell'opera e senza fare altro spartimento. E così a imitazione del Giudizio del Buonarroto, figurò in un cielo la gloria de' Santi, sparsi per quella volta sopra certe nuvole, e con tutti i cori degl'angeli intorno a una Nostra Donna, la quale, essendo assunta in cielo, è aspettata da Cristo in atto di coronarla, mentre stanno partiti in diversi mucchi i patriarchi, i profeti, le sibille, gl'apostoli, i martiri, i confessori e le vergini, le quali figure in diverse attitudini mostrano rallegrarsi della venuta di essa Vergine gloriosa. La quale invenzione sarebbe stata certamente grande occasione a Battista di mostrarsi valentuomo, se egli avesse preso miglior via, non solo di farsi pratico ne' colori a fresco, ma di governarsi con miglior ordine e giudizio in tutte le cose, che egli non fece. Ma egli usò in quest'opera il medesimo modo di fare che nell'altre sue, perciò che fece sempre le medesime figure, le medesime effigie, i medesimi panni e le medesime membra; oltreché il colorito fu senza vaghezza alcuna et ogni cosa fatta con difficultà e stentata. Laonde, finita del tutto, rimasero poco sodisfatti il duca Guidobaldo, il Genga e tutti gl'altri che da costui aspettavano gran cose e simili al bel disegno che egli mostrò loro da principio. E nel vero per fare un bel disegno Battista non avea pari e si potea dir valente uomo. La qual cosa conoscendo quel Duca e pensando che i suoi disegni, messi in opera da coloro che lavoravano eccellentemente vasi di terra a Castel Durante, i quali si e-rano molto serviti delle stampe di Raffaello da Urbino e di quelle d'altri valentuomini, riuscirebbono benissimo, fece fare a Battista infiniti disegni, che messi in opera in quella sorte di terra gentilissima sopra tutte l'altre d'Italia, riuscirono cosa rara. Onde ne furono fatti tanti e di tante sorte vasi, quanti sarebbono bastati e stati orrevoli in una credenza reale, e le pitture che in essi furono fatte non sarebbono state migliori, quando fussero state fatte a olio da eccellentissimi maestri. Di questi vasi adunque, che molto rassomigliano, quanto alla qualità della terra, quell'antica che in Arezzo si lavorava anticamente al tempo di Porsena re di Toscana, mandò il detto duca Guidobaldo una credenza doppia a Carlo Quinto imperadore et una al cardinal Farnese, fratello della signora Vettoria sua consorte. E devemo sapere che di questa sorte pitture in vasi non ebbono, per quanto si può giudicare, i romani; perciò che i vasi che si sono trovati di que' tempi pieni delle ceneri de' loro morti o in altro modo sono pieni di figure graffiate e campite d'un colore solo in qualche parte, o nero, o rosso, o bianco e non mai con lustro d'invetriato, né con quella vaghezza e varietà di pitture che si sono vedute e veggiono a' tempi nostri; né si può dire che se forse l'avevano, sono state consumate le pitture dal tempo e dallo stare sotterrate, però che veggiamo queste nostre diffendersi da tutte le malignità del tempo e da ogni cosa; onde starebbono per modo di dire quattromil'anni sotto terra, che non si guasterebbono le pitture. Ma ancora che di sì fatti vasi e pitture si lavori per tutta Italia, le migliori terre e più belle nondimeno sono quelle che si fanno, come ho detto, a Castel Durante, terra dello stato d'Urbino, e quelle di Faenza, che per lo più che migliori, sono bianchissime e con poche pitture e quelle nel mezzo o intorno, ma vaghe e gentili affatto.
Ma tornando a Battista, nelle nozze che poi si fecero in Urbino del detto signor Duca e signora Vettoria Farnese, egli, aiutato da' suoi giovani, fece negl'archi ordinati dal Genga, il quale fu capo di quell'apparato, tutte le storie di pitture che vi andarono, ma perché il Duca dubitava che Battista non avesse finito a tempo, essendo l'impresa grande, mandò per Giorgio Vasari, che allora faceva in Arimini ai monaci bianchi di Scolca olivetani una capella grande a fresco e la tavola dell'altare maggiore a olio, acciò che andasse ad aiutare in quell'apparato il Genga e Battista. Ma sentendosi il Vasari indisposto, fece sua scusa con sua eccellenza e le scrisse che non dubitasse, perciò che era la virtù e sapere di Battista tale, che arebbe, come poi fu vero, a tempo finito ogni cosa. Et andando poi, finite l'opere d'Arimini, in persona a fare scusa et a visitare quel Duca, sua eccellenza gli fece vedere, perché la stimasse, la detta capella stata dipinta da Battista, la quale molto lodò il Vasari e raccomandò la virtù di colui che fu largamente sodisfatto dalla molta benignità di quel signore. Ma è ben vero che Battista allora non era in Urbino, ma in Roma, dove attendeva a disegnare non solo le statue, ma tutte le cose antiche di quella città per farne, come fece, un gran libro che fu opera lodevole.
Mentre adunque che attendeva Battista a disegnare in Roma, Messer Giovann'Andrea dall'Anguillara, uomo in al-cuna sorte di poesie veramente raro, avea fatto una compagnia di diversi begl'ingegni e facea fare nella maggior sala di Santo Apostolo una ricchissima scena et apparato per recitare comedie di diversi autori a gentiluomini, signori e gran personaggi, et aveva fatti fare gradi per diverse sorti di spettatori, e per i cardinali et altri gran prelati, accommodate alcune stanze donde per gelosie potevano senza esser veduti, vedere et udire. E perché nella detta compagnia erano pittori, architetti, scultori et uomini che avevano a recitare e fare altri ufficii, a Battista et all'Amannato fu dato cura, essendo fatti di quella brigata, di far la scena et alcune storie et ornamenti di pitture, le quali condusse Battista, con alcune statue che fece l'Amannato, tanto bene, che ne fu sommamente lodato. Ma perché la molta spesa in quel luogo superava l'en-trata, furono forzati Messer Giovann'Andrea e gl'altri levare la prospettiva e gl'altri ornamenti di Santo Apostolo e condurgli in strada Giulia nel tempio nuovo di S. Biagio, dove avendo Battista di nuovo accommodato ogni cosa, si recitarono molte comedie con incredibile sodisfazione del popolo e cortigiani di Roma, e di qui poi ebbono origine i comedianti che vanno attorno chiamati i Zanni.
Dopo queste cose venuto l'anno 1550, fece Battista insieme con Girolamo Seciolante da Sermoneta, al cardinale di Cesis nella facciata del suo palazzo, un'arme di papa Giulio III stato creato allora nuovo pontefice, con tre figure et alcuni putti che furono molto lodate. E quella finita, dipinse nella Minerva, in una capella stata fabricata da un canonico di S. Piero e tutta ornata di stucchi, alcune storie della Nostra Donna e di Gesù Cristo in uno spartimento della volta, che furono la miglior cosa che insino allora avesse mai fatto. In una delle due facciate dipinse la Natività di Gesù Cristo con alcuni pastori et Angeli che cantano sopra la capanna, e nell'altra la Resurrezione di Cristo con molti soldati in di-verse attitudini d'intorno al sepolcro, e sopra ciascuna delle dette storie in certi mezzi tondi fece alcuni profeti grandi e finalmente, nella facciata dell'altare, Cristo crucifisso, la Nostra Donna, S. Giovanni, S. Domenico et alcun'altri Santi nelle nicchie, ne' quali tutti si portò molto bene e da maestro eccellente. Ma perché i suoi guadagni erano scarsi e le spese di Roma sono grandissime, dopo aver fatto alcune cose in tela, che non ebbono molto spaccio, se ne tornò, pensando nel mutar paese anco fortuna, a Vinezia sua patria, dove mediante quel suo bel mo' di disegnare fu giudicato valentuomo; e pochi giorni dopo datogli a fare per la chiesa di S. Francesco della Vigna, nella capella di Monsignor Barbaro, eletto patriarca d'Aquileia, una tavola a olio, nella quale dipinse S. Giovanni che battezza Cristo nel Giordano, in aria Dio Padre, a basso due putti che tengono le vestimenta di esso Cristo, e negli angoli la Nunziata, et a' piè di queste figure finse una tela sopraposta con buon numero di figure piccole et ignude, cioè d'angeli, demonii et anime in purgatorio, e con un motto che dice: “In nomine Iesu omne genuflectatur”. La qual opera, che certo fu tenuta molto buona, gl'acquistò gran nome e credito, anzi fu cagione che i frati de' zoccoli, i quali stanno in quel luogo et hanno cura della chiesa di S. Iobbe in Canareio, gli facessero fare in detto S. Iobbe, alla capella di Ca' Foscari, una Nostra Donna che siede col Figliuolo in collo, un S. Marco da un lato, una Santa dall'altro et in aria alcuni Angeli che spargono fiori. In S. Bartolomeo alla sepoltura di Cristofano Fuccheri mercatante todesco fece in un quadro l'Abondanza, Mercurio et una Fama; a Messer Antonio della Vecchia viniziano dipinse in un quadro di figure grandi quanto il vivo e bellissime Cristo coronato di spine et alcuni farisei intorno che lo scherniscono.
Intanto essendo stata col disegno di Iacopo Sansovino condotta nel palazzo di S. Marco (come a suo luogo si dirà) di muraglia la scala che va dal terzo piano in su et adorna con varii partimenti di stucchi da Alessandro scultore e creato del Sansovino, dipinse Battista per tutto grotteschine minute et in certi vani maggiori buon numero di figure a fresco, che assai sono state lodate dagli artefici; e dopo fece il palco del ricetto di detta scala. Non molto di poi quando furono dati, come s'è detto di sopra, a fare tre quadri per uno ai migliori e più reputati pittori di Vinezia, per la libreria di San Marco, con patto che chi meglio si portasse a giudizio di que' magnifici senatori guadagnasse, oltre al premio ordinario, una collana d'oro, Battista fece in detto luogo tre storie con due filosofi fra le finestre e si portò benissimo, ancor che non guadagnasse il premio dell'onore, come dicemmo di sopra. Dopo le quali opere, essendogli allogato dal patriarca Grimani una capella in San Francesco dalla Vigna, che è la prima a man manca entrando in chiesa, Battista vi mise mano e cominciò a fare per tutta la volta ricchissimi spartimenti di stucchi e di storie in figure a fresco, lavorandovi con diligenza incredibile. Ma o fusse la trascuraggine sua, o l'aver lavorato alcune cose a fresco per le ville d'alcuni gentiluomini e forse sopra mura freschissime, come intesi, prima che avesse la detta capella finita, si morì; et ella, rimasa imperfetta, fu poi finita da Federigo Zucchero da Sant'Agnolo in Vado, giovane e pittore eccellente tenuto in Roma de' migliori, il quale fece a fresco nelle faccie dalle bande Maria Madalena che si converte alla predicazione di Cristo e la ressurezione di Lazzero suo fratello, che sono molto graziose pitture. E finite le facciate, fece il medesimo nella tavola dell'altare l'adorazione de' Magi, che fu molto lodata. Hanno dato nome e credito grandissimo a Battista, il quale morì l'anno 1561, molti suoi disegni stampati, che sono veramente da essere lodati.
Nella medesima città di Vinezia e quasi ne' medesimi tempi è stato, ed è vivo ancora, un pittore chiamato Iacopo Tintoretto, il quale si è dilettato di tutte le virtù e particolarmente di sonare di musica e diversi strumenti, et oltre ciò piacevole in tutte le sue azzioni, ma nelle cose della pittura stravagante, capriccioso, presto e risoluto et il più terribile cervello che abbia avuto mai la pittura, come si può vedere in tutte le sue opere e ne' componimenti delle storie, fantastiche e fatte da lui diversamente e fuori dell'uso degl'altri pittori; anzi ha superata la stravaganza, con le nuove e capricciose invenzioni e strani ghiribizzi del suo intelletto che ha lavorato a caso e senza disegno, quasi mostrando che quest'arte è una baia. Ha costui alcuna volta lasciato le bozze per finire, tanto a fatica sgrossate, che si veggiono i colpi de' pennegli fatti dal caso e dalla fierezza, più tosto che dal disegno e dal giudizio. Ha dipinto quasi di tutte le sorti pitture a fresco, a olio, ritratti di naturale et ad ogni pregio, di maniera, che con questi suoi modi ha fatto e fa la maggior parte delle pitture che si fanno in Vinezia. E perché nella sua giovanezza si mostrò in molte bell'opere di gran giudizio, se egli avesse conosciuto il gran principio che aveva dalla natura et aiutatolo con lo studio e col giudizio, come hanno fatto coloro che hanno seguitato le belle maniere de' suoi maggiori e non avesse come ha fatto tirato via di pratica, sarebbe stato uno de' maggiori pittori che avesse avuto mai Vinezia. Non che per questo si toglia che non sia fiero e buon pittore e di spirito svegliato, capriccioso e gentile.
Essendo dunque stato ordinato dal senato che Iacopo Tintoretto e Paulo Veronese, allora giovani di grande speranza, facessero una storia per uno nella sala del gran consiglio, et una Orazio figliuolo di Tiziano, il Tintoretto dipinse nella sua Federigo Barbarossa coronato dal Papa, figurandovi un bellissimo casamento et intorno al Pontefice gran numero di cardinali e di gentiluomini viniziani, tutti ritratti di naturale, e da basso la musica del Papa, nel che tutto si portò di maniera, che questa pittura può stare a canto a quella di tutti e d'Orazio detto, nella quale è una battaglia fatta a Roma fra i todeschi del detto Federigo et i romani, vicina a Castel Sant'Agnolo et al Tevere; et in questa è fra l'altre cose un cavallo in iscorto che salta sopra un soldato armato, che è bellissimo; ma vogliono alcuni che in quest'opera Orazio fusse aiutato da Tiziano suo padre. Appresso a queste Paulo Veronese, del quale si è parlato nella vita di Michele San Michele, fece nella sua il detto Federigo Barbarossa che apprestatosi alla corte bacia la mano a papa Ottaviano in pregiudizio di papa Alessandro Terzo, et oltre a questa storia, che fu bellissima, dipinse Paulo sopra una finestra quattro gran figure: il Tempo, l'Unione con un fascio di bacchette, la Pacienza e la Fede, nelle quali si portò bene quanto più non saprei dire. Non molto dopo, mancando un'altra storia in detta sala, fece tanto il Tintoretto con mezzi e con amici, ch'ella gli fu data a fare, onde la condusse di maniera, che fu una maraviglia e che ella merita di essere fra le migliori cose, che mai facesse, annoverata: tanto poté in lui il disporsi di voler paragonare, se non vincere e superare, i suoi concorrenti che avevano lavorato in quel luogo. E la storia che egli vi dipinse, acciò anco da quei che non sono dell'arte sia conosciuta, fu papa Alessandro che scomunica et interdice Barbarossa, et il detto Federigo che per ciò fa che i suoi non rendono più ubidienza al Pontefice. E fra l'altre cose capricciose che sono in questa storia, quella è bellissima dove il Papa et i cardinali, gettando da un luogo alto le torce e candele, come si fa quando si scomunica alcuno, è da basso una baruffa d'ignudi che s'azzuffano per quelle torce e candele, la più bella e più vaga del mondo. Oltre ciò, alcuni basamenti, anticaglie e ritratti di gentiluomini, che sono sparsi per questa storia, sono molto ben fatti e gl'acquistarono grazia e nome appresso d'ognuno, onde in S. Rocco, nella capella maggiore, sotto l'opera del Pordenone, fece duoi quadri a olio grandi quanto è larga tutta la capella, cioè circa braccia dodici l'uno. In uno finse una prospettiva come d'uno spedale pieno di letta e d'infermi in varie attitudini, i quali sono molto medicati da Santo Rocco, e fra questi sono alcuni ignudi molto bene intesi et un morto in iscorto che è bellissimo; nell'altro è una storia parimente di Santo Rocco piena di molto belle e graziose figure et insomma tale ch'ell'è tenuta delle migliori opere che abbia fatto questo pittore; a mezza la chiesa in una storia della medesima grandezza fece Gesù Cristo che alla probatica piscina sana l'infermo, che è opera similmente tenuta ragionevole. Nella chiesa di Santa Maria dell'Orto, dove si è detto di sopra che dipinsero il palco Cristofano et il fratello, pittori bresciani, ha dipinto il Tintoretto le due facciate, cioè a olio sopra tele, della capella maggiore, alte dalla volta insino alla cornice del sedere braccia ventidue. In quella che è a man destra ha fatto Moisè, il quale tornando dal monte dove da Dio aveva avuta la legge, truova il popolo che adora il vitel d'oro, e dirimpetto a questa, nell'altra, è il Giudizio Universale del novissimo giorno, con una stravagante invenzione che ha veramente dello spaventevole e del terribile per la diversità delle figure che vi sono di ogni età e d'ogni sesso, con strafori e lontani d'a-nime beate e dannate. Vi si vede anco la barca di Caronte, ma d'una maniera tanto diversa dall'altre, che è cosa bella e strana, e se quella capricciosa invenzione fusse stata condotta con disegno corretto e regolato et avesse il pittore atteso con diligenza alle parti et ai particolari, come ha fatto al tutto, esprimendo la confusione, il garbuglio e lo spavento di quel dì, ella sarebbe pittura stupendissima. E chi la mira così a un tratto resta maravigliato, ma considerandola poi minutamente ella pare dipinta da burla. Ha fatto il medesimo in questa chiesa, cioè nei portegli dell'organo a olio la Nostra Donna che saglie i gradi del tempio, che è un'opera finita e la meglio condotta e più lieta pittura che sia in quel luogo. Similmente nei portegli dell'organo di Santa Maria Zebenigo fece la conversione di San Paulo, ma con non molto studio; nella Carità una tavola con Cristo deposto di croce, e nella sagrestia di San Sebastiano, a concorrenza di Paulo da Verona, che in quel luogo lavorò molte pitture nel palco e nelle facciate, fece sopra gl'armarii Moisè nel deserto et altre storie che furono poi seguitate da Natalino pittore viniziano e da altri. Fece poi il medesimo Tintoretto in San Iobbe al-l'altare della Pietà tre Marie, San Francesco, San Bastiano, San Giovanni et un pezzo di paese, e nei portegli dell'organo della chiesa de' Servi, Santo Agostino e San Filippo, e di sotto Caino ch'uccide Abel suo fratello. In San Felice all'altare del Sacramento, cioè nel cielo della tribuna, dipinse i quattro Evangelisti e nella lunetta sopra l'altare una Nunziata, nel-l'altra Cristo che ora in sul Monte Oliveto, e nella facciata l'ultima cena che fece con gl'Apostoli. In San Francesco della Vigna è di mano del medesimo, all'altare del Deposto di croce, la Nostra Donna svenuta con altre Marie et alcuni Profeti, e nella scuola di San Marco da San Giovanni e Polo sono quattro storie grandi, in una delle quali è San Marco, che aparendo in aria, libera un suo divoto da molti tormenti, che se gli veggiono apparecchiati con diversi ferri da tormenta-re, i quali rompendosi, non gli poté mai adoperare il manigoldo contra quel devoto, et in questa è gran copia di figure, di scorti, d'armature, casamenti, ritratti et altre cose simili, che rendono molto ornata quell'opera. In un'altra è una tempesta di mare e San Marco similmente in aria che libera un altro suo divoto; ma non è già questa fatta con quella diligenza che la già detta. Nella terza è una pioggia et il corpo morto d'un altro divoto di San Marco e l'anima che se ne va in cielo; et in questa ancora è un componimento d'assai ragionevoli figure. Nella quarta, dove uno spiritato si scongiura, ha finto in prospettiva una gran loggia et in fine di quella un fuoco che la illumina con molti rinverberi; et oltre alle dette storie è all'altare un San Marco di mano del medesimo, che è ragionevole pittura.
Queste opere adunque, e molte altre che si lasciano, bastando avere fatto menzione delle migliori, sono state fatte dal Tintoretto con tanta prestezza, che quando altri non ha pensato a pena che egli abbia cominciato, egli ha finito, et è gran cosa che con i più stravaganti tratti del mondo ha sempre da lavorare. Perciò che quando non bastano i mezzi e l'amicizie a fargli avere alcun lavoro, se dovesse farlo non che per piccolo prezzo, in dono e per forza, vuol farlo ad ogni modo. E non ha molto che avendo egli fatto nella scuola di San Rocco a olio in un gran quadro di tela la Passione di Cristo, si risolverono gl'uomini di quella Compagnia di fare di sopra dipignere nel palco qualche cosa magnifica et ono-rata, e perciò di allogare quell'opera a quello de' pittori che erano in Vinezia il quale facesse migliore e più bel disegno. Chiamati adunque Iosef Salviati, Federico Zucchero, che allora era in Vinezia, Paulo da Verona et Iacopo Tintoretto, ordinarono che ciascuno di loro facesse un disegno, promettendo a colui l'opera, che in quello meglio si portasse. Mentre adunque gl'altri attendevano a fare con ogni diligenza i loro disegni, il Tintoretto tolta la misura della grandezza che aveva ad essere l'opera e tirata una gran tela, la dipinse senza che altro se ne sapesse con la solita sua prestezza e la pose dove aveva da stare. Onde ragunatasi una mattina la compagnia per vedere i detti disegni e risolversi, trovando il Tintoretto avere finita l'opera del tutto e postala al luogo suo. Per che adirandosi con esso lui e dicendo che avevano chiesto disegni e non datogli a far l'opera, rispose loro che quello era il suo modo di disegnare, che non sapeva far altrimenti e che i disegni e modelli dell'opere avevano a essere a quel modo per non ingannare nessuno; e finalmente, che se non volevano pagargli l'opera e le sue fatiche, che le donava loro. E così dicendo, ancor che avesse molte contrarietà, fece tanto, che l'opera è ancora nel medesimo luogo. In questa tela adunque è dipinto in un cielo Dio Padre che scende con molti Angeli ad abracciare San Rocco, e nel più basso sono molte figure che significano o vero rappresentano l'al-tre scuole maggiori di Vinezia, come la Carità, S. Giovanni Evangelista, la Misericordia, S. Marco e S. Teodoro, fatte tutte secondo la sua solita maniera. Ma perciò che troppo sarebbe lunga opera raccontare tutte le pitture del Tintoretto, basti avere queste cose ragionato di lui, che è veramente valente uomo e pittore da essere lodato.
Essendo ne' medesimi tempi in Vinezia un pittore chiamato Brazacco, creato di casa Grimani, il quale era stato in Roma molti anni, gli fu per favori dato a dipignere il palco della sala maggiore de' Cavi de' dieci. Ma conoscendo costui non poter far da sé et avere bisogno d'aiuto, prese per compagni Paulo da Verona e Battista Farinato, compartendo fra sé e loro nove quadri di pitture a olio che andavano in quel luogo: cioè quattro ovati ne' canti, quattro quadri bislunghi et un ovato maggiore nel mezzo, e questo con tre de' quadri dato a Paulo Veronese, il quale vi fece un Giove che fulmina i vizii et altre figure. Prese per sé due degl'altri ovati minori con un quadro, e due ne diede a Battista. In uno è Nettunno dio del mare e, ne gl'altri, due figure per ciascuno, dimostranti la grandezza e stato pacifico e quieto di Vinezia; et ancora che tutti e tre costoro si portassono bene, meglio di tutti si portò Paulo Veronese, onde meritò che da que' signori gli fusse poi allogato l'altro palco ch'è a canto a detta sala, dove fece a olio, insieme con Battista Farinato, un S. Marco in aria sostenuto da certi Angeli, e da basso una Vinezia in mezzo alla Fede, Speranza e Carità, la quale opera ancor che fusse bella, non fu in bontà pari alla prima. Fece poi Paulo solo nella Umiltà, in un ovato grande d'un palco, un'assunzione di Nostra Donna con altre figure, che fu una lieta, bella e ben intesa pittura.
È stato similmente a' dì nostri buon pittore in quella città Andrea Schiavone, dico buono perché ha pur fatto tal volta per disgrazia alcuna buon'opera e perché ha imitato sempre, come ha saputo il meglio, le maniere de' buoni. Ma perché la maggior parte delle sue cose sono stati quadri, che sono per le case de' gentiluomini, dirò solo d'alcune che sono publiche: nella chiesa di San Sebastiano in Vinezia, alla capella di quegli da Ca' Pellegrini, ha fatto un San Iacopo con due pellegrini; nella chiesa del Carmine, nel cielo d'un coro ha fatto un'Assunta con molti Angeli e Santi, e nella medesima chiesa, alla capella della Presentazione, ha dipinto Cristo puttino, dalla Madre presentato al tempio, con molti ritratti di naturale; ma la migliore figura che vi sia è una donna che allatta un putto et ha addosso un panno giallo, la quale è fatta con una certa pratica che s'usa a Vinezia, di macchie o vero bozze, senza esser finita punto. A costui fece fare Giorgio Vasari l'anno millecinquecento e quaranta in una gran tela a olio, la battaglia che poco innanzi era stata fra Carlo Quinto e Barbarossa, la quale opera, che fu delle migliori che Andrea Schiavone facesse mai e veramente bellissima, è oggi in Fiorenza in casa gl'eredi del Magnifico Messer Ottaviano de' Medici, al quale fu mandata a donare dal Vasari.
FINE DELLA VITA DI BATTISTA FRANCO, PITTORE VINIZIANO
VITA DI GIOVANFRANCESCO RUSTICHI
SCULTORE ET ARCHITETTO FIORENTINO

È gran cosa ad ogni modo che tutti coloro i quali furono della scuola del giardino di Medici, e favoriti del Magnifico Lorenzo Vecchio, furono tutti eccellentissimi. La qual cosa d'altronde non può essere avenuta se non dal molto anzi infinito giudizio di quel nobilissimo signore, vero mecenate degl'uomini virtuosi, il quale come sapeva conoscere gl'in-gegni e spiriti elevati, così poteva ancora e sapeva riconoscergli e premiargli. Portandosi dunque benissimo Giovanfrancesco Rustici, cittadin fiorentino, nel disegnare e fare di terra mentre era giovinetto, fu da esso Magnifico Lorenzo, il quale lo conobbe spiritoso e di bello e buono ingegno, messo a stare, perché imparasse, con Andrea del Verocchio, appresso al quale stava similmente Lionardo da Vinci, giovane raro e dotato d'infinite virtù; per che piacendo al Rustico la bella maniera et i modi di Lionardo, e parendogli che l'aria delle sue teste e le movenze delle figure fussono più graziose e fiere che quelle d'altri le quali avesse vedute già mai, si accostò a lui, imparato che ebbe a gettare di bronzo, tirare di prospettiva e lavorare di marmo, e dopo che Andrea fu andato a lavorare a Vinezia. Stando adunque il Rustico con Lionardo e servendolo con ogni amorevole sommessione, gli pose tanto amore esso Lionardo, conoscendo quel giovane di buono e sincero animo e liberale e diligente e paziente nelle fatiche dell'arte, che non faceva né più qua né più là di quello voleva Giovanfrancesco. Il quale, perciò che oltre all'essere di famiglia nobile, aveva da vivere onestamente, faceva l'arte più per suo diletto e disiderio d'onore, che per guadagnare. E per dirne il vero quegl'artefici che hanno per ultimo e principale fine il guadagno e l'utile e non la gloria e l'onore, rade volte, ancor che siano di bello e buono ingegno, riescono eccellentissimi; senzaché il lavorare per vivere, come fanno infiniti aggravati di povertà e di famiglia et il fare non a capricci e quando a ciò sono volti gli animi e la volontà, ma per bisogno dalla mattina alla sera, è cosa non da uomini che abbiano per fine la gloria e l'onore, ma da opere, come si dice, e da manovali, perciò che l'o-pere buone non vengono fatte senza essere prima state lungamente considerate. E per questo usava di dire il Rustico, nell'età sua più matura, che si deve prima pensare, poi fare gli schizzi et appresso i disegni, e quelli fatti, lasciargli stare settimane e mesi senza vedergli e poi, scelti i migliori, mettergli in opera; la qual cosa non può fare ognuno, né coloro l'usano che lavorano per guadagno solamente. Diceva ancora che l'opere non si deono così mostrare a ognuno prima che sieno finite, per poter mutarle quante volte et in quanti modi altri vuole, senza rispetto niuno.
Imparò Giovanfrancesco da Lionardo molte cose, ma particolarmente a fare cavalli, de' quali si dilettò tanto, che ne fece di terra, di cera e di tondo e basso rilievo in quante maniere possono imaginarsi, et alcuni se ne veggiono nel nostro libro tanto bene disegnati, che fanno fede della virtù e sapere di Giovanfrancesco, il quale seppe anco maneggiare i colori e fece alcune pitture ragionevoli, ancor che la sua principale professione fusse la scultura. E perché abitò un tempo nella via de' Martegli, fu amicissimo di tutti gl'uomini di quella famiglia, che ha sempre avuto uomini virtuosissimi e di valore, e particolarmente di Piero, al quale fece (come a suo più intrinseco) alcune figurette di tondo rilievo, e fra l'altre una Nostra Donna col Figlio in collo a sedere sopra certe nuvole piene di Cherubini, simile alla quale ne dipinse poi col tempo un'altra in un gran quadro a olio, con una ghirlanda di Cherubini che intorno alla testa le fa diadema. Essendo poi tornata in Fiorenza la famiglia de' Medici, il Rustico si fece conoscere al cardinale Giovanni per creatura di Lorenzo suo padre e fu ricevuto con molte carezze, ma perché i modi della corte non gli piacevano et erano contrarii alla sua natura tutta sincera e quieta e non piena d'invidia et ambizione, si volle star sempre da sé e far vita quasi da filosofo, godendosi una tranquilla pace e riposo. E quando pure alcuna volta volea ricrearsi o si trovava con suoi amici dell'arte, o con alcuni cittadini suoi dimestici, non restando per questo di lavorare quando voglia gliene veniva o glie-n'era porta occasione. Onde nella venuta l'anno millecinquecento e quindici di papa Leone a Fiorenza, a richiesta d'An-drea del Sarto, suo amicissimo, fece alcune statue che furono tenute bellissime, le quali, perché piacquero a Giulio cardinale de' Medici, furono cagione che gli fece fare, sopra il finimento della fontana che è nel cortile grande del palazzo de' Medici, il Mercurio di bronzo alto circa un braccio, che è nudo sopra una palla, in atto di volare, al quale mise fra le mani un instrumento che è fatto, dall'acqua che egli versa in alto, girare; imperò che, essendo bucata una gamba, passa la canna per quella e per il torso onde, giunta l'acqua alla bocca della figura, percuote in quello strumento bilicato con quattro piastre sottili saldate a uso di farfalla e lo fa girare. Questa figura dico, per cosa piccola, fu molto lodata.
Non molto dopo fece Giovanfrancesco per lo medesimo cardinale il modello per fare un Davit di bronzo simile a quello di Donato fatto al Magnifico Cosimo Vecchio, come s'è detto, per metterlo nel primo cortile, onde era stato levato quello. Il quale modello piacque assai, ma per una certa lunghezza di Giovanfrancesco non si gettò mai di bronzo, onde vi fu messo l'Orfeo di marmo del Bandinello; et il Davit di terra fatto dal Rustico, che era cosa rarissima, andò male, che fu grandissimo danno. Fece Giovanfrancesco in un gran tondo di mezzo rilievo una Nunziata, con una prospettiva bellissima, nella quale gli aiutò Raffaello Bello pittore e Niccolò Soggi, che gettata di bronzo riuscì di sì rara bellezza, che non si poteva vedere più bell'opera di quella, la quale fu mandata al re di Spagna. Condusse poi di marmo in un altro tondo simile una Nostra Donna col Figliuolo in collo e San Giovanni Battista fanciulletto, che fu messo nella prima sala del magistrato de' Consoli dell'arte di Por Santa Maria. Per quest'opere essendo venuto in molto credito Giovanfrancesco, i consoli dell'arte de' Mercatanti avendo fatto levare certe figuracce di marmo che erano sopra le tre porte del tempio di San Giovanni, già state fatte, come s'è detto, nel milledugento e quaranta, et allogate al Contucci Sansovino quelle che si avevano in luogo delle vecchie a mettere sopra la porta che è verso la Misericordia, allogarono al Rustico quelle che si avevano a porre sopra la porta che è volta verso la canonica di quel tempio, acciò facesse tre figure di bronzo di braccia quattro l'una e quelle stesse che vi erano vecchie, cioè un San Giovanni che predicasse e fusse in mezzo a un fariseo et a un levite. La quale opera fu molto conforme al gusto di Giovanfrancesco, avendo a essere posta in luogo sì celebre e di tanta importanza, et oltre ciò per la concorrenza d'Andrea Contucci. Messovi dunque subitamente mano e fatto un modelletto piccolo, il quale superò con l'eccellenza dell'opera, ebbe tutte quelle considerazioni e diligenza che una sì fatta opera richiedeva. La quale finita, fu tenuta in tutte le parti la più composta e meglio intesa che per simile fusse stata fatta insino allora, essendo quelle figure d'intera perfezione e fatte nell'aspetto con grazia e bravura terribile. Similmente le bracce ignude e le gambe sono benissimo intese et appiccate alle congiunture tanto bene, che non è possibile far più. E, per non dir nulla delle mani e de' piedi, che graziose attitudini e che gravità eroica hanno quelle teste? Non volle Giovanfrancesco mentre conduceva di terra quest'opera altri a torno che Lionardo da Vinci, il quale nel fare le forme, armarle di ferri et insomma sempre insino a che non furono gettate le statue, non l'abbandonò mai, onde credono alcuni, ma però non ne sanno altro, che Lionardo vi lavorasse di sua mano, o almeno aiutasse Giovanfrancesco col consiglio e buon giudizio suo. Queste statue, le quali sono le più perfette e meglio intese che siano state mai fatte di bronzo da maestro moderno, furono gettate in tre volte e rinette nella detta casa dove abitava Giovanfrancesco nella via de' Martelli, e così gl'ornamenti di marmo che sono intorno al San Giovanni, con le due colonne, cornici et insegna dell'arte de' Mercatanti. Oltre al San Giovanni, che è una figura pronta e vivace, vi è un zuccone grassotto, che è bellissimo; il quale, posato il braccio destro sopra un fianco, con un pezzo di spalla nuda, e tenendo con la sinistra mano una carta dinanzi agl'occhi, ha sopraposta la gamba sinistra alla destra, e sta in atto consideratissimo per rispondere a San Giovanni, con due sorti di panni vestito: uno sottile, che scherza intorno alle parti ignude della figura, et un manto di sopra più grosso, condotto con un andar di pieghe che è molto facile et artifizioso. Simile a questo è il fariseo perciò che, postasi la man destra alla barba, con atto grave, si tira alquanto a dietro, mostrando stupirsi delle parole di Giovanni.
Mentre che il Rustici faceva quest'opera, essendogli venuto a noia l'avere a chiedere ogni dì danari ai detti consoli o loro ministri, che non erano sempre que' medesimi e sono le più volte persone che poco stimano virtù o alcun'opera di pregio, vendé (per finire l'opera) un podere di suo patrimonio che avea poco fuor di Firenze a San Marco vecchio. E non ostanti tante fatiche, spese e diligenze, ne fu male dai consoli e dai suoi cittadini remunerato; perciò che uno de' Ridolfi, capo di quell'uffizio, per alcun sdegno particolare e perché forse non l'aveva il Rustico così onorato, né lasciatogli vedere a suo commodo le figure, gli fu sempre in ogni cosa contrario. E quello che a Giovanfrancesco dovea risultare in onore, faceva il contrario e storto, però che dove meritava d'essere stimato non solo come nobile e cittadino, ma anco come virtuoso, l'essere eccellentissimo artefice gli toglieva appresso gl'ignoranti et idioti di quello che per nobiltà se gli doveva. Avendosi dunque a stimar l'opera di Giovanfrancesco, et avendo egli chiamato per la parte sua Michelagnolo Buonarroti, il magistrato, a persuasione del Ridolfi, chiamò Baccio d'Agnolo, di che dolendosi il Rustico e dicendo agl'uomini del magistrato, nell'udienza, che era pur cosa troppo strana che un artefice legnaiuolo avesse a stimare le fatiche d'uno statuario, e quasi che egli erano un monte di buoi, il Ridolfi rispondeva che anzi ciò era ben fatto e che Giovanfrancesco era un superbaccio et un arrogante. Ma quello che fu peggio, quell'opera che non meritava meno di duemila scudi, gli fu stimata dal magistrato cinquecento, che anco non gli furono mai pagati interamente, ma solamente quattrocento per mezzo di Giulio cardinale de' Medici. Veggendo dunque Giovanfrancesco tanta malignità, quasi disperato si ritirò con proposito di mai più non volere far opere per magistrati, né dove avesse a dependere più che da un cittadino o altr'uomo solo. E così standosi da sé e menando vita soletaria nelle stanze della Sapienza a canto ai frati de' Servi, andava lavorando alcune cose per non istare in ozio e passarsi tempo. Consumandosi oltre ciò la vita et i danari dietro a cercare di congelare mercurio in compagnia d'un altro cervello così fatto chiamato Raffaello Baglioni, dipinse Giovanfrancesco in un quadro lungo tre braccia et alto due una conversione di San Paulo a olio piena di diverse sorti cavalli sotto i soldati di esso Santo, in varie e belle attitudini e scorti. La quale pittura insieme con molte altre cose di mano del medesimo è appresso gli eredi del già detto Piero Martelli, a cui la diede. In un quadretto dipinse una caccia piena di diversi animali, che è molto bizzarra e vaga pittura, la quale ha oggi Lorenzo Borghini, che la tien cara come quegli che molto si diletta delle cose delle nostre arti. Lavorò di mezzo rilievo di terra per le monache di San Luca in via di San Gallo un Cristo nell'orto che appare a Maria Madalena, il quale fu poi invetriato da Giovanni della Robbia e posto a un altare nella chiesa delle dette suore dentro a un ornamento di macigno. A Iacopo Salviati il vecchio, del qua-le fu amicissimo, fece in un suo palazzo sopra al ponte alla badia un tondo di marmo bellissimo per la cappella, dentro-vi una Nostra Donna, et intorno al cortile molti tondi pieni di figure di terra cotta, con altri ornamenti bellissimi, che furono la maggior parte, anzi quasi tutti, rovinati dai soldati l'anno dell'assedio e messo fuoco nel palazzo dalla parte contraria a' Medici. E perché aveva Giovanfrancesco grande affezzione a questo luogo, si partiva per andarvi alcuna volta a Firenze così in lucco, et uscito dalla città se lo metteva in ispalla e pian piano, fantasticando, se n'andava tutto solo insin lassù; et una volta fra l'altre, essendo per questa gita e facendogli caldo, nascose il lucco in una macchia fra certi pruni e condottosi al palazzo vi stette due giorni prima che se ne ricordasse; finalmente mandando un suo uomo a cercarlo, quando vide colui averlo trovato, disse: “Il mondo è troppo buono, durerà poco”. Era uomo Giovanfrancesco di somma bontà et amorevolissimo de' poveri, onde non lasciava mai partire da sé niuno sconsolato, anzi tenendo i danari in un paniere, o pochi o assai che n'avesse, ne dava secondo il poter suo a chiunche gliene chiedeva; per che, veggendolo un povero, che spesso andava a lui per la limosina, andar sempre a quel paniere, disse, pensando non essere udito: “O Dio, se io avessi in camera quello che è dentro a quel paniere, acconcerei pure i fatti miei”. Giovanfrancesco, udendolo, poi che l'ebbe alquanto guardato fiso, disse: “Vien qua, i' vo' contentarti”. E così, votatogli in un lembo della cappa il paniere, disse: “Va, che sii benedetto”. E poco appresso mandò a Niccolò Buoni suo amicissimo, il quale faceva tutti i fatti suoi, per danari; il quale Niccolò, che teneva conto di sue ricolte de' danari di monte e vendeva le robe a' tempi, aveva per costume, secondo che esso Rustico voleva, dargli ogni settimana tanti danari, i quali tenendo poi Giovanfrancesco nella cassetta del calamaio senza chiave, ne toglieva di mano in mano chi voleva, per spendergli ne' bisogni di casa secondo che occorreva.
Ma tornando alle sue opere, fece Giovanfrancesco un bellissimo Crucifisso di legno grande quanto il vivo per mandarlo in Francia, ma rimase a Niccolò Buoni insieme con altre cose di bassi rilievi e disegni che son oggi appresso di lui, quando disegnò partirsi di Firenze, parendogli che la stanza non facesse per lui e pensando di mutare, insieme col paese, fortuna.
Al duca Giuliano, dal quale fu sempre molto favorito, fece la testa di lui in profilo di mezzo rilievo e la gettò di bronzo, che fu tenuta cosa singolare, la quale è oggi in casa Messer Alessandro di Messer Ottaviano de' Medici. A Ruberto di Filippo Lippi pittore, il quale fu suo discepolo, diede Giovanfrancesco molte opere di sua mano di bassi rilievi, e modelli e disegni, e fra l'altre in più quadri una Leda, un'Europa, un Nettunno et un bellissimo Vulcano, et un altro quadretto di basso rilievo dove è un uomo nudo a cavallo, che è bellissimo, il quale quadro è oggi nello scrittoio di don Silvano Razzi negl'Angeli. Fece il medesimo una bellissima femina di bronzo alta due braccia finta per una Grazia, che si premeva una poppa, ma questa non si sa dove capitasse, né in mano di cui si truovi. De' suoi cavalli di terra con uomini sopra e sotto, simili ai già detti, ne sono molti per le case de' cittadini, i quali furono da lui, che era cortesissimo e non come il più di simili uomini avaro e scortese, a diversi suoi amici donati. E Dionigi da Diaceto, gentiluomo onorato e da bene, che tenne ancor egli, sì come Niccolò Buoni, i conti di Giovanfrancesco e gli fu amico, ebbe da lui molti bassi rilievi. Non fu mai il più piacevole e capriccioso uomo di Giovanfrancesco, né chi più si dilettasse d'animali: si aveva fatto così domestico un istrice, che stava sotto la tavola com'un cane et urtava alcuna volta nelle gambe in modo, che ben presto altri le tirava a sé; aveva un'aquila et un corbo che dicea infinite cose sì schiettamente, che pareva una persona.
Attese anco alle cose di negromanzia, e mediante quella, intendo che fece di strane paure ai suoi garzoni e familiari, e così viveva senza pensieri. Avendo murata una stanza quasi a uso di vivaio et in quella tenendo molte serpi o vero biscie che non potevano uscire, si prendeva grandissimo piacere di stare a vedere, e massimamente di state, i pazzi giuochi ch'elle facevano e la fierezza loro. Si ragunava nelle sue stanze della Sapienza una brigata di galantuomini, che si chiamavano la Compagnia del Paiuolo, e non potevano essere più che dodici: e questi erano esso Giovanfrancesco, Andrea del Sarto, Spillo pittore, Domenico Puligo, il Robetta orafo, Aristotile da San Gallo, Francesco di Pellegrino, Niccolò Boni, Domenico Baccelli, che sonava e cantava ottimamente, il Solosmeo scultore, Lorenzo detto Guazzetto e Ruberto di Filippo Lippi pittore, il quale era loro proveditore. Ciascuno de' quali dodici a certe loro cene e passatempi poteva menare quattro e non più. E l'ordine delle cene era questo (il che racconto volentieri perché è quasi del tutto dismesso l'uso di queste Compagnie) che ciascuno si portasse alcuna cosa da cena, fatta con qualche bella invenzione, la quale, giunto al luogo, presentava al signore, che sempre era un di loro, il quale la dava a chi più gli piaceva, scambiando la cena d'uno con quella dell'altro. Quando erano poi a tavola, presentandosi l'un l'altro, ciascuno avea d'ogni cosa, e chi si fusse riscontrato nell'invenzione della sua cena con un altro, e fatto una cosa medesima, era condennato. Una sera dunque che Giovanfrancesco diede da cena a questa sua Compagnia del Paiuolo, ordinò che servisse per tavola un grandissimo paiuolo fatto d'un tino, dentro al quale stavano tutti, e parea che fussino nell'acqua della caldaia: di mezzo alla quale venivono le vivande intorno intorno, et il manico del paiuolo, che era alla volta, faceva bellissima lumiera nel mezzo, onde si vedevano tutti in viso guardando intorno. Quando furono adunque posti a tavola dentro al paiuolo benissimo accomodato, uscì del mezzo un albero con molti rami, che mettevono innanzi la cena, cioè le vivande a due per piatto; e ciò fatto, tornando a basso, dove erano persone che sonavano, di lì a poco risurgeva di sopra e porgeva le seconde vivande e dopo le terze e così di mano in mano, mentre attorno erano serventi che mescevano preziosissimi vini. La quale invenzione del paiuolo, che con tele e pitture era accomodato benissimo, fu molto lodata da quegl'uomini della Compagnia. In questa tornata il presente del Rustico fu una caldaia fatta di pasticcio, dentro alla quale Ulisse tuffava il padre per farlo ringiovanire, le quali due figure erano capponi lessi che avevano forma d'uomini, sì bene erano acconci le membra et il tutto con diverse cose tutte buone a mangiare; Andrea del Sarto presentò un tempio a otto faccie, simile a quello di San Giovanni, ma posto sopra colonne; il pavimento era un grandissimo piatto di gelatina con spartimenti di varii colori di musaico; le colonne, che parevano di porfido, erano grandi e grossi salsicciotti, le base et i capitegli era-no di cacio parmigiano, i cornicioni di paste di zuccheri e la tribuna era di quarti di marzapane, nel mezzo era posto un leggio da coro fatto di vitella fredda con un libro di lasagne che aveva le lettere e le note da cantare di granella di pepe e quelli che cantavano al leggio erano tordi cotti col becco aperto e ritti con certe camiciuole a uso di cotte, fatte di rete di porco sottile, e dietro a questi per contrabasso erano due pippioni grossi, con sei ortolani che facevano il sovrano; Spillo presentò per la sua cena un magnano, il quale avea fatto d'una grande oca, o altro uccello simile, con tutti gl'in-strumenti da potere racconciare, bisognando, il paiuolo; Domenico Puligo d'una porchetta cotta fece una fante con la rocca da filare allato, la quale guardava una covata di pulcini et aveva a servire per rigovernare il paiuolo; il Robetta per conservare il paiuolo fece d'una testa di vitella, con acconcime d'altri untumi, un'incudine, che fu molto bello e buono, come anche furono gl'altri presenti, per non dire di tutti a uno a uno di quella cena e di molte altre che ne feciono. La Compagnia poi della Cazzuola, che fu simile a questa e della quale fu Giovanfrancesco, ebbe principio in questo modo: essendo l'anno 1512 una sera a cena, nell'orto che aveva nel campaccio Feo d'Agnolo gobbo, sonatore di pifferi e persona molto piacevole, esso Feo, ser Bastiano Sagginati, ser Raffaello del Beccaio, ser Cecchino de' Profumi, Girolamo del Giocondo et il Baia, venne veduto, mentre che si mangiavano le ricotte, al Baia in un canto dell'orto appresso alla tavola un monticello di calcina, dentrovi la cazzuola, secondo che il giorno innanzi l'aveva quivi lasciata un muratore; per che prese con quella mestola o vero cazzuola alquanto di quella calcina, la cacciò tutta in bocca a Feo, che da un altro aspettava a bocca aperta un gran boccone di ricotta, il che vedendo la brigata, si cominciò a gridare: “Cazzuola, cazzuola!”. Creandosi dunque per questo accidente la detta Compagnia, fu ordinato che in tutto gl'uomini di quella fussero ventiquattro, dodici di quelli che andavano, come in que' tempi si diceva, per la maggiore, e dodici per la minore, e che l'insegna di quella fusse una cazzuola, alla quale aggiunsero poi quelle botticine nere che hanno il capo grosso e la coda, le quali si chiamano in Toscana cazzuole. Il loro avvocato era Santo Andrea, il giorno della cui festa celebravano solennemente, facendo una cena e convito, secondo i loro capitoli, bellissimo. I primi di questa Compagnia, che anda-vano per la maggiore, furono Iacopo Bottegai, Francesco Rucellai, Domenico suo fratello, Giovambatista Ginori, Girolamo del Giocondo, Giovanni Miniati, Niccolò del Barbigia, Mezzabotte suo fratello, Cosimo da Panzano, Matteo suo fratello, Marco Iacopi, Pieraccino Bartoli; e per la minore, ser Bastiano Sagginotti, ser Raffaello del Beccaio, ser Cecchino de' Profumi, Giuliano Bugiardini pittore, Francesco Granacci pittore, Giovanfrancesco Rustici, Feo gobbo, il Talina sonatore suo compagno, Pierino Piffero, Giovanni Trombone et il Baia bombardiere. Gl'aderenti furono Bernardino di Giordano, il Talano, il Caiano, maestro Iacopo del Bientina e Messer Giovambatista di Cristofano ottonaio, araldi ambedue della signoria, Buon Pocci e Domenico Barlacchi. E non passarono molti anni (tanto andò crescendo in nome) facendo feste e buon tempi, che furono fatti di essa Compagnia della Cazzuola il signor Giuliano de' Medici, Ottangolo Benvenuti, Giovanni Canigiani, Giovanni Serristori, Giovanni Gaddi, Giovanni Bandini, Luigi Martelli, Paulo da Romena e Filippo Pandolfini gobbo. E con questi in una medesima mano, come aderenti, Andrea del Sarto dipintore, Bartolomeo Trombone musico, ser Bernardo Pisanello, Piero cimatore, il Gemma merciaio et ultimamente maestro Manen-te da San Giovanni medico. Le feste che costoro feciono in diversi tempi furono infinite, ma ne dirò solo alcune poche per chi non sa l'uso di queste Compagnie che oggi sono, come si è detto, quasi del tutto dismesse. La prima della Cazzuola, la quale fu ordinata da Giuliano Bugiardini, si fece in un luogo detto l'Aia, da Santa Maria Nuova, dove dicemo disopra, che furono gettate di bronzo le porte di San Giovanni. Quivi dico, avendo il signor della Compagnia comandato che ognuno dovesse trovarsi vestito in che abito gli piaceva, con questo che coloro che si scontrassero nella maniera del vestire et avessero una medesima foggia fussero condennati, comparsero all'ora deputata le più belle e più bizzarre stravaganze d'abiti che si possano imaginare; venuta poi l'ora di cena, furon posti a tavola secondo le qualità de' vestimenti. Chi aveva abiti da principi ne' primi luoghi, i ricchi e gentiluomini appresso, et i vestiti da poveri negl'ultimi e più bassi gradi, ma se dopo cena si fecero delle feste e de' giuochi, meglio è lasciare che altri se lo pensi, che dirne al-cuna cosa. A un altro pasto che fu ordinato dal detto Bugiardino e da Giovanfrancesco Rustici, comparsero gl'uomini della Compagnia, sì come avea il signor ordinato, tutti in abito di muratori e manovali: cioè quelli che andavano per la maggiore con la cazzuola che tagliasse et il martello a cintola, e quegli che per la minore vestiti da manovali col vassoio e manovelle da far lieva e la cazzuola sola a cintola. Et arrivati tutti nella prima stanza, avendo loro mostrato il signore la pianta d'uno edifizio che si aveva da murare per la Compagnia, e dintorno a quello messo a tavola i maestri, i manovali cominciarono a portare le materie per fare il fondamento: cioè vassoi pieni di lasagne cotte per calcina e ricotte acconce col zucchero, rena fatta di cacio, spezie e pepe mescolati, e per ghiaia confetti grossi e spicchi di berlingozzi, i quadrucci, mezzane e pianelle che erano portate ne' corbelli e con le barelle, erano pane e stiacciate. Venuto poi uno imbasamento, perché non pareva dagli scarpellini stato così ben condotto e lavorato, fu giudicato che fusse ben fatto spezzarlo e romperlo, per che, datovi dentro e trovatolo tutto composto di torte, fegategli et altre cose simili, se le goderono essendo loro poste innanzi dai manovali. Dopo, venuti i medesimi in campo con una gran colonna fasciata di trippe di vitella cotte e quella disfatta e dato il lesso di vitella e caponi et altro di che era composta, si mangiarono la basa di cacio parmigiano et il capitello acconcio maravigliosamente con intagli di caponi arrosto, fette di vitella e con la cimasa di lingue. Ma perché sto io a contare tutti i particolari? Dopo la colonna fu portato sopra un carro un pezzo di molto artifizioso architrave con fregio e cornicione, in simile maniera tanto bene e di tante diverse vivande composto, che troppo lunga storia sarebbe voler dirne l'intero; basta che quando fu tempo di svegliare, venendo una pioggia fitta dopo molti tuoni, tutti lasciarono il lavoro e si sfuggirono et andò ciascuno a casa sua.
Un'altra volta essendo nella medesima Compagnia signore Matteo da Panzano, il convito fu ordinato in questa maniera: Cerere cercando Proserpina sua figliuola, la quale avea rapita Plutone, entrata dove erano ragunati gli uomini del-la Cazzuola dinanzi al loro signore, gli pregò che volessino accompagnarla all'inferno, alla quale dimanda dopo molte dispute essi acconsentendo, le andarono dietro. E così entrati in una stanza alquanto oscura, videro in cambio d'una porta una grandissima bocca di serpente, la cui testa teneva tutta la facciata; alla quale porta d'intorno accostandosi tutti, mentre Cerbero abaiava, dimandò Cerere se là entro fusse la perduta figliuola, et essendole risposto di sì, ella soggiunse che disiderava di riaverla. Ma avendo risposto Plutone non voler renderla et invitatale con tutta la Compagnia alla nozze che s'apparecchiavano, fu accettato l'invito; per che, entrati tutti per quella bocca piena di denti, che essendo gangherata s'apriva a ciascuna coppia d'uomini che entrava e poi si chiudeva, si trovarono in ultimo in una gran stanza di forma tonda, la quale non aveva altro che un assai piccolo lumicino nel mezzo, il quale sì poco risplendeva, che a fatica si scorgevano. Quivi essendo da un bruttissimo diavolo, che era nel mezzo con un forcone, messi a sedere dove erano le tavole apparecchiate di nero, comandò Plutone che per onore di quelle sue nozze cessassero, per insino a che quivi dimoravano, le pene dell'inferno; e così fu fatto. E perché erano in quella stanza tutte dipinte le bolgie del regno de' dannati e le loro pene e tormenti, dato fuoco a uno stopino in un baleno fu acceso a ciascuna bolgia un lume che mostrava nella sua pittura in che modo e con quali pene fussero quelli che erano in essa tormentati. Le vivande di quella infernal cena furono tutti animali schifi e bruttissimi in apparenza, ma però dentro, sotto la forma del pasticcio e coperta abominevole, erano cibi delicatissimi e di più sorti. La scorza dico, et il difuori mostrava che fussero serpenti, biscie, ramarri, lucertole, tarantole, botte, ranocchi, scorpioni, pipistrelli et altri simili animali, et il didentro era composizione d'ottime vivande. E queste furono poste in tavola con una pala, e dinanzi a ciascuno e con ordine, dal diavolo che era nel mezzo, un compagno del quale mesceva con un corno di vetro, ma di fuori brutto e spiacevole, preziosi vini in coreggiuoli da fondere invetriati, che servivano per bicchieri. Finite queste prime vivande, che furono quasi un antipasto, furono messe per frutte, fingendo che la cena (affatica non cominciata) fusse finita, in cambio di frutte e confezzioni, ossa di morti giù giù per tutta la tavola, le quali frutte e reliquie erano di zucchero. Ciò fatto, comandando Plutone, che disse voler andare a riposarsi con Proserpina sua, che le pene tornassero a tormentare i dannati, furono da certi venti in un attimo spenti tutti i già detti lumi et uditi infiniti romori, grida e voci orribili e spaventose e fu veduta nel mezzo di quelle tenebre, con un lumicino, l'imagine del Baia bombardiere, che era uno de' circostanti, come s'è detto, condannato da Plutone all'inferno, per avere nelle sue girandole e machine di fuoco avuto sempre per suggetto et invenzione i sette peccati mortali e cose d'inferno. Mentre che a vedere ciò et a udire diverse lamentevoli voci s'attendeva, fu levato via il doloroso e funesto apparato, e venendo i lumi, veduto in cambio di quello un apparecchio reale e ricchissimo e con orrevoli serventi che portarono il rimanente della cena, che fu magnifica et onorata; al fine della quale venendo una nave piena di varie confezioni, i padroni di quella, mostrando di levar mercanzie, condussero a poco a poco gl'uomini della Compagnia nelle stanze di sopra, dove essendo una scena et apparato ricchissimo, fu recitata una comedia intitolata Filogenia, che fu molto lodata; e quella finita all'alba ognuno si tornò lietissimo a casa.
In capo a due anni, toccando dopo molte feste e comedie al medesimo a essere un'altra volta signore, per tassare alcuni della Compagnia che troppo avevano speso in certe feste e conviti (per essere mangiati, come si dice, vivi) fece ordinare il convito suo in questa maniera. All'Aia, dove erano soliti ragunarsi, furono primieramente fuori della porta nella facciata, dipinte alcune figure di quelle che ordinariamente si fanno nelle facciate e ne' portici degli spedali, cioè lo spedalingo che in atti tutti pieni di carità invita e riceve i poveri e peregrini; la quale pittura scopertasi la sera della festa al tardi, cominciarono a comparire gl'uomini della Compagnia, i quali bussando, poi che all'entrare erano dallo spedalingo stati ricevuti, pervenivano a una gran stanza acconcia a uso di spedale con le sue letta dagli lati et altre cose simiglianti; nel mezzo della quale dintorno a un gran fuoco erano vestiti a uso di poltronieri, furfanti e poveracci, il Bientina, Battista dell'Ottonaio, il Barlacchi, il Baia et altri così fatti uomini piacevoli, i quali fingendo di non esser veduti da coloro che di mano in mano entravano e facevano cerchio e discorrendo sopra gl'uomini della Compagnia e sopra loro stessi, dicevano le più ladre cose del mondo di coloro che avevano gettato via il loro e speso in cene et in feste troppo più che non conviene. Il quale discorso finito, poi che si videro esser giunti tutti quelli che vi avevono a essere, venne santo Andrea loro avvocato, il quale, cavandogli dello spedale, gli condusse in un'altra stanza magnificamente apparecchiata, dove messi a tavola, cenarono allegramente, e dopo il santo comandò loro piacevolmente che per non soprabondare in spese superflue et avere a stare lontano dagli spedali, si contentassero d'una festa l'anno, principale e solenne, e si partì. Et essi l'ubidirono facendo per ispazio di molti anni ogni anno una bellissima cena e comedia, onde recitarono in diversi tempi, come si disse nella vita d'Aristotile da San Gallo, la Calandra di Messer Bernardo cardinale di Bibbiena, i Suppositi e la Cassaria dell'Ariosto, e la Clizia e Mandragola del Machiavello, con altre molte.
Francesco e Domenico Rucellai nella festa che toccò a far loro quando furono signori, fecero una volta l'Arpie di Fineo e l'altra, dopo una disputa di filosofi sopra la Trinità, fecero mostrare da santo Andrea un cielo aperto con tutti i cori degl'angeli, che fu cosa veramente rarissima; e Giovanni Gaddi con l'aiuto di Iacopo Sansovino, d'Andrea del Sarto e di Giovanfrancesco Rustici, rappresentò un Tantalo nell'inferno che diede mangiare a tutti gl'uomini della Compagnia, vestiti in abiti di diversi dii, con tutto il rimanente della favola e con molte capricciose invenzioni di giardini, paradisi, fuochi lavorati et altre cose che troppo, raccontandole, farebbono lunga la nostra storia. Fu anche bellissima invenzione quella di Luigi Martelli, quando essendo signor della Compagnia, le diede cena in casa di Giuliano Scali alla porta Pinti; perciò che rappresentò Marte per la crudeltà tutto di sangue imbrattato, in una stanza piena di membra umane sanguinose, in un'altra stanza mostrò Marte e Venere nudi in un letto, e poco appresso Vulcano, che avendogli coperti sotto la rete, chiama tutti gli dii a vedere l'oltraggio fattogli da Marte e dalla trista moglie. Ma è tempo oggimai dopo questa, che parrà forse ad alcuno troppo lunga digressione, che non del tutto a me pare fuor di proposito per molte cagioni stata raccontata, che io torni alla vita del Rustico.
Giovanfrancesco adunque, non molto sodisfacendogli, dopo la cacciata de' Medici l'anno 1528, il vivere di Firenze, lasciato d'ogni sua cosa cura a Niccolò Boni, con Lorenzo Naldini cognominato Guazzetto, suo giovane, se n'andò in Francia; dove, essendo fatto conoscere al re Francesco da Giovambatista della Palla, che allora là si trovava, e da Francesco di Pellegrino suo amicissimo che v'era andato poco innanzi, fu veduto ben volentieri et ordinatogli una provisione di cinquecento scudi l'anno. Dal qual Re, a cui fece Giovanfrancesco alcune cose, delle quali non si ha particolarmente notizia, gli fu dato a fare ultimamente un cavallo di bronzo due volte grande quanto il naturale, sopra il quale doveva esser posto esso Re. Laonde, avendo messo mano all'opera, dopo alcuni modelli, che molto erano al Re piaciuti, andò continuando di lavorare il modello grande et il cavo per gettarlo, in un gran palazzo statogli dato a godere dal Re. Ma che che se ne fusse cagione, il Re si morì prima che l'opera fusse finita; ma perché nel principio del regno d'Enrico, furono levate le provisioni a molti e ristrette le spese della corte, si dice che Giovanfrancesco, trovandosi vecchio e non molto agiato, si viveva, non avendo altro, del frutto che traeva del fitto di quel gran palagio e casamento che aveva avuto a godersi dalla liberalità del re Francesco; ma la fortuna, non contenta di quanto aveva insino allora quell'uomo sopportato, gli diede, oltre all'altre, un'altra grandissima percossa; perché avendo donato il re Enrico quel palagio al signor Piero Strozzi, si sarebbe trovato Giovanfrancesco a pessimo termine; ma la pietà di quel signore, al quale increbbe molto della fortuna del Rustico che se gli diede a conoscere, gli venne nel maggior bisogno a tempo, imperò che il signor Piero mandandolo a una badia, o altro luogo che si fusse, del fratello, non solamente sovvenne la povera vecchiezza di Giovanfrancesco, ma lo fece servire e governare, secondo che la sua molta virtù meritava, insino all'ultimo della vita.
Morì Giovanfrancesco d'anni ottanta, e le sue cose rimasero per la maggior parte al detto signore Piero Strozzi. Non tacerò essermi venuto a notizia che mentre Antonio Mini, discepolo del Buonarroti, dimorò in Francia e fu da Giovanfrancesco trattenuto et accarezzato in Parigi, che vennero in mano di esso Rustichi alcuni cartoni, disegni e modelli di mano di Michelagnolo, de' quali una parte ebbe Benvenuto Cellini scultore mentre stette in Francia, il quale gli ha condotti a Fiorenza. Fu Giovanfrancesco, come si è detto, non pure senza pari nelle cose di getto, ma costumatissimo, di somma bontà e molto amatore de' poveri, onde non è maraviglia se fu con molta liberalità sovvenuto nel suo maggior bisogno di danari e d'ogni altra cosa dal detto signor Piero; però che è sopra ogni verità verissimo che in mille doppi, eziandio in questa vita, sono ristorate le cose che al prossimo ci fanno per Dio. Disegnò il Rustico benissimo come, oltre al nostro libro, si può vedere in quello de' disegni del molto reverendo don Vincenzio Borghini. Il sopra detto Lorenzo Naldini, cognominato Guazzetto, discepolo del Rustico, ha in Francia molte cose lavorato ottimamente di scultura, ma non ho potuto sapere i particolari, come né anco dal suo maestro, il quale si può credere che non stesse tanti anni in Francia quasi ozioso, né sempre intorno a quel suo cavallo. Aveva il detto Lorenzo alcune case fuor della porta a San Gallo ne' borghi, che furono per l'assedio di Firenze rovinati, che gli furono insieme con l'altre dal popolo gettate per terra, la qual cosa gli dolse tanto, che tornando egli a rivedere la patria l'anno 1540, quando fu vicino a Fiorenza un quarto di miglio si mise la capperuccia d'una sua cappa in capo e si coprì gl'occhi per non vedere disfatto quel borgo e la sua casa nell'entrare per la detta porta; onde, veggendolo così incarruffato le guardie della porta e dimandando che ciò volesse dire, intesero da lui perché si fusse così coperto e se ne risero. Costui essendo stato pochi mesi in Firenze, se ne tornò in Francia e vi menò la madre, dove ancora vive e lavora.
IL FINE DELLA VITA DI GIOVANFRANCESCO RUSTICHI FIORENTINO
VITA DI FRA' GIOVANN'AGNOLO MONTORSOLI
SCULTORE

Nascendo a un Michele d'Agnolo da Poggibonzi, nella villa chiamata Montorsoli, lontana da Firenze tre miglia in sulla strada di Bologna, dove aveva un suo podere assai grande e buono, un figliuolo maschio, gli pose il nome di suo padre cioè Angelo. Il quale fanciullo crescendo et avendo, per quello che si vedeva, inclinazione al disegno, fu posto dal padre, essendo a così fare consigliato dagl'amici, allo scarpellino con alcuni maestri che stavano nelle cave di Fiesole, quasi dirimpetto a Montorsoli, appresso ai quali continuando Angelo di scarpellare in compagnia di Francesco del Tadda, allora giovinetto, e d'altri, non passarono molti mesi che seppe benissimo maneggiare i ferri e lavorare molte cose di quello esercizio. Avendo poi per mezzo del Tadda fatto amicizia con maestro Andrea scultore da Fiesole, piacque a quello uomo in modo l'ingegno del fanciullo, che postogli affezione, gli cominciò a insegnare, e così lo tenne appresso di sé tre anni. Dopo il quale tempo, essendo morto Michele suo padre, se n'andò Angelo in compagnia di altri giovani scarpellini alla volta di Roma, dove essendosi messo a lavorare nella fabrica di San Piero, intagliò alcuni di que' rosoni che sono nella maggior cornice che gira dentro a quel tempio, con suo molto utile e buona provisione. Partitosi poi di Roma, non so perché, si acconciò in Perugia con un maestro di scarpello, che in capo a un anno gli lasciò tutto il carico de' suoi lavori. Ma conoscendo Agnolo che lo stare a Perugia non faceva per lui e che non imparava, portasegli occasione di partire se n'andò a lavorare a Volterra nella sepoltura di Messer Raffaello Maffei detto il Volaterranno, nella quale, che si faceva di marmo, intagliò alcune cose, che mostrarono quell'ingegno dovere fare un giorno qualche buona riuscita. La quale opera finita, intendendo che Michelagnolo Buonarroti metteva allora in opera i migliori intagliatori e scarpellini che si trovassero, nelle fabriche della sagrestia e libreria di San Lorenzo, se n'andò a Firenze dove messo a lavorare, nelle prime cose che fece conobbe Michelagnolo in alcuni ornamenti che quel giovinetto era di bellissimo ingegno e risoluto e che più conduceva egli solo in un giorno che in due non facevono i maestri più pratichi e vecchi. Onde fece dare a lui fanciullo il medesimo salario che essi attempati tiravano.
Fermandosi poi quelle fabriche l'anno 1527 per la peste e per altre ragioni, Agnolo non sapendo che altro farsi, se n'andò a Poggibonzi, là onde avevano avuto origine i suoi, padre et avolo, e quivi con Messer Giovanni Norchiati suo zio, persona religiosa e di buone lettere, si trattenne un pezzo, non facendo altro che disegnare e studiare. Ma venutagli poi volontà, veggendo il mondo sotto sopra, d'essere religioso e d'attendere alla quiete e salute dell'anima sua, se n'andò a l'eremo di Camaldoli, dove provando quella vita e non patendo que' disagi e digiuni et astinenze di vita, non si fermò altrimenti. Ma tuttavia nel tempo che vi dimorò, fu molto grato a que' padri perché era di buona condizione, et in detto tempo il suo trattenimento fu intagliare in capo d'alcune mazze, o vero bastoni, che que' santi padri portano quando vanno da Camaldoli all'ermo, o altrimenti a diporto per la selva quando si dispensa il silenzio, teste d'uomini e di diversi animali, con belle e capricciose fantasie. Partito dall'eremo con licenzia e buona grazia del maggiore et andatosene alla Vernia, come quelli che ad ogni modo era tirato a essere religioso, vi stette un pezzo, seguitando il coro e conversando con que' padri. Ma né anco quella vita piacendogli, dopo avere avuto informazioni del vivere di molte religioni in Fiorenza et in Arezzo, dove andò partendosi dalla Vernia, et in niun'altra potendosi accomodare in modo, che gli fusse comodo attendere al disegno et alla salute dell'anima, si fece finalmente frate negl'Ingesuati di Firenze, fuor della porta Pinti, e fu da loro molto volentieri ricevuto con speranza, attendendo essi alle finestre di vetro, che egli dovesse in ciò essere loro di molto aiuto e comodo. Ma non dicendo que' padri messa secondo l'uso del vivere e Regola loro, e tenendo per ciò un prete che la dica ogni mattina, avevano allora per capellano un fra' Martino dell'Ordine de' Servi, persona d'assai buon giudizio e costumi. Costui dunque, avendo conosciuto l'ingegno del giovane e considerato che poco poteva esercitarlo fra que' padri che non fanno altro che dire paternostri, fare finestre di vetro, stillare acqua, acconciare orti et altri somiglianti esercizii, e non istudiano, né attendono alle lettere, seppe tanto fare e dire, che il giovane, uscito de-gl'Ingesuati, si vestì ne' frati de' Servi della Nunziata di Firenze a' dì sette d'ottobre l'anno 1530 e fu chiamato fra' Gio-vann'Agnolo. L'anno poi 1531, avendo in quel mentre apparato le cerimonie et ufficii di quell'Ordine e studiato l'opere d'Andrea del Sarto che sono in quel luogo, fece, come dicono essi, professione; e l'anno seguente, con piena sodisfazione di quei padri e contentezza de' suoi parenti, cantò la sua prima messa, con molta pompa et onore. Dopo essendo state da giovani più tosto pazzi che valorosi nella cacciata de' Medici guaste l'imagini di cera di Leone, Clemente e d'altri di quella famiglia nobilissima, che vi erano posti per voto, deliberando i frati che si rifacessero, fra' Giovann'Agnolo con l'aiuto d'alcuni di loro, che attendevano a sì fatte opere d'imagini, rinovò alcune che v'erano vecchie e consumate dal tempo e di nuovo fece il papa Leone e Clemente, che ancor vi si veggiono; e poco dopo il re di Bossina et il signor Vecchio di Piombino; nelle quali opere acquistò fra' Giovann'Agnolo assai.
Intanto essendo Michelagnolo a Roma appresso papa Clemente, il qual voleva che l'opera di San Lorenzo si seguitasse e perciò l'avea fatto chiamare, gli chiese Sua Santità un giovane che restaurasse alcune statue antiche di Belvedere, che erano rotte. Per che ricordatosi il Buonarroto di fra' Giovann'Agnolo, lo propose al Papa e Sua Santità per un suo breve lo chiese al generale dell'Ordine de' Servi, che gliel concedette, per non poter far altro e mal volentieri. Giunto dunque il frate a Roma, nelle stanze di Belvedere, che dal Papa gli furono date per suo abitare e lavorare, rifece il braccio sinistro che mancava all'Apollo et il destro del Laoconte che sono in quel luogo, e diede ordine di racconciare l'Ercole similmente. E perché il Papa quasi ogni mattina andava in Belvedere per suo spasso e dicendo l'ufficio, il frate il ritrasse di marmo tanto bene, che gli fu l'opera molto lodata e gli pose il Papa grandissima affezione, e massimamente veggendolo studiosissimo nelle cose dell'arte e che tutta la notte disegnava per avere ogni mattina nuove cose da mostrare al Papa, che molto se ne dilettava. In questo mentre essendo vacato un canonicato di San Lorenzo di Fiorenza, chiesa stata edificata e dotata dalla casa de' Medici, fra' Giovann'Agnolo, che già avea posto giù l'abito di frate, l'otten-ne per Messer Giovanni Norchiati suo zio, che era in detta chiesa cappellano.
Finalmente avendo deliberato Clemente che il Buonarroto tornasse a Firenze a finire l'opere della sagrestia e libreria di San Lorenzo, gli diede ordine, perché vi mancavano molte statue, come si dirà nella vita di esso Michelagnolo, che si servisse dei più valentuomini che si potessero avere, e particolarmente del frate, tenendo il medesimo modo che aveva tenuto il San Gallo per finire l'opere della Madonna di Loreto. Condottosi dunque Michelagnolo et il frate a Firenze, Michelagnolo nel condurre le statue del duca Lorenzo e Giuliano si servì molto del frate nel rinettarle e fare certe difficultà di lavori traforati in sotto squadra, con la quale occasione imparò molte cose il frate da quello uomo veramente divino, standolo con attenzione a vedere lavorare et osservando ogni minima cosa. Ora perché fra l'altre statue, che mancavano al finimento di quell'opera, mancavano un San Cosimo e Damiano che dovevano mettere in mezzo la Nostra Donna, diede a fare Michelagnolo a Raffaello Monte Lupo il San Damiano et al frate San Cosimo, ordinandogli che lavorasse nelle medesime stanze dove egli stesso avea lavorato e lavorava. Messovi dunque il frate con grandissimo studio intorno all'opera, fece un modello grande di quella figura che fu ritocco dal Buonarroto in molte parti, anzi fece di sua mano Michelagnolo la testa e le braccia di terra, che sono oggi in Arezzo tenute dal Vasari, fra le sue più care cose, per memoria di tanto uomo. Ma non mancarono molti invidiosi che biasimarono in ciò Michelagnolo, dicendo che in allogare quella statua avea avuto poco iudizio e fatto mala elezzione, ma gl'effetti mostrarono poi, come si dirà, che Michelagnolo avea avuto ottimo giudicio e che il frate era valentuomo. Avendo Michelagnolo finiti con l'aiuto del frate e posti su le statue del duca Lorenzo e Giuliano, essendo chiamato dal Papa, che volea si desse ordine di fare di marmo la facciata di San Lorenzo, andò a Roma; ma non vi ebbe fatto molta dimora che, morto papa Clemente, si rimase ogni cosa imperfetta; onde scopertasi a Firenze con l'altre opere la statua del frate, così imperfetta come era, ella fu sommamente lodata, e nel vero, o fusse lo studio e diligenza di lui, o l'aiuto di Michelagnolo, ella riuscì poi ottima figura e la migliore che mai facesse il frate di quante ne lavorò in vita sua; onde fu veramente degna di essere, dove fu, collocata.
Rimaso libero il Buonarroto per la morte del Papa dall'obligo di San Lorenzo, voltò l'animo a uscir di quello che aveva per la sepoltura di papa Giulio Secondo, ma perché aveva in ciò bisogno d'aiuto, mandò per lo frate, il quale non andò a Roma altrimenti prima che avesse finita del tutto l'imagine del duca Alessandro nella Nunziata, la quale condusse fuor dell'uso dell'altre e bellissima, in quel modo che esso signore si vede armato e ginocchioni sopra un elmo alla borgognona e con una mano al petto in atto di raccomandarsi a quella Madonna. Fornita adunque questa imagine et andato a Roma, fu di grande aiuto a Michelagnolo nell'opera della già detta sepoltura di Giulio Secondo. In tanto intendendo il cardinale Ipolito de' Medici che il cardinale Turnone aveva da menare in Francia per servizio del Re uno scultore, gli mise innanzi fra' Giovann'Agnolo, il quale essendo a ciò molto persuaso con buone ragioni da Michelagnolo, se n'andò col detto cardinale Turnone a Parigi; dove giunti fu introdotto al Re, che il vide molto volentieri e gl'assegnò poco appresso una buona provisione, con ordine che facesse quattro statue grandi, delle quali non aveva anco il frate finiti i modelli, quando essendo il Re lontano et occupato in alcune guerre ne' confini del regno con gl'inglesi, cominciò a essere bistrattato dai tesorieri et a non tirare le sue provisioni, né avere cosa che volesse secondo che dal Re era stato ordinato. Per che sdegnatosi e parendogli che quanto stimava quel magnanimo Re le virtù e gli uomini virtuosi, altretanto fussero dai ministri disprezzate e vilipese, si partì, non ostante che dai tesorieri, i quali pur s'avidero del suo mal animo, gli fussero le sue decorse provisioni pagate infino a un quattrino. Ma è ben vero che prima che si movesse, per sue lettere fece asapere così al Re come al cardinale volersi partire. Da Parigi dunque andato a Lione, e di lì per la Provenza a Genova, non vi fé molta stanza ché in compagnia d'alcuni amici andò a Vinezia, Padova, Verona e Mantoa, veggendo con molto suo piacere, e talora disegnando, fabriche, sculture e pitture, ma sopra tutte molto gli piacquero in Mantoa le pitture di Giulio Romano, alcuna delle quali disegnò con diligenza. Avendo poi inteso in Ferrara et in Bologna che i suoi frati de' Servi facevano capitolo generale a Budrione, vi andò per visitare molti amici suoi e particolarmente maestro Zacheria fiorentino, suo amicissimo, ai preghi del quale fece in un dì et una notte due figure di terra grandi quanto il naturale, cioè la Fede e la Carità, le quali finte di marmo bianco, servirono per una fonte posticcia, da lui fatta con un gran vaso di rame, che durò a gettar acqua tutto il giorno che fu fatto il generale, con molta sua lode et onore. Da Budrione tornatosene con detto maestro Zacheria a Firenze nel suo convento de' Servi, fece similmente di terra, e le pose in due nicchie del capitolo, due figure maggiori del naturale, cioè Moisè e San Paulo, che gli furono molto lodate. Essendo poi mandato in Arezzo da maestro Dionisio, allora generale de' Servi, il quale fu poi fatto cardinale da papa Paulo III et il quale si sentiva molto obligato al generale Angelo d'Arezzo che l'avea allevato et insegnatogli le buone lettere, fece fra' Giovann'Agnolo al detto generale aretino una bella sepoltura di macigno in S. Piero di quella città, con molti intagli et alcune statue, e di naturale sopra una cassa il detto generale Angelo e due putti nudi di tondo rilievo, che piagnendo spengono le faci della vita umana, con altri ornamenti che rendono molto bella quest'ope-ra; la quale non era anco finita del tutto quando, essendo chiamato a Firenze dai proveditori sopra l'apparato che allora faceva fare il duca Alessandro, per la venuta in quella città di Carlo V imperadore che tornava vittorioso da Tunis, fu forzato partirsi. Giunto dunque a Firenze, fece al ponte a Santa Trinita sopra una basa grande una figura d'otto braccia che rappresentava il fiume Arno a giacere, il quale in atto mostrava di rallegrarsi col Reno, Danubio, Biagrada et Ibero fatti da altri, della venuta di sua maestà, il quale Arno dico fu una molto bella e buona figura. In sul canto de' Carnesecchi fece il medesimo in una figura di dodici braccia Iason duca degl'Argonauti, ma questa per esser di smisurata grandezza et il tempo corto, non riuscì della perfezzione che la prima; come né anco una Ilarità augusta che fece al canto alla Cuculia. Ma considerata la brevità del tempo nel quale egli condusse quest'opere, elle gl'acquistarono grand'onore e nome così appresso gl'artefici come l'universale. Finita poi l'opera d'Arezzo, intendendo che Girolamo Genga avea da fare un'opera di marmo in Urbino, l'andò il frate a trovare, ma non si essendo venuto a conchiudere niuna, prese la volta di Roma, e quivi badato poco, se n'andò a Napoli con speranza d'avere a fare la sepoltura di Iacopo Sanazaro gentiluomo napoletano e poeta veramente singolare e rarissimo.
Avendo edificato il Sanazaro a Margoglino, luogo di bellissima vista et amenissimo nel fine di Chiaia sopra la marina, una magnifica e molto commoda abitazione, la quale si godé mentre visse, lasciò venendo a morte quel luogo, che ha forma di convento, et una bella chiesetta all'Ordine de' frati de' Servi, ordinando al signor Cesare Mormerio et al signor conte di Lif, esecutori del suo testamento, che nella detta chiesa da lui edificata, e la quale doveva essere ufficiata dai detti padri, gli facessero la sua sepoltura. Ragionandosi dunque di farla, fu proposto dai frati ai detti essecutori fra' Giovann'Agnolo, al quale, andato egli come s'è detto a Napoli, finalmente fu la detta sepoltura allogata, essendo stati giudicati i suoi modelli assai migliori di molti altri che n'erano stati fatti da diversi scultori, per mille scudi. De' quali avendo avuto buona partita, mandò a cavare i marmi Francesco del Tadda da Fiesole, intagliatore eccellente, al quale aveva dato a fare tutti i lavori di quadro e d'intaglio che avevano a farsi in quell'opera per condurla più presto.
Mentre che il frate si metteva a ordine per fare la detta sepoltura, essendo in Puglia venuta l'armata turchesca e perciò standosi in Napoli con non poco timore, fu dato ordine di fortificare la città e fatti sopra ciò quattro grand'uomini e di migliore giudizio; i quali per servirsi d'architettori intendenti, andarono pensando al frate, il quale avendo di ciò alcuno sentore avuto e non parendogli che ad uomo religioso come egli era istesse bene adoperarsi in cose di guerra, fece intendere a detti essecutori che farebbe quell'opera o in Carrara, o in Fiorenza, e ch'ella sarebbe al promesso tempo condotta e murata al luogo suo. Così dunque condottosi da Napoli a Fiorenza, gli fu subito fatto intendere dalla signora donna Maria, madre del duca Cosimo, che egli finisse il S. Cosimo, che già aveva cominciato con ordine del Buonarroto, per la sepoltura del Magnifico Lorenzo Vecchio. Onde rimessovi mano, lo finì; e ciò fatto, avendo il Duca fatto fare gran parte de' condotti per la fontana grande di Castello sua villa et avendo quella ad avere per finimento un Ercole in cima che facesse scoppiare Anteo, a cui uscisse in cambio del fiato acqua di bocca che andasse in alto, fu fattone fare al frate un modello assai grandetto, il quale piacendo a sua eccellenza, fu comessogli che lo facesse et andasse a Carrara a cavare il marmo; la dove andò il frate molto volentieri per tirare innanzi con quella occasione la detta sepoltura del Sanazzaro e particolarmente una storia di figure di mezzo rilievo. Standosi dunque il frate a Carrara, il cardinale Doria scrisse di Genova al cardinal Cibo, che si trovava a Carrara, che non avendo mai finita il Bandinello la statua del principe Doria e non avendola a finire altrimenti, che procacciasse di fargli avere qualche valentuomo scultore che la faces-se, perciò che avea cura di sollecitare quell'opera. La quale lettera avendo ricevuta Cibo, che molto innanzi avea cognizione del frate, fece ogni opera di mandarlo a Genova, ma egli disse sempre non potere e non volere in niun modo ser-vire sua signoria reverendissima, se prima non sodisfaceva all'obligo e promessa che aveva col duca Cosimo. Avendo mentre che queste cose si trattavano tirata molto innanzi la sepoltura del Sanazzaro et abbozzato il marmo dell'Ercole, se ne venne con esso a Firenze, dove con molta prestezza e studio lo condusse a tal termine, che poco arebbe penato a fornirlo del tutto, se avesse seguitato di lavorarvi; ma essendo uscita una voce che il marmo a gran pezza non riusciva opera perfetta come il modello e che il frate era per averne difficultà a rimettere insieme le gambe dell'Ercole che non riscontravano col torso, Messer Pierfrancesco Riccio maiordomo, che pagava la provisione al frate, cominciò, lasciandosi troppo più volgere di quello che doverebbe un uomo grave, ad andare molto ratenuto a pagargliela, credendo troppo al Bandinello che con ogni sforzo pontava contro a colui, per vendicarsi dell'ingiuria che parea che gl'avesse fatto di aver promesso voler fare la statua del Doria, disobligato che fusse dal Duca. Fu anco openione che il favore del Tribolo, il quale faceva gl'ornamenti di Castello, non fusse d'alcun giovamento al frate, il quale, comunche si fusse, vedendosi essere bistrattato dal Riccio, come collerico e sdegnoso, se n'andò a Genova, dove dal cardinale Doria e dal principe gli fu allogata la statua di esso principe che dovea porsi in sulla piazza Doria; alla quale avendo messo mano senza però intralasciare del tutto l'opera del Sanazzaro, mentre il Tadda lavorava a Carrara il resto degl'intagli e del quadro, la finì con molta sodisfazione del principe e de' genovesi. E se bene la detta statua era stata fatta per dovere essere posta in sulla piazza Doria, fecero nondimeno tanto i genovesi, che a dispetto del frate ella fu posta in sulla piazza della Signoria, non ostante che esso frate dicesse che avendola lavorata perché stesse isolata sopra un basamento, ella non poteva star bene, né avere la sua veduta a canto a un muro. E per dire il vero non si può far peggio che mettere un'opera fatta per un luogo in un altro; essendo che l'artefice nell'operare si va quanto ai lumi e le vedute accomodando al luogo dove dee essere la sua o scultura o pittura collocata. Dopo ciò vedendo i genovesi e piacendo molto loro le storie et altre figure fatte per la sepoltura del Sanazzaro, vollono che il frate facesse per la loro chiesa catedrale un San Giovanni Evangelista, che finito, piacque loro tanto, che ne restarono stupefatti.
Da Genova partito finalmente fra' Giovann'Agnolo andò a Napoli dove nel luogo già detto mise su la sepoltura detta del Sanazzaro, la quale è così fatta: in sui canti da basso sono due piedistalli, in ciascuno de' quali è intagliata l'arme di esso Sanazzaro, e nel mezzo di questi è una lapide di braccia uno e mezzo, nella quale è intagliato l'epitaffio che Iacopo stesso si fece, sostenuto da due puttini; di poi sopra ciascuno dei piedistalli è una statua di marmo tonda a sedere, alta quattro braccia, cioè Minerva et Apollo, et in mezzo a queste fra l'ornamento di due mensole, che sono dai lati, è una storia di braccia due e mezzo per ogni verso, dentro la quale sono intagliati di basso rilievo fauni, satiri, ninfe et altre figure, che suonano e cantano nella maniera che ha scritto nella sua dottissima Arcadia di versi pastorali quell'uomo eccellentissimo. Sopra questa storia è posta una cassa tonda di bellissimo garbo e tutta intagliata et adorna molto, nella quale sono l'ossa di quel poeta, e sopra essa in sul mezzo è in una basa la testa di lui ritratta dal vivo con queste parole a piè: “Actius Sincerus”, accompagnata da due putti con l'ale a uso d'amori, che intorno hanno alcuni libri. In due nicchie poi, che sono dalle bande nell'altre due facce della cappella, sono sopra due base due figure tonde di marmo ritte e di tre braccia l'una o poco più: cioè San Iacopo apostolo e San Nazzaro. Murata dunque nella guisa che s'è detta quest'opera, ne rimasero sodisfattissimi i detti signori esecutori e tutto Napoli. Dopo ricordandosi il frate d'avere promesso al principe Doria di tornare a Genova, per fargli in San Matteo la sua sepoltura et ornare tutta quella chiesa, si partì subito da Napoli et andossene a Genova, dove arrivato e fatti i modelli dell'opera che dovea fare a quel signore, i quali gli piacquero infinitamente, vi mise mano con buona provisione di danari e buon numero di maestri. E così dimorando il frate in Genova fece molte amicizie di signori et uomini virtuosi e particolarmente con alcuni medici, che gli furono di molto aiuto, perciò che giovandosi l'un l'altro e facendo molte notomie di corpi umani et attendendo all'architettura e prospettiva, si fece fra' Giovann'Agnolo eccellentissimo. Oltre ciò, andando spesse volte il principe dove egli lavorava e piacendogli i suoi ragionamenti, gli pose grandissima affezione. Similmente in detto tempo di due suoi nipoti che aveva lasciati in custodia a maestro Zacheria gliene fu mandato uno chiamato Angelo, giovane di bell'ingegno e costumato, e poco appresso dal medesimo un altro giovanetto chiamato Martino, figliuolo d'un Bartolomeo sarto, de' quali ambi due giovani insegnando loro, come gli fussero figliuoli, si servì il frate in quell'opera che avea fra mano. Della quale ultimamente venuto a fine, messe su la cappella, sepoltura e gl'altri ornamenti fatti per quella chiesa; la quale facendo a sommo la prima navata del mezzo una croce e giù per lo manico tre, ha l'altar maggiore nel mezzo et in testa isolato. La cappella dunque è retta ne' cantoni da quattro gran pilastri, i quali sostengono parimente il cornicione che gira intorno e sopra cui girano in mezzo tondo quattro archi, che posano alla dirittura de' pilastri; de' quali archi tre ne sono nel vano di mezzo, ornati di finestre non molto grandi, e sopra questi archi gira una cornice tonda, che fa quattro angoli fra arco et arco ne' canti, e di sopra fa una tribuna a uso di catino. Avendo dunque il frate fatto molti ornamenti di marmo, dintorno all'altare da tutte quattro le bande, sopra quello pose un bellissimo e molto ricco vaso di marmo per lo Santissimo Sacramento, in mezzo a due Angeli pur di marmo, grandi quanto il naturale; intorno poi gira un partimento di pietre commesse nel marmo con bello e variato andare di mischi e pietre rare, come sono serpentini, porfidi e diaspri. E nella testa e faccia principale della cappella, fece un altro partimento dal piano del pavimento insino all'altezza di simili mischi e marmi, il quale fa basamento a quattro pilastri di marmo che fanno tre vani, in quello del mezzo, che è maggior degl'altri, è in una sepoltura il corpo di non so che Santo, et in quelli dalle bande sono due statue di marmo fatte per due Evangelisti. Sopra questo ordine è una cornice, e sopra la cornice altri quattro pilastri minori che reggono un'altra cornice, che fa spartimento per tre quadretti che ubbidiscono ai vani di sotto; in quel di mezzo, che posa in sulla maggior cornice, è un Cristo di marmo che risuscita, di tutto rilievo e maggiore del naturale. Nelle facce dalle bande ribatte il medesimo ordine, e sopra la detta sepoltura nel vano di mezzo è una Nostra Donna di mezzo rilievo con Cristo morto, la quale Madonna mettono in mezzo Davit re e San Giovanni Battista, e nell'altra è Santo Andrea e Geremia profeta. I mezzi tondi degl'archi sopra la maggior cornice, dove sono due finestre, sono di stucchi con putti intorno, che mostrano ornare la finestra. Negl'angoli sotto la tribuna sono quattro sibille similmente di stucco, sì come è anco lavorata tutta la volta a grottesche di varie maniere; sotto questa cappella è fabricata una stanza sotterranea, la quale, scendendo per scale di marmo, si vede in testa una cassa di marmo con due putti sopra, nella quale doveva essere posto, come credo sia stato fatto dopo la sua morte, il corpo di esso signore Andrea Doria. E dirimpetto alla cassa, sopra un altare, dentro a un bellissimo vaso di bronzo, che fu fatto e rinetto, da chi si fusse che lo gettasse, divinamente, è alquanto del legno della Santissima Croce sopra cui fu crucifisso Gesù Cristo benedetto, il qual legno fu donato a esso principe Doria dal duca di Savoia. Sono le pariete di detta tomba tutte incrostate di marmo e la volta lavorata di stucchi e d'oro con molte storie de' fatti egregii del Doria, et il pavimento è tutto spartito di varie pietre mischie a corrispondenza della volta; sono poi nelle facciate della crociera della navata, da sommo, due sepolture di marmo con due tavole di mezzo rilievo; in una è sepolto il conte Filippino Doria e nell'altra il signor Giannettino della medesima famiglia. Ne' pilastri dove comincia la navata del mezzo, sono due bellissimi pergami di marmo; e dalle bande delle navate minori sono spartite nelle facciate con bell'ordine d'architettura alcune cappelle con colonne et altri molti ornamenti, che fanno quella chiesa essere un'o-pera veramente magnifica e ricchissima.
Finita la detta chiesa, il medesimo principe Doria fece mettere mano al suo palazzo e fargli nuove aggiunte di fabriche e giardini bellissimi, che furono fatti con ordine del frate, il quale avendo in ultimo fatto, dalla parte dinanzi di detto palazzo, un vivaio, fece di marmo un mostro marino, di tondo rilievo, che versa in gran copia acqua nella detta peschiera; simile al quale mostro ne fece un altro a que' signori, che fu mandato in Ispagna al Granvela. Fece un gran Nettunno di stucco, che sopra un piedistallo fu posto nel giardino del Principe; fece di marmo due ritratti del medesimo Principe e due di Carlo Quinto, che furono portati da Coves in Ispagna. Furono molto amici del frate, mentre stette in Genova, Messer Cipriano Palavigino, il quale per essere di molto giudizio nelle cose delle nostre arti ha praticato sempre volentieri con gl'artefici più eccellenti e quelli in ogni cosa favoriti, il signore abbate Negro, Messer Giovanni da Monte Pulvano et il signor Priore di San Matteo, et insomma tutti i primi gentiluomini e signori di quella città, nella quale acquistò il frate fama e ricchezza.
Finite dunque le sopra dette opere, si partì fra' Giovann'Agnolo di Genova e se n'andò a Roma per rivedere il Buonarroto, che già molti anni non aveva veduto, e vedere se per qualche mezzo avesse potuto rapiccare il filo col duca di Fiorenza e tornare a fornire l'Ercole che aveva lasciato imperfetto. Ma arrivato a Roma, dove si comperò un cavalierato di San Piero, inteso per lettere avute da Fiorenza che il Bandinello, mostrando aver bisogno di marmo e facendo a credere che il detto Ercole era un marmo storpiato, l'aveva spezzato con licenzia del maiorduomo Riccio e servitosene a far cornici per la sepoltura del signor Giovanni, la quale egli allora lavorava, se ne prese tanto sdegno, che per allora non volle altrimenti tornare a rivedere Fiorenza, parendogli che troppo fusse sopportata la prosonzione, arroganza et insolenza di quell'uomo. Mentre che il frate si andava trattenendo in Roma avendo i messinesi deliberato di fare sopra la piazza del lor Duomo una fonte con un ornamento grandissimo di statue, avevano mandati uomini a Roma a cercare d'avere uno eccellente scultore; i quali uomini, se bene avevano fermo Raffaello da Monte Lupo, perché s'infermò quando apunto volea partire con esso loro per Messina, fecero altra resoluzione e condussero il frate, che con ogni instanza e qualche mezzo cercò d'avere quel lavoro. Avendo dunque posto in Roma al legnaiuolo Angelo suo nipote che gli riuscì di più grosso ingegno che non aveva pensato, con Martino si partì il frate e giunsono in Messina del mese di settembre 1547, dove, accomodati di stanze e messo mano a fare il condotto dell'acque che vengono di lontano et a fare venire marmi da Carrara, condusse con l'aiuto di molti scarpellini et intagliatori con molta prestezza quella fonte, che è così fatta: ha, dico, questa fonte otto facce, cioè quattro grandi e principali e quattro minori, due delle quali maggiori venendo in fuori fanno in sul mezzo un angolo, e due, andando in dentro, s'accompagnano con un'altra faccia piana che fa l'altra parte dell'altre quattro facce, che in tutto sono otto. Le quattro facce angolari, che vengono in fuori facendo risalto, danno luogo alle quattro piane, che vanno in dentro; e nel vano è un pilo assai grande, che riceve acque in gran copia da quattro fiumi di marmo che accompagnano il corpo del vaso di tutta la fonte intorno alle dette otto facce; la qual fonte posa sopra un ordine di quattro scalee che fanno dodici facce: otto maggiori che fanno la forma dell'angolo, e quattro minori dove sono i pili. E sotto i quattro fiumi sono le sponde alte palmi cinque, et in ciascun angolo (che tutti fanno venti facce) fa ornamento un termine; la circonferenza del primo vaso dall'otto facce è centodue palmi et il diametro è trentaquattro, et in ciascuna delle dette venti facce è intagliata una storietta di marmo in basso rilievo, con poesie di cose convenienti a fonti et acque, come dire il cavallo Pegaso che fa il fonte Castalio, Europa che passa il mare, Icaro che volando cade nel medesimo, Aretusa conversa in fonte, Iason che passa il mare col montone d'oro, Narciso converso in fonte, Diana nel fonte che converte Ateon in cervio, con altre simili. Negl'otto angoli che dividono i risalti delle scale della fonte che saglie due gradi andando ai pili et ai fiumi e quattro alle sponde angolari sono otto mostri marini in diverse forme a giacere sopra certi dadi, con le zampe dinanzi che posano sopra alcune maschere, le quali gettano acqua in certi vasi. I fiumi che sono in sulla sponda et i quali posano di dentro sopra un dado tanto alto, che pare che seggano nell'acqua, sono il Nilo con sette putti, il Tevere circondato da una infinità di palme e trofei, l'Ibero con molte vittorie di Carlo Quinto et il fiume Cumano vicino a Messina, dal quale si prendono l'acque di questa fonte, con alcune storie e ninfe fatte con belle considerazioni. Et insino a questo piano di dieci palmi sono sedici getti d'acqua grossissimi: otto ne fanno le maschere dette, quattro i fiumi e quattro alcuni pesci alti sette palmi, i quali stando nel vaso ritti e con la testa fuora gettano acqua dalla parte della maggior faccia. Nel mezzo dell'otto facce, sopra un dado alto quattro palmi, sono sopra ogni canto una serena con l'ale e senza braccia, e sopra queste, le quali si annodano nel mezzo, sono quattro tritoni alti otto palmi, i quali anch'essi con le code annodate e con le braccia reggono una gran tazza, nella quale gettano acqua quattro maschere intagliate superbamente; di mezzo alla quale tazza surgendo un piede tondo sostiene due maschere bruttissime, fatte per Scilla e Cariddi, le quali sono conculcate da tre ninfe ignude grandi sei palmi l'una, sopra le quali è posta l'ultima tazza, che da loro è con le braccia sostenuta. Nella quale tazza, facendo basamento quattro delfini col capo basso e con le code alte, reggono una palla, di mezzo alla quale per quattro teste esce acqua che va in alto e così dai delfini sopra i quali sono a cavallo quattro putti nudi. Finalmente nell'ultima cima è una figura armata rappresentante Orione, stella celeste, che ha nello scudo l'arme della città di Messina, della quale si dice,
o più tosto si favoleggia essere stata edificatrice.
Così fatta dunque è la detta fonte di Messina, ancor che non si possa così ben con le parole come si farebbe col disegno dimostrarla. E perché ella piacque molto a' messinesi, gliene feciono fare un'altra in sulla marina dove è la dogana, la quale riuscì anch'essa bella e ricchissima; et ancor che quella similmente sia a otto facce, è nondimeno diversa dalla sopra detta, perciò che questa ha quattro facce di scale che sagliono tre gradi, e quattro altre minori mezze tonde, sopra le quali dico è la fonte in otto facce; e le sponde della fontana grande di sotto hanno al pari di loro in ogni angolo un piedistallo intagliato, e nelle facce della parte dinanzi un altro in mezzo a quattro di esse. Dalle parte poi dove sono le scale tonde è un pilo di marmo aovato, nel quale per due maschere, che sono nel parapetto sotto le sponde intagliate, si getta acqua in molta copia; e nel mezzo del bagno di questa fontana è un basamento alto a proporzione, sopra il quale è l'arme di Carlo Quinto et in ciascun angolo di detto basamento è un cavallo marino che fra le zampe schizza acqua in alto. E nel fregio del medesimo, sotto la cornice di sopra, sono otto mascheroni che gettano all'ingiù otto polle d'acqua, et in cima è un Nettunno di braccia cinque il quale avendo il tridente in mano posa la gamba ritta a canto a un delfino; sono poi dalle bande sopra due altri basamenti Scilla e Cariddi in forma di due mostri, molto ben fatti, con teste di cane e di furie intorno. La quale opera finita similmente piacque molto a' messinesi i quali avendo trovato un uomo secondo il gusto loro diedero, finite le fonti, principio alla facciata del Duomo, tirandola alquanto inanzi, e dopo ordinarono di far dentro dodici cappelle d'opera corinzia, cioè sei per banda con i dodici Apostoli di marmo di braccia cinque l'uno, delle quali tutte ne furono solamente finite quattro dal frate, che vi fece di sua mano un San Pietro et un San Paulo, che furono due grandi e molto buone figure. Doveva anco fare in testa della cappella maggiore un Cristo di marmo, con ricchissimo ornamento intorno, e sotto ciascuna delle statue degl'Apostoli una storia di basso rilievo, ma per allora non fece altro.
In sulla piazza del medesimo Duomo ordinò con bella architettura il tempio di San Lorenzo, che gli fu molto lodato. In sulla marina fu fatta di suo ordine la torre del fanale, e mentre che queste cose si tiravano innanzi, fece condurre in San Domenico per il capitan Cicala una cappella, nella quale fece di marmo una Nostra Donna grande quanto il naturale, e nel chiostro della medesima chiesa, alla cappella del signor Agnolo Borsa, fece in marmo di basso rilievo una storia, che fu tenuta bella e condotta con molta diligenza; fece anco condurre, per lo muro di Santo Agnolo, acqua per una fontana e vi fece di sua mano un putto di marmo grande che versa in un vaso molto adorno e benissimo accomodato, che fu tenuta bell'opera, et al muro della Vergine fece un'altra fontana, con una Vergine di sua mano che versa acqua in un pilo; e per quella che è posta al palazzo del signor don Filippo Laroca, fece un putto maggiore del naturale d'una certa pietra che s'usa in Messina, il qual putto, che è in mezzo a certi mostri et altre cose marittime, getta acqua in un vaso. Fece di marmo una statua di quattro braccia, cioè una Santa Caterina martire molto bella, la quale fu mandata a Tarumezia, luogo lontano da Messina 24 miglia.
Furono amici di fra' Giovann'Agnolo, mentre stette in Messina, il detto signor don Filippo Laroca e don Francesco della medesima famiglia, Messer Bardo Corsi, Giovanfrancesco Scali e Messer Lorenzo Borghini, tutti tre gentiluomini fiorentini allora in Messina, Serafino da Fermo et il signor gran mastro di Rodi che più volte fece opera di tirarlo a Malta e farlo cavalieri, ma egli rispose non volere confinarsi in quell'isola, senza che pur alcuna volta, conoscendo che faceva male a stare senza l'abito della sua Religione, pensava di tornare. E nel vero so io che quando bene non fusse stato in un certo modo forzato, era risoluto ripigliarlo e tornare a vivere da buono religioso. Quando adunque al tempo di papa Paulo Quarto, l'anno 1557 furono tutti gl'apostati o vero sfratati astretti a tornare alle loro Religioni sotto gravissime pene, fra' Giovann'Agnolo lasciò l'opere che avea fra mano et in suo luogo Martino suo creato, e da Messina del mese di maggio, se ne venne a Napoli per tornare alla sua Religione de' Servi in Fiorenza. Ma prima che altro facesse, per darsi a Dio interamente, andò pensando come dovesse i suoi molti guadagni dispensare convenevolmente; e così dopo avere maritate alcune sue nipote fanciulle povere et altre della sua patria e da Montorsoli, ordinò che ad Angelo suo ni-pote, del quale si è già fatto menzione, fussero dati in Roma mille scudi e comperatogli un cavaliere del giglio; a due spedali di Napoli diede per limosina buona somma di danari per ciascuno; al suo convento de' Servi lasciò mille scudi per comperare un podere, e quello di Montorsoli stato de' suoi antecessori: con questo, che a due suoi nipoti frati del medesimo Ordine fussino pagati ogni anno, durante la vita loro, venticinque scudi per ciascuno, e con alcuni altri carichi che di sotto si diranno; le quali cose, come ebbe accomodato, si scoperse in Roma e riprese l'abito con molta sua contentezza e de' suoi frati, e particolarmente di maestro Zaccheria. Dopo venuto a Fiorenza fu ricevuto e veduto da-gl'amici e parenti con incredibile piacere e letizia. Ma ancor che avesse deliberato il frate di volere il rimanente della vita spendere in servigio di Nostro Signore Dio e dell'anima sua e starsi quietamente in pace, godendosi un cavalierato che s'era serbato, non gli venne ciò fatto così presto, perciò che, essendo con istanzia chiamato a Bologna da maestro Giulio Bovio, zio del vascone Bovio, perché facesse nella chiesa de' Servi l'altar maggiore tutto di marmo et isolato, et oltre ciò una sepoltura con figure e ricco ornamento di pietre mischie et incostrature di marmo, non poté mancargli, e massimamente avendosi a fare quell'opera in una chiesa del suo Ordine. Andato dunque a Bologna e messo mano all'o-pera, la condusse in ventotto mesi, facendo il detto altare, il quale da un pilastro all'altro chiude il coro de' frati tutto di marmo dentro e fuori con un Cristo nudo nel mezzo di braccia due e mezzo e con alcun'altre statue dagli lati. È l'archi-tettura di quest'opera bella veramente, e ben partita et ordinata, e commessa tanto bene, che non si può far meglio; il pavimento ancora, dove in terra è la sepoltura del Bovio, è spartito con bell'ordine, e certi candellieri di marmo et alcune storiette e figurine sono assai bene accomodate, et ogni cosa è ricca d'intaglio; ma le figure, oltre che son piccole per la difficultà che si ha di condurre pezzi grandi di marmo a Bologna, non sono pari all'architettura, né molto da essere lodate. Mentre che fra' Giovann'Agnolo lavorava in Bologna quest'opera, come quello che in ciò non era anco ben risoluto, andava pensando in che luogo potesse più comodamente di quelli della sua Religione consumare i suoi ultimi anni, quando maestro Zaccheria suo amicissimo, che allora era priore della Nunziata di Firenze, disiderando di tirarlo e fermarlo in quel luogo, parlò di lui col duca Cosimo, riducendogli a memoria la virtù del frate e pregando che volesse servirsene; a che, avendo risposto il Duca benignamente e che si servirebbe del frate tornato che fusse da Bologna, maestro Zaccaria gli scrisse del tutto, mandatogli appresso una lettera del cardinale Giovanni de' Medici, nella quale il confortava quel signore a tornare a fare nella patria qualche opera segnalata di sua mano. Le quali lettere avendo il frate ricevuto, ricordandosi che Messer Pierfrancesco Ricci, dopo essere vivuto pazzo molti anni era morto, e che similmente il Bandinello era mancato, i quali parea che poco gli fussero stati amici, riscrisse che non mancherebbe di tornare quanto prima potesse a servire sua eccellenza illustrissima, per fare in servigio di quella non cose profane, ma alcun'opera sacra, avendo tutto volto l'animo al servigio di Dio e de' suoi Santi. Finalmente dunque, essendo tornato a Fiorenza l'anno 1561, se n'andò con maestro Zaccheria a Pisa, dove erano il signor Duca et il Cardinale, per fare a loro illustrissime signorie reverenza. Da' quali signori essendo stato benignamente ricevuto e carezzato, e dettogli dal Duca che nel suo ritorno a Fiorenza gli sarebbe dato a fare un'opera d'importanza, se ne tornò. Avendo poi ottenuto col mezzo di maestro Zaccheria licenza dai suoi frati della Nunziata di potere ciò fare, fece nel capitolo di quel convento, dove molti anni innanzi aveva fatto il Moisè e San Paulo di stucchi, come s'è detto di sopra, una molto bella sepoltura in mezzo per sé e per tutti gl'uomini dell'arte del disegno, pittori, scultori et architettori che non avessono proprio luogo dove essere sotterrati, con animo di lasciare come fece per contratto che que' frati, per i beni che lascerebbe loro, fussero obligati dire messa alcuni giorni di festa e feriali in detto capitolo, e che ciascun anno, il giorno della Santissima Trinità, si facesse festa solennissima et il giorno seguente un ufficio di morti per l'anime di coloro che in quel luogo fussero stati sotterrati.
Questo suo disegno adunque, avendo esso fra' Giovann'Agnolo e maestro Zacheria scoperto a Giorgio Vasari, che era loro amicissimo, et insieme avendo discorso sopra le cose della Compagnia del disegno che al tempo di Giotto era stata creata et aveva le sue stanze avute in Santa Maria Nuova di Fiorenza, come ne appare memoria ancor oggi all'altar maggiore dello spedale, dal detto tempo insino a' nostri, pensarono con questa occasione di raviarla e rimetterla su. E perché era la detta Compagnia dall'altar maggiore sopra detto stata traportata (come si dirà nella vita di Iacopo di Casentino) sotto le volte del medesimo spedale in sul canto della via della Pergola, e di lì poi era stata ultimamente levata e tolta loro da don Isidoro Montaguti spedalingo di quel luogo, ella si era quasi del tutto dismessa e più non si ragunava. Avendo, dico, il frate, maestro Zacheria e Giorgio discorso sopra lo stato di detta Compagnia lungamente, poi che il frate ebbe parlato di ciò col Bronzino, Francesco San Gallo, Amannato, Vincenzio de' Rossi, Michel di Ridolfo et altri molti scultori e pittori de' primi, e manifestato loro l'animo suo, venuta la mattina della Santissima Trinità, furono tutti i più nobili et eccellenti artefici dell'arte del disegno in numero di quarantotto ragunati nel detto capitolo, dove si era ordinato una bellissima festa e dove già era finita la detta sepoltura e l'altare tirato tanto innanzi, che non mancavano se non alcune figure che v'andavano di marmo. Quivi, detta una solennissima messa, fu fatta da un di que' padri una bell'o-razione in lode di fra' Giovann'Agnolo e della magnifica liberalità che egli faceva alla Compagnia detta, donando loro quel capitolo, quella sepoltura e quella cappella. Della quale, acciò pigliassero il possesso, conchiuse essersi già ordinato che il corpo del Puntormo, il quale era stato posto in un deposito nel primo chiostretto della Nunziata, fusse primo di tutti messo in detta sepoltura. Finita dunque la messa e l'orazione, andati tutti in chiesa dove in una bara erano l'ossa del detto Puntormo, postolo sopra le spalle de' più giovani, con una falcola per uno et alcune torce, girando intorno la piazza il portarono nel detto capitolo, il quale dove prima era parato di panni d'oro, trovarono tutto nero, e pieno di morti dipinti et altre cose simili. E così fu il detto Puntormo collocato nella nuova sepoltura. Licenziandosi poi la Compagnia, fu ordinata la prima tornata per la prossima domenica, per dar principio, oltre al corpo della Compagnia, a una scelta de' migliori e creato un'accademia, con l'aiuto della quale chi non sapeva imparasse, e chi sapeva, mosso da onorata e lodevole concorrenza, andasse maggiormente acquistando.
Giorgio intanto, avendo di queste cose parlato col Duca e pregatolo a volere così favorire lo studio di queste nobili arti, come avea fatto quello delle lettere, avendo riaperto lo studio di Pisa, creato un collegio di scolari e dato principio all'Accademia fiorentina, lo trovò tanto disposto ad aiutare e favorire questa impresa quanto più non arebbe saputo disiderare. Dopo queste cose avendo i frati de' Servi meglio pensato al fatto, si risolverono, e lo fecero intendere alla Compagnia, di non volere che il detto capitolo servisse loro se non per farvi feste, uffici e seppellire, e che in niun altro modo volevano avere, mediante le loro tornate e ragunarsi, quella servitù nel loro convento. Di che avendo parlato Giorgio col Duca e chiestogli un luogo, sua eccellenza disse avere pensato di accomodarne loro uno, dove non solamente potrebbono edificare una Compagnia, ma avere largo campo di mostrare, lavorando, la virtù loro. E poco dopo scrisse e fece intendere per Messer Lelio Torelli al priore e monaci degl'Angeli che accomodassono la detta Compagnia del tempio stato cominciato nel loro monasterio da Filippo Scolari detto lo Spano. Ubbidirono i frati e la Compagnia fu accomodata d'alcune stanze, nelle quali si ragunò più volte, con buona grazia di que' padri che anco nel loro capitolo proprio gl'accettarono alcune volte molto cortesemente. Ma essendo poi detto al signor Duca che alcuni di detti monaci non e-rano del tutto contenti che là entro si edificasse la Compagnia, perché il monasterio arebbe quella servitù et il detto tempio, il quale dicevano volere con l'opere loro fornire, si starebbe quanto a loro a quel modo, sua eccellenza fece sapere agl'uomini dell'Accademia, che già aveva avuto principio et avea fatta la festa di San Luca nel detto tempio, che poiché i monaci, per quanto intendeva, non molto di buonavoglia gli volevano in casa, che non mancherebbe di proveder loro un altro luogo. Disse oltre ciò il detto signor Duca, come principe veramente magnanimo che è, non solo voler favorire sempre la detta Accademia, ma egli stesso esser capo, guida e protettore e che per ciò crearebbe, anno per anno, un luogotenente che in sua vece intervenisse a tutte le tornate. E così facendo per lo primo elesse il reverendo don Vincenzio Borghini, spedalingo degl'Innocenti, delle quali grazie et amorevolezze mostrate dal signor Duca a questa sua nuova Accademia fu ringraziato da dieci de' più vecchi et eccellenti di quella; ma perché della riforma della Compagnia e degl'ordini dell'Accademia si tratta largamente ne' capitoli che furono fatti dagl'uomini a ciò deputati et eletti da tutto il corpo per riformatori, fra' Giovann'Agnolo, Francesco da San Gallo, Agnolo Bronzino, Giorgio Vasari, Michele di Ridolfo e Pierfrancesco di Iacopo di Sandro, coll'intervento del detto luogotenente e confermazione di sua eccellenza, non ne dirò altro in questo luogo. Dirò bene, che non piacendo a molti il vecchio sugello et arme o vero insegna della Compagnia, il quale era un bue con l'ali a giacere, animale dell'Evangelista San Luca, e che ordinatosi perciò che ciascuno dicesse o mostrasse con un disegno il parer suo, si videro i più bei capricci e le più stravaganti e belle fantasie che si possano imaginare. Ma non perciò è anco risoluto interamente quale debba essere accettato.
Martino intanto, discepolo del frate, essendo da Messina venuto a Fiorenza, in pochi giorni morendosi, fu sotterrato nella sepoltura detta, stata fatta dal suo maestro, e non molto poi, nel 1564, fu nella medesima con onoratissime essequie sotterrato esso padre fra' Giovann'Agnolo, stato scultore eccellente e dal molto reverendo e dottissimo maestro Michelagnolo publicamente nel tempio della Nunziata lodato con una molto bella orazione. E nel vero hanno le nostre arti, per molte cagioni, grand'obligo con fra' Giovann'Agnolo, per avere loro portato infinito amore et agl'artefici di quella parimente. E di quanto giovamento sia stata e sia l'Accademia, che quasi da lui, nel modo che si è detto, ha avuto principio, e la quale è oggi in protezione del signor duca Cosimo e di suo ordine si raguna in San Lorenzo nella sagrestia nuova, dove sono tant'opere di scultura di Michelagnolo, si può da questo conoscere che non pure nell'essequie di esso Buonarroto, che furono, per opera de' nostri artefici e con l'aiuto del Principe, non dico magnifiche, ma poco meno che reali, delle quali si ragionerà nella vita sua, ma in molte altre cose, hanno per la concorrenza i medesimi, e per non essere indegni accademici, cose maravigliose operato. Ma particolarmente nelle nozze dell'illustrissimo signor principe di Fiorenza e di Siena, il signor don Francesco Medici, e della serenissima reina Giovanna d'Austria, come da altri interamente è stato con ordine raccontato e da noi sarà a luogo più comodo largamente replicato.
E perciò che non solo in questo buon padre, ma in altri ancora de' quali si è ragionato disopra, si è veduto e vede continuamente che i buoni religiosi (non meno che nelle lettere, nei publici studii e nei sacri concilii) sono di giovamento al mondo e d'utile nell'arti e negl'esercizii più nobili e che non hanno a vergognarsi in ciò dagl'altri, si può dire non essere per aventura del tutto vero quello che alcuni, più da ira e da qualche particolare sdegno che da ragione mossi e da verità, affermarono troppo largamente di loro: cioè che essi a cotal vita si danno, come quegli che per viltà d'animo non hanno argomento, come gl'altri uomini, di civanzarsi; ma Dio gliel perdoni.
Visse fra' Giovann'Agnolo anni 56, e morì all'ultimo d'agosto 1563.
FINE DELLA VITA DI FRA' GIOVANN'AGNOLO MONTORSOLI, SCULTORE
VITA DI FRANCESCO DETTO DE' SALVIATI
PITTORE FIORENTINO

Fu padre di Francesco Salviati, del quale al presente scriviamo la vita et il quale nacque l'anno 1510, un buon uomo chiamato Michelagnolo de' Rossi, tessitore di velluti, il quale, avendo non questo solo, ma molti altri figliuoli maschi e femine, e per ciò bisogno d'essere aiutato, aveva seco medesimo deliberato di volere per ogni modo che Francesco attendesse al suo mestiero di tessere velluti. Ma il giovinetto, che ad altro avea volto l'animo et a cui dispiaceva il mestiero di quell'arte, come che anticamente ella fusse esercitata da persone non dico nobili, ma assai agiate e ricche, malvolentieri in questo seguitava il volere del padre. Anzi praticando nella via de' Servi, dove aveva una sua casa, con i figliuoli di Domenico Naldini suo vicino e cittadino orrevole, si vedea tutto volto a costumi gentili et onorati e molto inclinato al disegno. Nella qual cosa gli fu un pezzo di non piccolo aiuto un suo cugino chiamato il Diaceto, orefice e giovane che aveva assai buon disegno; imperò che non pure gl'insegnava costui quel poco che sapeva; ma l'accomoda-va di molti disegni di diversi valentuomini, sopra i quali giorno e notte nascosamente dal padre, con incredibile studio si esercitava Francesco. Ma essendosi di ciò accorto Domenico Naldini, dopo aver bene esaminato il putto, fece tanto con Michelagnolo suo padre, che lo pose in bottega del zio a imparare l'arte dell'orefice; mediante la quale comodità di disegnare fece in pochi mesi Francesco tanto profitto, che ognuno si stupiva. E perché usava in quel tempo una Compagnia di giovani orefici e pittori trovarsi alcuna volta insieme et andare il dì delle feste a disegnare per Fiorenza l'opere più lodate, niuno di loro più si affaticava né con più amore di quello che faceva Francesco; i giovani della qual Compagnia erano Nanni di Prospero delle Corniuole, Francesco di Girolamo dal Prato orefice, Nannoccio da San Giorgio, e molti altri fanciulli che poi riuscirono valentuomini nelle loro professioni.
In questo tempo, essendo anco ambidue fanciulli, divennero amicissimi Francesco e Giorgio Vasari in questo modo: l'anno 1523 passando per Arezzo Silvio Passerini cardinale di Cortona, come legato di papa Clemente Settimo, Antonio Vasari suo parente menò Giorgio suo figliuol maggiore a fare reverenza al Cardinale, il quale veggendo quel putto, che allora non aveva più di nove anni, per la diligenza di Messer Antonio da Saccone e di Messer Giovanni Polastra eccellente poeta aretino, essere nelle prime lettere di maniera introdotto, che sapeva a mente una gran parte dell'Eneide di Vergilio, che gliela volle sentire recitare, e che da Guglielmo da Marzilla pittor franzese aveva imparato a disegnare, ordinò che Antonio stesso gli conducesse quel putto a Fiorenza; dove postolo in casa di Messer Niccolò Vespucci cavaliere di Rodi, che stava in sulla coscia del Ponte Vecchio, sopra la chiesa del Sepolcro, et acconciolo con Michelagnolo Buonarruoti, venne la cosa a notizia di Francesco, che allora stava nel chiasso di Messer Bivigliano, dove suo padre teneva una gran casa a pigione, che riusciva il dinanzi in Vachereccia, e molti lavoranti. Onde perché ogni simile ama il suo simile, fece tanto, che divenne amico di esso Giorgio per mezzo di Messer Marco da Lodi gentiluomo del detto cardinale di Cortona, il quale mostrò a Giorgio, a cui piacque molto, un ritratto di mano di esso Francesco, il quale poco innanzi s'era messo al dipintore con Giuliano Bugiardini.
Il Vasari intanto, non lasciando gli studii delle lettere, d'ordine del Cardinale si tratteneva ogni giorno due ore con Ipolito et Alessandro de' Medici, sotto il Pierio lor maestro e valentuomo. Questa amicizia dunque contratta come di sopra fra il Vasari e Francesco, fu tale, che durò sempre fra loro, ancor che per la concorrenza e per un suo modo di parlare un poco altiero, che avea detto Francesco, fusse da alcuni creduto altrimenti. Il Vasari dopo essere stato alcuni mesi con Michelagnolo, essendo quell'eccellente uomo chiamato a Roma da papa Clemente per dargli ordine che si cominciasse la libreria di San Lorenzo, fu da lui, avanti che partisse, acconcio con Andrea del Sarto, sotto el quale attendendo Giorgio a disegnare, accomodava continuamente di nascoso dei disegni del suo maestro a Francesco, che non aveva maggior desiderio che d'averne e studiargli come faceva giorno e notte. Dopo essendo dal Magnifico Ipolito acconcio Giorgio con Baccio Bandinelli, che ebbe caro avere quel putto appresso di sé et insegnargli, fece tanto, che vi tirò anco Francesco, con molta utilità dell'uno e dell'altro, perciò che impararono e fecero stando insieme più frutto in un mese, che non avevano fatto disegnando da loro in due anni; sì come anco fece un altro giovinetto che similmente stava allora col Bandinello, chiamato Nannoccio dalla costa San Giorgio, del quale si parlò poco fa. Essendo poi l'anno 1527 cacciati i Medici di Firenze, nel combattersi il palazzo della Signoria, fu gettata d'alto una purliza per dare addosso a coloro che combattevano la porta; ma quella, come volle la sorte, percosse un braccio del Davit di marmo del Buonarroto, che è sopra la ringhiera a canto alla porta e lo roppe in tre pezzi; per che essendo stati i detti pezzi per terra tre giorni senza esser da niuno stati raccolti, andò Francesco a trovare al Ponte Vecchio Giorgio e dettogli l'animo suo, così fanciulli come erano, andarono in piazza e di mezzo ai soldati della guardia, senza pensare a pericolo niuno, tolsono i pezzi di quel braccio e nel chiasso di Messer Bivigliano gli portarono in casa di Michelagnolo, padre di Francesco; donde avutigli poi il duca Cosimo gli fece col tempo rimettere al loro luogo con perni di rame. Standosi dopo i Medici fuori e con essi il detto cardinale di Cortona, Antonio Vasari ricondusse il figliuolo in Arezzo con non poco dispiacere di lui e di Francesco, che s'amavano come fratelli; ma non stettono molto l'uno dall'altro separati perciò che essendo per la peste, che venne l'agosto seguente, morto a Giorgio il padre et i migliori di casa sua, fu tanto con lettere stimolato da Francesco, il quale fu per morirsi anch'egli di peste, che tornò a Fiorenza, dove con incredibile studio, per ispazio di due anni cacciati dal bisogno e dal disiderio d'imparare, fecero acquisto maraviglioso, riparandosi insieme col detto Nannoccio da San Giorgio tutti e tre in bottega di Raffaello del Brescia pittore, appresso al quale fece Francesco molti quadretti come quegli che avea più bisogno per procacciarsi da poter vivere.
Venuto l'anno 1529, non parendo a Francesco che lo stare in bottega del Brescia facesse molto per lui, andò egli e Nannoccio a stare con Andrea del Sarto, e vi stettono quanto durò l'assedio, ma con tanto incommodo, che si pentirono non aver seguitato Giorgio, il quale con Manno orefice si stette quell'anno in Pisa, attendendo per trattenersi quattro mesi all'orefice. Essendo poi andato il Vasari a Bologna, quando vi fu da Clemente Settimo incoronato Carlo Quinto imperadore, Francesco, che era rimaso in Fiorenza, fece in una tavoletta un boto d'un soldato che per l'assedio fu assaltato nel letto da certi soldati per amazzarlo, et ancora che fussi cosa bassa, lo studiò e lo condusse perfettamente; il qual boto capitò nelle mani a Giorgio Vasari non è molti anni che lo donò al reverendo don Vincenzio Borghini spedalingo degli Innocenti, che lo tien caro. Fece ai monaci neri di Badia tre piccole storie in un tabernacolo del Sagramento stato fatto dal Tasso intagliatore, a uso d'arco trionfale; in una delle quali è il sacrifizio d'Abramo, nella seconda la manna e nella terza gl'ebrei, che nel partire d'Egitto mangiano l'agnel pasquale. La quale opera fu sì fatta, che diede saggio della riuscita che ha poi fatto. Dopo fece a Francesco Sertini, che lo mandò in Francia, in un quadro una Dalida che tagliava i capegli a Sansone, e nel lontano quando egli abbracciando le colonne del tempio, lo rovina addosso ai Filistei, il quale quadro fece conoscere Francesco per il più eccellente de' pittori giovani che allora fussero a Fiorenza.
Non molto dopo, essendo a Benvenuto dalla Volpaia, maestro d'oriuoli, il quale allora si trovava in Roma, chiesto dal cardinale Salviati il Vecchio un giovane pittore, il quale stesse appresso di sé, e gli facesse per suo deletto alcune pitture, Benvenuto gli propose Francesco il quale era suo amico e sapeva esser il più sufficiente di quanti giovani pittori conosceva; il che fece anco tanto più volentieri, avendo promesso il Cardinale gli darebbe ogni comodo et aiuto da potere studiare.
Piacendo dunque al Cardinale le qualità del giovane, disse a Benvenuto che mandasse per lui e gli diede per ciò danari; e così arrivato Francesco in Roma, piacendo il suo modo di fare et i suoi costumi e maniere al Cardinale, ordinò che in Borgo Vecchio avesse le stanze, e quattro scudi il mese et il piatto alla tavola de' gentiluomini. Le prime opere che Francesco (al quale pareva avere avuto grandissima ventura) facesse al Cardinale furono un quadro di Nostra Donna, che fu tenuto bello, et in una tela un signor franzese che corre cacciando dietro a una cervia, il quale fuggendo, si salva nel tempio di Diana; della quale opera tengo io il disegno di sua mano, per memoria di lui, nel nostro libro. Finita questa tela, il Cardinale fece ritrarre in un quadro bellissimo di Nostra Donna una sua nipote maritata al signor Cagnino Gonzaga et esso signore parimente. Ora standosi Francesco in Roma e non avendo maggior disiderio che di vedere in quella città l'amico suo Giorgio Vasari, ebbe in ciò la fortuna favorevole ai suo' disideri, ma molto più esso Vasari. Perciò che, essendosi partito tutto sdegnato il cardinale Ipolito da papa Clemente, per le cagioni che allora si dissero, e ritornandosene indi a non molto a Roma accompagnato da Baccio Valori, nel passare per Arezzo trovò Giorgio che era rimaso senza padre e si andava trattenendo il meglio che poteva. Per che disiderando che facesse qualche frutto nell'arte e di volerlo appresso di sé, ordinò a Tommaso de' Nerli, che quivi era commessario, che glielo mandasse a Roma subito che avesse finita una cappella, che faceva a fresco ai monaci di S. Bernardo dell'Ordine di Monte Oliveto in quella città. La qual commessione essequì il Nerli subitamente; onde arrivato Giorgio in Roma andò subito a trovare Francesco, il quale tutto lieto gli raccontò in quanta grazia fusse del Cardinale suo signore, e che era in luogo dove potea cavarsi la voglia di studiare, aggiugnendo: “Non solo mi godo di presente, ma spero ancor meglio. Perciò che, oltre al veder te in Roma, col quale potrò come giovane amicissimo considerare e conferire le cose dell'arte, sto con speranza d'andare a servire il cardinale Ipolito de' Medici, dalla cui liberalità e pel favore del Papa potrò maggiori cose sperare, che quelle che ho al presente, e per certo mi verrà fatto, se un giovane che aspetta di fuori non viene”. Giorgio, se bene sapeva che il giovane il quale s'aspettava era egli e che il luogo si serbava per lui, non però volle scoprirsi, per un certo dubbio cadutogli in animo: non forse il Cardinale avesse altri per le mani, e per non dir cosa che poi fusse riuscita altrimenti. Aveva Giorgio portato una lettera del detto commessario Nerli al Cardinale, la quale in cinque dì ch'era stato in Roma non aveva anco presentata. Finalmente andati Giorgio e Francesco a palazzo, trovarono, dove è oggi la sala de' re, Mes-ser Marco da Lodi, che già era stato col Cardinale di Cortona, come si disse di sopra, et il quale allora serviva Medici. A costui fattosi incontra Giorgio gli disse che aveva una lettera del commessario d'Arezzo, la quale andava al Cardinale e che lo pregava volesse dargliele; la quale cosa mentre prometteva Messer Marco di far tostamente, ecco che appunto arriva quivi il Cardinale. Per che fattosegli Giorgio incontra e presentata la lettera, con basciargli le mani, fu ricevuto lietamente e poco appresso commesso a Iacopone da Bibbiena, maestro di casa, che l'accomodasse di stanze e gli desse luogo alla tavola de' paggi. Parve cosa strana a Francesco che Giorgio non gl'avesse conferita la cosa, tuttavia pensò che l'avesse fatto a buon fine e per lo migliore.
Avendo dunque Iacopone sopra detto dato alcune stanze a Giorgio dietro a Santo Spirito e vicine a Francesco, attesero tutta quella vernata ambidue di compagnia con molto profitto alle cose dell'arte, non lasciando né in palazzo, né in altra parte di Roma, cosa alcuna notabile la quale non disegnassono. E perché quando il Papa era in palazzo non pote-vano così stare a disegnare, subito che Sua Santità cavalcava, come spesso faceva, alla Magliana, entravano per mezzo d'amici in dette stanze a disegnare, e vi stavano dalla mattina alla sera senza mangiare altro che un poco di pane e quasi assiderandosi di freddo. Essendo poi dal cardinale Salviati ordinato a Francesco che dipignesse a fresco nella cappella del suo palazzo, dove ogni mattina udiva messa, alcune storie della vita di San Giovanni Battista, si diede Francesco a studiare ignudi di naturale e Giorgio con esso lui, in una stufa quivi vicina, e dopo feciono in Camposanto alcune notomie.
Venuta poi la primavera, essendo il cardinale Ipolito mandato dal Papa in Ungheria, ordinò che esso Giorgio fusse mandato a Firenze e che quivi lavorasse alcuni quadri e ritratti, che aveva da mandare a Roma. Ma il luglio vegnente fra per le fatiche del verno passato et il caldo della state, amalatosi Giorgio, in ceste fu portato in Arezzo, con molto dispiacere di Francesco, il quale infermò anch'egli e fu per morire. Pure guarito Francesco, gli fu per mezzo d'Antonio Abaco, maestro di legname, dato a fare da maestro Filippo da Siena, sopra la porta di dietro di Santa Maria della Pace, in una nicchia, a fresco un Cristo che parla a San Filippo, et in due angoli la Vergine e l'Angelo che l'annunzia, le quali pitture, piacendo molto a mastro Filippo, furono cagione che facesse fare nel medesimo luogo in un quadro grande che non era dipinto, dell'otto facce di quel tempio, un'Assunzione di Nostra Donna. Onde considerando Francesco avere a fare quest'opera, non pure in luogo publico, ma in luogo dove erano pitture d'uomini rarissimi, di Raffaello da Urbino, del Rosso, di Baldassarri da Siena e d'altri, mise ogni studio e diligenza in condurla a olio nel muro, onde gli riuscì bella pittura e molto lodata, e fra l'altre è tenuta bonissima figura il ritratto che vi fece del detto maestro Filippo con le mani giunte. E perché Francesco stava, come s'è detto, col cardinale Salviati et era conosciuto per suo creato, cominciando a essere chiamato e non conosciuto per altro che per Cecchino Salviati, ha avuto insino alla morte questo cognome.
Essendo morto papa Clemente Settimo e creato Paulo Terzo, fece dipignere Messer Bindo Altoviti, nella facciata della sua casa in ponte Sant'Agnolo, da Francesco l'arme di detto nuovo pontefice con alcune figure grandi et ignude, che piacquero infinitamente. Ritrasse ne' medesimi tempi il detto Messer Bindo, che fu una molto buona figura et un bel ritratto, ma questo fu poi mandato alla sua villa in San Mizzano in Valdarno, dove è ancora; dopo fece per la chiesa di San Francesco a Ripa una bellissima tavola a olio d'una Nunziata, che fu condotta con grandissima diligenza. Nel-l'andata di Carlo Quinto a Roma l'anno 1535, fece per Antonio da San Gallo alcune storie di chiaro scuro, che furono poste nell'arco che fu fatto a San Marco, le quali pitture, come s'è detto in altro luogo, furono le migliori che fussero in tutto quell'apparato. Volendo poi il signor Pierluigi Farnese, fatto allora signor di Nepi, adornare quella città di nuove muraglie e pitture, prese al suo servizio Francesco, dandogli le stanze in Belvedere, dove gli fece in tele grandi alcune storie a guazzo de' fatti d'Alessandro Magno che furono poi in Fiandra messe in opera di panni d'arazzo. Fece al medesimo signor di Nepi una grande e bellissima stufa con molte storie e figure lavorate in fresco. Dopo essendo il medesimo fatto duca di Castro, nel fare la prima entrata fu fatto con ordine di Francesco un bellissimo e ricco apparato in quella città et un arco alla porta tutto pieno di storie e di figure e statue fatte con molto giudizio da valentuomini, et in particolare da Alessandro detto Scherano scultore da Settignano. Un altro arco a uso di facciata fu fatto al Petrone et un altro alla piazza, che quanto al legname furono condotti da Batista Botticegli, et oltre all'altre cose fece in questo apparato Francesco una bella scena e prospettiva per una comedia che si recitò.
Avendo ne' medesimi tempi Giulio Camillo, che allora si trovava in Roma, fatto un libro di sue composizioni per mandarlo al re Francesco di Francia, lo fece tutto storiare a Francesco Salviati, che vi mise quanta più diligenza è possibile mettere in simile opera. Il cardinal Salviati, avendo disiderio avere un quadro di legni tinti, cioè di tarsia, di mano di fra' Damiano da Bergamo converso di S. Domenico di Bologna, gli mandò un disegno come volea che lo facesse, di mano di Francesco, fatto di lapis rosso; il quale disegno, che rappresentò il re Davit unto da Samuello, fu la miglior cosa e veramente rarissima che mai disegnasse Cecchino Salviati. Dopo, Giovanni da Cepperello e Battista gobbo da San Gallo, avendo fatto dipignere a Iacopo del Conte fiorentino, pittore allora giovane, nella Compagnia della Misericordia de' Fiorentini, di San Giovanni Dicollato sotto il Campidoglio in Roma, cioè nella seconda chiesa, dove si ragunano, una storia di detto San Giovanni Battista, cioè quando l'Angelo nel tempio appare a Zaccheria; feciono i medesimi sotto quella fare da Francesco un'altra storia del medesimo Santo, cioè quando la Nostra Donna visita Santa Lisabetta; la quale opera, che fu finita l'anno 1538, condusse in fresco di maniera, ch'ella è fra le più graziose e meglio intese pitture che Francesco facesse mai, da essere annoverata nell'invenzione, nel componimento della storia e nell'osservanza et ordine del diminuire le figure con regola, nella prospettiva et architettura de' casamenti, negl'ignudi, ne' vestiti, nella grazia delle teste et in somma in tutte le parti, onde non è maraviglia se tutta Roma ne restò ammirata.
Intorno a una finestra fece alcune capricciose bizzarrie finte di marmo et alcune storiette, che hanno grazia maravigliosa; e perché non perdeva Francesco punto di tempo, mentre lavorò quest'opera, fece molte altre cose e disegni e colorì un Fetonte con i cavalli del sole, che aveva disegnato Michelagnolo. Le quali tutte cose mostrò il Salviati a Giorgio, che dopo la morte del duca Alessandro era andato a Roma per due mesi, dicendogli che finito che avesse un quadro d'un San Giovanni giovinetto, che faceva al cardinale Salviati suo signore, et una Passione di Cristo in tele, che s'aveva a mandare in Ispagna, et un quadro di Nostra Donna, che faceva a Raffaello Acciaiuoli, voleva dare di volta a Fiorenza a rivedere la patria, i parenti e gl'amici, essendo anco vivo il padre e la madre, ai quali fu sempre di grandissimo aiuto e massimamente in allogare due sue sorelle, una delle quali fu maritata e l'altra è monaca nel monasterio di Monte Domini. Venendo dunque a Firenze, dove fu con molta festa ricevuto dai parenti e dagl'amici, s'abbatté a punto a esservi quando si faceva l'apparato per le nozze del duca Cosimo e della signora donna Leonora di Tolledo. Per che, essendogli data a fare una delle già dette storie che si feciono nel cortile, l'accettò molto volentieri: che fu quella dove l'Imperatore mette la corona ducale in capo al duca Cosimo. Ma venendo voglia a Francesco, prima che l'avesse finita, d'andare a Vinezia, la lasciò a Carlo Portegli da Loro, che la finì secondo il disegno di Francesco; il quale disegno, con molti altri del medesimo, è nel nostro libro.
Partito Francesco di Firenze e condottosi a Bologna vi trovò Giorgio Vasari, che di due giorni era tornato da Camaldoli, dove aveva finito le due tavole che sono nel tramezzo della chiesa e cominciata quella dell'altare maggiore, e dava ordine di fare tre tavole grandi per lo refettorio de' padri di San Michele in Bosco, dove tenne seco Francesco due giorni. Nel qual tempo fecero opera alcuni amici suoi che gli fusse allogata una tavola, che avevano da far fare gl'uomi-ni dello spedale della Morte, ma con tutto che il Salviati ne facesse un bellissimo disegno, quegl'uomini, come poco intendenti, non seppono conoscere l'occasione che loro aveva mandata Messer Domenedio di potere avere un'opera di mano d'un valentuomo in Bologna. Per che, partendosi Francesco quasi sdegnato, lasciò in mano di Girolamo Fagiuoli alcuni disegni molto begli perché gl'intagliasse in rame e gli facesse stampare. E giunto in Vinezia, fu raccolto cortesemente dal patriarca Grimani e da Messer Vettor suo fratello, che gli fecero infinite carezze. Al quale patriarca, dopo pochi giorni fece a olio in uno ottangolo di quattro braccia una bellissima Psiche alla quale, come a dea, per le sue bellezze sono offerti incensi e voti; il quale ottangolo fu posto in un salotto della casa di quel signore, dove è un palco nel cui mezzo girano alcuni festoni fatti da Camillo Mantovano, pittore in fare paesi, fiori, frondi, frutti, et altre sì fatte cose eccellente; fu posto dico il detto ottangolo in mezzo di quattro quadri di braccia due e mezzo l'uno, fatti di storie del-la medesima Psiche, come si disse nella vita del Genga, da Francesco da Furlì. Il quale ottangolo è non solo più bello senza comparazione di detti quattro quadri, ma la più bell'opera di pittura che sia in tutta Vinezia. Dopo fece in una ca-mera, dove Giovanni Ricamatore da Udine aveva fatto molte cose di stucchi, alcune figurette a fresco ignude e vestite, che sono molto graziose; parimente in una tavola che fece alle monache del Corpus Domini in Vinezia, dipinse con molta diligenza un Cristo morto con le Marie et un Angelo in aria che ha i misterii della Passione in mano.
Fece il ritratto di Messer Pietro Aretino, che come cosa rara fu da quel poeta mandato al re Francesco con alcuni versi in lode di chi l'aveva dipinto. Alle monache di Santa Cristina di Bologna dell'Ordine di Camaldoli dipinse il medesimo Salviati, pregato da don Giovanfrancesco da Bagno loro confessore, una tavola con molte figure, che è nella chiesa di quel monasterio, veramente bellissima. Essendo poi venuto a fastidio il vivere di Vinezia a Francesco, come a colui che si ricordava di quel di Roma, e parendogli che quella stanza non fusse per gl'uomini del disegno se ne partì per tornare a Roma. E dato una giravolta da Verona e da Mantova, veggendo in una quelle molte antichità che vi sono e nell'altra l'opere di Giulio Romano, per la via di Romagna se ne tornò a Roma e vi giunse l'anno 1541. Quivi posatosi alquanto, le prime opere che fece furono il ritratto di Messer Giovanni Gaddi e quello di Messer Anniballe Caro suoi amicissimi, e quelli finiti fece per la cappella de' cherici di camera nel palazzo del papa una molto bella tavola, e nella chiesa de' tedeschi cominciò una cappella a fresco per un mercatante di quella nazione, facendo di sopra nella volta de-gl'Apostoli che ricevono lo Spirito Santo, et in un quadro che è nel mezzo alto Gesù Cristo che risuscita, con i soldati tramortiti intorno al sepolcro in diverse attitudini, e che scortano con gagliarda e bella maniera. Da una banda fece Santo Stefano e dall'altra San Giorgio in due nicchie; da basso fece San Giovanni limosinario che dà la limosina a un poverello nudo et ha a canto la Carità, e dall'altro lato Santo Alberto frate carmelitano in mezzo alla Loica et alla Prudenza; e nella tavola grande fece ultimamente a fresco Cristo morto con le Marie.
Avendo Francesco fatto amicizia con Piero di Marcone orefice fiorentino, e divenutogli compare, fece alla comare e moglie di esso Piero, dopo il parto, un presente d'un bellissimo disegno, per dipignerlo in un di que' tondi nei quali si porta da mangiare alle donne di parto. Nel quale disegno era in un partimento riquadrato et accomodato sotto e sopra, con bellissime figure, la vita dell'uomo, cioè tutte l'età della vita umana, che posavano ciascuna sopra diversi festoni appropriati a quella età secondo il tempo. Nel quale bizzarro spartimento erano accomodati in due ovati bislunghi la figura del sole e della luna, e nel mezzo Isais città d'Egitto che dinanzi al tempio della dea Pallade dimandava sapienza; quasi volendo mostrare che ai nati figliuoli si doverebbe inanzi ad ogni altra cosa pregare sapienza e bontà. Questo disegno tenne poi sempre Piero così caro, come fusse stato, anzi come era, una bellissima gioia.
Non molto dopo, avendo scritto il detto Piero et altri amici a Francesco che avrebbe fatto bene a tornare alla patria, perciò che si teneva per fermo che sarebbe stato adoperato dal signor duca Cosimo, che non aveva maestri intorno se non lunghi et irresoluti, si risolvé finalmente (confidando anco molto nel favore di Messer Alamanno fratello del Cardinale e zio del Duca) a tornarsene a Fiorenza. E così venuto, prima che altro tentasse, dipinse al detto Messer Alamanno Salviati un bellissimo quadro di Nostra Donna, il quale lavorò in una stanza che teneva nell'Opera di Santa Maria del Fiore Francesco dal Prato, il quale allora di orefice e maestro di tausia s'era dato a gettare figurette di bronzo et a dipignere con suo molto utile et onore. Nel medesimo luogo dico, il quale stava colui, come ufficiale sopra i legnami dell'Opera, ritrasse Francesco l'amico suo Piero di Marcone et Aveduto del Cegia Vaiaio e suo amicissimo, il quale Aveduto, oltre a molte altre cose che ha di mano di Francesco, ha il ritratto di lui stesso fatto a olio e di sua mano naturalissimo. Il sopra detto quadro di Nostra Donna, essendo, finito che fu, in bottega del Tasso intagliatore di legname et allora architettore di palazzo, fu veduto da molti e lodato infinitamente. Ma quello che anco più lo fece tenere pittura rara, si fu che il Tasso, il quale soleva biasimare quasi ogni cosa, la lodava senza fine, e, che fu più, disse a Messer Pierfrancesco maiordomo che sarebbe stato ottimamente fatto che il Duca avesse dato da lavorare a Francesco alcuna cosa d'importanza. Il quale Messer Pierfrancesco e Cristofano Rinieri, che avevano gli orecchi del Duca, fecero sì fatto ufficio, che parlando Messer Alamanno a sua eccellenza e dicendogli che Francesco desiderava che gli fusse dato a dipignere il salotto dell'udienza, che è dinanzi alla capella del palazzo ducale, e che non si curava d'altro pagamento, ella si contentò che ciò gli fusse conceduto. Per che, avendo Francesco fatto in disegni piccoli il trionfo e molte storie de' fatti di Furio Camillo, si mise a fare lo spartimento di quel salotto, secondo le rotture dei vani delle finestre e delle porte, che sono quali più alte e quali più basse. E non fu piccola difficultà ridurre il detto spartimento in modo che avesse ordine e non guastasse le storie. Nella faccia dove è la porta per la quale si entra nel salotto rimanevano due vani grandi divisi dalla porta; dirimpetto a questa, dove sono le tre finestre che guardano in piazza ne rimanevano quattro, ma non più larghi che circa tre braccia l'uno. Nella testa che è a man ritta entrando, dove sono due finestre che rispondono similmente in piazza, da un altro lato erano tre vani simili, cioè di tre braccia circa, e nella testa, che è a man manca dirimpetto a questa, essendo la porta di marmo che entra nella capella et una finestra con una grata di bronzo, non rimaneva se non un vano grande da potervi accommodare cosa di momento. In questa facciata adunque della capella dentro a un ornamento di pilastri corinti che reggono un architrave, il quale ha uno sfondato di sotto dove pendono due ricchissimi festoni e due pendagli di variate frutte molto bene contrafatte e sopra cui siede un putto ignudo che tiene l'ar-me ducale, cioè di casa Medici e Tolledo, fece due storie: a man ritta Camillo che comanda che quel maestro di scuola sia dato in preda a' fanciulli suoi scolari, e nell'altra il medesimo, che mentre l'esercito combatte et il fuoco arde gli steccati et alloggiamenti del campo, rompe i Galli; et a canto dove seguita il medesimo ordine di pilastri fece grande quanto il vivo una Occasione che ha preso la Fortuna per lo crine, et alcune imprese di sua eccellenza, con molti ornamenti fatti con grazia maravigliosa. Nella facciata maggiore, dove sono due gran vani divisi dalla porta principale, fece due storie grandi e bellissime. Nella prima sono Galli, che pesando l'oro del tributo, vi aggiungono una spada, acciò sia il peso maggiore, e Camillo che sdegnato con la virtù dell'armi si libera dal tributo, la qual storia è bellissima, copiosa di figure, di paesi, d'antichità e di vasi benissimo et in diverse maniere finti d'oro e d'argento. Nell'altra storia a canto a questa è Camillo sopra il carro trionfale tirato da quattro cavalli, et in alto la Fama che lo corona. Dinanzi al carro sono sacerdoti con la statua della dea Giunone, con vasi in mano, molto riccamente abbigliati e con alcuni trofei e spoglie bellissime; d'intorno al carro sono infiniti prigioni in diverse attitudini, e dietro i soldati dell'esercito armati, fra i quali ritrasse Francesco se stesso tanto bene, che par vivo. Nel lontano dove passa il trionfo è una Roma molto bella, e sopra la porta è una Pace di chiaro scuro con certi prigioni, la quale abrucia l'armi; il che tutto fu fatto da Francesco con tanta diligenza e studio, che non può vedersi più bell'opra. Nell'altra faccia, che è volta a ponente, fece nel mezzo e ne' maggior vani in una nicchia Marte armato, e sotto quello una figura ignuda finta per un Gallo con la cresta in capo simile a quella de' galli naturali, et in un'altra nicchia Diana succinta di pelle, che si cava una freccia del turcasso, e con un cane. Ne' due canti di verso l'altre due facciate sono due Tempi, uno che aggiusta i pesi con le bilance e l'altro che tempra, versando l'acqua di due vasi l'uno nell'altro. Nell'ultima facciata, dirimpetto alla capella, la quale volta a tramontana, è da un canto a man ritta il sole figurato nel mo' che gli ... egizzii il mostrano, e dall'altro la luna nel medesimo modo; nel mezzo è il Favore finto in un giovane ignudo in cima alla ruota, et in mezzo da un lato all'Invidia, all'Odio et alla Maladicenza e dall'altro agli Onori, al Diletto et a tutte l'altre cose descritte da Luciano. Sopra le finestre è un fregio tutto pieno di bellissimi ignudi, grandi quanto il vivo et in diverse forme et attitudini, con alcune storie similmente de' fatti di Camillo, e dirimpetto alla Pace, che arde l'arme, è il fiume Arno che avendo un corno di dovizia abbondantissimo, scuopre (alzando con una mano un panno) una Fiorenza e la grandezza de' suoi pontefici e gli eroi di casa Medici. Vi fece oltre di ciò un basamento che gira intorno a queste storie e nicchie con alcuni termini di femina che reggono festoni, e nel mezzo sono certi ovati con storie di popoli che adornano una Sfinge et il fiume Arno. Mise Francesco in fare quest'opera tutta quella diligenza e studio che è possibile, e la condusse felicemente ancora che avesse molte contrarietà, per lasciar nella patria un'opra degna di sé e di tanto prencipe.
Era Francesco di natura malinconico, e le più volte non si curava quando era a lavorare d'avere intorno niuno. Ma nondimeno quando a principio cominciò quest'opera, quasi sforzando la natura e facendo il liberale, con molta dimestichezza lasciava che il Tasso et altri amici suoi, che gli avevano fatto qualche servizio, stesseno a vederlo lavorare, carezzandogli in tutti i modi che sapeva. Quando poi ebbe preso, secondo che dicono, pratica della corte e che gli parve essere in favore, tornando alla natura sua colorosa, mordace, non aveva loro alcun rispetto; anzi, che era peggio, con parole mordacissime, come soleva (il che servì per una scusa a' suoi avversarii), tassava e biasimava l'opere altrui, e sé e le sue poneva sopra le stelle. Questi modi, dispiacendo ai più e medesimamente a certi artefici, gl'acquistarono tanto odio, che il Tasso e molti altri che d'amici gli erano divenuti contrarii, gli cominciarono a dar che fare e che pensare; perciò che, se bene lodavano l'eccellenza che era in lui dell'arte e la facilità e prestezza con le quali conduceva l'opere interamente e benissimo, non mancava loro dall'altro lato che biasimare. E perché, se gli avesseno lasciato pigliar piede et accommodare le cose sue, non avrebbono poi potuto offenderlo e nuocergli, cominciarono a buon'ora a dargli che fare e molestarlo. Per che ristrettisi insieme molti dell'arte et altri e fatta una setta, cominciarono a seminare fra i maggiori che l'opera del salotto non riusciva, e che lavorando per pratica non istudiava cosa che facesse. Nel che il lacera-vano veramente a torto, perciò che se bene non istentava a condurre le sue opere, come facevano essi, non è però che egli non istudiasse e che le sue cose non avessero invenzione e grazia infinita, né che non fussero ottimamente messe in opera. Ma non potendo i detti aversarii superare con l'opere la virtù di lui, volevano con sì fatte parole e biasimi sotterrarla, ma ha finalmente troppa forza la virtù et il vero. Da principio si fece Francesco beffe di cotali rumori, ma veggendoli poi crescere oltre il convenevole, se ne dolse più volte col Duca. Ma non veggendosi che quel signore gli faces-se in apparenza quegli favori ch'egli arebbe voluto, e parendo che non curasse quelle sue doglienze, cominciò Francesco a cascare di maniera, che presogli i suoi contrarii animo addosso, missono fuori una voce che le sue storie della sala s'avevano a gettare per terra e che non piacevano, né avevano in sé parte niuna di bontà. Le quali tutte cose, che gli pontavano contra, con invidia e maledicenza incredibile de' suoi avversarii, avevano ridotto Francesco a tale, che se non fusse stata la bontà di Messer Lelio Torelli, di Messer Pasquino Bertini e d'altri amici suoi, egli si sarebbe levato dinanzi a costoro, il che era a punto quello che eglino desideravano. Ma questi sopra detti amici suoi confortandolo tuttavia a finire l'opera della sala et altre che aveva fra mano, il rattennono, sì come feciono anco molti altri amici suoi fuori di Firenze, ai quali scrisse queste sue persecuzioni, e fra gli altri Giorgio Vasari in rispondendo a una lettera, che sopra ciò gli scrisse il Salviati, lo confortò sempre ad aver pazienza, perché la virtù perseguitata raffinisce come al fuoco l'oro, aggiungendo che era per venir tempo che sarebbe conosciuta la sua virtù et ingegno, che non si dolesse se non di sé, che anco non conosceva gli umori e come son fatti gli uomini et artefici della sua patria. Nonostante dunque tante contrarietà e persecuzioni che ebbe il povero Francesco, finì quel salotto, cioè il lavoro che aveva tolto a fare in fresco nelle facciate, perciò che nel palco o vero soffittato non fu bisogno che lavorasse alcuna cosa, essendo tanto riccamente intagliato e messo tutto d'oro, che per sì fatta non si può vedere opera più bella. E per accompagnare ogni cosa fece fare il Duca di nuovo due finestre di vetro con l'imprese et arme sue e di Carlo V, che si può far di quel lavoro meglio, che furono condotte da Batista dal Borro, pittore aretino raro in questa professione.
Dopo questa fece Francesco per sua eccellenza il palco del salotto ove si mangia il verno, con molte imprese e figurine a tempera, et un bellissimo scrittoio che risponde sopra la camera verde. Ritrasse similmente alcuni de' figliuoli del Duca, et un anno per carnovale fece nella sala grande la scena e prospettiva d'una comedia, che si recitò, con tanta bellezza e diversa maniera da quelle che erano state fatte in Fiorenza insino allora, che ella fu giudicata superiore a tutte. Né di questo è da maravigliarsi, essendo verissimo che Francesco in tutte le sue cose fu sempre di gran giudizio, vario e copioso d'invenzione, e che, più, possedeva le cose del disegno et aveva più bella maniera che qualunche altro fusse allora a Fiorenza et i colori maneggiava con molta pratica e vaghezza. Fece ancora la testa o vero ritratto del signor Giovanni de' Medici, padre del duca Cosimo, che fu bellissima, la quale è oggi nella guardaroba di detto signor Duca. A Cristofano Rinieri, suo amicissimo, fece un quadro di Nostra Donna molto bello che è oggi nell'udienza della decima; a Ridolfo Landi fece in un quadro una Carità, che non può esser più bella, et a Simon Corsi fece similmente un quadro di Nostra Donna, che fu molto lodato; a Messer Donato Acciaioli cavalier di Rodi, col quale tenne sempre singular dimestichezza, fece certi quadretti, che sono bellissimi. Dipinse similmente in una tavola un Cristo che mostra a San Tomaso, il quale non credeva che fusse nuovamente risuscitato, i luoghi delle piaghe e ferite che aveva ricevute dai giudei, la quale tavola fu da Tomaso Guadagni condotta in Francia e posta in una chiesa di Lione alla capella de' Fiorentini. Fece parimente Francesco a riquisizione del detto Cristofano Rinieri e di maestro Giovanni Rosto, arazziere fiamingo, tutta la storia di Tarquinio e Lucrezia romana in molti cartoni, che essendo poi messi in opera di panni d'a-razzo fatti d'oro, di seta e filaticci, riuscì opera maravigliosa. La qual cosa intendendo il Duca, che allora faceva fare panni similmente d'arazzo al detto maestro Giovanni in Fiorenza per la sala de' Dugento tutti d'oro e di seta, et aveva fatto far cartoni delle storie di Ioseffo ebreo al Bronzino et al Pontormo, come s'è detto, volle che anco Francesco ne facesse un cartone, che fu quello dell'interpretazione delle sette vacche grasse e magre. Nel quale cartone, dico, mise Francesco tutta quella diligenza che in simile opera si può maggiore e che hanno di bisogno le pitture che si tessono: invenzioni capricciose, componimenti varii vogliono aver le figure, che spicchino l'una dall'altra, perché abbiano rilievo e venghino allegre ne' colori, ricche nelli abiti e vestiri. Dove essendo poi questo panno e gli altri riusciti bene, si risolvé sua eccellenza di mettere l'arte in Fiorenza e la fece insegnare a alcuni putti, i quali cresciuti fanno ora opere eccellentissime per questo Duca.
Fece anco un bellissimo quadro di Nostra Donna pur a olio, che è oggi in camera di Messer Alessandro figliuolo di Messer Ottaviano de' Medici. Al detto Messer Pasquino Bertini fece in tela un altro quadro di Nostra Donna, con Cristo e San Giovanni fanciulletti che ridono d'un papagallo che hanno tra mano, il quale fu opera capricciosa e molto vaga. Et al medesimo fece un disegno bellissimo d'un Crucifisso alto quasi un braccio con una Madalena a' piedi, in sì nuova e vaga maniera, che è una maraviglia. Il qual disegno, avendo Messer Salvestro Bertini accommodato a Girolamo Razzi suo amicissimo, che oggi è don Silvano, ne furono coloriti due da Carlo da Loro, che n'ha poi fatti molti altri che sono per Firenze. Avendo Giovanni e Piero d'Agostino Dini fatta in Santa Croce, entrando per la porta di mezzo a man ritta, una capella di macigni molto ricca et una sepoltura per Agostino et altri di casa loro, diedero a fare la tavola di quella a Francesco, il quale vi dipinse Cristo che è deposto di croce da Ioseffo Baramatia e da Nicodemo, et a' piedi la Nostra Donna svenuta con Maria Madalena, San Giovanni e l'altre Marie. La quale tavola fu condotta da Francesco con tanta arte e studio, che non solo il Cristo nudo è bellissimo, ma insieme tutte l'altre figure ben disposte e colorite con forza e rilievo. Et ancora che da principio fusse questa tavola dagli avversarii di Francesco biasimata, ella gl'acquistò nondimeno gran nome nell'universale, e chi n'ha fatto dopo lui a concorrenza, non l'ha superato. Fece il medesimo avanti che partisse di Firenze il ritratto del già detto Messer Lelio Torelli et alcune altre cose di non molta importanza, delle quali non so i particolari, ma fra l'altre cose diede fine a una carta, la quale aveva disegnata molto prima in Roma della conversione di San Paolo, che è bellissimo, il quale fece intagliar in rame da Enea Vico da Parma in Fiorenza. Et il Duca si contentò trattenerlo infino a che fusse ciò fatto in Fiorenza, con i suoi soliti stipendii e provisione. Nel qual tempo, che fu l'anno 1548, essendo Giorgio Vasari in Arimini a lavorare a fresco et a olio l'opere delle quali si è favellato in altro luogo, gli scrisse Francesco una lunga lettera, ragguagliandolo per apunto d'ogni cosa e come le sue cose passavano in Fiorenza, et in particolare d'aver fatto un disegno per la capella maggiore di San Lorenzo, che di ordine del signor Duca s'aveva a dipignere; ma che intorno a ciò era stato fatto malissimo ufficio per lui appresso sua eccellenzia, e che oltre all'altre cose, teneva quasi per fermo che Messer Pierfrancesco maiordomo non avesse mostro il suo disegno, onde era stata allogata l'opera al Pontorno; et ultimamente, che per queste cagioni se ne tornava a Roma, malissimo sodisfatto degl'uomini et artefici della sua patria.
Tornato dunque in Roma, avendo comperata una casa vicina al palazzo del cardinale Farnese, mentre si andava trattenendo con lavorare alcune cose di non molta importanza, gli fu dal detto cardinale, per mezzo di Messer Annibale Caro e di don Giulio Clovio, data a dipignere la capella del palazzo di San Giorgio. Nella quale fece bellissimi partimenti di stucchi et una graziosa volta a fresco con molte figure e storie di San Lorenzo, et in una tavola di pietra a olio la Natività di Cristo, accommodando in quell'opera, che fu bellissima, il ritratto di detto Cardinale. Dopo essendogli allogato un altro lavoro nella già detta Compagnia della Misericordia, dove aveva fatto Iacopo del Conte la predica et il battesimo di San Giovanni, nelle quali, se bene non aveva passato Francesco, si era portato benissimo, e dove avevano fatto alcune altre cose Battista Franco viniziano e Pirro Ligorio, fece Francesco in questa parte, che è a punto a canto all'altra sua storia della Visitazione, la natività di esso San Giovanni, la quale, se bene condusse ottimamente, ella nondimeno non fu pari alla prima. Parimente in testa di detta Compagnia fece per Messer Bartolomeo Pussotti due figure in fresco, cioè Santo Andrea e San Bartolomeo Apostoli, molto belli, i quali mettono in mezzo la tavola dell'altare, nella quale è un Deposto di croce di mano del detto Iacopo del Conte, che è bonissima pittura e la migliore opera che infino allora avesse mai fatto.
L'anno 1550 essendo stato eletto sommo pontefice Giulio Terzo, nell'apparato della coronazione, per l'arco che si fece sopra la scala di San Piero, fece Francesco alcune storie di chiaro scuro molto belle, e dopo essendosi fatto nella Minerva, dalla Compagnia del Sacramento, il medesimo anno, un sepolcro con molti gradi et ordini di colonne, fece in quello alcune storie e figure di terretta, che furono tenute bellissime; in una capella di San Lorenzo in Damaso fece due Angeli in fresco che tengono un panno, d'uno de' quali n'è il disegno nel nostro libro. Dipinse a fresco nel reffettorio di San Salvatore del Lauro a Monte Giordano, nella facciata principale, le nozze di Cana galilea, nelle quali fece Gesù Cristo dell'acqua vino, con gran numero di figure, e dalle bande alcuni Santi e papa Eugenio Quarto che fu di quell'or-dine et altri fondatori. E di dentro sopra la porta di detto reffettorio fece in un quadro a olio San Giorgio che ammazza il serpente, la quale opera condusse con molta pratica, finezza e vaghezza di colori. Quasi ne' medesimi tempi mandò a Fiorenza a Messer Alamanno Salviati un quadro grande, nel quale sono dipinti Adamo et Eva che nel Paradiso terrestre mangiano d'intorno all'albero della vita il pomo vietato, che è una bellissima opera. Dipinse Francesco al signor Ranuccio cardinale Sant'Agnolo di casa Farnese, nel salotto che è dinanzi alla maggior sala del palazzo de' Farnesi, due facciate, con bellissimo capriccio: in una fece il signor Ranuccio Farnese il Vecchio che da Eugenio Quarto riceve il bastone del capitanato di Santa Chiesa, con alcune virtù, e nell'altra papa Paolo Terzo Farnese che dà il bastone della Chiesa al signor Pier Luigi, e mentre si vede venire da lontano Carlo Quinto imperatore, accompagnato da Alessandro cardinale Farnese e da altri signori ritratti di naturale. Et in questa, oltra le dette e molte altre cose, dipinse una Fama et altre figure, che sono molto ben fatte. Ma è ben vero che quest'opera non fu del tutto finita da lui, ma da Taddeo Zucchero da Sant'Agnolo, come si dirà a suo luogo. Diede proporzione e fine alla capella del Popolo, che già fra' Bastiano Viniziano aveva cominciata per Agostino Chigii, che non essendo finita, Francesco la finì, come s'è ragionato in fra' Bastiano nella vita sua. Al cardinale Riccio da Monte Pulciano dipinse nel suo palazzo di strada Giulia una bellissima sala, dove fece a fresco in più quadri molte storie di Davit, e fra l'altre una Bersabè in un bagno che si lava con molte altre femine, mentre Davit la sta a vedere: è una storia molto ben composta, graziosa e tanto piena d'invenzione, quanto altra che si possa vedere. In un altro quadro è la morte d'Uria, in uno l'arca a cui vanno molti suoni inanzi, et insomma dopo alcune altre una battaglia che fa Davit con i suoi nimici, molto ben composta; e per dirlo brevemente, l'opera di questa sala è tutta piena di grazia, di bellissime fantasie e di molte capricciose et ingegnose invenzioni. Lo spartimento è fatto con molte considerazioni et il colorito è vaghissimo, e per dire il vero, sentendosi Francesco gagliardo e copioso d'invenzione et avendo la mano ubbidiente all'ingegno, arebbe voluto sempre avere opere grandi e straordinarie alle mani. E non per altro fu strano nel conversare con gli amici, se non perché essendo vario et in certe cose poco stabile, quello che oggi gli piaceva, domani aveva in odio, e fece pochi lavori d'importanza che non avesse in ultimo a contendere del prezzo; per le quali cose era fuggito da molti.
Dopo queste opere, avendo Andrea Tassini a mandar un pittore al re di Francia, et avendo l'anno 1554 in vano ricercato Giorgio Vasari, che rispose non volere, per qual si voglia gran provisione o promesse o speranza, partirsi dal servizio del duca Cosimo suo signore, convenne finalmente con Francesco e lo condusse in Francia, con obligare di satisfarlo in Roma, non lo satisfacendo in Francia. Ma prima che esso Francesco partisse di Roma, come quello che pensò non avervi mai più a ritornare, vendé la casa, le masserizie et ogni altra cosa, eccetto gli ufficii che aveva. Ma la cosa non riuscì come si aveva promesso, perciò che arrivato a Parigi, dove da Messer Francesco Primaticcio abbate di San Mar-tino e pittore et architetto del Re fu ricevuto benignamente e con molte cortesie, fu subito conosciuto per quello che si dice per un uomo così fatto. Conciò fusse che non vedesse cosa né del Rosso, né d'altri maestri, la quale egli alla scoperta o così destramente non biasimasse. Per che aspettando ognuno da lui qualche gran cosa, fu dal cardinale di Loreno, che là l'aveva condotto, messo a fare alcune pitture in un suo palazzo a Dampiera, per che avendo fatto molti disegni, mise finalmente mano all'opra facendo alcuni quadri di storie a fresco sopra cornicioni di camini et uno studiolo pieno di storie, che dicono che fu di gran fattura. Ma che che se ne fusse cagione, non gli furono cotali opere molto lodate. Oltre di questo non vi fu mai Francesco molto amato, per esser di natura tutto contraria a quella degli uomini di quel paese, essendo che, quanto vi sono avuti cari et amati gli uomini allegri, gioviali, che vivono alla libera e si trova-no volentieri in brigata et a far banchetti, tanto vi sono, non dico fuggiti, ma meno amati e carezzati coloro che sono come Francesco era, di natura malinconico, sobrio, malsano e stitico. Ma d'alcune cose arebbe meritato scusa, però che se la sua complessione non comportava che s'avilupasse ne' pasti e nel mangiar troppo e bere, arebbe potuto essere più dolce nel conversare. E, che è peggio, dove suo debito era, secondo l'uso del paese e di quelle corti, farsi vedere e corteggiare, egli arebbe voluto, e parevagli meritarlo, essere da tutto il mondo corteggiato. In ultimo, essendo quel re occupato in alcune guerre e parimente il Cardinale, e mancando le provisioni e promesse, si risolvé Francesco, dopo essere stato là venti mesi, a ritornarsene in Italia. E così condottosi a Milano (dove dal cavalier Lione Aretino fu cortesemente ricevuto in una sua casa, la quale si ha fabricata ornatissima e tutta piena di statue antiche e moderne e di figure di gesso, formate da cose rare come in altro luogo si dirà) dimorato che quivi fu quindici giorni e riposatosi, se ne ven-ne a Fiorenza, dove avendo trovato Giorgio Vasari e dettogli quanto aveva ben fatto a non andare in Francia, gli contò cose da farne fuggire la voglia a chiunque d'andarvi l'avesse maggiore. Da Firenze tornatosene Francesco a Roma, mosse un piato a' mallevadori, che erano entrati per le sue provisioni del cardinale di Loreno, e gli strinse a pagargli ogni cosa, e riscosso i danari comperò, oltre ad altri che vi avea prima, alcuni uffizii, con animo risoluto di voler badare a vivere, conoscendosi malsano et avere in tutto guasta la complessione. Ma ciò nonostante, avrebbe voluto essere impiegato in opere grandi, ma non gli venendo fatto così presto, si trattenne un pezzo in facendo quadri o ritratti.
Morto papa Paulo Quarto, essendo creato Pio similmente Quarto, che dilettandosi assai di fabricare si serviva nelle cose d'architettura di Pirro Ligorio, ordinò Sua Santità che il cardinale Alessandro Farnese e l'Emulio facessono finire la sala grande, detta dei re, a Daniello da Volterra, che l'aveva già cominciata. Fece ogni opera il detto reverendissimo Farnese perché Francesco n'avesse la metà; nel che fare essendo lungo combattimento fra Daniello e Francesco e massimamente adoperandosi Michel Agnolo Buonarroti in favore di Daniello, non se ne venne per un pezzo a fine. Intanto essendo andato il Vasari con Giovanni cardinale de' Medici, figliuolo del duca Cosimo, a Roma, nel raccontargli Francesco molte sue disaventure e quelle particolarmente nelle quali, per le cagioni dette pur ora, si ritrovava, gli mostrò Giorgio, che molto amava la virtù di quell'uomo, che egli si era insino allora assai male governato e che lasciasse per l'avenire fare a lui, perciò che farebbe in guisa, che per ogni modo gli toccarebbe a fare la metà della detta sala de' re, la quale non poteva Daniello fare da per sé, essendo uomo lungo et irresoluto, e non forse così gran valentuomo et universale come Francesco. Così dunque stando le cose, e per allora non si facendo altro, fu ricerco Giorgio non molti giorni dopo dal Papa di fare una parte di detta sala; ma avendo egli risposto che nel palazzo del duca Cosimo suo signore ave-va a farne una tre volte maggiore di quella, et oltra ciò che era sì male stato trattato da papa Giulio Terzo, per lo quale aveva fatto molte fatiche alla vigna al monte et altrove, che non sapeva più che si sperare da certi uomini, aggiugnendo che (avendo egli fatta al medesimo senza esserne stato pagato una tavola in palazzo, dentrovi Cristo che nel mare di Tiberiade chiama dalle reti Pietro et Andrea, la quale gl'era stata levata da papa Paulo Quarto da una capella, che aveva fatta Giulio sopra il corridore di Belvedere, e doveva essere mandata a Milano) Sua Santità volesse fargliela o rendere o pagare. Alle quali cose rispondendo il Papa disse (o vero, o non vero che così fusse) non sapere alcuna cosa di detta tavola, e volerla vedere; per che fattala venire, veduta che Sua Santità l'ebbe a mal lume, si contentò che ella gli fusse renduta. Dopo rapiccatosi il ragionamento della sala, disse Giorgio al Papa liberamente che Francesco era il primo e miglior pittore di Roma, e che non potendo niuno meglio servirlo di lui, era da farne capitale. E che se bene il Buonarroto et il cardinale di Carpi favorivano Daniello, lo facevano più per interesse dell'amicizia, e forse come appassionati, che per altro. Ma per tornare alla tavola, non fu sì tosto partito Giorgio dal Papa, che l'ebbe mandata a casa di Francesco, il quale poi di Roma gliela fece condurre in Arezzo, dove come in altro luogo abbiam detto, è stata dal Vasari con ricca et onorata spesa nella Pieve di quella città collocata. Stando le cose della sala de' re nel modo che si è detto di sopra, nel partire il duca Cosimo da Siena per andar a Roma, il Vasari, che era andato insin lì con sua eccellenza, gli raccomandò caldamente il Salviati, acciò gli facesse favore appresso al Papa, et a Francesco scrisse quanto aveva da fare, giunto che fusse il Duca in Roma. Nel che non uscì punto Francesco del consiglio datogli da Giorgio, per che andando a far reverenza al Duca, fu veduto con bonissima cera da sua eccellenza, e poco appresso fatto tale ufficio per lui appresso Sua Santità, che gli fu allogata mezza la detta sala, alla quale opera mettendo mano, prima che altro facesse, gettò a terra una storia stata cominciata da Daniello, onde furono poi fra loro molte contese.
Serviva come s'è già detto questo Pontefice nelle cose d'architettura Pirro Logorio, il quale aveva molto da principio favorito Francesco, et arebbe seguitato; ma colui non tenendo più conto né di Pirro, né d'altri, poi che ebbe cominciato a lavorare, fu cagione che d'amico gli divenne in un certo modo avversario, e se ne videro manifestissimi segni; perciò che Pirro cominciò a dire al Papa, che essendo in Roma molti giovani pittori e valentuomini, che a voler cavare le mani di quella sala sarebbe stato ben fatto allogar loro una storia per uno e vederne una volta il fine. I quali modi di Pirro, a cui si vedeva che il Papa in ciò acconsentiva, dispiacquero tanto a Francesco, che tutto sdegnato si tolse giù dal lavoro e dalle contenzioni, parendogli che poca stima fusse fatta di lui. E così montato a cavallo, senza far motto a niuno, se ne venne a Fiorenza, dove tutto fantastico, senza tener conto d'amico che avesse, si pose in uno albergo, come non fusse stato di questa patria e non vi avesse né conoscenza, né chi fusse in cosa alcuna per lui. Dopo, avendo baciato le mani al Duca, fu in modo accarezzato, che si sarebbe potuto sperare qualche cosa di buono, se Francesco fusse stato d'altra natura e si fusse attenuto al consiglio di Giorgio, il quale lo consigliava a vendere gl'ufficii che aveva in Roma e ridursi in Fiorenza a godere la patria e gl'amici, per fuggire il pericolo di perdere insieme con la vita tutto il frutto del suo su-dore e fatiche intollerabili. Ma Francesco guidato dal senso, dalla còllora e dal desiderio di vendicarsi, si risolvette volere tonare a Roma ad ogni modo fra pochi giorni. In tanto levandosi di su quell'albergo a' prieghi degl'amici si ritirò in casa di Messer Marco Finale priore di Santo Apostolo, dove fece, quasi per passarsi tempo, a Messer Iacopo Salviati sopra tela d'argento, una Pietà colorita, con la Nostra Donna e l'altre Marie, che fu cosa bellissima; rinfrescò di colori un tondo d'arme ducale, che altra volta avea fatta a posta sopra la porta del palazzo di Messer Alamanno, et al detto Messer Iacopo fece un bellissimo libro di abiti bizzarri et acconciature diverse d'uomini e cavalli per mascherate, per che ebbe infinite cortesie dall'amorevolezza di quel signore, che si doleva della fantastica e strana natura di Francesco, il quale non poté mai questa volta, come l'altre avea fatto, tirarselo in casa.
Finalmente avendo Francesco a partire per Roma, Giorgio come amico gli ricordò che essendo ricco d'età, mal complessionato e poco più atto alle fatiche, badasse a vivere quietamente e lasciare le gare e le contenzioni; il che non arebbe potuto fare commodamente, avendosi acquistato roba et onore a bastanza, se non fusse stato troppo avaro e disideroso di guadagnare. Lo confortò oltre ciò a vendere gran parte degl'ufficii che aveva et a accommodare le sue cose, in modo che in ogni bisogno o accidente che venisse, potesse ricordarsi degli amici e di coloro che l'avevano con fede e con amore servito. Promise Francesco di ben fare e dire e confessò che Giorgio gli diceva il vero, ma come al più de-gl'uomini adiviene, che danno tempo al tempo, non ne fece altro.
Arrivato Francesco in Roma, trovò che il cardinale Emulio aveva allogate le storie della sala e datone due a Taddeo Zucchero da Sant'Agnolo, una a Livio da Forlì, un'altra a Orazio da Bologna, una a Girolamo Sermoneta, e l'altre ad altri; la qual cosa avisando Francesco a Giorgio e dimandando se era bene che seguitasse quella che avea cominciata, gli fu risposto che sarebbe stato ben fatto, dopo tanti disegni piccoli e cartoni grandi, che n'avesse finita una; nonostante che a tanti da molto meno di lui fusse stata allogata la maggior parte, e che facesse sforzo d'avicinarsi con l'operare, quanto potesse il più, alle pitture della facciata e volta del Buonarroto nella capella di Sisto et a quelle della Paulina, perciò che veduta che fusse stata la sua, si sarebbono l'altre mandate a terra e tutte con sua molta gloria allogate a lui; avvertendolo a non curarsi né d'utile, né di danari, o dispiacere che gli fusse fatto da chi governava quell'opera; però che troppo più importa l'onore, che qualunche altra cosa. Delle quali tutte lettere e proposte e risposte, ne sono le copie e gl'originali fra quelle che tenghiamo noi per memoria di tant'uomo, nostro amicissimo, e per quelle che di nostra mano deono essere state fra le sue cose ritrovate. Stando Francesco dopo queste cose sdegnato e non ben risoluto di quello che fare volesse, afflitto dell'animo, malsano del corpo et indebolito da continuo medicarsi, si amalò finalmente del male della morte, che in poco tempo il condusse all'estremo, senza avergli dato tempo di potere disporre delle sue cose interamente. A un suo creato chiamato Annibale, figliuolo di Nanni di Baccio Bigio, lasciò scudi sessanta l'anno in sul Monte delle Farine, quattordici quadri e tutti i disegni et altre cose dell'arte; il resto delle sue cose lasciò a suor Gabriella sua sorella monaca, ancor che io intenda che ella non ebbe, come si dice, del sacco le corde; tuttavia le dovette venire in mano un quadro dipinto sopra tela d'argento con un ricamo intorno, il quale aveva fatto per lo Re di Portogallo o di Polonia, che e' si fusse, e lo lasciò a lei, acciò il tenesse per memoria di lui. Tutte l'altre cose, cioè gl'ufficii che aveva dopo intolerabili fatiche comperati, tutti si perderono.
Morì Francesco il giorno di San Martino a' dì 11 di novembre l'anno 1563, e fu sepolto in San Ieronimo, chiesa vicina alla casa dove abitava. Fu la morte di Francesco di grandissimo danno e perdita all'arte, perché se bene aveva cinquantaquattro anni et era malsano, ad ogni modo continuamente studiava e lavorava, et in questo ultimo s'era dato a lavorare di musaico, e si vede che era capriccioso et avrebbe voluto far molte cose, e s'egli avesse trovato un principe che avesse conosciuto il suo umore e datogli da far lavori secondo il suo capriccio, avrebbe fatto cose maravigliose, perché era, come abbiam detto, ricco, abondante e copiosissimo nell'invenzione di tutte le cose et universale in tutte le parti della pittura. Dava alle sue teste, di tutte le maniere, bellissima grazia, e possedeva gli ignudi bene quanto altro pittore de' tempi suoi; ebbe nel fare de' panni una molto graziata e gentile maniera, acconciandogli in modo che si vedeva sempre nelle parti dove sta bene l'ignudo et abbigliando sempre con nuovi modi di vestiri le sue figure; fu capriccioso e vario nell'acconciature de' capi, ne' calzari et in ogni altra sorte d'ornamenti. Maneggiava i colori a olio, a tempera et a fresco in modo che si può affermare lui essere stato uno de' più valenti, spediti, fieri e solleciti artefici della nostra età; e noi, che l'abbiamo praticato tanti anni, ne possiamo fare rettamente testimonianza. Et ancora che fra noi sia stata sempre per lo desiderio che hanno i buoni artefici di passare l'un l'altro qualche onesta emulazione, non però mai, quanto all'interesse dell'amicizia appartiene, è mancato fra noi l'affezzione e l'amore, se bene dico ciascuno di noi a concorrenza l'un dell'altro ha lavorato ne' più famosi luoghi d'Italia, come si può vedere in un infinito di numero di lettere, che appresso di me sono, come ho detto, di mano di Francesco. Era il Salviati amorevole di natura, ma sospettoso, facile a credere ogni cosa, acuto, sottile e penetrativo, e quando si metteva a ragionare d'alcuni delle nostre arti, o per burla o da dovero, offendeva alquanto e talvolta toccava insino in sul vivo. Piacevagli il praticare con persone letterate e con grand'uomini, et ebbe sempre in odio gl'artefici plebei, ancor che fussino sempre in alcuna cosa virtuosi; fuggiva certi che sempre dicono male, e quando si veniva a ragionamento di loro gli lacerava senza rispetto; ma sopra tutto gli dispiacevano le giunterie che fanno alcuna volta gl'artefici, delle quali, essendo stato in Francia et uditone alcune, sapeva troppo bene ragionare. Usava alcuna volta (per meno essere offeso dalla malinconia) trovarsi con gl'amici e far forza di star allegro. Ma finalmente quella sua sì fatta natura irresoluta, sospettosa e soletaria non fece danno se non a lui. Fu suo grandissimo amico Manno fiorentino orefice in Roma, uomo raro nel suo esercizio et ottimo per costumi e bontà, e perché egli è carico di famiglia, se Francesco avesse potuto disporre del suo e non avesse spese tutte le sue fatiche in ufficii per lasciargli al Papa, ne arebbe fatto gran parte a questo uomo da bene et artefice eccellente. Fu parimente suo amicissimo il sopradetto Aveduto dell'Aveduto Vaiaio, il quale fu a Francesco il più amorevole et il più fedele di quanti altri amici avesse mai; e se fusse costui stato in Roma quando Francesco morì, si sarebbe forse in alcune cose con migliore consiglio governato che non fece. Fu suo creato ancora Roviale spagnuolo, che fece molte opere seco, e da sé nella chiesa di Santo Spirito di Roma una tavola, dentrovi la conversione di San Paolo. Volle anco gran bene il Salviati a Francesco di Girolamo dal Prato, in compagnia del quale, come si è detto di sopra, essendo anco fanciullo, attese al disegno. Il quale Francesco fu di bellissimo ingegno e disegnò meglio che altro orefice de' suoi tempi, e non fu inferiore a Girolamo suo padre, il quale di piastra d'argento lavorò meglio qualunche cosa, che altro qual si volesse suo pari. E secondo che dicono, veniva a costui fatto agevolmente ogni cosa, perciò che battuta la piastra d'argento con alcuni stozzi e quella messo sopra un pezzo d'asse e sotto cera, sego e pece, faceva una materia fra il duro et il tenero, la quale spignendo con ferri in dentro et in fuori, gli faceva riuscire quello che voleva: teste, petti, braccia, gambe, schiene e qualunche altra cosa voleva o gli era addimandata da chi faceva far voti, per appendergli a quelle sante imagini che in alcun luogo, dove avessero avuto grazie o fussero stati esauditi, si ritrovavano. Questo Francesco dunque, non attendendo solamente a fare boti, come faceva il padre, lavorò anco di tausia et a commettere nell'acciaio oro et argento alla damaschina, facendo fogliami, lavori, figure e qualunche altra cosa voleva. Della qual sorte di lavoro fece un'armadura intera e bellissima da fonte a piè al duca Alessandro de' Medici, e fra molte altre medaglie che fece il medesimo, quelle furo-no di sua mano e molto belle che con la testa del detto duca Alessandro furono poste ne' fondamenti della fortezza della porta a Faenza, insieme con altre, nelle quali era da un lato la testa di papa Clemente Settimo e dall'altro un Cristo ignudo, con i flagelli della sua Passione. Si dilettò anco Francesco dal Prato delle cose di scultura e gittò alcune figurette di bronzo, le quali ebbe il duca Alessandro, che furono graziosissime; il medesimo rinettò, e condusse a molta perfezione, quattro figure simili fatte da Baccio Bandinelli, cioè una Leda, una Venere et un Ercole et un Apollo, che furono date al medesimo Duca.
Dispiacendo adunque a Francesco l'arte dell'orefice e non potendo attendere alla scultura, che ha bisogno di troppe cose, si diede, avendo buon disegno, alla pittura; e perché era persona che praticava poco, né si curava che si sapesse più che tanto che egli attendesse alla pittura, lavorò da sé molte cose. Intanto, come si disse da principio, venendo Francesco Salviati a Firenze, lavorò nelle stanze che costui teneva nell'Opera di Santa Maria del Fiore, il quadro di Messer Alamanno; onde con questa occasione vedendo costui il modo di fare del Salviati, si diede con molto più studio, che insino allora fatto non aveva, alla pittura; e condusse in un quadro molto bello una conversione di San Paolo, la quale oggi è appresso Guglielmo del Tovaglia. E dopo in un quadro della medesima grandezza, dipinse le serpi che piovono addosso al popolo ebreo; in un altro fece Gesù Cristo che cava i Santi Padri del limbo, i quali ultimi due, che sono bellissimi, ha oggi Filippo Spini, gentiluomo che molto si diletta delle nostre arti. Et oltre a molte altre cose piccole che fece Francesco dal Prato, disegnò assai, e bene, come si può vedere in alcuni di sua mano che sono nel nostro libro de' disegni. Morì costui l'anno 1562 e dolse molto a tutta l'accademia, perché oltre all'esser valentuomo nell'arte, non fu mai il più da bene uomo di lui.
Fu allievo di Francesco Salviati Giuseppo Porta da Castel Nuovo della Garfagnana, che fu chiamato anch'egli per rispetto del suo maestro, Giuseppo Salviati. Costui giovanetto, l'anno 1535 essendo stato condotto in Roma da un suo zio, segretario di monsignor Onofrio Bartolini arcivescovo di Pisa, fu acconcio col Salviati, appresso al quale imparò in poco tempo, non pure a disegnare benissimo, ma ancora a colorire ottimamente. Andato poi col suo maestro a Vinezia, vi prese tante pratiche di gentiluomini, che essendovi da lui lasciato fece conto di volere che quella città fusse sua patria, e così presovi moglie, vi si è stato sempre et ha lavorato in pochi altri luoghi che a Vinezia. In sul campo di S. Stefano dipinse già la facciata della casa de' Loredani di storie colorite a fresco molto vagamente, e fatte con bella maniera; dipinse similmente a San Polo quella de' Bernardi, et un'altra dietro a San Rocco, che è opera bonissima. Tre altre facciate di chiaro scuro ha fatto molto grandi, piene di varie storie: una a San Moisè, la seconda a San Cassiano e la terza a Santa Maria Zebenigo. Ha dipinto similmente a fresco in un luogo detto Treville, appresso Trevisi, tutto il palazzo de' Priuli, fabrica ricca e grandissima, dentro e fuori, della quale fabrica si parlerà a luogo nella vita del Sansovino. A Pieve di Sacco ha fatto una facciata molto bella et a Bagnuolo, luogo de' frati di Santo Spirito di Vinezia, ha dipinto una tavola a olio, et ai medesimi padri ha fatto nel convento di Santo Spirito il palco, o vero soffittato del loro refettorio, con uno spartimento pieno di quadri dipinti, e nella testa principale un bellissimo cenacolo. Nel palazzo di San Marco ha dipinto nella sala del doge le sibille, i profeti, le virtù cardinali e Cristo con le Marie, che gli sono state infinitamente lodate. E nella già detta libraria di San Marco, fece due storie grandi, a concorrenza degli altri pittori di Vinezia, de' quali si è ragionato di sopra. Essendo chiamato a Roma dal cardinale Emulio, dopo la morte di Francesco, finì una delle maggiori storie che sieno nella detta sala dei re, e ne cominciò un'altra, e dopo essendo morto papa Pio Quarto, se ne tornò a Venezia, dove gli ha dato la Signoria a dipignere in palazzo un palco pieno di quadri a olio, il quale è a sommo delle scale nuove. Il medesimo ha dipinto sei molto belle tavole a olio: una in San Francesco della Vigna, all'al-tare della Madonna; la seconda nella chiesa de' Servi all'altar maggiore; la terza ne' fra' minori; la quarta nella Madonna dell'Orto; la quinta a San Zacaria e la sesta a San Moisè, e due n'ha fatto a Murano, che sono belle e fatte con molta diligenza e bella maniera.
Di questa Giuseppe, il quale ancor vive e si fa eccellentissimo, non dico altro per ora, se non che, oltre alla pittura, attende con molto studio alla geometria, e di sua mano è la voluta del capitel ionico che oggi mostra in stampa come si deve girare secondo la misura antica; e tosto doverà venire in luce un'opra che ha composto delle cose di geometria. Fu anche discepolo di Francesco un Domenico Romano, che gli fu di grande aiuto nella sala che fece in Fiorenza, et in altre opere, et il quale sté l'anno 1550 col signor Giuliano Cesarino e non lavora da sé solo.
FINE DELLA VITA DI FRANCESCO SALVIATI, PITTORE FIORENTINO
VITA DI DANIELLO RICCIARELLI DA VOLTERRA
PITTORE E SCULTORE

Avendo Daniello quando era giovanetto imparato alquanto a disegnare da Giovanni Antonio Soddoma, il quale andò a fare in quel tempo alcuni lavori in quella città, partito che si fu, fece esso Daniello molto migliore e maggiore acquisto sotto Baldassarre Peruzzi che sotto la disciplina di esso Soddoma fatto non aveva. Ma per vero dire, con tutto ciò, non fece per allora gran riuscita, e questo perciò che quanto metteva fatica e studio, spinto da una gran voglia in cercando d'apparare, altre tanto all'incontro il serviva poco l'ingegno e la mano. Onde nelle sue prime opere che fece in Volterra si conosce una grandissima, anzi infinita fatica, ma non già principio di bella e gran maniera, né vaghezza, né grazia, né invenzione, come si è veduto a buon'ora in molti altri che sono nati per essere dipintori, i quali hanno mostro anco ne' primi principii, facilità, fierezza e saggio di qualche buona maniera. Anzi le prime cose di costui mostrano essere state fatte veramente da un malinconico, essendo piene di stento e condotte con molta pazienza e lunghezza di tempo.
Ma venendo alle sue opere, per lasciar quelle delle quali non è da far conto, fece nella sua giovanezza in Volterra a fresco la facciata di Messer Mario Maffei, di chiaro scuro, che gli diede buon nome e gli acquistò molto credito. La quale, poi che ebbe finita, vedendo non aver quivi concorrenza che lo spignesse a cercare di salire a miglior grada e non essere in quella città opere, né antiche, né moderne, dalle quali potesse molto imparare, si risolvette di andare per ogni modo a Roma, dove intendeva che allora non erano molti che attendessero alla pittura, da Perino del Vaga in fuori. Ma prima che partisse, andò pensando di voler portare alcun'opera finita che lo facesse conoscere, e così, avendo fatto in una tela un Cristo a olio battuto alla colonna con molte figure, e messovi in farlo tutta quella diligenza che è possibile, servendosi di modelli e ritratti dal vivo, lo portò seco. E giunto in Roma, non vi fu stato molto, che per mezzo d'amici mostrò al cardinale Triulzi quella pittura, la quale in modo gli sodisfece, che non pure la comperò, ma pose grandissima affezzione a Daniello, mandandolo poco appresso a lavorare dove avea fatto fuor di Roma a un suo casale detto Salone un grandissimo casamento, il quale faceva adornare di fontane, stucchi e pitture e dove apunto allora lavoravano Gianmaria da Milano et altri alcune stanze di stucchi e grottesche. Qui dunque giunto Daniello, sì per la concorrenza e sì per servire quel signore, dal quale poteva molto onore et utile sperare, dipinse in compagnia di coloro diverse cose in molte stanze e logge, e particolarmente vi fece molte grottesche piene di varie feminette, ma sopra tutto riuscì molto bella una storia di Fetonte fatta a fresco di figure grandi quanto il naturale et un fiume grandissimo che vi fece, il quale è una molto buona figura. Le quali tutte opere, andando spesso il detto cardinale a vedere e menando seco or uno or altro cardinale, furono cagione che Daniello facesse con molti di loro servitù et amicizia. Dopo, avendo Perino del Vaga, il qua-le allora faceva alla Trinità la capella di Messer Agnolo de' Massimi, bisogno d'un giovane che gl'aiutasse, Daniello, che disiderava di acquistare, tirato dalle promesse di colui, andò a star seco e gl'aiutò fare nell'opera di quella capella alcune cose, le quali condusse con molta diligenza a fine.
Avendo fatto Perino inanzi al Sacco di Roma, come s'è detto, alla capella del Crucifisso di San Marcello, nella volta la creazione di Adamo et Eva grandi quanto il vivo, e molto maggiori due Evangelisti, cioè San Giovanni e San Marco, et anco non finiti del tutto perché la figura del San Giovanni mancava dal mezzo in su, gl'uomini di quella Compagnia si risolverono, quando poi furono quietate le cose di Roma, che il medesimo Perino finisse quell'opera. Ma avendo altro che fare, fattone i cartoni la fece finire a Daniello, il quale finì il San Giovanni lasciato imperfetto; fece del tutto gl'altri due Evangelisti, San Luca e San Matteo, nel mezzo due putti che tengono un candelieri, e nell'arco della faccia che mette in mezzo la finestra due Angeli, che volando e stando sospesi in su l'ale, tengono in mano misterii della Passione di Gesù Cristo; e l'arco adornò riccamente di grottesche e molte belle figurine ignude, et insomma si portò in tutta que-sta opera bene oltre modo, ancor che vi mettesse assai tempo.
Dopo, avendo il medesimo Perino dato a fare a Daniello un fregio nella sala del palazzo di Messer Agnolo Massimi con molti partimenti di stucco et altri ornamenti e storie de' fatti di Fabio Massimo, si portò tanto bene che veggendo quell'opera la signora Elena Orsina et udendo molto lodare la virtù di Daniello, gli diede a fare una sua capella nella chiesa della Trinità di Roma, in su 'l monte dove stanno i frati di San Francesco di Paula, onde Daniello mettendo ogni sforzo e diligenza per fare un'opera rara la quale il facesse conoscere per eccellente pittore, non si curò mettervi le fatiche di molti anni. Dal nome dunque di quella signora, dandosi alla capella il titolo della croce di Cristo Nostro Salvatore, si tolse il suggetto de' fatti di S. Elena. E così nella tavola principale, facendo Daniello Gesù Cristo che è deposto di croce da Gioseffo e Nicodemo et altri Discepoli, lo svenimento di Maria Vergine sostenuta sopra le braccia da Madalena et altre Marie, mostrò grandissimo giudizio e di esser raro uomo, perciò che, oltre al componimento delle figure che è molto ricco, il Cristo è ottima figura et un bellissimo scorto, venendo coi piedi inanzi e col resto in dietro. Sono similmente belli e difficili scorti e figure quelli di coloro che avendolo sconfitto, lo reggono con le fascie stando sopra certe scale e mostrando in alcune parti l'ignudo fatto con molta grazia. Intorno poi a questa tavola fece un bellissimo e vario ornamento di stucchi pieno d'intagli, e con due figure che sostengono con la testa il frontone, mentre con una mano tengono il capitello e con l'altra cercano mettere la colonna che lo regga, la quale è posta da piè in sulla basa sotto il capitello, la quale opera è fatta con incredibile diligenza.
Nell'arco sopra la tavola dipinse a fresco due sibille, che sono le migliori figure di tutta quell'opera, le quali sibille mettono in mezzo la finestra che è sopra il mezzo di detta tavola e dà lume a tutta la capella, la cui volta è divisa in quattro parti con bizzarro, vario e bello spartimento di stucchi e grottesche, fatte con nuove fantasie di maschere e festoni, dentro ai quali sono quattro storie della Croce e di Santa Elena madre di Gostantino. Nella prima è quando avanti la Passione del Salvatore sono fabricate tre croci; nella seconda quando Santa Elena comanda ad alcuni Ebrei che le insegnino le dette croci; nella terza quando, non volendo essi insegnarle, ella fa mettere in un pozzo colui che le sapeva, e nella quarta quando colui insegna il luogo dove tutte e tre erano sotterrate; le quali quattro storie sono belle oltre ogni credenza e condotte con molto studio. Nelle facce dalle bande sono altre quattro storie, cioè due per faccia, e ciascuna è divisa dalla cornice che fa l'imposta dell'arco sopra cui posa la crocera della volta di detta capella: in una è Santa Elena che fa cavare d'un pozzo la Croce santa e l'altre due, e nella seconda quando quella del Salvatore sana un infermo. Ne' quadri di sotto a man ritta, la detta Santa quella di Cristo riconosce nel risuscitare un morto sopra cui è posta, nell'ignu-do del quale morto mise Daniello incredibile studio per ritrovare i muscoli e rettamente tutte le parti dell'uomo. Il che fece ancora in coloro che gli mettono addosso la croce e nei circonstanti che stanno tutti stupidi a veder quel miracolo; et oltre ciò è fatto con molta diligenza un bizzarro cataletto con una ossatura di morto che l'abbraccia, condotto con bella invenzione e molta fatica. Nell'altro quadro, che a questo è dirimpetto, dipinse Eraclio imperadore, il quale scalzo, a piedi et in camicia messe la Croce di Cristo nella porta di Roma, dove sono femine, uomini e putti ginocchioni che l'a-dorano, molti suoi baroni et uno staffiere che gli tiene il cavallo. Sotto per basamento sono per ciascuna due femine di chiaro scuro e fatte di marmo, molto belle, le quali mostrano di reggere dette storie, e sotto l'arco primo della parte dinanzi fece nel piano per lo ritto due figure grandi quanto il vivo: un San Francesco di Paula, capo di quell'ordine che uffizia la detta chiesa, et un San Ieronimo vestito da cardinale, che sono due bonissime figure, sì come anche sono quelle di tutta l'opera, la quale condusse Daniello in sette anni e con fatiche e studio inestimabile. Ma perché le pitture che son fatte per questa via hanno sempre del duro e del difficile, manca quest'opera d'una certa leggiadra facilità che suole molto dilettare. Onde Daniello stesso, confessando la fatica che aveva durata in quest'opera e temendo di quello che gl'avenne e di non essere biasimato, fece per suo capriccio e quasi per sua defensione sotto i piedi di detti due Santi due storiette di stucco di basso rilievo, nelle quali volle mostrare che essendo suoi amici Michelagnolo Buonarroti e fra' Bastiano del Piombo (l'opere de' quali andava imitando, et osservando i precetti), se bene faceva adagio e con istento, nondimeno il suo imitare quei due uomini poteva bastare a difenderlo dai morsi degl'invidiosi e maligni, la mala natura de' quali è forza, ancor che loro non paia, che si scuopra.
In una, dico, di queste storiette fece molte figure di satiri, che a una stadera pesano gambe, braccia et altre membra di figure, per ridurre al netto quelle che sono a giusto peso e stanno bene e per dare le cattive a Michelagnolo e fra' Bastiano che le vanno conferendo; nell'altra è Michelagnolo che si guarda in uno specchio, di che il significato è chiarissimo. Fece similmente in due angoli dell'arco dalla banda di fuori due ignudi di chiaro scuro, che sono della medesima bontà che sono l'altre figure di quell'opera; la quale scoperta che fu dopo sì lungo tempo, fu molto lodata e tenuta lavo-ro bellissimo e difficile et il suo maestro eccellentissimo. Dopo questa capella gli fece, Alessandro cardinale Farnese in una stanza del suo palazzo, cioè in sul cantone, sotto uno di que' palchi ricchissimi fatti con ordine di maestro Antonio da San Gallo, a tre cameroni che sono in fila, fare un fregio di pittura bellissimo con una storia di figure per ogni faccia, che furono un trionfo di Bacco bellissimo, una caccia et altre simili che molto sodisfecero a quel cardinale, il quale, oltre ciò, gli fece fare in più luoghi di quel fregio un liocorno in diversi modi in grembo a una vergine, che è l'impresa di quella illustrissima famiglia. La quale opera fu cagione che quel signore, il quale è sempre stato amatore di tutti gl'uo-mini rari e virtuosi, lo favorisse sempre; e più arebbe fatto se Daniello non fusse stato così lungo nel suo operare. Ma di questo non aveva colpa Daniello poiché sì fatta era la sua natura et ingegno, et egli più tosto si contentava di fare poco e bene, che assai e non così bene. Adunque, oltre all'affezione che gli portava il cardinale, lo favorì di maniera il signor Annibale Caro appresso i suoi signori Farnesi, che sempre l'aiutarono. Et a madama Margarita d'Austria, figliuola di Carlo Quinto, nel palazzo de' Medici a Navona, dello scrittoio del quale si è favellato nella vita dell'Indaco, in otto vani dipinse otto storiette de' fatti et opere illustri di detto Carlo Quinto imperatore con tanta diligenza e bontà, che per simile cosa non si può quasi fare meglio.
Essendo poi l'anno 1547 morto Perino del Vaga et avendo lasciata imperfetta la sala dei re, che, come si è detto, è nel palazzo del papa dinanzi alla capella di Sisto et alla Paulina, per mezzo di molti amici e signori e particolarmente di Michelagnolo Buonarroti fu da papa Paolo Terzo messo in suo luogo Daniello, con la medesima provisione che aveva Perino, et ordinatogli che desse principio agl'ornamenti delle facciate che s'avevano a fare di stucchi con molti ignudi tutti tondi sopra certi frontoni. E perché quella sala rompeno sei porte grandi di mischio, tre per banda, et una sola facciata rimane intera, fece Daniello sopra ogni porta quasi un tabernacolo di stucco bellissimo, in ciascuno de' quali disegnava fare di pittura uno di quei re che hanno difesa la chiesa apostolica, e seguitare nelle facciate istorie di que' re che con tributi o vittorie hanno beneficato la chiesa, onde in tutto venivano a essere sei storie e sei nicchie. Dopo le quali nicchie, o vero tabernacoli, fece Daniello con l'aiuto di molti tutto l'altro ornamento ricchissimo di stucchi che in quella sala si vede, studiando in un medesimo tempo i cartoni di quello che aveva disegnato far in quel luogo di pittura. Il che fatto, diede principio a una delle storie, ma non ne dipinse più che due braccia in circa e due di que' re ne' tabernacoli di stucco sopra le porte, perché, ancor che fusse sollecitato dal cardinale Farnese e dal Papa, senza pensare che la morte suole spesse volte guastare molti disegni, mandò l'opera tanto in lungo, che quando sopravenne la morte del Papa, l'an-no 1549, non era fatto se non quello che è detto; per che, avendosi a fare nella sala che era piena di palchi e legnami il conclave, fu necessario gettare ogni cosa per terra e scoprire l'opera. La quale essendo veduta da ognuno, l'opere di stucco furono, sì come meritavano, infinitamente lodate, ma non già tanto i due re di pittura, perciò che pareva che in bontà non corrispondesseno all'opera della Trinità e che egli avesse, con tanta commodità e stipendii onorati, più tosto dato a dietro che acquistato. Essendo poi creato pontefice l'anno 1550 Giulio Terzo, si fece inanzi Daniello con amici e con favori per avere la medesima provisione e seguitare l'opera di quella sala, ma il Papa, non vi avendo volto l'animo, diede sempre passata, anzi mandato per Giorgio Vasari, che aveva seco avuto servitù insino quando esso pontefice era arcivescovo Sipontino, si serviva di lui in tutte le cose del disegno. Ma nondimeno avendo Sua Santità deliberato fare una fontana in testa al corridore di Belvedere e non piacendogli un disegno di Michelagnolo, nel quale era un Moisè che percotendo la pietra ne faceva uscire acqua, per esser cosa che non potea condursi se non con lunghezza di tempo, volendolo Michelagnolo far di marmo, ma il consiglio di Giorgio, il quale fu che la Cleopatra figura divina e stata fatta da' Greci si accommodasse in quel luogo, ne fu dato, per mezzo del Buonarroto, cura a Daniello, con ordine che in detto luogo facesse di stucchi una grotta dentro la quale fusse la detta Cleopatra collocata. Daniello dunque, avendovi messo mano, ancor che fusse molto sollecitato lavorò con tanta lentezza in quell'opera, finì la stanza sola di stucchi e di pitture, ma molte altre cose che 'l Papa voleva fare vedendo andare più allungo che non pensava, che uscitone la voglia al Papa non fu altrimenti finita, ma si rimase in quel modo che oggi si vede ogni cosa.
Fece Daniello nella chiesa di Santo Agostino a fresco in una capella in figure grandi quanto il naturale una Santa Elena che fa ritrovare la Croce, e dalle bande in due nicchie Santa Cecilia e Santa Lucia, la quale opera fu parte colorita da lui e parte, con suoi disegni, dai giovani che stavano con esso lui; onde non riuscì di quella perfezzione che l'altre opere sue. In questo medesimo tempo dalla signora Lucrezia della Rovere gli fu allogata una capella nella Trinità, dirimpetto a quella della signora Elena Orsina, nella quale, fatto uno spartimento di stucchi, fece con suoi cartoni dipignere di storie della Vergine la volta da Marco da Siena e da Pellegrino da Bologna. Et in una delle facciate fece fare a Bizzera spagnuolo la natività di essa Vergine e nell'altra, da Giovan Paulo Rossetti da Volterra suo creato, Gesù Cristo presentato a Simeone; et al medesimo fece fare in due storie, che sono negl'archi di sopra, Gabriello che annunzia essa Vergine e la Natività di Cristo; di fuori negl'angoli fece due figuroni e sotto ne' pilastri due Profeti; nella facciata del-l'altare dipinse Daniello di sua mano la Nostra Donna che saglie i gradi del tempio, e nella principale la medesima Vergine che sopra molti bellissimi Angeli in forma di putti saglie in cielo et i dodici Apostoli a basso che stanno a vederla salire. E perché il luogo non era capace di tante figure et egli desiderava di fare in ciò nuova invenzione, finse che l'al-tare di quella capella fusse il sepolcro et intorno misse gl'Apostoli, facendo loro posare i piedi in sul piano della capella dove comincia l'altare, il quale modo di fare ad alcuni è piaciuto et ad altri, che sono la maggior e miglior parte, non punto. Ma con tutto che penasse Daniello quatordeci anni a condurre quest'opera, non è però punto migliore della prima. Nell'altra facciata che restò a finirsi di questa capella, nella quale andava l'uccisione de' fanciulli innocenti, fece lavorare il tutto, avendone fatto i cartoni, a Michele Alberti fiorentino, suo creato.
Avendo monsignor Messer Giovanni della Casa fiorentino et uomo dottissimo (come le sue leggiadrissime e dotte opere, così latine come volgari, ne dimostrano) cominciato a scrivere un trattato delle cose di pittura, e volendo chiarirsi d'alcune minuzie e particolari dagl'uomini della professione, fece fare a Daniello con tutta quella diligenza che fu possibile il modello d'un Davit di terra finito, e dopo gli fece dipignere, o vero ritrarre, in un quadro il medesimo Davit che è bellissimo, da tutte due le bande, cioè il dinanzi et il di dietro, che fu cosa capricciosa, il quale quadro è oggi appresso Messer Annibale Rucellai. Al medesimo Messer Giovanni fece un Cristo morto con le Marie, et in una tela per mandare in Francia Enea che spogliandosi per andare a dormire con Dido è sopragiunto da Mercurio, che mostra di parlargli nella maniera che si legge ne' versi di Vergilio. Al medesimo fece in un altro quadro, pure a olio, un bellissimo San Giovanni in penitenza grande quanto il naturale che da quel signore, mentre visse, fu tenuto carissimo, e parimente un San Girolamo bello a maraviglia. Morto papa Giulio Terzo e creato sommo pontefice Paulo Quarto, il cardinale di Carpi cercò che fusse da Sua Santità data a finire a Daniello la detta sala dei re, ma non si dilettando quel papa di pitture, rispose essere molto meglio fortificare Roma che spendere in dipignere, e così avendo fatto mettere mano al portone di Castello, secondo il disegno di Salustio, figliuolo di Baldassarre Peruzzi sanese, suo architetto, fu ordinato che in quell'opera, la quale si conduceva tutta di trevertino a uso d'arco trionfale magnifico e sontuoso, si ponessero nelle nicchie cinque statue di braccia quattro e mezzo l'una; per che, essendo ad altri state allogate l'altre, a Daniello fu dato a fare un Angelo Michele. Avendo intanto monsignor Giovanni Riccio cardinale di Monte Pulciano deliberato di fare una capella in San Pietro a Montorio, dirimpetto a quella che aveva papa Giulio fatta fare con ordine di Giorgio Vasari, et allogata la tavola, le storie in fresco e le statue di marmo che vi andavano a Daniello, esso Daniello, già resoluto al tutto di volere abandonare la pittura e darsi alla scultura, se n'andò a Carrara a far cavare i marmi, così del San Michele come delle statue aveva da fare per la capella di Montorio, mediante la quale occasione, venendo a vedere Firenze e l'opere che il Vasari faceva in palazzo al duca Cosimo e l'altre di quella città, gli furono fatte da infiniti amici suoi molte carezze e particolarmente da esso Vasari, al quale l'aveva per sue lettere raccommandato il Buonarroti.
Dimorando adunque Daniello in Firenze e veggendo quanto il signor Duca si dilettasse di tutte l'arti del disegno, venne in disiderio d'accommodarsi al servigio di sua eccellenza illustrissima; per che, avendo adoperato molti mezzi et avendo il signor Duca a coloro che lo raccomandavano risposto che fusse introdotto dal Vasari, così fu fatto. Onde Daniello offerendosi a servire sua eccellenza amorevolmente, ella gli rispose che molto volentieri l'accettava e che, sodisfatto che egli avesse agl'oblighi ch'aveva in Roma, venisse a sua posta che sarebbe veduto ben volentieri. Stette Daniello tutta quella state in Firenze, dove l'accommodò Giorgio in una casa di Simon Botti suo amicissimo; là dove in detto tempo formò di gesso quasi tutte le figure di marmo che di mano di Michelagnolo sono nella sagrestia nuova di San Lorenzo, e fece per Michele Fuchero fiamingo una Leda che fu molto bella figura. Dopo, andato a Carrara e di là mandati marmi che voleva alla volta di Roma, tornò di nuovo a Fiorenza per questa cagione. Avendo Daniello menato in sua compagnia, quando a principio venne da Roma a Fiorenza, un suo giovane chiamato Orazio Pianetti, virtuoso e molto gentile, qualunche di ciò si fusse la cagione, non fu sì tosto arrivato a Fiorenza, che si morì. Di che sentendo infinita noia e dispiacere Daniello, come quegli che molto, per le sue virtù, amava il giovane, e non potendo altrimenti verso di lui il suo buono animo mostrare, tornato quest'ultima volta a Fiorenza, fece la testa di lui di marmo dal petto in su, ritraendola ottimamente da una formata in sul morto, e quella finita la pose con uno epitaffio nella chiesa di San Michele Berteldi in sulla piazza degl'Antinori. Nel che si mostrò Daniello, con questo veramente amorevole uffizio, uomo di rara bontà et altrimenti amico agl'amici di quello che oggi si costuma communemente, pochissimi ritrovandosi che nel-l'amicizia altra cosa amino che l'utile e commodo proprio.
Dopo queste cose, essendo gran tempo che non era stato a Volterra sua patria, vi andò prima che ritornasse a Roma e vi fu molto carezzato dagl'amici e parenti suoi; et essendo pregato di lasciare alcuna memoria di sé nella patria, fece in un quadrotto di figure piccole la storia degl'innocenti, che fu tenuta molto bell'opera, e la pose nella chiesa di San Piero; dopo, pensando di non mai più dovervi ritornare, vendé quel poco che vi aveva di patrimonio a Lionardo Ricciarelli suo nipote, il quale essendo con esso lui stato a Roma et avendo molto bene imparato a lavorare di stucco, servì poi tre anni Giorgio Vasari in compagnia di molti altri nell'opere che allora si fecero nel palazzo del Duca.
Tornato finalmente Daniello a Roma, avendo papa Paolo Quarto volontà di gettare in terra il Giudizio di Michelagnolo per gli ignudi che li pareva che mostrasseno la parti vergognose troppo disonestamente, fu detto da cardinali et uomini di giudizio che sarebbe gran peccato guastarle e trovoron modo che Daniello facesse lor certi panni sottili che le coprissi, che tal cosa finì poi sotto Pio Quarto con rifar la Santa Caterina et il San Biagio, parendo che non istesseno con onestà. Cominciò le statue in quel mentre per la capella del detto cardinale di Monte Pulciano et il San Michele del Portone, ma nondimeno non lavorava con quella prestezza che arebbe potuto e dovuto, come lui che se n'andava di pensiero in pensiero. Intanto, dopo essere stato morto il re Arrigo di Francia in giostra, venendo il signor Ruberto Strozzi in Italia et a Roma, Caterina de' Medici reina, essendo rimasa reggente in quel regno, per fare al detto suo morto marito alcuna onorata memoria, commise che il detto Ruberto fusse col Buonarroto e facesse che in ciò il suo disiderio avesse compimento; onde, giunto egli a Roma, parlò di ciò lungamente con Michelagnolo, il quale non potendo, per essere vecchio, tòrre sopra di sé quell'impresa, consigliò il signor Ruberto a darla a Daniello, al quale egli non mancarebbe né d'aiuto né di consiglio in tutto quello potesse. Della quale offerta facendo gran conto lo Strozzi, poi che si fu maturamente considerato quello fusse da farsi, fu risoluto che Daniello facesse un cavallo di bronzo tutto d'un pezzo, alto palmi venti dalla testa insino a' piedi e lungo quaranta incirca, e che sopra quello poi si ponesse la statua di esso re Arrigo armato e similmente di bronzo. Avendo dunque fatto Daniello un modelletto di terra secondo il consiglio e giudizio di Michelagnolo, il quale molto piacque al signor Ruberto, fu scritto il tutto in Francia et in ultimo convenuto fra lui e Daniello del modo di condurre quell'opera, del tempo, del prezzo e d'ogni altra cosa; per che, messa Daniello mano al cavallo con molto studio, lo fece di terra, senza fare mai altro, come aveva da essere interamente. Poi, fatta la forma, si andava apparecchiando a gettarlo, e da molti fonditori, in opera di tanta importanza, pigliava parere d'intorno al modo che dovesse tenere perché venisse ben fatta, quando Pio Quarto, dopo la morte di Paolo stato creato pontefice, fece intendere a Daniello volere - come si è detto nella vita del Salviati - che si finisse l'opera della sala de' re e che perciò si lasciasse indietro ogni altra cosa; al che rispondendo Daniello, disse essere occupatissimo et ubligato alla reina di Francia, ma che farebbe i cartoni e la farebbe tirare inanzi a' suoi giovani, e che oltre ciò farebbe anch'egli la parte sua. La quale risposta non piacendo al Papa, andò pensando di allogare il tutto al Salviati, onde Daniello, ingelosito, fece tanto col mezzo del cardinale di Carpi e di Michelagnolo, che a lui fu data a dipignere la metà di detta sala e l'altra metà, come abbiamo detto, al Salviati, nonostante che Daniello facesse ogni possibile opera d'averla tutta, per andarsi tranquillando senza concorrenza, a suo commodo. Ma in ultimo la cosa di questo lavoro fu guidata in modo, che Daniello non vi fece cosa niuna più di quello che già avesse fatto molto inanzi, et il Salviati non finì quel poco che aveva cominciato, anzi gli fu anco quel poco dalla malignità d'alcuni gettato per terra.
Finalmente Daniello dopo quattro anni (quanto a lui apparteneva) arebbe gettato il già detto cavallo, ma gli bisognò indugiare molti mesi, più di quello che arebbe fatto, mancandogli le provisioni che doveva fare di ferramenti, metallo et altre materie il signor Ruberto; le quali tutte cose essendo finalmente state provedute, sotterrò Daniello la forma, che era una gran machina, fra due fornaci da fondere in una stanza molto a proposito che aveva a Monte Cavallo, e fonduta la materia, dando nelle spine il metallo, per un pezzo andò assai bene, ma in ultimo sfondando il peso del metallo la forma del cavallo, nel corpo tutta la materia prese altra via, il che travagliò molto da principio l'animo di Daniello, ma nondimeno, considerato il tutto, trovò la via da rimediare a tanto inconveniente. E così, in capo a due mesi gettandolo la seconda volta, prevalse la sua virtù agl'impedimenti della fortuna, onde condusse il getto di quel cavallo (che è un sesto,
o più, maggiore che quello d'Antonino che è in Campidoglio) tutto unito e sottile ugualmente per tutto. Et è gran cosa che sì grand'opera non pesa se non venti migliaia. Ma furono tanti i disagi e le fatiche che vi spese Daniello, il quale, anzi che non, era di poca complessione e malinconico, che non molto dopo sopragiunse un catarro crudele che lo condusse molto male, anzi dove arebbe dovuto Daniello star lieto, avendo in così raro getto superato infinite difficultà, non parve che mai poi, per cosa che prospera gl'avenisse, si rallegrasse. E non passò molto che il detto catarro in due giorni gli tolse la vita a dì quattro d'aprile 1566; ma inanzi avendosi preveduta la morte si confessò molto divotamente e volle tutti i sacramenti della chiesa, e poi, facendo testamento, lasciò che il suo corpo fusse sepellito nella nuova chiesa stata principiata alle Terme da Pio Quarto ai monaci certosini, ordinando che in quel luogo et alla sua sepoltura fusse posta la statua di quell'Angelo che aveva già cominciata per lo portone di Castello. E di tutto diede cura (facendogli in ciò essecutori del suo testamento) a Michele degl'Alberti fiorentino et a Feliciano da San Vito di quel di Roma, lasciando per ciò loro dugento scudi. La quale ultima volontà essequirono ambidue con amore e diligenza, dandogli in detto luogo, secondo che da lui fu ordinato, onorata sepoltura. Ai medesimi lasciò tutte le sue cose appartenenti all'arte, forme di gesso, modelli, disegni e tutte altre masserizie e cose da lavorare, onde si offersono all'ambasciadore di Francia di dare finita del tutto fra certo tempo l'opera del cavallo e la figura del re che vi andava sopra, e nel vero essendosi ambidue esercitati molti anni sotto la disciplina e studio di Daniello, si può da loro sperare ogni gran cosa.
È stato creato similmente di Daniello Biagio da Carigliano pistolese e Giovampaulo Rossetti da Volterra, che è persona molto diligente e di bellissimo ingegno, il quale Giovampaulo, essendosi già molti anni sono ritirato a Volterra, ha fatto e fa opere degne di molta lode. Lavorò parimente con Daniello e fece molto frutto Marco da Siena, il quale condottosi a Napoli si è presa quella città per patria e vi sta e lavora continuamente; è stato similmente creato di Daniello Giulio Mazzoni da Piacenza, che ebbe i suoi primi principii dal Vasari quando in Fiorenza lavorava una tavola per Messer Biagio Mei che fu mandata a Lucca e posta in San Piero Cigoli, e quando in Monte Oliveto di Napoli faceva esso Giorgio la tavola dell'altare maggiore, una grande opera nel reffettorio e la sagrestia di San Giovanni carbonaro, i portegli dell'organo del piscopio con altre tavole et opere. Costui avendo poi da Daniello imparato a lavorare di stucchi, paragonando in ciò il suo maestro, ha ornato di sua mano tutto il didentro del palazzo del cardinale Capo di Ferro e fattovi opere maravigliose, non pure di stucchi, ma di storie a fresco et a olio, che gli hanno dato e meritamente infinita lode. Ha il medesimo fatta di marmo e ritratta dal naturale la testa di Francesco del Nero tanto bene, che non credo sia possibile far meglio, onde si può sperare che abbia a fare ottima riuscita e venire in queste nostre arti a quella perfezione che si può maggiore e migliore.
È stato Daniello persona costumata e da bene e di maniera intento ai suoi studii dell'arte, che nel rimanente del viver suo non ha avuto molto governo et è stato persona malinconica e molto solitaria. Morì Daniello di 57 anni in circa. Il suo ritratto s'è chiesto a quei suoi creati che l'aveano fatto di gesso, e quando fui a Roma l'anno passato me l'avevano promesso. Né per imbasciate o lettere che io abbia loro scritto non l'han voluto dare, mostrando poca amorevolezza al lor morto maestro; però non ho voluto guardare a questa loro ingratitudine, essendo stato Daniello amico mio, che si è messo questo che ancora che li somigli poco, faccia la scusa della diligenza mia e della poca cura et amorevolezza di Michele degli Alberti e di Feliciano da San Vito.
FINE DELLA VITA DI DANIELLO DA VOLTERRA, PITTORE E SCULTORE
VITA DI TADDEO ZUCCHERO
PITTORE DA SANT'AGNOLO IN VADO

Esendo duca d'Urbino Francesco Maria, nacque nella terra di Santo Agnolo in Vado, luogo di quello stato, l'anno 1529 a dì primo di settembre ad Ottaviano Zucchero pittore un figliuol maschio, al quale pose nome Taddeo, il qual putto avendo di dieci anni imparato a leggere e scrivere ragionevolmente, se lo tirò il padre appresso e gl'insegnò alquanto a disegnare. Ma veggendo Ottaviano quello suo figliuolo aver bellissimo ingegno e potere divenire altr'uomo nella pittura, che a lui non pareva essere, lo mise a stare con Pompeo da Fano, suo amicissimo e pittore ordinario; l'ope-re del quale non piacendo a Taddeo e parimente i costumi, se ne tornò a Sant'Agnolo, quivi et altrove aiutando al padre quanto poteva e sapeva. Finalmente, essendo cresciuto Taddeo d'anni e di giudizio, veduto non potere molto acquistare sotto la disciplina del padre, carico di sette figliuoli maschi et una femina, et anco non essergli col suo poco sapere d'aiuto più che tanto, tutto solo se n'andò di quattordici anni a Roma, dove a principio, non essendo conosciuto da niuno e niuno conoscendo, patì qualche disagio. E se pure alcuno vi conosceva, vi fu da loro peggio trattato che dagl'altri, per che accostatosi a Francesco cognominato di Sant'Agnolo, il quale lavorava di grottesche con Perino del Vaga a giornate, se gli raccomandò con ogni umiltà, pregandolo che volesse, come parente che gl'era, aiutarlo; ma non gli venne fatto, perciò che Francesco, come molte volte fanno certi parenti, non pure non l'aiutò, né di fatti, né di parole, ma lo riprese e ributtò agramente. Ma non per tanto non si perdendo d'animo, il povero giovinetto senza sgomentarsi si andò molti mesi trattenendo per Roma, o per meglio dire stentando, con macinare colori ora in questa et ora in quell'altra bottega, per piccol prezzo, e talora, come poteva il meglio, alcuna cosa disegnando. E se bene in ultimo si acconciò per garzone con un Giovampiero calavrese, non vi fece molto frutto, perciò che colui, insieme con una sua moglie, fastidiosa donna, non pure lo facevano macinare colori giorni e notte, ma lo facevano non ch'altro patire del pane; del quale acciò non potesse anco avere a bastanza, né a sua posta, lo tenevano in un paniere appiccato al palco con certi campanelli, che ogni poco che il paniere fosse tocco, sonavano e facevano la spia. Ma questo arebbe dato poca noia a Taddeo, se avesse avuto commodo di potere disegnare alcune carte, che quel suo maestraccio aveva di mano di Raffaello da Urbino.
Per queste e molt'altre stranezze, partitosi Taddeo da Giovampiero, si risolvette a stare da per sé et andarsi riparando per le botteghe di Roma, dove già era conosciuto, una parte della settimana spendendo in lavorare a opere per vivere, et un'altra in disegnando e particularmente l'opere di mano di Raffaello, che erano in casa d'Agostino Chigi et in altri luoghi di Roma. E perché molte volte, sopragiugnendo la sera, non aveva dove in altra parte ritirarsi, si riparò molte notti sotto le logge del detto Chigi et in altri luoghi simili, i quali disagi gli guastorno in parte la complessione, e se non l'a-vesse la giovinezza aiutato, l'arebbono ucciso del tutto. Con tutto ciò amalandosi e non essendo da Francesco Sant'A-gnolo suo parente più aiutato di quello che fosse stato altra volta, se ne tornò a Sant'Agnolo a casa il padre, per non finire la vita in tanta miseria quanta quella era in che si trovava. Ma per non perdere oggimai più tempo in cose che non importano più che tanto, e bastando avere mostrato con quanta difficultà e disagi acquistasse, dico che Taddeo finalmente guarito e tornato a Roma, si rimesse a' suoi soliti studii (ma con aversi più cura, che per l'adietro fatto non ave-va), e sotto un Iacopone imparò tanto, che venne in qualche credito, onde il detto Francesco suo parente, che così empiamente si era portato verso lui, veggendolo fatto valent'uomo, per servirsi di lui si rapatumò seco e cominciarono a lavorare insieme, essendosi Taddeo, che era di buona natura, tutte l'ingiurie dimenticato. E così facendo Taddeo i disegni et ambidui lavorando molti fregi di camere e logge a fresco, si andavano giovando l'uno all'altro. Intanto Daniello da Parma pittore, il quale già stette molti anni con Antonio da Coreggio, et avea avuto pratica con Francesco Mazzuoli parmigiano, avendo preso a fare a Vitto di là di Sore nel principio dell'Abruzzo una chiesa a fresco per la capella di Santa Maria, prese in suo aiuto Taddeo conducendolo a Vitto. Nel che fare, se bene Daniello non era il migliore pittore del mondo, aveva nondimeno per l'età e per avere veduto il modo di fare del Coreggio e del Parmigiano, e con che morbidezza conducevano le loro opere, tanta pratica, che mostrandola a Taddeo et insegnandogli, gli fu di grandissimo giovamento con le parole, non altrimenti che un altro arebbe fatto con l'operare. Fece Taddeo in quest'opera, che aveva la volta a croce, i quattro Evangelisti, due Sibille, duoi Profeti e quattro storie non molto grandi di Iesù Cristo e della Vergine sua madre.
Ritornato poi a Roma, ragionando Messer Iacopo Mattei gentiluomo romano con Francesco Sant'Agnolo di volere fare dipignere di chiaro scuro la facciata d'una sua casa, gli mise inanzi Taddeo, ma perché pareva troppo giovane a quel gentiluomo, gli disse Francesco che ne facesse prova in due storie, e che quelle non riuscendo, si sarebbono potute gettare per terra, e riuscendo arebbe seguitato. Avendo dunque Taddeo messo mano all'opera, riuscirno sì fatte le due prime storie, che ne restò Messer Iacopo non pure sodisfatto, ma stupido; onde avendo finita quell'opera l'anno 1548, fu sommamente da tutta Roma lodata e con molta ragione. Perciò che dopo Pulidoro, Maturino, Vincenzo da San Gimignano e Baldassarre da Siena, niuno era in simili opere arrivato a quel segno che aveva fatto Taddeo, giovane allora di diciotto anni; l'istorie della quale opera si possono comprendere da queste inscrizzioni, che sono sotto ciascuna de' fatti di Furio Camillo; la prima dunque è questa: TUSCULANI, PACE CONSTANTI, VIM ROMANAM ARCENT; la seconda; M[ARCUS] F[URIUS) C[AMILLUS] SIGNIFERUM SECUM IN HOSTEM RAPIT; la terza: M[ARCO] F[URIO] C[AMILLO] AUCTORE INCENSA URBS RESTITUITUR; la quarta: M[ARCUS] F[URIUS) C[AMILLUS] PACTIONIBUS TURBATIS PRAELIUM GALLIS NUNCIAT; la quinta: M[ARCUS] F[URIUS] C[AMILLUS) PRODITOREM VINCTUM FALERIO REDUCENDUM TRADIT; la sesta: MATRONALIS AURI COLLATIONE, VOTUM APOLLINI SOLVITUR; la settima: M[ARCUS] F[URIUS] C[AMILLUS] IUNONI REGINAE TEMPLUM IN AVENTINO DEDICAT; l'ottava: SIGNUM IUNONIS REGINAE A VEIIS ROMAM TRANSFERTUR; la nona: M[ARC...] F[URI...] C[AMILL...] ... [M]ANLIUS DICT[ATOR] DECEM ... SOS ... CIOS CAPIT.
Dal detto tempo insino all'anno 1550, che fu creato papa Giulio Terzo, si andò trattenendo Taddeo in opera di non molta importanza, ma però con ragionevole guadagno; il quale anno 1550, essendo il Giubileo, Ottaviano padre di Taddeo, la madre et un altro loro figliuolo andorno a Roma a pigliare il santissimo Giubileo et in parte vedere il figliolo. Là dove stati che furno alcune settimane con Taddeo, nel partirsi gli lasciarono il detto putto che avevano menato con esso loro, chiamato Federigo, acciò lo facesse attendere alle lettere: ma giudicandolo Taddeo più atto alla pittura, come si è veduto essere poi stato vero, ne l'eccellente riuscita che esso Federigo ha fatto, lo cominciò, imparato che ebbe le prime lettere, a fare attendere al disegno con miglior fortuna et appoggio che non aveva avuto egli. Fece intanto Taddeo nella chiesa di Santo Ambrogio de' Milanesi, nella facciata de l'altare maggiore, quattro storie de' fatti di quel Santo, non molto grandi e colorite a fresco, con un fregio di puttini e femine a uso di termini, che fu assai bell'opera, e, questa finita, allato a Santa Lucia della Tinta, vicino all'Orso, fece una facciata piena di storie di Alessandro Magno, cominciando dal suo nascimento e seguitando in cinque storie i fatti più notabili di quell'uomo famoso, che gli fu molto lodata, ancor che questa avesse il paragone a canto d'un'altra facciata di mano di Pulidoro.
In questo tempo, avendo Guido Baldo duca d'Urbino udita la fama di questo giovane suo vasallo e desiderando dar fine alle facciate della capella del Duomo d'Urbino, dove Batista Franco, come s'è detto, aveva a fresco dipinta la volta, fece chiamare Taddeo a Urbino; il quale, lasciando in Roma chi avesse cura di Federigo e lo facesse attendere a imparare, e parimente d'un altro suo fratello, il quale pose con alcuni amici suoi all'orefice, se n'andò ad Urbino, dove gli furono da quel Duca fatte molte carezze e poi datogli ordine di quanto avesse a disegnare per conto della capella et altre cose. Ma in quel mentre, avendo quel Duca come generale de' signori viniziani a ire a Verona et a vedere l'altre fortificazioni di quel dominio, menò seco Taddeo, il quale gli ritrasse il quadro di mano di Raffaello, che è, come in altro luogo s'è detto, in casa de' signori conti da Canossa; dopo cominciò, pur per sua eccellenza, una telona grande, dentrovi la conversione di San Pavolo, la quale è ancora così imperfetta a Sant'Agnolo appresso Ottaviano suo padre. Ritornato poi in Urbino andò per un pezzo seguitando i disegni della detta capella, che furono de' fatti di Nostra Donna, come si può vedere in una parte di quelli, che è appresso Federigo suo fratello, disegnati di penna e chiaro scuro; ma o venisse che 'l Duca non fosse resoluto e gli paresse Taddeo troppo giovane, o da altra cagione, si stette Taddeo con esso lui due anni, senza fare altro che alcune pitture in uno studiolo a Pesaro et un'arme grande a fresco nella facciata del palazzo et il ritratto di quel Duca in un quadro grande quanto il vivo, che tutte furono bell'opere.
Finalmente, avendo il Duca a partire per Roma per andare a ricevere il bastone, come generale di santa Chiesa, da papa Giulio Terzo, lasciò a Taddeo che seguitasse la detta capella e che fosse di tutto quello, che per ciò bisognava, proveduto. Ma i ministri del Duca, facendogli come i più di simili uomini fanno, cioè stentare ogni cosa, furono cagione che Taddeo, dopo avere perduto duoi anni di tempo, se n'andò a Roma, dove truovato il Duca si scusò destramente, senza dar biasimo a nessuno, promettendo che non mancherebbe di fare quando fosse tempo. L'anno poi 1551, avendo Stefano Veltroni dal Monte Sansavino ordine dal Papa e dal Vasari di fare adornare di grottesche le stanze della vigna, che fu del cardinale Poggio, fuori della porta del Popolo in sul monte, chiamò Taddeo, e nel quadro del mezzo gli fece dipignere una Occasione, che avendo presa la Fortuna, mostra di volerle tagliare il crine con le forbice, impresa di quel Papa, nel che Taddeo si portò molto bene. Dopo avendo il Vasari fatto sotto il palazzo nuovo, primo di tutti gl'altri, il disegno del cortile e della fonte, che poi fu seguitata dal Vignola e dall'Amannato e murata da Baronino, nel dipignervi molte cose Prospero Fontana, come di sotto si dirà, si servì assai di Taddeo in molte cose, che gli furono occasione di maggiore bene; perciò che, piacendo a quel Papa il suo modo di fare, gli fece dipignere in alcune stanze sopra il corridore di Belvedere alcune figurette colorite, che servirono per fregii di quelle camere, et in una loggia scoperta, dietro quelle che voltavano verso Roma, fece nella facciata di chiaro scuro e grandi quanto il vivo tutte le fatiche di Ercole, che furono al tempo di papa Pavolo Quarto rovinate, per farvi altre stanze e murarvi una capella. Alla vigna di papa Giulio, nelle prime camere del palazzo, fece di colori nel mezzo della volta alcune storie, e particularmente il monte Parnaso, e nel cortile del medesimo fece due storie di chiaro scuro de' fatti delle Sabine, che mettono in mezzo la porta di mischio principale, che entra nella loggia, dove si scende alla fonte de l'acqua vergine, le quali opere furono lodate e commendate molto. E perché Federigo, mentre Taddeo era a Roma col Duca, era tornato a Urbino e quivi et a Pesaro statosi poi sempre, lo fece Taddeo dopo le dette opere tornare a Roma per servirsene in fare un fregio grande in una sala et altri in altre stanze della casa di Giambecari sopra la piazza di Sant'Apostolo, et in altri fregi che fece dalla guglia di San Mauro nelle case di Messer Antonio Portatore, tutti pieni di figure, et altre cose, che furono tenute bellissime.
Avendo compro Mattiuolo, maestro delle poste al tempo di papa Giulio, un sito in campo Marzio e murato un casotto molto commodo, diede a dipignere a Taddeo la facciata di chiaro scuro, il qual Taddeo vi fece tre storie di Mercurio messaggero degli dii, che furono molto belle, et il restante fece dipignere ad altri con disegni di sua mano. Intanto, a-vendo Messer Iacopo Mattei fatta murare nella chiesa della Consolazione sotto il Campidoglio una capella, la diede, sapendo già quanto valesse, a dipignere a Taddeo, il quale la prese a fare volentieri e per piccol prezzo per mostrare ad alcuni, che andavano dicendo che non sapeva se non fare facciate et altri lavori di chiaro scuro, che sapeva anco fare di colori. A quest'opera dunque avendo Taddeo messo mano, non vi lavorava se non quando si sentiva in capriccio e vena di far bene, spendendo l'altro tempo in opere che non gli premevano quanto questa per conto dell'onore, e così con suo commodo la condusse in quattro anni. Nella volta fece a fresco quattro storie della Passione di Cristo di non molta grandezza con bellissimi capricci e tanto bene condotte, per invenzione, disegno e colorito, che vinse se stesso; le quali storie sono la cena con gl'Apostoli, la lavazione d'i piedi, l'orare nell'orto e quando è preso e baciato da Giuda. In una delle facciate dalle bande fece, in figure grandi quanto il vivo, Cristo battuto alla colonna, e nell'altra Pilato che lo mostra flagellato ai giudei, dicendo “Ecce homo”; e sopra questa in un arco è il medesimo Pilato che si lava le mani, e nel-l'altro arco dirimpetto Cristo menato dinanzi ad Anna. Nella faccia dell'altare fece il medesimo quando è crucifisso e le Marie a' piedi con la Nostra Donna tramortita, messa in mezzo dalle bande da due Profeti, e nell'arco sopra l'ornamento di stucco fece due Sibille, le quali quattro figure trattano della Passione di Cristo, e nella volta sono quattro mezze figure intorno a certi ornamenti di stucco, figurate per i quattro Evangelisti, che sono molto belle. Quest'opera, la quale fu scoperta l'anno 1556, non avendo Taddeo più che ventisei anni, fu et è tenuta singolare et egli allora giudicato dagl'arte-fici eccellente pittore.
Questa finita gl'allogò Messer Mario Frangipane nella chiesa di San Marcello una sua capella, nella quale si servì Taddeo, come fece anco in molti altri lavori, de' giovani forestieri, che sono sempre in Roma e vanno lavorando a giornate per imparare e guadagnare, ma nondimeno per allora non la condusse del tutto. Dipinse il medesimo al tempo di Paolo Quarto in palazzo del Papa alcune stanze a fresco, dove stava il cardinale Caraffa, nel torrone sopra la guardia de' Lanzi, et a olio in alcuni quadrotti la Natività di Cristo, la Vergine e Giuseppo quando fuggono in Egitto, i quali duoi furono mandati in Portogallo dall'ambasciatore di quel re. Volendo il cardinal di Mantoa fare dipignere dentro tutto il suo palazzo a canto all'arco di Portogallo con prestezza grandissima, allogò quell'opera a Taddeo per convenevole prezzo; il qual Taddeo cominciando con buon numero d'uomini, in brieve lo condusse a fine, mostrando avere grandissimo giudizio in sapere accommodare tanti diversi cervelli in opera sì grande e conoscere le maniere differenti per sì fatto modo, che l'opera mostri essere tutta d'una stessa mano; insomma sodisfece in questo lavoro Taddeo con suo molto utile al detto cardinale et a chiunche la vide, ingannando l'opinione di coloro che non potevano credere che egli avesse a riuscire in viluppo di sì grand'opera.
Parimente dipinse dalle Botteghe Scure per Messer Alessandro Mattei, in certi sfondati delle stanze del suo palazzo, alcune storie di figure a fresco, et alcun'altre ne fece condurre a Federigo suo fratello, acciò si accommodasse al lavorare, il quale Federigo, avendo preso animo, condusse poi da sé un monte di Parnaso sotto le scale d'Araceli in casa d'un gentiluomo chiamato Stefano Margani romano, nello sfondato d'una volta. Onde Taddeo, veggendo il detto Federigo assicurato e fare da sé con i suoi proprii disegni, senza essere più che tanto da niuno aiutato, gli fece allogare dagli uomini di Santa Maria dell'Orto a Ripa in Roma (mostrando quasi di volerla fare egli) una capella, perciò che a Federigo solo, essendo anco giovinetto, non sarebbe stata data già mai. Taddeo dunque, per sodisfare a quegl'uomini, vi fece la Natività di Cristo et il resto poi condusse tutto Federigo, portandosi di maniera, che si vide principio di quella eccellenza che oggi è in lui manifesta. Né medesimi tempi, al duca di Guisa che era allora in Roma, disiderando egli di condurre un pittore pratico e valent'uomo a dipignere un suo palazzo in Francia, fu mezzo per le mani Taddeo; onde, vedute delle opere sue e piaciutagli la maniera, convenne di dargli l'anno di provisione seicento scudi, e che Taddeo, finita l'o-pera che aveva fra mano, dovesse andare in Francia a servirlo. E così arebbe fatto Taddeo, essendo i danari per mettersi a ordine stati lasciati in un banco, se non fossero allora seguite le guerre che furono in Francia e poco appresso la morte di quel Duca.
Tornato dunque Taddeo a fornire in San Marcello l'opera del Frangipane, non poté lavorare molto a lungo senza essere impedito, perciò che, essendo morto Carlo Quinto imperatore, e dandosi ordine di fargli onoratissime esequie in Roma, come a imperatore de' romani, furono allogate a Taddeo, che il tutto condusse in venticinque giorni, molte storie de' fatti di detto imperatore e molti trofei et altri ornamenti, che furono da lui fatti di carta pesta molto magnifici et onorati; onde gli furono pagati per le sue fatiche, e di Federigo et altri che gli avevano aiutato, scudi secento d'oro. Poco dopo dipinse in Bracciano, al signor Paolo Giordano Orsini, due cameroni bellissimi et ornati di stucchi et oro riccamente, cioè in uno le storie d'Amore e di Psiche e nell'altro, che prima era stato da altri comminciato, fece alcune storie di Alessandro Magno, et altre che gli restarono a fare, continuando i fatti del medesimo, fece condurre a Federigo suo fratello, che si portò benissimo. Dipinse poi a Messer Stefano del Bufalo, al suo giardino dalla fontana di Trievi, in fresco le Muse d'intorno al fonte Castalio et il monte di Parnaso, che fu tenuta bell'opera.
Avendo gl'Operai della Madonna d'Orvieto, come s'è detto nella vita di Simone Mosca, fatto fare nelle navate della chiesa alcune capelle con ornamenti di marmi e stucchi, e fatto fare alcune tavole a Girolamo Mosciano da Brescia, per mezzo d'amici, udita la fama di lui, condussero Taddeo, che menò seco Federigo, a Orvieto; dove, messo mano a lavorare, condusse nella faccia d'una di dette capelle due figurone grandi, una per la Vita Attiva e l'altra per la Contemplativa, che furono tirate via con una pratica molto sicura, nella maniera che faceva le cose, che molto non studiava. E mentre che Taddeo lavorava queste, dipinse Federigo nella nicchia della medesima capella tre storiette di San Paolo; alla fine delle quali, essendo amalati amendue, si partirono, promettendo di tornare al settembre; e Taddeo se ne tornò a Roma, e Federigo a Sant'Agnolo con un poco di febbre, la quale passatagli, in capo a due mesi tornò anch'egli a Roma. Dove la settimana santa vegnente, nella Compagnia di Santa Agata de' fiorentini, che è dietro a Banchi, dipinsero ambidue in quattro giorni per un ricco apparato, che fu fatto per lo giovedì e venerdì santo, di storie di chiaro scuro, tutta la Passione di Cristo nella volta e nicchia di quello oratorio, con alcuni Profeti et altre pitture, che feciono stupire chiunche le vide.
Avendo poi Alessandro cardinale Farnese condotto a buon termine il suo palazzo di Caprarola con architettura del Vignola, di cui si parlerà poco appresso, lo diede a dipignere tutto a Taddeo, con queste condizioni, che non volendosi Taddeo privare degl'altri suoi lavori di Roma, fusse obligato a fare tutti i disegni, cartoni, ordini e partimenti dell'opere, che in quel luogo si avevano a fare, di pitture e di stucchi, che gli uomini i quali avevano a mettere in opera fussono a volontà di Taddeo, ma pagati dal cardinale, che Taddeo fosse obligato a lavorarvi egli stesso due o tre mesi dell'anno, et ad andarvi quante volte bisognava a vedere come le cose passavano e ritoccare quelle che non istessono a suo modo. Per le quali tutte fatiche gli ordinò il cardinale dugento scudi l'anno di provisione; per lo che Taddeo avendo così onorato trattenimento e l'appoggio di tanto signore, si risolvé a posare l'animo et a non volere più pigliare per Roma, come insino allora aveva fatto, ogni basso lavoro, e massimamente per fuggire il biasimo che gli davano molti dell'arte, dicendo che con certa sua avara rapacità pigliava ogni lavoro per guadagnare con le braccia d'altri quello ch'a molti sarebbe stato onesto trattenimento da potere studiare, come aveva fatto egli nella sua prima giovanezza. Dal quale biasimo si difendeva Taddeo con dire che lo faceva per rispetto di Federigo e di quell'altro suo fratello, che aveva alle spalle e voleva che con l'aiuto suo imparasseno.
Risolutosi dunque a servire Farnese et a finire la capella di San Marcello, fece dare da Messer Tizio da Spoleti, maestro di casa del detto cardinale, a dipignere a Federigo la facciata d'una sua casa, che aveva in sulla piazza della Dogana, vicina a Santo Eustachio, al quale Federigo fu ciò carissimo, perciò che non aveva mai altra cosa tanto desiderato quanto d'avere alcun lavoro sopra di sé. Fece dunque di colori in una facciata la storia di Santo Eustachio quando si battezza insieme con la moglie e con i figliuoli, che fu molto buon'opera, e nella facciata di mezzo fece il medesimo Santo, che cacciando vede fra le corna d'un cervio Iesù Cristo crucifisso. Ma perché Federigo quando fece quest'opera non aveva più che ventotto anni, Taddeo, che pure considerava quell'opera essere in luogo publico e che importava molto all'onore di Federigo, non solo andava alcuna volta a vederlo lavorare, ma anco talora voleva alcuna cosa ritoccare e racconciare. Per che Federigo, avendo un pezzo avuto pacienza, finalmente traportato una volta dalla collera, come quegli che arebbe voluto fare da sé, prese la martellina e gittò in terra non so che, che aveva fatto Taddeo, e per isdegno stette alcuni giorni che non tornò a casa. La qual cosa intendendo gl'amici dell'uno e dell'altro, fecciono tanto, che si rapattumarono con questo, che Taddeo potesse correggere e mettere mano nei disegni e cartoni di Federigo a suo piacimento, ma non mai nell'opere che facesse, o a fresco, o a olio, o in altro modo. Avendo dunque finita Federigo l'opera di detta casa, ella gli fu universalmente lodata e gl'acquistò nome di valente pittore.
Essendo poi ordinato a Taddeo che rifacesse nella sala de' palafrenieri quegl'Apostoli, che già vi aveva fatto di terretta Raffaello, e da Paolo Quarto erano stati gettati per terra, Taddeo fattone uno, fece condurre tutti gli altri da Federigo suo fratello, che si portò molto bene; e dopo feciono insieme nel palazzo di Araceli un fregio colorito a fresco in una di quelle sale. Trattandosi poi, quasi nel medesimo tempo che lavoravano costoro in Araceli, di dare al signor Federigo Borromeo per donna la signora donna Verginia, figliola del duca Guido Baldo d'Urbino, fu mandato Taddeo a ritrarla, il che fece ottimamente, et avanti che partisse da Urbino fece tutti i disegni d'una credenza, che quel Duca fece poi fare di terra in Castel Durante per mandare al re Filippo di Spagna. Tornato Taddeo a Roma, presentò al Papa il ritratto, che piacque assai, ma fu tanta la cortesia di quel Pontefice o de' suoi ministri, che al povero pittore non furono, non che altro, rifatte le spese. L'anno 1560, aspettando il Papa in Roma il signor duca Cosimo e la signora duchessa Leonora sua consorte, et avendo disegnato d'alloggiare loro eccellenze nelle stanze che già Innocenzio Ottavo fabricò, le quali respondono sul primo cortile del palazzo et in quello di San Piero e che hanno dalla parte dinanzi logge che rispondono sopra la piazza dove si dà la benedizione, fu dato carico a Taddeo di fare le pitture et alcuni fregi che v'andavano, e di mettere d'oro i palchi nuovi, che si erano fatti in luogo de' vecchi consumati dal tempo. Nella qual opera, che certo fu grande e d'importanza, si portò molto bene Federigo, al quale diede quasi cura del tutto Taddeo suo fratello, ma con suo gran pericolo perciò che, dipignendo grottesche nelle dette logge, cascando d'uno ponte che posava sul principale fu per capitare male. Né passò molto, ch'il cardinale Emulio, a cui aveva di ciò dato cura il Papa, diede a dipignere a molti giovani (acciò fosse finito tostamente) il palazzetto, che è nel bosco di Belvedere, cominciato al tempo di papa Paolo Quarto con bellissima fontana et ornamenti di molte statue antiche, secondo l'architettura e disegno di Pirro Ligorio. I giovani dunque, che in detto luogo con loro molto onore lavorarono, furono Federigo Bassocci da Urbino, giovane di grande aspettazione, Lionardo Cungii e Durante del Nero, ambidue dal Borgo Sansepolcro, i quali condussono le stanze del primo piano. A sommo la scala, fatta a lumaca, dipinse la prima stanza Santi Zidi, pittore fiorentino, che si portò molto bene e la maggior, ch'è a canto a questa, dipinse il sopra detto Federigo Zucchero, fratello di Taddeo, e di là da questa, condusse un'altra stanza Giovanni dal Carso Schiavone, assai buon maestro di grottesche. Ma ancor che ciascuno dei sopra detti si portasse benissimo, nondimeno superò tutti gli altri Federigo in alcune storie che vi fece di Cristo, come la Transfigurazione, le nozze di Cana Galilea et il centurione inginocchiato. E di due, che ne mancavano, una ne fece Orazio Sammacchini, pittore bolognese, e l'altra un Lorenzo Costa mantovano; il medesimo Federigo Zucchero dipinse in questo luogo la loggetta, che guarda sopra il vivaio, e dopo fece un fregio in Belvedere nella sala principale, a cui si saglie per la lumaca, con istorie di Moisè e Faraone, belle a fatto. Della qual opera ne diede, non ha molto, esso Federigo il disegno fatto e colorito di sua mano in una bellissima carta al reverendo don Vincenzio Borghini, che lo tiene carissimo e come disegno di mano d'eccellente pittore. E nel medesimo luogo dipinse il medesimo l'Angelo che amazza in Egitto i primigeniti, facendosi, per fare più presto, aiutare a molti suoi giovani. Ma nello stimarsi da alcuni le dette opere, non furono le fatiche di Federigo e degl'altri riconosciute come dovevano, per essere in alcuni artefici nostri, in Roma, a Fiorenza e per tutto, molti maligni che, accecati dalle passioni e dall'invidie, non conoscono o non vogliono conoscere l'altrui opere lodevoli et il difetto delle proprie. E questi tali sono molte volte cagione ch'i begl'ingegni de' giovani, sbigottiti, si raffreddano negli studii e nell'operare.
Nell'offizio della Ruota dipinse Federigo, dopo le dette opere, intorno a un'arme di papa Pio Quarto, due figure maggior del vivo, cioè la Giustizia e l'Equità, che furono molto lodate, dando in quel mentre tempo a Taddeo di attendere all'opera di Caprarola et alla capella di San Marcello. Intanto Sua Santità, volendo finire ad ogni modo la sala de' re, dopo molte contenzioni state fra Daniello et il Salviati, come s'è detto, ordinò al vescovo di Furlì quanto intorno a ciò voleva che facesse, onde egli scrisse al Vasari a dì tre di settembre l'anno 1561, che volendo il Papa finire l'opera della sala de' re, gl'aveva commesso che si trovassero uomini, i quali ne cavassero una volta le mani, e che perciò, mosso dall'antica amicizia e d'altre cagioni, lo pregava a voler andare a Roma per fare quell'opera, con bona grazia e licenzia del Duca suo signore; perciò che con suo molto onore et utile ne farebbe piacere a Sua Beatitudine, e che acciò quanto prima rispondesse. Alla quale lettera rispondendo, il Vasari disse che, trovandosi stare molto bene al servizio del Duca et essere delle sue fatiche rimunerato altrimenti che non era stato fatto a Roma da altri pontefici, voleva continuare nel servigio di sua eccellenza per cui aveva da mettere allora mano a molto maggior sala che quella de' re non era, e che a Roma non mancavano uomini di chi servirsi in quell'opera. Avuta il detto vescovo dal Vasari questa risposta, e con Sua Santità conferito il tutto, dal cardinale Emulio, che novamente aveva avuto cura dal Pontefice di far finire quella sala, fu compartita l'opera, come s'è detto, fra molti giovani, che erano parte in Roma e parte furono d'altri luoghi chiamati. A Giuseppe Porta da Castel Nuovo della Carfagnana, creato del Salviati, furono date due [del]le maggiori storie della sala; a Girolamo Siciolante da Sermoneta un'altra delle maggiori et un'altra delle minori; a Orazio Sammacchini bolognese un'altra minore, et a Livo da Furlì una simile; a Giambattista Fiorini bolognese un'altra delle minori. La qual cosa udendo Taddeo e veggendosi escluso, per essere stato detto al detto cardinale Emulio che egli era persona che più attendeva al guadagno che alla gloria e che al bene operare, fece col cardinale Farnese ogni opera per essere anch'e-gli a parte di quel lavoro, ma il cardinale non si volendo in ciò adoperare, gli rispose che gli dovevano bastare l'opere di Caprarola e che non gli pareva dovere che i suoi lavori dovessero essere lasciati indietro per l'emulazioni e gare degli artefici, aggiungendo ancora che quando si fa bene sono l'opere che danno nome ai luoghi, e non i luoghi all'opere. Ma ciò nonostante, fece tanto Taddeo con altri mezzi appresso l'Emulio, che finalmente gli fu dato a fare una delle storie minori sopra una porta, non potendo, né per preghi o altri mezzi, ottenere che gli fusse conceduto una delle maggiori. E nel vero dicono che l'Emulio andava in ciò rattenuto perciò che, sperando che Giuseppo Salviati avesse a passare tutti, era d'animo di dargli il restante e forse gittare in terra quelle che fussero state fatte d'altri. Poi dunque che tutti i sopra detti ebbono condotte le lor opere a buon termine, le volle tutte il Papa vedere; e così fatto scoprire ogni cosa, conobbe (e di questo parere furono tutti i cardinali et i migliori artefici) che Taddeo s'era portato meglio degl'altri, come che tutti si fossero portati ragionevolmente; per il che ordinò Sua Santità al signor Agabrio, che gli facesse dare dal cardinal Emulio a far un'altra storia delle maggiori. Onde gli fu allogata la testa, dove è la porta della capella Paulina, nella qua-le diede principio all'opera, ma non seguitò più oltre, sopravenendo la morte del Papa e scoprendosi ogni cosa per fare il conclave, ancor che molte di quelle storie non avessero avuto il suo fine. Della quale storia, che in detto luogo cominciò Taddeo, ne abbiamo il disegno di sua mano, e da lui statoci mandato, nel detto nostro libro de' disegni.
Fece nel medesimo tempo Taddeo, oltre ad alcune altre cosette, un bellissimo Cristo in un quadro, che doveva essere mandato a Caprarola al cardinal Farnese, il quale è oggi appresso Federigo suo fratello, che dice volerlo per sé mentre che vive. La qual pittura ha il lume d'alcuni Angeli, che piangendo tengono alcune torce. Ma perché dell'opere che Taddeo fece a Caprarola si parlerà a lungo poco appresso nel discorso del Vignuola, che fece quella fabrica, per ora non ne dirò altro.
Federigo intanto, essendo chiamato a Vinezia, convenne col patriarca Grimani di finirgli la capella di San Francesco della Vigna rimasa imperfetta, come s'è detto, per la morte di Battista Franco viniziano. Ma inanzi che cominciasse detta capella adornò al detto patriarca le scale del suo palazzo di Venezia di figurette poste con molta grazia dentro a certi ornamenti di stucco, e dopo condusse a fresco nella detta capella le due storie di Lazzero e la conversione di Madalena. Di che n'è il disegno di mano di Federigo nel detto nostro libro. Appresso nella tavola della medesima capella fece Federigo la storia de' Magi a olio; dopo fece fra Ghioggia e Monselice, alla villa di Messer Gioambatista Pellegrini, dove hanno lavorato molte cose Andrea Schiavone e Lamberto e Gualtieri fiaminghi, alcune pitture in una loggia, che sono molto lodate.
Per la partita dunque di Federigo, seguitò Taddeo di lavorare a fresco tutta quella state nella capella di San Marcello, per la quale fece finalmente nella tavola a olio la conversione di San Paolo; nella quale si vede fatto con bella maniera quel Santo cascato da cavallo, e tutto sbalordito dallo splendore e dalla voce di Gesù Cristo, il quale figurò in una gloria d'Angeli, in atto a punto che pare che dica: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”; sono similmente spaventati e stanno come insensati e stupidi tutti i suoi, che gli stanno d'intorno. Nella volta dipinse a fresco dentro a certi ornamenti di stucco tre storie del medesimo Santo: in una quando, essendo menato prigione a Roma, sbarca nell'isola di Malta, dove si vede che nel far fuoco se gl'aventa una vipera alla mano per morderlo, mentre in diverse maniere stanno alcuni marinari quasi nudi d'intorno alla barca; in un'altra è quando cascando dalla finestra uno giovane, è presentato a San Paolo, che in virtù di Dio lo risuscita; e nella terza è la decollazione e morte di esso Santo. Nelle facce da basso sono, similmente a fresco, due storie grandi: in una San Paolo che guarisce uno stropiato delle gambe, e nell'altra una disputa dove fa rimanere cieco un mago, che l'una e l'altra sono veramente bellissime. Ma quest'opera essendo per la sua morte rimasa imperfetta, l'ha finita Federigo questo anno e si è scoperta con molta sua lode. Fece nel medesimo tempo Taddeo alcuni quadri a olio, che dall'ambasciatore di quel re furono mandati in Francia.
Essendo rimaso imperfetto per la morte del Salviati il salotto del palazzo de' Farnesi, cioè mancando due storie nel-l'entrata, dirimpetto al finestrone, le diede a fare il cardinale Sant'Agnolo Farnese a Taddeo, che le condusse molto bene a fine, ma non però passò Francesco, né anco l'arrivò, nell'opere fatte da lui nella medesima stanza, come alcuni maligni et invidiosi erano andati dicendo per Roma, per diminuire con false calumnie la gloria del Salviati. E se bene Taddeo si difendeva con dire che aveva fatto fare il tutto a' suoi garzoni e che non era in quell'opera di sua mano se non il disegno e poche altre cose, non furono cotali scuse accettate, perciò che non si deve nelle concorrenzie, da chi vuole alcuno superare, mettere in mano il valore della sua virtù e fidarlo a persone deboli, però che si va a perdita manifesta. Conobbe adunque il cardinale Sant'Agnolo, uomo veramente di sommo giudizio in tutte le cose e di somma bontà, quanto aveva perduto nella morte del Salviati; imperò che, se bene era superbo, altiero e di mala natura, era nelle cose della pittura veramente eccellentissimo. Ma tuttavia essendo mancati in Roma i più eccellenti si risolvé quel signore, non ci essendo altri, di dare a dipignere la sala maggiore di quel palazzo a Taddeo, il quale la prese volentieri, con speranza di avere a mostrare con ogni sforzo quanta fusse la virtù e saper suo. Aveva già Lorenzo Pucci fiorentino cardinal Santiquattro fatta fare nella Trinità una capella e dipignere da Perino del Vaga tutta la volta, e fuori certi Profeti, con due putti che tenevano l'arme di quel cardinale. Ma essendo rimasa imperfetta e mancando a dipignersi tre facciate, morto il cardinale, que' padri senza aver rispetto al giusto e ragionevole, venderono all'arcivescovo di Corfù la detta ca-pella, che fu poi data dal detto Arcivescovo a dipignere a Taddeo. Ma quando pure per qualche cagione e rispetto della chiesa fusse stato ben fatto trovar modi di finire la capella, dovevano, almeno in quella parte che era fatta, non consentire che si levasse l'arme del Cardinale per farvi quella del detto Arcivescovo, la quale potevano mettere in altro luogo e non far ingiuria così manifesta alla buona mente di quel Cardinale. Per aversi dunque Taddeo tant'opere alle mani, ogni dì sollecitava Federigo a tornarsene da Venezia, il quale Federigo, dopo aver finita la capella del patriarca, era in pratica di tòrre a dipignere la facciata principale della sala grande del consiglio, dove già dipinse Antonio Viniziano. Ma le gare e le contrarietà che ebbe dai pittori veniziani furno cagione che non l'ebbero né essi con tanti lor favori, né egli parimente.
In quel mentre Taddeo, avendo disiderio di vedere Fiorenza e le molte opere che intendeva avere fatto e fare tuttavia il duca Cosimo et il principio della sala grande che faceva Giorgio Vasari amico suo, mostrando una volta d'an-dare a Caprarola in servizio dell'opera che vi faceva, se ne venne, per un San Giovanni, a Fiorenza, in compagnia di Tiberio Calcagni, giovane scultore et architetto fiorentino, dove oltre la città gli piacquero infinitamente l'opere di tanti scultori e pittori eccellenti, così antichi come moderni; e se non avesse avuto tanti carichi e tante opere alle mani, vi si sarebbe volentieri trattenuto qualche mese. Avendo dunque veduto l'apparecchio del Vasari per la detta sala, cioè quarantaquattro quadri grandi, di braccia quattro, sei, sette e dieci l'uno, nei quali lavorava figure per la maggior parte di sei et otto braccia, e con l'aiuto solo di Giovanni Strada fiamingo et Iacopo Zucchi, suoi creati, e Battista Naldini, e tutto essere stato condotto in meno d'un anno, n'ebbe grandissimo piacere e prese grand'animo; onde, ritornato a Roma, mes-se mano alla detta capella della Trinità, con animo d'avere a vincere se stesso nelle storie che vi andavano di Nostra Donna, come si dirà poco appresso.
Ora Federigo, se bene era sollecitato a tornarsene da Vinezia, non poté non compiacere e non starsi quel carnovale in quella città in compagnia d'Andrea Palladio architetto, il quale avendo fatto alli signori della Compagnia della Calza un mezzo teatro di legname, a uso di colosseo, nel quale si aveva da recitare una tragedia, fece fare nell'apparato a Federigo dodici storie grandi, di sette piedi e mezzo l'una per ogni verso, con altre infinite cose de' fatti d'Ircano, re di Ierusalem, secondo il soggetto della tragedia; nella quale opera acquistò Federigo onore assai per la bontà di quella e prestezza con la quale la condusse. Dopo, andando il Palladio a fondare nel Friuli il palazzo di Civitale, di cui aveva già fatto il modello, Federigo andò con esso lui per vedere quel paese, nel quale disegnò molte cose che gli piacquero. Poi, avendo veduto molte cose in Verona et in molte altre città di Lombardia, se ne venne finalmente a Firenze, quando a punto si facevano ricchissimi apparati e maravigliosi per la venuta della reina Giovanna d'Austria. Dove arrivato, fece, come volle il signore Duca, in una grandissima tela, che copriva la scena in testa della sala, una bellissima e capricciosa caccia di colori et alcune storie di chiaro scuro per un arco, che piacquero infinitamente. Da Firenze andato a Sant'A-gnolo a rivedere gli amici e' parenti, arrivò finalmente in Roma alli sedici del vegnente genaio, ma fu di poco soccorso in quel tempo a Taddeo: perciò che la morte di papa Pio Quarto, e poi quella del cardinal Sant'Agnolo, interroppero l'o-pera della sala de' re e quella del palazzo de' Farnesi, onde Taddeo, che aveva finito un altro appartamento di stanze a Caprarola e quasi condotto a fine la capella di San Marcello, attendeva all'opera della Trinità con molta sua quiete e conduceva il transito di Nostra Donna e gli Apostoli, che sono intorno al cataletto. Et avendo anco in quel mentre preso per Federigo una capella da farsi in fresco nella chiesa de' preti riformati del Gesù, alla guglia di San Mauro, esso Federigo vi mise subitamente mano.
Mostrava Taddeo (fingendosi sdegnato per avere Federigo troppo penato a tornare) non curarsi molto della tornata di lui, ma nel vero l'aveva carissima, come si vide poi per gl'effetti, conciò fusse che gl'era di molta molestia l'avere a provedere la casa (il quale fastidio gli soleva levare Federigo), et il disturbo di quel loro fratello che stava all'orefice; pure, giunto Federigo, ripararono a molti inconvenienti per potere con animo riposato attendere a lavorare. Cercavano in quel mentre gl'amici di Taddeo dargli donna, ma egli, come colui che era avezzo a vivere libero e dubitava di quello che le più volte suole avenire, cioè di non tirarsi in casa, insieme con la moglie, mille noiose cure e fastidii, non si volle mai risolvere; anzi, attendendo alla sua opera della Trinità, andava facendo il cartone della facciata maggiore, nella quale andava il salire di Nostra Donna in cielo, mentre Federigo fece in un quadro San Piero in prigione, per lo signor Duca d'Urbino, et un altro dove è una Nostra Donna in cielo, con alcuni Angeli intorno, che doveva essere mandato a Milano; un altro, che fu mandato a Perugia, un'Occasione.
Avendo il cardinale di Ferrara tenuto molti pittori e maestri di stucco a lavorare a una sua bellissima villa, che ha a Tigoli, vi mandò ultimatamente Federigo a dipignere due stanze, una delle quali è dedicata alla Nobiltà e l'altra alla Gloria, nelle quali si portò Federigo molto bene e vi fece di belle e capricciose invenzioni, e ciò finito se ne tornò a Roma alla sua opera della detta capella conducendola, come ha fatto, a fine; nella quale ha fatto un coro di molti Angeli e variati splendori, con Dio Padre che manda lo Spirito Santo sopra la Madonna, mentre è dall'angelo Gabriello annunziata, e messa in mezzo da sei Profeti maggiori del vivo e molto belli. Taddeo seguitando intanto di fare nella Trinità in fresco l'assunta della Madonna, pareva che fosse spinto dalla natura a far in quell'opera, come ultima, l'estremo di sua possa; e di vero fu l'ultima; perciò che infermato d'un male che a principio parve assai leggeri e cagionato dai gran caldi che quell'anno furono, e poi riuscì gravissimo, si morì del mese di settembre l'anno 1566, avendo prima come buon cristiano ricevuto i Sacramenti della Chiesa e veduto la più parte dei suoi amici, lasciando in suo luogo Federigo suo fratello, ch'anch'egli allora era amalato. E così in poco tempo, essendo stati levati del mondo il Buonarroto, il Salviati, Daniello e Taddeo, hanno fatto grandissima perdita le nostre arti e particolarmente la pittura.
Fu Taddeo molto fiero nelle sue cose et ebbe una maniera assai dolce e pastosa, e tutto lontana da certe crudezze; fu abondante ne' suoi componimenti e fece molto belle le teste, le mani e gl'ignudi, allontanandosi in essi da molte crudezze, nelle quali fuor di modo si affaticano alcuni per parere d'intendere l'arte e la notomia, ai quali aviene molte volte, come avenne a colui che, per volere essere nel favellare troppo ateniese, fu da una donniciola per non ateniese conosciuto. Colorì parimente Taddeo con molta vaghezza et ebbe maniera facile, perché fu molto aiutato dalla natura, ma alcuna volta se ne volle troppo servire. Fu tanto volentoroso d'avere da sé, che durò un pezzo a pigliare ogni lavoro per guadagnare, et insomma fece molte, anzi infinite cose degne di molta lode. Tenne lavoranti assai per condurre l'opere, perciò che non si può fare altrimenti; fu sanguigno, subito e molto sdegnoso, et oltre ciò dato alle cose veneree, ma nondimeno, ancor che a ciò fusse inclinatissimo di natura, fu temperato e seppe fare le sue cose con una certa onesta vergogna e molto segretamente; fu amorevole degli amici e dove potette giovare loro se n'ingegnò sempre. Restò coperta alla morte sua l'opera della Trinità et imperfetta la sala grande del palazzo di Farnese, e così l'opere di Caprarola, ma tutte nondimeno rimasero in mano di Federigo suo fratello, il quale si contentano i padroni dell'opera che dia a quelle fine come farà, e nel vero non sarà Federigo meno erede della virtù di Taddeo che delle facultà. Fu da Federigo data sepoltura a Taddeo nella Ritonda di Roma, vicino al tabernacolo dove è sepolto Raffaello da Urbino del medesimo stato, e certo sta bene l'uno a canto all'altro, perciò che sì come Raffaello d'anni trentasette e nel medesimo dì che era nato morì, cioè il venerdì santo, così Taddeo nacque a dì primo di settembre 1529 e morì alli due dello stesso mese, l'anno 1566. È d'animo Federigo, se gli fia conceduto, restaurare l'altro tabernacolo pure nella Ritonda e fare qualche memoria in quel luogo al suo amorevole fratello, al quale si conosce obligatissimo.
Ora perché di sopra si è fatto menzione di Iacopo Barozzi da Vignuola e detto che secondo l'ordine et architettura di lui ha fatto l'illustrissimo cardinal Farnese il suo ricchissimo e reale villaggio di Caprarola, dico che Iacopo Barozzi da Vignuola, pittore et architetto bolognese, che oggi ha 58 anni, nella sua puerizia e gioventù fu messo all'arte della pittura in Bologna, ma non fece molto frutto, perché non ebbe buono indirizzo da principio, et anco, per dire il vero, egli aveva da natura molto più inclinazione alle cose d'architettura che alla pittura, come infine allora si vedeva apertamente ne' suoi disegni et in quelle poche opere che fece di pittura, imperò che sempre si vedeva in quella cose d'architettura e prospettiva, e fu in lui così forte e potente questa inclinazione di natura, che si può dire ch'egli imparasse quasi da se stesso i primi principii e le cose più difficili ottimamente in breve tempo, et onde si videro di sua mano, quasi prima che fosse conosciuto, belle e capricciose fantasie di varii disegni, fatti per la più parte a requisizione di Messer Francesco Guicciardini allora governatore di Bologna, e d'alcuni altri amici suoi, i quali disegni furno poi messi in opera di legni commessi e tinti a uso di tarsie da fra' Damiano da Bergamo, dell'Ordine di San Domenico in Bologna. Andato poi esso Vignola a Roma per attendere alla pittura e cavare di quella onde potesse aiutare la sua povera famiglia, si trattenne da principio in Belvedere con Iacopo Melighini ferrarese, architettore di papa Paolo Terzo, disegnando per lui alcune cose di architettura; ma dopo, essendo allora in Roma un'accademia di nobilissimi gentiluomini e signori, che attendevano alla lezione di Vitruvio, fra' quali era Messer Marcello Cervini, che fu poi papa, monsignor Maffei, Messer Alessandro Manzuoli et altri, si diede il Vignuola per servizio loro a misurare interamente tutte l'anticaglie di Roma et a fare alcune cose secondo i loro capricci, la qual cosa gli fu di grandissimo giovamento nell'imparare e nell'utile parimente.
Intanto, essendo venuto a Roma Francesco Primaticcio, pittore bolognese, del quale si parlerà in altro luogo, si servì molto del Vignuola in formare una gran parte dell'antichità di Roma, per portare le forme in Francia e gettarne poi statue di bronzo simili all'antiche; della qual cosa speditosi il Primaticcio, nell'andare in Francia condusse seco il Vignuola per servirsene nelle cose di architettura e perché gl'aiutasse a gettare di bronzo le dette statue che avevano formate, sì come nell'una e nell'altra cosa fece con molta diligenza e giudizio. E passati duoi anni, se ne tornò a Bologna, secondo che aveva promesso al conte Filippo Pepoli, per attendere alla fabrica di San Petronio. Nel qual luogo consumò parecchi anni in ragionamenti e dispute con alcuni, che seco in quei maneggi competevano, senza avere fatto altro che condurre e fatto fare con i suoi disegni il navilio che condusce le barche drento a Bologna, là dove prima non si accostavano a tre miglia, della qual opera non fu mai fatta né la più utile né la migliore, ancor che male ne fosse rimunerato il Vignuola, inventore di così utile e lodevole impresa. Essendo poi l'anno 1550 creato papa Giulio Terzo, per mezzo del Vasari fu accommodato il Vignuola per architetto di Sua Santità e datogli particolar cura di condurre l'Acqua Vergine, e d'essere sopra le cose della vigna di esso papa Giulio, che prese volentieri a suo servigio il Vignuola per avere avuto cognizione di lui quando fu legato di Bologna. Nella quale fabrica et altre cose che fece per quel Pontefice, durò molta fatica, ma ne fu male remunerato. Finalmente avendo Alessandro cardinale Farnese conosciuto l'ingegno del Vignuola e sempre molto favoritolo nel fare la sua fabrica e palazzo di Caprarola, volle che tutto nascesse dal capriccio, disegno et invenzione del Vignuola, e nel vero non fu punto manco il giudizio di quel signore in fare elezione d'un eccellente architettore, che la grandezza dell'animo in mettere mano a così grande e nobile edifizio, il quale, ancor che sia in luogo che si possa poco godere dall'universale essendo fuor di mano, è nondimeno cosa maravigliosa per sito e molto il proposito per chi vuole ritirarsi alcuna volta dai fastidii e tumulti della città. Ha dunque questo edificio forma di pentagono ed è spartito in quattro appartamenti senza la parte dinanzi, dove è la porta principale, dentro alla quale parte dinanzi è una loggia di palmi quaranta in larghezza et ottanta in lunghezza; in su uno de' lati è girata, in forma tonda, una scala a chiocciola di palmi dieci nel vano degli scaglioni, e venti è il vano del mezzo che dà lume a detta scala, la quale gira dal fondo per insino all'altezza del terzo appartamento più alto, e la detta scala si regge tutta sopra colonne doppie, con cornici che girano in tondo secondo la scala, che è ricca e varia, cominciando dall'ordine dorico e seguitando il ionico, corinto e composto, con richezza di balaustri, nicchie et altre fantasie, che la fanno essere cosa rara e bellissima. Dirimpetto a questa scala, cioè in sull'altro de' canti che mettono in mezzo la detta loggia dell'entrata, è un appartamento di stanze che comincia da un ricetto tondo, simile alla larghezza della scala, e camina in una gran sala terrena, lunga palmi ottanta e larga quaranta, la quale sala è lavorata di stucchi e dipinta di storie di Giove, cioè la nascita, quando è [nutrito] dalla capra [Amaltea] e che ella è incoronata, con due altre storie che la mettono in mezzo; nelle quali è quando ell'è collocata in cielo fra le quarantaotto imagini; e con un'altra simile storia della medesima capra, che allude, come fanno anco l'altre, al nome di Caprarola. Nelle facciate di questa sala sono prospettive di casamenti tirati dal Vignuola e colorite da un suo genero, che sono molto belle e fanno parere la stanza maggiore. A canto a questa sala è un salotto di palmi quaranta, che a punto viene a essere in sull'angolo che segue, nel quale, oltre ai lavori di stucco, sono dipinte cose che tutte dimostrano la Primavera. Da questo salotto seguitando verso l'altro angolo, cioè verso la punta del pentagono, dove è cominciata una torre, si va in tre camere, larghe ciascuna quaranta palmi e trenta lunghe; nella prima delle quali è di stucchi e pitture, con varie invenzioni, dipinta la State, alla quale stagione è questa prima camera dedicata; nell'altra che segue, è dipinta e lavorata nel medesimo modo la stagione dell'Autunno, e nell'ultima, fatta in simil modo, la quale si difende dalla tramontana, è fatto di simile lavoro l'Invernata.
E così infin qui avemo ragionato (quanto al piano che è sopra le prime stanze sotterranee, intagliate nel tufo, dove sono tinelli, cucine, dispense, cantine) della metà di questo edifizio pentagono, cioè dalla parte destra, dirimpetto alla quale, nella sinistra, sono altre tante stanze a punto e della medesima grandezza. Dentro ai cinque angoli del pentagono ha girato il Vignuola un cortile tondo, nel quale rispondono con le loro porte tutti gl'appartamenti dell'edifizio, le quali porte, dico, riescono tutte in sulla loggia tonda, che circonda il cortile intorno, e la quale è larga diciotto palmi, et il diametro del cortile resta palmi novantacinque e cinque once. I pilastri della quale loggia, tramezzata da nicchie che sostengono gl'archi e le volte, essendo accoppiati con la nicchia in mezzo, sono venti, di larghezza palmi quindici ogni due, che altretanto sono i vani degl'archi. Et intorno alla loggia negl'angoli, che fanno il sesto del tondo, sono quattro scale a chiocciola, che vanno dal fondo del palazzo per fino in cima per commodo del palazzo e delle stanze, con pozzi che smaltiscono l'acque piovane e fanno nel mezzo una citerna grandissima e bellissima, per non dire nulla de' lumi e d'altre infinite commodità, che fanno questa parere, come è veramente, una rara e bellissima fabrica; la quale, oltre al-l'avere forma e sito di fortezza, è accompagnata di fuori da una scala ovata, da fossi intorno e da ponti levatoi fatti con bell'invenzione e nuova maniera, che vanno ne' giardini pieni di ricche e varie fontane, di graziosi spartimenti di verzure et insomma di tutto quello che a un villaggio veramente reale è richiesto.
Ora, sagliendo per la chioccia grande dal piano del cortile in sull'altro appartamento di sopra, si trovavano finite sopra la detta parte di cui si è raggionato, altre tante stanze, e di più la capella, la quale è dirimpetto alla detta scala tonda principale in su questo piano. Nella sala, che è a punto sopra quella di Giove e di pari grandezza, sono dipinte di mano di Taddeo e d'i suoi giovani, con ornamenti ricchissimi e bellissimi di stucco, i fatti degl'uomini illustri di casa Farnese. Nella volta è uno spartimento di sei storie, cioè di quattro quadri e due tondi, che girano intorno alla cornice di detta sala, e nel mezzo tre ovati accompagnati per lunghezza da due quadri minori, in uno de' quali è dipinta la Fama e nel-l'altro Bellona. Nel primo de' tre ovati è la Pace, in quel del mezzo l'arme vecchia di casa Farnese col cimiero, sopra cui è un liocorno, e nell'altro la Religione. Nella prima delle sei dette storie, che è un tondo, è Guido Farnese con molti personaggi ben fatti intorno, e con questa inscrizzione sotto: GUIDO FARNESIUS URBIS VETERIS PRINCIPATUM, CIVIBUS IPSIS DEFERENTIBUS ADEPTUS, LABORANTI INTESTINIS DISCORDIIS CIVITATI, SEDITIOSA FACTIONE EIECTA, PACEM ET TRANQUILLITATEM RESTITUIT, ANNO 1323. In un quadro lungo è Pietro Nicolò Farnese, che libera Bologna, con questa iscrizzione sotto: PETRUS NICOLAUS, SEDIS ROMANAE POTENTISSIMIS HOSTIBUS MEMORABILI PRAELIO SUPERATIS, IMMINENTI OBSIDIONIS PERICULO BONONIAM LIBERAT, ANNO SALUTIS 1361. Nel quadro, che è canto a questo, è Pietro Farnese, fatto capitano de' fiorentini, con questa iscrizzione: PETRUS FARNESIUS REIPUBLICAE IMPERATOR, MAGNIS PISANORUM COPIIS ... URBEM FLORENTIAM TRIUMPHANS INGREDITUR, ANNO 1362. Nell'altro tondo, che è dirimpetto al sopra detto, è un altro Pietro Farnese, che rompe i nemici della Chiesa romana a Orbatello, con la sua inscrizzione. In uno de' due altri quadri, che sono eguali, è il signor Ranieri Farnese fatto generale de' fiorentini in luogo del sopra detto signor Pietro suo fratello, con questa iscrizzione: RAINERIUS FARNESIUS A FLORENTINIS, DIFICILI REIPUBLICAE TEMPORE, IN PETRI FRATRIS MORTUI LOCUM, COPIARUM OMNIUM DUX DELIGITUR, ANNO 1362. Nell'altro quadro è Ranuccio Farnese fatto da Eugenio Terzo generale della Chiesa, con questa iscrizzione: RANUTIUS FARNESIUS, PAULI TERTII PAPAE AVUS, EUGENIO TERTIO PONTEFICE MAXIMO ROSAE AUREAE MUNERE INSIGNITUS, PONTIFICII EXERCITUS IMPERATOR CONSTITUITUR, ANNO CHRISTI 1435. Insomma sono in questa volta un numero infinito di bellissime figure, di stucchi et altri ornamenti messi d'oro. Nelle facciate sono otto storie, cioè due per facciata: nella prima, entrando a man ritta, è in una papa Giulio Terzo, che conferma Parma e Piacenza al duca Ottavio et al principe suo figliuolo, presenti il cardinale Farnese, Sant'Agnolo suo fratello, Santa Fiore camarlingo, Salviati il vecchio, Chieti, Carpi, Polo e Morone, tutti ritratti di naturale con questa inscrizione: IULIUS III PONTIFEX MAXIMUS, ALEXANDRO FARNESIO AUCTORE, OCTAVIO FARNESIO EIUS FRATRI, PARMAM AMMISSAM RESTITUIT, ANNO SALUTIS 1550. Nella seconda è il cardinale Farnese, che va in Vormanzia, legato all'imperatore Carlo Quinto, e gl'escono incontra sua maestà et il principe suo figliuolo, con infinita moltitudine di baroni e con essi il re de' romani, con la sua inscrizione. Nella facciata a man manca entrando, è nella prima storia la guerra d'Alemagna contra i luterani, dove fu legato il duca Ottavio Farnese l'anno 1546, con la sua inscrizione. Nella seconda è il detto cardinale Farnese e l'Imperatore con i figliuoli, i quali tutti e quattro sono sotto il baldacchino portato da diversi, che vi sono ritratti di naturale, in fra i quali è Taddeo maestro dell'opera, con una comitiva di molti signori intorno. In una delle facce, o vero testate, sono due storie, et in mezzo un ovato, dentro al qua-le è il ritratto del re Filippo con questa inscrizzione: PHILIPPO HISPANIARUM REGI MAXIMO, OB EXIMIA IN DOMUM FARNESIAM MERITA. In una delle storie è il duca Ottavio, che prende per isposa madama Margherita d'Austria con papa Paulo Terzo in mezzo, con questi ritratti: del cardinale Farnese giovane e del cardinale di Carpi, del duca Pierluigi, Messer Durante, Eurialo da Cingoli, Messer Giovanni Riccio da Monte Pulciano, il vescovo di Como, la signora Livia Colonna, Claudia Mancina, Settimia e donna Maria di Mendozza; nell'altra è il duca Orazio, che prende per isposa la sorella del re Enrico di Francia, con questa inscrizzione: HENRICUS II VALESIUS GALLIAE REX HORATIO FARNESIO CASTRI DUCI, DIANAM FILIAM IN MATRIMONIUM COLLOCAT, ANNO SALUTIS 1552. Nella quale storia, oltre al ritratto di essa Diana col manto reale e del duca Orazio suo marito, sono ritratti: Caterina Medici reina di Francia, Margherita sorella del re, il re di Navarra, il connestabile, il duca di Guisa, il duca di Nemors, l'amiraglio principe di Condé, il cardinale di Loreno giovane, Guisa non ancor cardinale e 'l signor Piero Strozzi, madama di Monponsier, madamisella di Roano. Nell'altra testata rincontro alla detta, sono similmente due altre storie, con l'ovato in mezzo, nel quale è il ritratto del re Enrico di Francia con questa inscrizione: HENRICO FRANCORUM REGI MAXIMO FAMILIAE FARNESIAE CONSERVATORI. In una delle storie, cioè in quella che è a man ritta, papa Paulo Terzo veste il duca Orazio, che è inginocchioni, una veste sacerdotale e lo fa prefetto di Roma, con il duca Pierluigi appresso et altri signori intorno, con queste parole: PAULUS III PONTIFEX MAXIMUS HORATIUM FARNESIUM NEPOTEM SUMMAE SPEI ADOLESCENTEM PRAEFECTUM URBIS CREAT, ANNO SALUTIS 1549. Et in questa sono questi ritratti: il cardinal di Parigi, Viseo, Morone, Badia, Trento, Sfondrato et Ardinghelli. A canto a questa, nell'altra storia, il medesimo Papa dà il baston generale a Pierluigi et ai figliuoli, che non erano ancor cardinali, con questi ritratti: il Papa, Pierluigi Farnese, camarlingo, duca Ottavio, Orazio, cardinale di Capua, Simonetta, Iacobaccio, San Iacopo, Ferrara, signor Ranuccio Farnese giovanetto, il Giovio, il Molza e Marcello Cervini, che poi fu papa, marchese di Marignano, signor Giovambattista Castaldo, signor Alessandro Vitelli et il signor Giovambattista Savelli.
Venendo ora al salotto, che è a canto a questa sala, che viene a essere sopra alla Primavera, nella volta adorna con un partimento grandissimo e ricco di stucchi et oro, è nello sfondato del mezzo l'incoronazione di papa Paulo Terzo con quattro vani che fanno epitaffio in croce, con queste parole: PAULUS III FARNESIUS PONTIFEX MAXIMUS, DEO ET HOMINIBUS APPROBANTIBUS, SACRA TIARA SOLEMNI RITU CORONATUR, ANNO SALUTIS 1534, III NONARUM NOVEMBRIS. Seguitano quattro storie sopra la cornice, cioè sopra ogni faccia la sua. Nella prima il Papa benedisce le galee a Civitavecchia per mandarle a Tunis di Barberia l'anno 1535, nell'altra il medesimo scomunica il re d'Inghilterra l'anno 1537, col suo epitaffio; nella terza è un'armata di galee, che prepararono l'imperadore e' viniziani contra il Turco con autorità et aiuto del Pontefice l'anno 1538; nella quarta quando, essendosi Perugia ribellata dalla Chiesa, vanno i perugini a chiedere perdono l'anno 1540.
Nelle facciate di detto salotto sono quattro storie grandi, cioè una per ciascuna faccia, e tramezzate da finestre e porte. Nella prima è in una storia grande Carlo Quinto imperatore, che tornato da Tunis vittorioso bacia i piedi a papa Paulo Farnese in Roma l'anno 1535; nell'altra, che è sopra la porta, è a man manca la pace che papa Paulo Terzo, a Bussel, fece fare a Carlo Quinto imperatore e Francesco Primo di Francia l'anno 1538, nella quale storia sono questi ritratti: Borbone vecchio, il re Francesco, il re Enrico, Lorenzo vecchio, Turnone, Lorenzo giovane, Borbone giovane e due figliuoli del re Francesco. Nella terza il medesimo Papa fa legato il cardinal di Monte al Concilio di Trento, dove sono infiniti ritratti. Nell'ultima, che è fra le due finestre, il detto fa molti cardinali per la preparazione del Concilio, fra i quali vi sono quattro che dopo lui successivamente furono papi: Iulio Terzo, Marcello Cervino, Paulo Quarto e Pio Quarto. Il qual salotto, per dirlo brevemente, è ornatissimo di tutto quello che a sì fatto luogo si conviene.
Nella prima camera a canto a questo salotto, dedicata al vestire, che è lavorata anch'essa di stucchi e d'oro riccamente, è nel mezzo un sacrifizio con tre figure nude, fra le quali è un Alessandro Magno armato, che butta sopra il fuoco alcune vesti di pelle, et in molte altre storie, che sono nel medesimo luogo, è quando si trovò il vestire d'erbe e d'altre cose salvatiche, che troppo sarebbe volere il tutto pienamente raccontare. Di questa si entra nella seconda camera, dedicata al Sonno, la quale quando ebbe Taddeo a dipignere ebbe queste invenzioni dal comendatore Anniballe Caro, di commessione del cardinale. E perché meglio s'intenda il tutto, porremo qui l'aviso del Caro, con le sue proprie parole, che sono queste:
I soggetti che il cardinale mi ha comandato che io vi dia, per le pitture del palazzo di Caprarola, non basta che vi si dichino a parole, perché oltre all'invenzione vi si ricerca la disposizione, l'attitudini, i colori et altre avertenze assai, secondo le descrizioni che io truovo delle cose che mi ci paiono al proposito; per che distendarò in carta tutto che sopra ciò mi occorre più brevemente e più distintamente ch'io potrò. E prima, quanto alla camera della volta piatta, che d'altro per ora non mi ha dato carico, mi pare che essendo ella destinata per il letto della propria persona di sua signoria illustrissima, vi si debbano fare cose convenienti al luogo e fuor dell'ordinario, sì quanto all'invenzione, come quanto all'artifizio. Ma per dir prima il mio concetto in universale, vorrei che vi si facesse una Notte, perché oltre che sarebbe appropriata al dormire, sarebbe cosa non molto divulgata e sarebbe diversa dall'altre stanze e darebbe occasione a voi di far cose belle e rare dell'arte vostra; perché i gran lumi e le grand'ombre che ci vanno soglion dare assai di vaghezza e di rilievo alle figure, e' mi piacerebbe che il tempo di questa Notte fosse in su l'alba, perché le cose che vi si rapresenteranno siano verisimilmente visibili. E per venire ai particolari et alla disposizion d'essi, è necessario che ci intendiamo prima del sito e del ripartimento della camera. Diciamo adunque che ella sia, come è, divisa in volta et in parete, o facciate che le vogliamo chiamare; la volta poi in un sfondato di forma ovale nel mezzo et in quattro peducci grandi in su' canti, i quali stringendosi di mano in mano e continuandosi l'uno con l'al-tro lungo le facciate, abracciano il sopra detto ovato. Le parte poi sono pur quattro e da un peduccio all'altro fanno quattro lunette; e per dare il nome a tutte queste parti con le divisioni che faremo della camera tutta, potremo nominare d'ogn'intorno le parti sue da ogni banda. Dividasi dunque in cinque siti: il primo sarà da capo, e questo presupongo che sia verso il giardino; il secondo, che sarà l'oposito a questo, diremo da' piè; il terzo da man destra chiamaremo destro; il quarto dalla sinistra, sinistro; il quinto, poiché sarà fra tutti questi, si dirà mezzo. E con questi nomi no-minando tutte le parti, diremo come dir lunetta da capo, facciata da piedi, sfondato sinistro, corno destro, e se alcun'altra parte ci converrà nominare; et ai peducci, che stanno nei canti fra dua di questi termini, daremo nome dell'uno e dell'altro. Così determinaremo ancora di sotto nel pavimento il sito del letto, il quale dovrà esser secondo me lungo la facciata da' piè, con la testa volta alla faccia sinistra. Or nominate le parti tutte, torniamo a dar forma a tutte insieme, di poi a ciascuna da sé. Primieramente lo sfondato della volta, o veramente l'ovato, secondo che il cardinale ha ben considerato, si fingerà che sia tutto cielo; il resto della volta, che saranno i quattro peducci con quel ricinto che avemo già detto che abbraccia intorno l'ovato, si farà parer che sia la parte non rotta dentro dalla camera e che posi sopra le facciate con qualche bell'ordine di architettura a vostro modo. Le quattro lunette vorrei che si fingessero sfondate ancor esse, e dove l'ovato di sopra rappresenta cielo, queste rappresentassero cielo, terra e mare di fuor della camera, secondo le figure e l'istorie che vi si faranno. E perché, per esser la volta molto stiacciata, le lunette riescano tante basse che non sono capaci se non di picciole figure, io farei di ciascuna lunetta tre parti per longitudine, e lassando le streme a filo con l'altezza de' peducci, sfonderei quella di mezzo sotto esso filo, per modo che ella fusse come un finestrone alto e mostrasse il di fuora della stanza con istorie e figure grandi a proporzione dell'altre; e le due estremità che restano di qua e di là come corni di essa lunetta (che corni di qui inanzi si dimandaranno), rimanessero basse, secondo che vengono dal filo in su, per fare in ciaschedun di essi una figura a sedere o a giacere, o dentro o di fuora della stanza, che le vogliate far parere, secondo che meglio ritornerà; e questo che dico d'una lunetta, dico di tutt'e quattro. Ripigliando poi tutta la parte di dentro della camera insieme, mi parrebbe che ella dovesse esser per se stessa tutta in oscuro, se non quanto li sfondati, così dell'ovato di sopra come de' finestroni dalli lati, gli dessero non so che di chiaro, parte dal cielo con i lumi celesti, parte dalla terra con fuochi che vi si faranno, come si dirà poi. E con tutto ciò dalla mezza stanza in giù vorrei che quanto più si andasse verso il da piè, dove sarà la Notte, tanto vi fusse più scuro, e così dal-l'altra metà in su, secondo che da mano in mano più si avvicinasse al capo dove sarà l'Aurora, si andasse tutta via più illuminando. Così disposto il tutto, veniamo a divisar i soggetti dando a ciascheduna parte il suo.
Nell'ovato, che è nella volta, si facci a capo di essa, come avemo detto, l'Aurora. Questa truovo che si puol fare in più modi, ma io scerrò di tutti quello che a me pare che si possi far più graziosamente in pittura. Facciasi dunque una fanciulla di quella bellezza che i poeti si ingegnano di esprimere con parole, componendola di rose, d'oro, di porpora, di rugiada, di simil vaghezze, e questo quanto ai colori e carnagione. Quanto all'abi-to, componendone pur di molti uno che paia più al proposito, si ha da considerare che ella, come ha tre stati e tre colori distinti, così ha tre nomi: Alba, Vermiglia e Rancia; per questo gli farei una vesta fino alla cintura, candida, sottile e come trasparente; dalla cintura infino alle ginocchia una sopraveste di scarlatto, con certi trinci e gruppi, che imitassero quei suoi riverberi nelle nuvole quando è vermiglia; dalle ginocchia in giù fino a' piedi di color d'oro per rappresentarla quando è rancia, avvertendo che questa veste deve esser fessa, cominciando dalle cosce per fargli mostrare le gambe ignude; e così la veste, come la sopraveste, siano scosse dal vento e faccino pieghe e svolazzi. Le braccia vogliono essere ignude ancor esse d'incarnagione pur di rose; negl'omeri gli si facciano l'ali di varii colori, in testa una corona di rose, nelle mani gli si ponga una lampada, o una facella accesa, o vero gli si mandi avanti un amore che porti una face et un altro dopo, che con un'altra svegli Titone; sia posta a sedere in una sedia indorata, sopra un carro simile, tirato o da un Pegaso alato o da dua cavalli, che nell'un modo e nell'altro si dipigne. I colori de' cavalli siano del-l'uno splendente in bianco, dell'altro splendente in rosso per denotargli secondo i nomi che Omero dà loro di Lampo e di Fetonte; facciasi sorgere da una marina tranquilla, che mostri di esser crespa, luminosa e brillante. Dietro nella facciata gli si facci dal corno destro Titone suo marito, e dal sinistro Cefalo suo innamorato; Titone sia un vecchio tutto canuto sopra un letto ranciato, o veramente in una culla, secondo quelli che per la gran vecchiaia lo fanno rimbambito, e facciasi in attitudine di tenerla o di vagheggiarla o di sospirarla, come la sua partita gli rincresce; Cefalo un giovane bellissimo vestito di un farsetto soccinto nel mezzo, con i sua usattini in piedi, con il dardo in mano, che abbi il ferro inorato, con un cane a lato in modo di entrare in un bosco, come non curante di lei per l'amore che porta alla sua Procri. Tra Cefalo e Titone, nel vano del finestrone dietro l'Aurora, si faccino spontare alcuni pochi razzi di sole di splendore più vivo di quel dell'Aurora, ma che sia poi impedito, che non si vegga, da una gran donna, che li si pari dinanzi. Questa donna sarà la Vigilanza e vuol esser così fatta, che paia illuminata dietro alle spalle dal sole che nasce e che ella per prevenirlo si cacci dentro alla camera per il finestrone che si è detto; la sua forma sia d'una donna alta, splendida, valorosa, con gl'oc-chi bene aperti, con le ciglia ben inarcate, vestita di velo trasparente fino ai piedi, succinta nel mezzo della persona, con una mano si appoggi a u-n'asta e con l'altra raccolga una falda di gonna, stia ferma sul piè destro, e tenendo il piè sinistro sospeso, mostri da un canto di posar saldamente e dall'altro di avere pronti i passi; alzi il capo a mirare l'Aurora e paia sdegnata che ella si sia levata prima di lei; porti in testa una celata con un gallo suvi, il qual dimostri di battere l'ali e di cantare; e tutto questo dietro l'Aurora; ma davanti a lei nel cielo dello sfondato farei alcune figurette di fanciulle l'una dietro l'altra, quali più chiare e quali meno, secondo che elle meno o più fussero appresso al lume di essa Aurora, per significare l'Ore, che vengono inanzi al sole et a lei. Queste Ore siano fatte con abiti, ghirlande et acconciature da vergini, alate con le man piene di fiori, come se gli spargessero.
Nell'opposita parte, a piè dell'ovato, sia la Notte, e come l'Aurora sorge, questa tramonti; come ella ne mostra la fronte, questa ne volga le spalle; questa esca di un mar tranquillo, questa se imerga in uno che sia nubiloso e fosco; i cavalli di quella vengano con il petto inanzi, di questa mostrino le groppe, e così la persona istessa della Notte sia varia del tutto a quella dell'Aurora. Abbia la carnagione nera, nero il manto, neri i capelli, nere l'ali e queste siano aperte come se volasse; tenga le mani alte e dall'una un bambino bianco che dorma per significare il Sonno, dall'altra un altro nero, che paia dormire e significhi la Morte, perché de ambidua questi dicesi esser madre; mostri di cadere con il capo inanzi fitto in un'ombra più folta, et il ciel d'intorno sia di azzurro più carico e sparso di molte stelle. Il suo carro sia di bronzo con le rote distinte in quattro spazii, per toccare le sua quattro vigilie. Nella facciata poi dirimpetto, cioè da' piè, come l'Aurora ha di qua e di là Titone e Cefalo, questa abbia l'Oceano e Atlante. L'Oceano si farà dalla destra un omaccione con barba e crini bagnati e rabbuffati, e così de' crini come della barba gli escano a post'a posta alcune teste di delfini; accennisi appoggiato sopra un carro tirato da balene, con i tritoni davanti con le buccine, intorno con le ninfe, e dietro alcune bestie di mare. Se non con tutte queste cose, almeno con alcune, secondo lo spazio che averete, che mi par poco a tanta materia. Per Atlante facciasi dalla sinistra un monte, che abbia il petto, le braccia e tutte le parti disopra d'uomo robusto, barbuto e muscoloso, in atto di sostenere il cielo come è la sua figura ordinaria. Più a basso medesimamente, incontro la Vigilanzia, che avemo posta sotto l'Aurora, si dovrebbe porre il Sonno; ma perché mi par meglio che stia sopra il letto, per alcune ragioni, porremo in suo luogo la Quiete; questa Quiete truovo bene che ell'era adorata e che l'era dedicato il tempio, ma non truovo già come fosse figurata; se già la sua figura non fosse quella della Sicurtà, il che non credo, perché la sicurtà è dell'animo e la quiete è del corpo. Figuraremo dunque la Quiete da noi in questo modo: una giovane di aspetto piacevole, che come stanca non giaccia, ma segga e dorma con la testa appoggiata sopra al braccio sinistro; abbi un'asta che se gli posi sopra nella spalla e da piè ponti in terra, e sopra essa lasci cadere il braccio spendolone e vi tenga una gamba cavalcioni in atto di posare per ristoro e non per infingardia. Tenga una corona di papaveri et un scettro apartato da un canto, ma non sì che non possi prontamente ripigliarlo, e dove la Vigilanza ha in capo un gallo che canta, a questa si puol fare una gallina che covi, per mostrare che ancora posando fa la sua azzione.
Dentro all'ovato medesimo, dalla parte destra, farassi una Luna. La sua figura sarà di una giovane di anni circa diciotto, grande, di aspetto virginale, simile ad Apollo, con le chiome lunghe, folte e crespe alquanto, o con uno di quelli cappelli in capo che si dicano acidari, largo di sotto et acuto e torto in cima come il corno del doge, con due ali verso la fronte, che pendano e cuoprino l'orecchie e fuori della testa con due cornette, come da una luna crescente, o secondo Apuleio con un tondo schiacciato, liscio e risplendente a guisa di specchio in mezzo la fronte, che di qua e di là abbia alcuni serpenti e sopra certe poche spighe, con una corona in capo o di dittamo, secondo i Greci, o di diversi fiori, secondo Marziano, o di elicriso, secondo alcun altri. La veste, chi vuol che sia lunga fino a' piedi, chi corta fino alle ginocchia, succinta sotto le mamelle et attraversata sotto l'ombilico alla ninfale, con un mantelletto in spalla affibbiato sul destro muscolo, e con usattini in piede vagamente lavorati. Pausania alludendo credo a Diana, la fa vestita di pelle di cervo; Apuleio, pigliandola forse per Iside, gli dà un abito di velo sottilissimo di varii colori: bianco, giallo, rosso, et un'altra veste tutta nera, ma chiara e lucida, sparsa di molte stelle con una luna in mezzo e con un lembo d'intorno, con ornamenti di fiori e di frutti pendente a guisa di fiocchi. Pigliate un di questi abiti, qual meglio vi torna. Le braccia fate che siano ignude, con le lor maniche larghe, con la destra tenga una face ardente, con la sinistra un arco allentato, il quale secondo Claudiano è di corno e secondo Ovidio di oro. Fatelo come vi pare et attaccategli il turcasso agl'omeri. Si truova in Pausania con doi serpenti nella sinistra, et in Apuleio con un vaso dorato, col manico di serpe, il quale pare come gonfio di veleno, e col piede ornato di foglie di palme; ma con questo credo che vogli significare Iside; però mi risolvo che gli facciate l'arco come disopra. Cavalchi un carro tirato da cavalli, un nero, l'altro bianco, o se vi piacesse di variare, da un mulo, secondo Festo Pompeio, o da giovenchi, secondo Claudiano et Ausonio, e facendo giovenchi vogliono avere le corna molte piccole et una macchia bianca sul destro fianco. L'attitudine della Luna deve essere di mirare sopra dal cielo dell'ovato verso il corno dell'istessa facciata che guarda il giardino, dove sia posto Endimione suo amante e s'inchini dal carro per baciarlo; e non si potendo per la interposizione del ricinto lo vagheggi et illumini del suo splendore. Per Endimione bisogna fare un bel giovane pastore, adormentato a' piè del monte Lamio.
Nel corno dell'altra parte sia Pane, dio de' pastori, inamorato di lei, la figura del quale è notissima. Pongaseli una sampogna al collo e con am-be le mani stenda una matassa di lana bianca verso la Luna, con che fingono che si acquistasse l'amore di lei e con questo presente mostri di pregarla che scenda a starsi con lui. Nel resto del vano del medesimo finestrone si facci un'istoria e sia quella de' sagrificii lemurii, che usavano fare di notte per cacciare i mali spiriti di casa. Il rito di questi era con le man lavate e co' piedi scalzi andare attorno spargendo fava nera, rivolgendosela prima per bocca e poi gittandosela dietro le spalle, e tra questi erano alcuni, che sonando bacini e tali instrumenti di rame, facevano romore. Dal lato sinistro dell'ovato si farà Mercurio nel modo ordinario con il suo cappelletto alato, con i talari a' piedi, col caduceo alla sinistra, con borsa nella destra, ignudo tutto, salvo con quello suo mantelletto nella spalla, giovane bellissimo, ma di una bellezza naturale, senza artifizio alcuno; di volto allegro, d'occhi spiritosi, sbarbato o di prima lanuggine, stretto nelle spalle e di pel rosso. Alcuni gli pongono l'ali sopra l'orecchie e gli fanno uscire da' capelli certe penne d'oro. L'attitudine fate a vostro modo, pur che mostri di calarsi dal cielo per infonder sonno, e che rivolto verso la parte del letto, paia di voler toccare il padiglione con la verga.
Nella facciata sinistra, nel corno verso la facciata da' piè, si potria fare i Lari dèi, che sono due figliuoli i quali erano genii delle case private, cioè due giovani vestiti di pelli di cani, con certi abiti soccinti e gittati sopra la spalla sinistra per modo che venghino sotto la destra per mostrare che siano disinvolti e pronti alla guardia di casa. Stiano a sedere l'uno a canto l'altro, tenghino un'asta per ciascuno nella destra et in mezzo di essi sia un cane, e disopra loro sia un piccolo capo di Vulcano, con un cappelletto in testa et a canto con una tanaglia da fabbri. Nell'altro corno verso la facciata da capo farei un Batto, che per avere rivelato le vacche rubate da lui, sia convertito in sasso. Facciasi un pastor vecchio a sedere, che col braccio destro e con l'indice mostri il luogo dove le vacche erano ascoste, e col sinistro si appoggi a un pedone o vincastro, bastone de' pastori, e da mezzo in giù sia sasso nero di colore di paragone in che fu convertito. Nel resto poi del finestrone dipingasi l'istoria del sacrifizio, che faceano gli antichi ad esso Mercurio, perché il sonno non si interrompesse. E per figurare questo bisogna fare un altare con suvi la sua statua, a piede un fuoco e d'intorno genti che vi gettano legne ad abruciare e che con alcune tazze in mano piene di vino, parte ne spargano e parte ne beano.
Nel mezzo dell'ovato, per empier tutta la parte del cielo, farei il Crepuscolo, come mezzano tra l'Aurora e la Notte. Per significare questo, truovo che si fa un giovanetto tutto ignudo, talvolta con l'ali talvolta senza, con due facelle accese, l'una delle quali faremo che si accenda a quella del-l'Aurora e l'altra che si stenda verso la Notte. Alcuni fanno che questo giovanetto con le due faci medesime cavalchi sopra un cavallo del Sole o del-l'Aurora, ma questo non farebbe componimento a nostro proposito, però lo faremo come di sopra e volto verso la Notte, ponendogli dietro fra le gambe una gran stella, la quale fosse quella di Venere, perché Venere e Fosforo et Espero e Crepuscolo pare che si tenga per una cosa medesima. E da questa in fuori, di verso l'Aurora, fate che tutte le minori stelle siano sparite, et avendo infin qui ripieno tutto il di dentro della camera, così di sopra nell'ovato, come nelli lati e nelle facciate, resta che venghiamo al didentro, che sono nella volta i quattro peducci, e cominciando da quello che è sopra 'l letto, che viene a essere tra la facciata sinistra e quella da' piè, faccisi il Sonno, e per figurare lui bisogna prima figurare la sua casa. Ovidio la pone in Lenno e ne' Cimerii, Omero nel mare Egeo, Stazio appresso alli Etiopi, l'Ariosto nell'Arabia; dovunque si sia, basta che si finga un monte, qual se ne può imaginare uno, dove siano sempre tenebre e non mai sole; a' piè di esso una concavità profonda, per dove passi un'acqua come morta, per mostrare che non mormori, e sia di color fosco, perciò che la fanno un ramo di Lete; dentro questa concavità sia un letto, il quale fingendo d'essere d'ebano, sarà di color nero e di neri panni si cuopra. In questo sia collocato il Sonno, un giovane di tutta bellezza, perché bellissimo e placidissimo lo fanno, ignudo secondo alcuni, e secondo alcuni altri vestito di due vesti, una bianca di sopra, l'altra nera di sotto, con l'ali in sugl'omeri, e secondo Stazio ancora nella cima del capo. Tenga sotto il braccio un corno, che mostri rovesciare sopra 'l letto un liquore livido per denotare oblivione, ancora che altri lo facciano pieno di frutti; in una mano abbi la verga, nell'altra tre vesciche di papavero; dorma come infermo, col capo e con le membra languide e come abandonato nel dormire; d'intorno al suo letto si vegga Morfeo, Icalo e Fantaso e gran quantità di Sogni, che tutti questi sono suoi figliuoli. I Sogni siano certe figurette alate di bell'aspetto, altre di brutto, come quelli che parte dilettano e spaventano; abbiano l'ali ancor essi et i piedi storti come instabili et incerti, che se ne volino e si girino intorno a lui, facendo come una rappresentazione con trasformarsi in cose possibili et impossibili. Morfeo è chiamato da Ovidio artefice e fingitore di figure, e però lo farei in atto di figurare maschere di variati mostacci, ponendone alcune di esse a' piedi; Icalo dicano che si trasforma esso stesso in più forme, e questo figurerei per modo, che nel tutto paresse uomo et avesse parti di fiera, di uccello, di serpente come Ovidio medesimo lo descrive; Fantaso vogliano che si trasmuti in diverse cose insensate, e questo si puole rappresentare ancora, con le parole di Ovidio, parte di sasso, parte d'acqua, parte di legno. Fingasi che in questo luogo siano due porte, una di avorio onde escano i sogni falsi, et una di corno onde escano i veri, et i veri sieno coloriti più distinti, più lucidi e meglio fatti; i falsi, confusi, foschi et imperfetti.
Nell'altro peduccio, tra la facciata da' piè et a man destra, farete Brinto, dea de' vaticinii et interpretante de' sogni. Di questa non truovo l'abito, ma la farei ad uso di sibilla, assisa a' piè di quell'olmo descritto da Virgilio sotto le cui frondi pone infinite imagini, mostrando che sì come caggiano dalle sue fronde, così gli volino d'intorno nella forma che avemo loro data, e come si è detto, quale più chiare, quale più fosche, alcune interrotte, alcune confuse e certe svanite quasi del tutto per rappresentare con esse i sogni, le visioni, gli oracoli, le fantasme e le vanità che si veggono dormendo, che fin di queste cinque sorti par che le faccia Macrobio; et ella stia come in astratto per interpretarle, e d'intorno abbi genti, che gli offeriscono panieri pieni di ogni sorte di cose, salvo di pesce. Nel peduccio poi tra la facciata destra e quella di capo starà convenientemente Arpocrate, dio del silenzio, perché rappresentandosi nella prima vista a quelli che entrano dalla porta che viene dal camerone dipinto, avvertirà gl'intranti che non faccino strepito. La figura di questo è di un giovane o putto più tosto di colore nero, per essere dio degli Egizii, col dito alla bocca in atto di comandare che si taccia. Porti in mano un ramo di persico, e se pare, ghirlanda delle sue foglie. Fingano che nascesse debile di gambe, e che essendo ucciso, la madre Iside lo resuscitasse, e per questo altri lo fanno disteso in terra, altri in grembo di essa madre, con piè congiunti. E per accompagnamento dell'altre figure, io lo farei pur dritto et appoggiato in qualche modo, o veramente a sedere come quello dell'illustrissimo cardinale San-t'Agnolo, il quale è anco alato e tiene un corno di dovizia. Abbia gente intorno che gli offeriscono, come era solito, primizie di lenticchie et altri legumi e di persichi sopra detti. Altri facevano per questo medesimo dio una figura senza faccia, con un cappelletto in testa, con una pelle di lupo in-torno, tutto coperto d'occhi e di orecchi. Fate di questi qual vi pare.
Nell'ultimo peduccio, tra la facciata da capo e la sinistra, sarà ben locata Angerona, dea della segretezza, che per venire di dentro alla porta dell'entrata medesima, amonirà quelli che escono di camera a tener segreto tutto quello che hanno inteso e veduto, come si conviene servendo a' signori. La sua figura è d'una donna posta sopra un altare, con la bocca legata e sigillata; non so con che abito la facessero, ma io la rivolgerei in un panno lungo che la coprisse tutta, e mostrarei che si ristringesse nelle spalle. Faccinsi intorno a lei alcuni pontefici dai quali se gli sacrificava nella curia inanzi alla porta, perché non fosse lecito a persona di revelare cosa che vi si trattasse, in pregiudizio della republica.
Ripieni dalla parte di dentro i peducci, resta ora a dir solamente che intorno a tutta quest'opera mi parrebbe che dovesse essere un fregio, che la terminasse da ogn'intorno, et in questo farei o grottesche o istoriette di figure piccole, e la materia vorrei che fusse conforme ai soggetti già dati di sopra e di mano in mano ai più vicini. E facendo istoriette mi piacerebbe che mostrassero l'azzioni che fanno gl'uomini et anco gl'animali nell'ora che ci aviam proposto. E cominciando pur da capo, farei nel fregio di quella facciata, come cose appropriate all'Aurora, artefici, operari, gente di più sorti, che già levate tornassero alli esercizi et alle fatiche loro, come fabbri alla fucina, litterati alli studii, cacciatori alla campagna, mulattieri alla lor via, e sopra tutto ci vorrei quella vecchiarella del Petrarca, che [dis]cinta e scalza levatasi da filare accendesse il fuoco; e se vi pare farvi grottesche di animali, fateci degl'uccelli che cantino, dell'oche che escano a pascere, de' galli che annunziano il giorno e simili novelle. Nel fregio della facciata da' piè, conforme alle tenebre, vi farei gente che andassero a frugnolo, spie, adulteri, scalatori di finestre e cose tali, e per grottesche istrici, ricci, tassi, un pavone con la ruota che significa la notte stellata, gufi, civette, pipistrelli e simili. Nel fregio della facciata destra, per cose proporzionate alla Luna, pescatori di notte naviganti alla busola, negromanti, streghe e simili: per grottesche un fanale di lontano, reti, nasse con alcuni pesci dentro, e granchi che pascessero al lume di luna, e se [il] luogo n'è capace, un elefante inginocchioni che la adorasse; et ultimamente nel fregio della facciata sinistra, matematici con i loro strumenti da misurare, ladri, falsatori di monete, cavatori di tesori, pastori con le mandre ancor chiuse intorno agli lor fuochi, e simili. E per animali vi farei lupi, volpe, scimie, cuccie, e se altre vi sono di queste sorte maliziosi et insidiatori degl'altri animali. In questa parte ho messo queste fantasie così a caso, per accennare di che specie invenzioni vi si potessero fare, ma per non esser cose che abbino bisogno di essere descritte, lasso che voi ve l'imaginiate a vostro modo, sapendo che i pittori sono per lor natura ricchi e graziosi in trovare di queste bizzarrie. Et avendo già ripiene tutte le parti dell'opera così di dentro come di fuori della camera, non ci occorre dirvi altro, se non che conferiate il tutto con monsignor illustrissimo e secondo il suo gusto, agiungendovi o togliendone quel che bisogna, cerchiate voi dalla parte vostra farvi onore. State sano.
Ma ancora che tutte queste belle invenzioni del Caro fussero capricciose, ingegnose e lodevoli molto, non poté nondimeno Taddeo mettere in opera se non quelle di che fu il luogo capace, che furono la maggior parte, ma quelle che egli vi fece furono da lui condotte con molta grazia e bellissima maniera.
A canto a questa, nell'ultima delle dette tre camere, che è dedicata alla Solitudine, dipinse Taddeo, con l'aiuto de' suoi uomini, Cristo che predica agl'Apostoli nel deserto e nei boschi, con un S. Giovanni a man ritta molto ben lavorato. In un'altra storia, che è dirimpetto a questa, sono dipinte molte figure, che si stanno nelle selve per fuggire la conversazione, le quali alcun'altre cercano di disturbare tirando loro sassi, mentre alcuni si cavano gl'occhi per non vedere. In questa medesimamente è dipinto Carlo V imperatore, ritratto di naturale, con questa inscrizione: POST INNUMEROS LABORES OCIOSAM QUIETAMQUE VITAM TRADUXIT. Dirimpetto a Carlo è il ritratto del Gran Turco ultimo, che molto si dilettò della solitudine, con queste parole: ANIMUM A NEGOCIO AD OCIUM REVOCAVIT. Appresso vi è Aristotile, che ha sotto queste parole: ANIMA FIT, SEDENDO ET QUIESCENDO, PRUDENTIOR. All'incontro a questo, sotto un'altra figura di mano di Taddeo, è scritto così: QUAE AD MODUM NEGOCII, SIC ET OCII RATIO HABENDA: sotto un'altra si legge: OCIUM CUM DIGNITATE, NEGOCIUM SINE PERICULO, e dirimpetto a questa sotto un'altra figura è questo motto: VIRTUTIS ET LIBERAE VITAE MAGISTRA OPTIMA SOLITUDO: sotto un'altra: PLUS AGUNT QUI NIHIL AGERE VIDENTUR, e sotto l'ultima: QUI AGIT PLURIMA, PLURIMUM PECCAT. E per dirlo brevemente, è questa stanza ornatissima di belle figure e ricchissima anch'ella di stucchi e d'oro.
Ma tornando al Vignuola, quanto egli sia eccellente nelle cose d'architettura, l'opere sue stesse che ha scritte e publicate, e va tuttavia scrivendo, oltre le fabriche maravigliose ne fanno pienissima fede, e noi nella vita di Michelagnolo ne diremo a quel proposito quanto occorrerà. Taddeo, oltre alle dette cose, ne fece molte altre delle quali non accade far menzione, ma in particolare una cappella nella chiesa degl'orefici in strada Giulia, una facciata di chiaro scuro da S. Ieronimo e la cappella dell'altare maggiore in Santa Sabina; e Federigo suo fratello, dove in S. Lorenzo in Damaso è la cappella di quel Santo tutta lavorata di stucco, fa nella tavola San Lorenzo in sulla graticola et il Paradiso aperto, la quale tavola si aspetta debba riuscire opera bellissima. E per non lasciare indietro alcuna cosa, la quale essere possa di utile, piacere o giovamento a chi leggerà questa nostra fatica, alle cose dette aggiugnerò ancora questa: mentre Taddeo lavorava, come s'è detto, nella vigna di papa Giulio, e la facciata di Matiolo delle Poste, fece a monsignore Innocenzio, illustrissimo e reverendissimo cardinale di Monte, due quadretti di pittura, non molto grandi; uno de' quali che è assai bello (avendo l'altro donato) è oggi nella salvaroba di detto cardinale in compagnia d'una infinità di cose antiche e moderne, veramente rarissime, in fra le quali non tacerò che è un quadro di pittura capricciosissimo quanto altra cosa di cui si sia fatto infin qui menzione. In questo quadro, dico, che è alto circa due braccia e mezzo, non si vede, da chi lo guarda in prospettiva et alla sua veduta ordinaria, altro che alcune lettere in campo incarnato, e nel mezzo la luna, che secondo le righe dello scritto va di mano in mano crescendo e diminuendo, e nondimeno, andando sotto il quadro e guardando in una sfera, o vero specchio, che sta sopra il quadro a uso d'un picciol baldacchino, si vede di pittura e naturalissimo in detto specchio, che lo riceve dal quadro, il ritratto del re Enrico Secondo di Francia, alquanto maggiore del naturale, con queste lettere intorno: HENRY II ROY DE FRANCE. Il medesimo ritratto si vede, calando il quadro abbasso e posta la fronte in sulla cornice di sopra, guardando in giù, ma è ben vero che chi lo mira a questo modo lo vede volto a contrario di quello che è nello specchio, il quale ritratto, dico, non si vede, se non mirandolo come di sopra, perché è dipinto sopra ventotto gradini sottilissimi, che non si veggiono, i quali sono fra riga e riga dell'infrascritte parole, nelle quali, oltre al significato loro ordinario, si legge, guardando i capiversi d'ambidue gl'estremi, alcune lettere alquante maggiori dell'altre, e nel mezzo: HENRICUS VALESIUS, DEI GRATIA, GALLORUM REX INVICTISSIMUS. Ma è ben vero che Messer Alessandro Taddei romano, segretario di detto cardinale, e don Silvano Razzi, mio amicissimo, i quali mi hanno di questo quadro e di molte altre cose dato notizia, non sanno di chi sia mano, ma solamente che fu donato dal detto re Enrico al cardinale Caraffa quando fu in Francia, e poi dal Caraffa al detto illustrissimo di Monte, che lo tenne come cosa rarissima, che è veramente. Le parole adunque, che sono dipinte nel quadro e che sole in esso si veggiono da chi lo guarda alla sua veduta ordinaria e come si guardano l'altre pitture, sono queste:
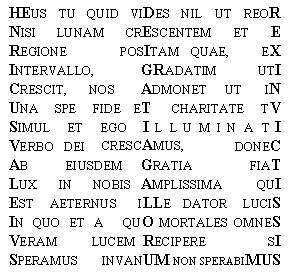
Nella medesima guardaroba è un bellissimo ritratto della signora Sofonisba Angusciuola di mano di lei medesima, e da lei stato donato a papa Giulio Terzo. E, che è da essere molto stimato, in un libro antichissimo, la Bucolica, Georgica et Eneida di Virgilio di caratteri tanto antichi, che in Roma et in altri luoghi è stato da molti letterati uomini giudicato che fusse scritto ne' medesimi tempi di Cesare Augusto, o poco dopo. Onde non è maraviglia se dal detto cardinale è tenuto in grandissima venerazione.
E questo sia il fine della vita di Taddeo Zucchero pittore.
VITA DI MICHELAGNOLO BUONARRUOTI FIORENTINO PITTORE, SCULTORE ET ARCHITETTO

Mentre gl'industriosi et egregii spiriti col lume del famosissimo Giotto e de' seguaci suoi si sforzavano dar saggio al mondo del valore che la benignità delle stelle e la proporzionata mistione degli umori aveva dato agli ingegni loro, e desiderosi di imitare con la eccellenza dell'arte la grandezza della natura, per venire il più che potevano a quella somma cognizione che molti chiamano intelligenza, universalmente, ancora che indarno, si affaticavano, il benignissimo Rettore del cielo volse clemente gli occhi alla terra, e veduta la vana infinità di tante fatiche, gli ardentissimi studii senza alcun frutto e la opinione prosuntuosa degli uomini, assai più lontana dal vero che le tenebre dalla luce, per cavarci di tanti errori si dispose mandare in terra uno spirito, che universalmente in ciascheduna arte et in ogni professione fusse abile, operando per sé solo a mostrare che cosa sia la perfezzione dell'arte del disegno nel lineare, dintornare, ombrare e lumeggiare, per dare rilievo alle cose della pittura, e con retto giudizio operare nella scultura, e rendere le abitazioni commode e sicure, sane, allegre, proporzionate e ricche di varii ornamenti nell'architettura. Volle oltra ciò accompagnarlo della vera filosofia morale, con l'ornamento della dolce poesia, acciò che il mondo lo eleggesse et ammirasse per suo singularissimo specchio nella vita, nell'opere, nella santità dei costumi et in tutte l'azzioni umane, e perché da noi più tosto celeste che terrena cosa si nominasse. E perché vide che nelle azzioni di tali esercizii et in queste arti singularissime, cioè nella pittura, nella scultura e nell'architettura, gli ingegni toscani sempre sono stati fra gli altri sommamente elevati e grandi, per essere eglino molto osservanti alle fatiche et agli studii di tutte le facultà, sopra qualsivoglia gente di Italia, volse dargli Fiorenza, dignissima fra l'altre città, per patria, per colmare al fine la perfezzione in lei meritamente di tutte le virtù per mezzo d'un suo cittadino.
Nacque dunque un figliuolo sotto fatale e felice stella nel Casentino, di onesta e nobile donna, l'anno 1474 a Lodovico di Lionardo Buonarruoti Simoni, disceso, secondo che si dice, della nobilissima et antichissima famiglia de' conti di Canossa. Al quale Lodovico, essendo podestà quell'anno del castello di Chiusi e Caprese, vicino al Sasso della Vernia, dove San Francesco ricevé le stimate, diocesi aretina, nacque dico un figliuolo il sesto dì di marzo, la domenica, intorno all'otto ore di notte, al quale pose nome Michelagnolo, perché non pensando più oltre, spirato da un che di sopra volse inferire costui essere cosa celeste e divina, oltre all'uso mortale, come si vidde poi nelle figure della natività sua, avendo Mercurio, e Venere in seconda, nella casa di Giove, con aspetto benigno ricevuto, il che mostrava che si doveva vedere ne' fatti di costui, per arte di mano e d'ingegno, opere maravigliose e stupende. Finito l'uffizio della podesteria, Lodovico se ne tornò a Fiorenza, e nella villa di Settignano, vicino alla città tre miglia, dove egli aveva un podere de' suoi passati (il qual luogo è copioso di sassi e per tutto pieno di cave di macigni, che son lavorati di continovo da scarpellini e scultori, che nascono in quel luogo la maggior parte), fu dato da Lodovico Michelagnolo a balia in quella villa alla moglie d'uno scarpellino. Onde Michelagnolo ragionando col Vasari una volta per ischerzo disse: “Giorgio, si' ho nulla di buono nell'ingegno, egli è venuto dal nascere nella sottilità dell'aria del vostro paese d'Arezzo, così come anche tirai dal latte della mia balia gli scarpegli e 'l mazzuolo con che io fo le figure”.
Crebbe col tempo in figliuoli assai Lodovico, et essendo male agiato e con poche entrate, andò accomodando all'Ar-te della Lana e Seta i figliuoli, e Michelagnolo, che era già cresciuto, fu posto con maestro Francesco da Urbino alla scuola di gramatica; e perché l'ingegno suo lo tirava al dilettarsi del disegno, tutto il tempo che poteva mettere di nascoso lo consumava nel disegnare, essendo per ciò e dal padre e da' suoi maggiori gridato e tal volta battuto, stimando forse che lo attendere a quella virtù non conosciuta da loro, fussi cosa bassa e non degna della antica casa loro. Aveva in questo tempo preso Michelagnolo amicizia con Francesco Granacci, il quale anche egli giovane si era posto appresso a Domenico del Grillandaio per imparare l'arte della pittura, là dove amando il Granacci Michelagnolo e vedutolo molto atto al disegno, lo serviva giornalmente de' disegni del Grillandaio, il quale era allora reputato non solo in Fiorenza, ma per tutta Italia de' migliori maestri che ci fussero. Per lo che crescendo giornalmente più il desiderio di fare a Michelagnolo, e Lodovico non potento diviare che il giovane al disegno non attendesse, e che non ci era rimedio, si risolvé, per cavarne qualche frutto e perché egli imparasse quella virtù, consigliato da amici, di acconciarlo con Domenico Grillandaio.
Aveva Michelagnolo, quando si acconciò all'arte con Domenico, quattordici anni, e perché chi ha scritto la vita sua dopo l'anno 1550, che io scrissi queste vite la prima volta, dicendo che alcuni, per non averlo praticato, n'han detto cose che mai non furono e lassatone di molte che son degne d'essere notate, e particularmente tocco questo passo tassando Domenico d'invidiosetto, né che porgessi mai aiuto alcuno a Michelagnolo, il che si vidde essere falso, potendosi vede-re per una scritta di mano di Lodovico padre di Michelagnolo scritto sopra i libri di Domenico, il qual libro è appresso oggi agli eredi suoi che dice così: “1488. Ricordo questo dì primo d'aprile, come io Lodovico di Lionardo di Buonarota acconcio Michelagnolo mio figliuolo con Domenico e Davit di Tommaso di Currado per anni tre prossimi a venire con questi patti e modi: che 'l detto Michelagnolo debba stare con i sopra detti detto tempo a imparare a dipignere et a fare detto essercizio, e ciò i sopra detti gli comanderanno, e detti Domenico e Davit gli debbon dare in questi tre anni fiorini ventiquattro di sugello, el primo anno fiorini sei, el secondo anno fiorini otto, il terzo fiorini dieci; in tutta la somma di lire novantasei”. Et appresso vi è sotto questo ricordo o questa partita, scritta pur di mano di Lodovico: “Hanne avuto il sopra detto Michelagnolo questo dì 16 d'aprile fiorini dua d'oro in oro. Ebbi io Lodovico di Lionardo, suo padre lui, contanti lire 12,12”. Queste partite ho copiate io dal proprio libro per mostrare che tutto quel che si scrisse allora e che si scriverrà al presente è la verità, né so che nessuno l'abbi più praticato di me e che gli sia stato più amico e servitore fedele, come n'è testimonio fino chi nol sa; né credo che ci sia nessuno che possa mostrare maggior numero di lettere scritte da lui proprio, né con più affetto che egli ha fatto a me. Ho fatto questa disgressione per fede della verità, e que-sto basti per tutto il resto della sua vita. Ora torniamo alla storia.
Cresceva la virtù e la persona di Michelagnolo di maniera che Domenico stupiva vedendolo fare alcune cose fuor d'ordine di giovane, perché gli pareva che non solo vincesse gli altri discepoli, dei quali aveva egli numero grande, ma che paragonasse molte volte le cose fatte da lui come maestro. Avvenga che uno de' giovani che imparava con Domenico, avendo ritratto alcune femine di penna, vestite, dalle cose del Grillandaio, Michelagnolo prese quella carta e con penna più grossa ridintornò una di quelle femmine di nuovi lineamenti nella maniera che arebbe avuto a stare, perché istessi perfettamente, che è cosa mirabile a vedere la diferenza delle due maniere e la bontà e giudizio d'un giovanetto così animoso e fiero che gli bastasse l'animo correggere le cose del suo maestro. Questa carta è oggi appresso di me tenuta per reliquia, che l'ebbi dal Granaccio per porla nel libro de' disegni con altri di suo avuti da Michelagnolo; e l'anno 1550, che era a Roma, Giorgio la mostrò a Michelagnolo che la riconobbe et ebbe caro rivederla, dicendo per modestia che sapeva di questa arte più quando egl'era fanciullo, che allora che era vecchio. Ora avvenne che lavorando Domenico la cappella grande di Santa Maria Novella, un giorno che egli era fuori si misse Michelagnolo a ritrarre di naturale il ponte con alcuni deschi, con tutte le masserizie dell'arte, et alcuni di que' giovani che lavoravano. Per il che tornato Domenico e visto il disegno di Michelagnolo disse: “Costui ne sa più di me”; e rimase sbigottito della nuova maniera e della nuova imitazione, che dal giudizio datogli dal cielo aveva un simil giovane in età così tenera, che invero era tanto quanto più desiderar si potesse nella pratica d'uno artefice che avesse operato molti anni. E ciò era che tutto il sapere e potere della grazia era nella natura essercitata dallo studio e dall'arte, per che in Michelagnolo faceva ogni dì frutti più divini, come apertamente cominciò a dimostrarsi nel ritratto che e' fece d'una carta di Martino tedesco stampata, che gli dette nome grandissimo. Imperò che, essendo venuta allora in Firenze una storia del detto Martino, quando i diavoli battano Santo Antonio, stampata in rame, Michelagnolo la ritrasse di penna di maniera, che non era conosciuta, e quella medesima con i colori dipinse; dove per contrafare alcune strane forme di diavoli, andava a comperare pesci che ave-vano scaglie bizzarre di colori, e quivi dimostrò in questa cosa tanto valore, che e' ne acquistò e credito e nome. Contrafece ancora carte di mano di varii maestri vecchi tanto simili, che non si conoscevano, perché tignendole et invecchiandole col fumo e con varie cose, in modo le insudiciava, che elle parevano vecchie, e paragonatole con la propria non si conosceva l'una dall'altra; né lo faceva per altro se non per avere le proprie di mano di coloro, col darli le ritratte, che egli per l'eccellenza dell'arte amirava e cercava di passargli nel fare, onde n'acquistò grandissimo nome.
Teneva in quel tempo il magnifico Lorenzo de' Medici nel suo giardino in sulla piazza di S. Marco Bertoldo scultore, non tanto per custode o guardiano di molte belle anticaglie, che in quello aveva ragunate e raccolte con grande spesa, quanto perché desiderando egli sommamente di creare una scuola di pittori e di scultori eccellenti, voleva che elli avessero per guida e per capo il sopra detto Bertoldo, che era discepolo di Donato. Et ancora che e' fusse sì vecchio che non potesse più operare, era nientedimanco maestro molto pratico e molto reputato, non solo per avere diligentissimamente rinettato il getto de' pergami di Donato suo maestro, ma per molti getti ancora che egli aveva fatti di bronzo di battaglie e di alcune altre cose piccole, nel magisterio delle quali non si trovava allora in Firenze chi lo avanzasse. Dolendosi adunque Lorenzo, che amor grandissimo portava alla pittura et alla scultura, che ne' suoi tempi non si trovassero scultori celebrati e nobili, come si trovavano molti pittori di grandissimo pregio e fama, deliberò, come io dissi, di fare una scuola; e per questo chiese a Domenico Ghirlandai, che se in bottega sua avesse de' suoi giovani che inclinati fussero a ciò, l'inviasse al giardino, dove egli desiderava di essercitargli e creargli in una maniera che onorasse sé e lui e la città sua. Laonde da Domenico gli furono per ottimi giovani dati fra gli altri Michelagnolo e Francesco Granaccio; per il che andando eglino al giardino, vi trovarono che il Torrigiano, giovane de' Torrigiani, lavorava di terra certe figure tonde che da Bertoldo gli erano state date. Michelagnolo, vedendo questo, per emulazione alcune ne fece; dove Lorenzo vedendo sì bello spirito lo tenne sempre in molta aspettazione, et egli inanimito dopo alcuni giorni si misse a contrafare con un pezzo di marmo una testa che v'era d'un fauno vecchio antico e grinzo, che era guasta nel naso e nella bocca rideva. Dove a Michelagnolo, che non aveva mai più tocco marmo né scarpegli, successe il contrafarla così bene, che il Magnifico ne stupì, e visto che fuor della antica testa di sua fantasia gli aveva trapanato la bocca e fattogli la lingua e vedere tutti i denti, burlando quel signore con piacevolezza, come era suo solito, gli disse: “Tu doveresti pur sapere che i vecchi non hanno mai tutti i denti e sempre qualcuno ne manca loro”. Parve a Michelagnolo in quella semplicità, temendo et amando quel signore, che gli dicesse il vero; né prima si fu partito, che subito gli roppe un dente e trapanò la gengìa di maniera, che pareva che gli fussi caduto; et aspettando con desiderio il ritorno del Magnifico, che venuto e veduto la semplicità e bontà di Michelagnolo, se ne rise più d'una volta contandola per miracolo a' suoi amici; e fatto proposito di aiutare e favorire Michelagnolo, mandò per Lodovico suo padre e gliene chiese, dicendogli che lo voleva tenere come un de' suoi figliuoli, et egli volentieri lo concesse; dove il Magnifico gli ordinò in casa sua una ca-mera, e lo faceva attendere, dove del continuo mangiò alla tavola sua co' suoi figliuoli et altre persone degne e di nobiltà, che stavano col Magnifico, dal quale fu onorato. E questo fu l'anno seguente che si era acconcio con Domenico, che aveva Michelagnolo da quindici anni o sedici; e stette in quella casa quattro anni, che fu poi la morte del Magnifico Lorenzo nel 1492. Imperò in quel tempo ebbe da quel signore Michelagnolo provisione, e per aiutare suo padre, di cinque ducati il mese, e per rallegrarlo gli diede un mantello pagonazzo, et al padre uno officio in dogana; vero è che tutti quei giovani del giardino erano salariati, chi assai e chi poco, dalla liberalità di quel magnifico e nobilissimo cittadino, e da lui mentre che visse furono premiati. Dove in questo tempo consigliato dal Poliziano, uomo nelle lettere singulare, Michelagnolo fece in un pezzo di marmo datogli da quel signore la battaglia di Ercole coi centauri, che fu tanto bella che talvolta per chi ora la considera non par di mano di giovane, ma di maestro pregiato e consumato negli studii e pratico in quell'arte. Ella è oggi in casa sua tenuta per memoria di Lionardo suo nipote come cosa rara che ell'è, il quale Lionardo non è molti anni che aveva in casa per memoria di suo zio una Nostra Donna di basso rilievo di mano di Michelagnolo di marmo alta poco più d'un braccio, nella quale sendo giovanetto in questo tempo medesimo, volendo contrafare la maniera di Donatello si portò sì bene che par di man sua, eccetto che vi si vede più grazia e più disegno. Questa donò Lionardo poi al duca Cosimo Medici, il quale la tiene per cosa singularissima, non essendoci di sua mano altro basso rilievo che questo di scultura.
E tornando al giardino del magnifico Lorenzo, era il giardino tutto pieno d'anticaglie e di eccellenti pitture molto adorno, per bellezza, per studio, per piacere ragunate in quel loco, del quale teneva di continuo Michelagnolo le chiavi, e molto più era sollecito che gli altri in tutte le sue azzioni, e con viva fierezza sempre pronto si mostrava. Disegnò molti mesi nel Carmine alle pitture di Masaccio, dove con tanto giudizio quelle opere ritraeva, che ne stupivano gli artefici e gli altri uomini di maniera, che gli cresceva l'invidia insieme col nome. Dicesi che il Torrigiano, contratta seco amicizia e scherzando, mosso da invidia di vederlo più onorato di lui e più valente nell'arte, con tanta fierezza gli percosse d'un pugno il naso, che rotto e stiacciatolo di mala sorte lo segnò per sempre; onde fu bandito di Fiorenza il Torrigiano, come s'è detto altrove.
Morto il magnifico Lorenzo, se ne tornò Michelagnolo a casa del padre con dispiacere infinito della morte di tanto uomo amico a tutte le virtù, dove Michelagnolo comperò un gran pezzo di marmo e fecevi dentro un Ercole di braccia quattro, che sté molti anni nel palazzo degli Strozzi, il quale fu stimato cosa mirabile e poi fu mandato l'anno dello assedio in Francia al re Francesco da Giovambatista della Palla. Dicesi che Piero de' Medici, che molto tempo aveva praticato Michelagnolo, sendo rimasto erede di Lorenzo suo padre mandava spesso per lui volendo comperare cose antiche di camei et altri intagli; et una invernata che e' nevicò in Fiorenza assai, gli fece fare di neve nel suo cortile una statua che fu bellissima, onorando Michelagnolo di maniera per le virtù sue, che 'l padre cominciando a vedere che era stimato fra i grandi, lo rivestì molto più onoratamente che non soleva. Fece per la chiesa di Santo Spirito della città di Firenze un Crocifisso di legno, che si pose et è sopra il mezzo tondo dello altare maggiore a compiacenza del priore, il quale gli diede comodità di stanze; dove molte volte scorticando corpi morti per studiare le cose di notomia, cominciò a dare perfezzione al gran disegno che gl'ebbe poi. Avvenne che furono cacciati di Fiorenza i Medici, e già poche settimane innanzi Michelagnolo era andato a Bologna e poi a Venezia, temendo che non gli avvenisse per essere familiare di casa qualche caso sinistro, vedendo l'insolenzie e mal modo di governo di Piero de' Medici; e non avendo avuto in Venezia trattenimento se ne tornò a Bologna; dove, avvenutogli inconsideratamente disgrazia di non pigliare un contrasegno al-lo entrare della porta per uscir fuori, come era allora ordinato per sospetto - ché Messer Giovanni Bentivogli voleva che i forestieri che non avevano il contrasegno fussino condennati in lire cinquanta di bolognini -, et incorrendo Michelagnolo in tal disordine, né avendo il modo di pagare, fu compassionevolmente veduto a caso da Messer Giovanfrancesco Aldovrandi, uno de' sedici del governo, il quale fattosi contare la cosa lo liberò e lo trattenne appresso di sé più d'uno anno. Et un dì l'Aldovrando, condottolo a vedere l'arca di San Domenico fatta, come si disse, da Giovan Pisano e poi da maestro Niccolò da l'Arca scultori vecchi, e mancandoci un Angelo che teneva un candelliere, et un San Petronio, figure d'un braccio incirca, gli dimandò se gli bastasse l'animo di fargli: rispose di sì. Così, fattogli dare il marmo, gli condusse, che son le miglior figure che vi sieno, e gli fece dare Messer Francesco Aldovrando ducati trenta d'amendue.
Stette Michelagnolo in Bologna poco più d'uno anno e vi sarebbe stato più per satisfare alla cortesia dello Aldovrandi, il quale l'amava e per il disegno e perché piacendoli come toscano la pronunzia del leggere di Michelagnolo, volentieri udiva le cose di Dante, del Petrarca e del Boccaccio et altri poeti toscani. Ma perché conosceva Michelagnolo che perdeva tempo, volentieri se ne tornò a Fiorenza e fé per Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici di marmo un San Giovannino, e poi dreto a un altro marmo si messe a fare un Cupido che dormiva, quanto il naturale; e finito, per mezzo di Baldassarri del Milanese fu mostro a Pierfrancesco per cosa bella, che giudicatolo il medesimo gli disse: “Se tu lo mettessi sotto terra sono certo che passerebbe per antico, mandandolo a Roma acconcio in maniera che paressi vecchio, e ne caveresti molto più che a venderlo qui”. Dicesi che Michelagnolo l'acconciò di maniera che pareva antico, né è da maravigliarsene perché aveva ingegno da far questo e meglio. Altri vogliono che 'l Milanese lo portassi a Roma e lo sotterrassi in una sua vigna, e poi lo vendessi per antico al cardinale San Giorgio ducati dugento. Altri dicono che gliene vendé un che faceva per il Milanese, che scrisse a Pierfrancesco che facessi dare a Michelagnolo scudi trenta, dicen-do che più del Cupido non aveva avuti, ingannando il cardinale Pierfrancesco e Michelagnolo; ma inteso poi da chi aveva visto che 'l putto era fatto a Fiorenza, tenne modi che seppe il vero per un suo mandato, e fece sì l'agente del Milanese gl'ebbe a rimettere e riebbe il Cupido, il quale venuto nelle mani al duca Valentino e donato da lui alla Marche-sana di Mantova, che lo condusse al paese dove oggi ancor si vede. Questa cosa non passò senza biasimo del cardinale San Giorgio, il quale non conoscendo la virtù dell'opera, che consiste nella perfezzione, che tanto son buone le moderne quanto le antiche pur che sieno eccellenti, essendo più vanità quella di coloro che van dietro più al nome che a' fatti; che di questa sorte d'uomini se n'è trovato d'ogni tempo, che fanno più conto del parere che dell'essere. Imperò questa cosa diede tanta riputazione a Michelagnolo che fu subito condotto a Roma et acconcio col cardinale San Giorgio, dove stette vicino a un anno, che come poco intendente di queste arti, non fece fare niente a Michelagnolo. In quel tempo un barbiere del cardinale stato pittore, che coloriva a tempera molto diligentemente, ma non aveva disegno, fattosi amico Michelagnolo gli fece un cartone d'un San Francesco che riceve le stimate, che fu condotto con i colori dal barbieri in una tavoletta molto diligentemente: la qual pittura è oggi locata in una prima cappella entrando in chiesa a man manca di San Piero a Montorio. Conobbe bene poi la virtù di Michelagnolo Messer Iacopo Galli, gentiluomo romano, persona ingegnosa, che gli fece fare un Cupido di marmo, quanto il vivo, et appresso una figura di un Bacco di palmi dieci che ha una tazza nella man destra e nella sinistra una pelle d'un tigre et un grappolo d'uve, che un satirino cerca di mangiargliene, nella qual figura si conosce che egli ha voluto tenere una certa mistione di membra maravigliose, e particolarmente avergli dato la sveltezza della gioventù del maschio e la carnosità e tondezza della femina: cosa tanto mirabile, che nelle statue mostrò essere eccellente più d'ogni altro moderno, il quale fino allora avesse lavorato. Per il che nel suo stare a Roma acquistò tanto nello studio dell'arte, ch'era cosa incredibile vedere i pensieri alti e la maniera difficile, con facilissima facilità da lui esercitata, tanto con ispavento di quegli che non erano usi a vedere cose tali, quanto degli usi alle buone, perché le cose che si vedevano fatte, parevano nulla al paragone delle sue. Le quali cose destarono al cardinale di San Dionigi, chiamato il cardinale Rovano franzese, disiderio di lasciar per mezzo di sì raro artefice qualche degna memoria di sé in così famosa città, e gli fé fare una Pietà di marmo tutta tonda, la quale finita fu messa in San Pietro nella cappella della Vergine Maria della Febbre nel tempio di Marte. Alla quale opera non pensi mai scultore, né artefice raro potere aggiugnere di disegno, né di grazia, né con fatica poter mai di finezza, pulitezza e di straforare il marmo tanto con arte, quanto Michelagnolo vi fece, perché si scorge in quella tutto il valore et il potere dell'arte. Fra le cose belle vi sono, oltra i panni divini suoi si scorge il morto Cristo, e non si pensi alcuno di bellezza di membra e d'ar-tificio di corpo vedere uno ignudo tanto ben ricerco di muscoli, vene, nerbi, sopra l'ossatura di quel corpo, né ancora un morto più simile al morto di quello. Quivi è dolcissima aria di testa, et una concordanza nelle appiccature e congiunture delle braccia et in quelle del corpo e delle gambe, i polsi e le vene lavorate, che invero si maraviglia lo stupore che mano d'artefice abbia potuto sì divinamente e propriamente fare in pochissimo tempo cosa sì mirabile; che certo è un miracolo che un sasso da principio senza forma nessuna, si sia mai ridotto a quella perfezzione che la natura a fatica suol formar nella carne. Poté l'amor di Michelagnolo e la fatica insieme in questa opera tanto, che quivi (quello che in altra opera più non fece) lasciò il suo nome scritto attraverso in una cintola che il petto della Nostra Donna soccigne: nascendo che un giorno Michelagnolo entrando drento dove l'è posta vi trovò gran numero di forestieri lombardi che la lodavano molto, un de' quali domandò a un di quegli chi l'aveva fatta, rispose: “Il Gobbo nostro da Milano”. Michelagnolo stette cheto e quasi gli parve strano che le sue fatiche fussino attribuite a un altro; una notte vi si serrò drento e con un lumicino, avendo portato gli scarpegli, vi intagliò il suo nome. Et è veramente tale, che come a vera figura e viva, disse un bellissimo spirito:
Bellezza et onestate,
e doglia e pièta in vivo marmo morte,
deh, come voi pur fate,
non piangete sì forte,
che anzi tempo risveglisi da morte,
e pur, mal grado suo,
nostro Signore e tuo
sposo, figliuolo e padre,
unica sposa sua figliuola e madre.
Laonde egli n'acquistò grandissima fama. E se bene alcuni, anzi goffi che no, dicono che egli abbia fatto la Nostra Donna troppo giovane, non s'accorgono e non sanno eglino che le persone vergini senza essere contaminate si mantengano e conservano l'aria del viso loro gran tempo, senza alcuna macchia, e che gli afflitti come fu Cristo fanno il contrario? Onde tal cosa accrebbe assai più gloria e fama alla virtù sua che tutte l'altre dinanzi.
Gli fu scritto di Fiorenza d'alcuni amici suoi che venisse, perché non era fuor di proposito che di quel marmo che era nell'Opera guasto, il quale Pier Soderini fatto gonfaloniere a vita allora di quella città aveva avuto ragionamento molte volte di farlo condurre a Lionardo da Vinci, et era allora in pratica di darlo a maestro Andrea Contucci dal Monte San Savino eccellente scultore, che cercava di averlo; e Michelagnolo, quantunque fussi dificile a cavarne una figura intera senza pezzi, al che fare non bastava a quegl'altri l'animo di non finirlo senza pezzi, salvo che a lui, e ne aveva avuto desiderio molti anni innanzi, venuto in Fiorenza tentò di averlo.
Era questo marmo di braccia nove, nel quale per mala sorte un maestro Simone da Fiesole aveva cominciato un gigante, e sì mal concio era quella opera, che lo aveva bucato fra le gambe e tutto mal condotto e storpiato: di modo che gli Operai di Santa Maria del Fiore, che sopra tal cosa erano, senza curar di finirlo, l'avevano posto in abandono e già molti anni era così stato et era tuttavia per istare. Squadrollo Michelagnolo di nuovo, et esaminando potersi una ragionevole figura di quel sasso cavare et accomodandosi con l'attitudine al sasso ch'era rimasto storpiato da maestro Simone, si risolse di chiederlo agli Operai et al Soderini, dai quali per cosa inutile gli fu conceduto, pensando che ogni cosa che se ne facesse, fusse migliore che lo essere nel quale allora si ritrovava, perché né spezzato, né in quel modo concio, utile alcuno alla Fabrica non faceva. Laonde Michelagnolo fatto un modello di cera finse in quello per la insegna del palazzo un Davit giovane, con una frombola in mano, acciò che, sì come egli aveva difeso il suo popolo e governatolo con giustizia, così chi governava quella città dovesse animosamente difenderla e giustamente governarla: e lo cominciò nell'Opera di Santa Maria del Fiore, nella quale fece una turata fra muro e tavole et il marmo circondato, e quello di continuo lavorando senza che nessuno il vedesse, a ultima perfezzione lo condusse. Era il marmo già da maestro Simone storpiato e guasto, e non era in alcuni luoghi tanto che alla volontà di Michelagnolo bastasse per quel che averebbe voluto fare: egli fece che rimasero in esso delle prime scarpellate di maestro Simone, nella estremità del marmo, delle quali ancora se ne vede alcuna. E certo fu miracolo quello di Michelagnolo far risuscitare uno che era morto.
Era questa statua quando finita fu, ridotta in tal termine che varie furono le dispute che si fecero per condurla in piazza de' Signori. Per che Giuliano da S. Gallo et Antonio suo fratello fecero un castello di legname fortissimo e quella figura con i canapi sospesero a quello, acciò che scotendosi non si troncasse, anzi venisse crollandosi sempre, e con le travi per terra piane con argani la tirorono e la missero in opera. Fece un cappio al canapo che teneva sospesa la figura facilissimo a scorrere, e stringeva quanto il peso l'agravava, che è cosa bellissima et ingegnosa che l'ho nel nostro libro disegnato di man sua, che è mirabile, sicuro e forte per legar pesi. Nacque in questo mentre, che vistolo su Pier Soderini, il quale piaciutogli assai, et in quel mentre che lo ritoccava in certi luoghi, disse a Michelagnolo che gli pareva che il naso di quella figura fussi grosso. Michelagnolo accortosi che era sotto al gigante il gonfalonieri e che la vista non lo lasciava scorgere il vero, per satisfarlo salì in sul ponte, che era accanto alle spalle, e preso Michelagnolo con prestezza uno scarpello nella man manca con un poco di polvere di marmo che era sopra le tavole del ponte, e cominciato a gettare leggieri con li scarpegli, lasciava cadere a poco a poco la polvere, né toccò il naso da quel che era. Poi guardato a basso al gonfalonieri, che stava a vedere, disse: “Guardatelo ora”. “A me mi piace più”, disse il gonfalonieri, “gli avete dato la vita.” Così scese Michelagnolo, e lo avere contento quel signore che se ne rise da sé Michelagnolo avendo compassione a coloro che per parere d'intendersi non sanno quel che si dicano; et egli, quando ella fu murata e finita la discoperse, e veramente che questa opera ha tolto il grido a tutte le statue moderne et antiche, o greche, o latine che elle si fussero, e si può dire che né 'l Marforio di Roma né il Tevere o il Nilo di Belvedere o i giganti di Monte Cavallo le sian simili in conto alcuno, con tanta misura e bellezza e con tanta bontà la finì Michelagnolo. Perché in essa sono contorni di gambe bellissime et appiccature e sveltezza di fianchi divine; né ma' più s'è veduto un posamento sì dolce né grazia che tal cosa pareggi, né piedi, né mani, né testa che a ogni suo membro di bontà d'artificio e di parità, né di disegno s'accordi tanto. E certo chi vede questa non dee curarsi di vedere altra opera di scultura fatta nei nostri tempi o negli altri da qual si voglia artefice. N'ebbe Michelagnolo da Pier Soderini per sua mercede scudi quattrocento, e fu rizzata l'anno 1504, e per la fama che per questo acquistò nella scultura fece al sopra detto gonfalonieri un Davit di bronzo bellissimo, il quale egli mandò in Francia; et ancora in questo tempo abbozzò e non finì due tondi di marmo, uno a Taddeo Taddei, oggi in casa sua, et a Bartolomeo Pitti ne cominciò un altro, il quale da fra' Miniato Pitti di Monte Oliveto, intendente e raro nella cosmografia et in molte scienzie e particolarmente nella pittura, fu donata a Luigi Guicciardini che gl'era grande amico; le quali opere furono tenute egregie e mirabili. Et in questo tempo ancora abbozzò una statua di marmo di San Matteo nell'Opera di Santa Maria del Fiore, la quale statua così abbozzata mostra la sua perfezzione et insegna agli scultori in che maniera si cavano le figure de' marmi senza che venghino storpiate, per potere sempre guadagnare col giudizio levando del marmo et avervi da potersi ritrarre e mutare qualcosa, come accade se bisognassi. Fece ancora di bronzo una Nostra Donna in un tondo che lo gettò di bronzo a requisizione di certi mercatanti fiandresi de' Moscheroni, persone nobilissime ne' paesi loro, che pagatogli scudi cento la mandassero in Fiandra.
Venne volontà ad Agnolo Doni, cittadino fiorentino amico suo, sì come quello che molto si dilettava aver cose belle così d'antichi come di moderni artefici, d'avere alcuna cosa di Michelagnolo; per che gli cominciò un tondo di pittura, dentrovi una Nostra Donna, la quale inginochiata con amendua le gambe, ha in sulle braccia un putto e porgelo a Giuseppo che lo riceve; dove Michelagnolo fa conoscere nello svoltare della testa della madre di Cristo e nel tenere gli occhi fissi nella somma bellezza del figliuolo, la maravigliosa sua contentezza e lo affetto del farne parte a quel santissimo vecchio, il quale con pari amore, tenerezza e reverenza lo piglia, come benissimo si scorge nel volto suo senza molto considerarlo. Né bastando questo a Michelagnolo, per mostrare maggiormente l'arte sua essere grandissima, fece nel campo di questa opera molti ignudi appoggiati, ritti et a sedere, e con tanta diligenza e pulitezza lavorò questa opera che certamente delle sue pitture in tavola, ancora che poche sieno, è tenuta la più finita e la più bella opera che si truovi. Finita che ella fu, la mandò a casa Agnolo, coperta, per un mandato insieme con una polizza, e chiedeva settanta ducati per suo pagamento. Parve strano ad Agnolo, che era assegnata persona, spendere tanto in una pittura, se bene e' conoscesse che più valesse, e disse al mandato che bastavano quaranta, e gliene diede; onde Michelagnolo gli rimandò indietro, mandandogli a dire che cento ducati o la pittura gli rimandasse indietro. Per il che Agnolo, a cui l'opera piaceva, disse: “Io gli darò quei settanta”. Et egli non fu contento, anzi per la poca fede d'Agnolo ne volle il doppio di quel che la prima volta ne aveva chiesto; per che se Agnolo volse la pittura, fu forzato mandargli centoquaranta.
Avvenne che dipignendo Lionardo da Vinci pittore rarissimo nella sala grande del Consiglio, come nella vita sua è narrato, Piero Soderini, allora gonfaloniere, per la gran virtù che egli vidde in Michelagnolo, gli fece allogagione d'una parte di quella sala: onde fu cagione che egli facesse a concorrenza di Lionardo l'altra facciata, nella quale egli prese per subietto la guerra di Pisa. Per il che Michelagnolo ebbe una stanza nello spedale de' Tintori a Santo Onofrio, e quivi cominciò un grandissimo cartone, né però volse mai che altri lo vedesse. E lo empié di ignudi che bagnandosi per lo caldo nel fiume d'Arno, in quello stante si dava a l'arme nel campo fingendo che gli inimici li assalissero, e mentre che fuor delle acque uscivano per vestirsi i soldati, si vedeva dalle divine mani di Michelagnolo chi affrettare lo armarsi per dare aiuto a' compagni, altri affibbiarsi la corazza, e molti mettersi altre armi in dosso, et infiniti combattendo a cavallo cominciare la zuffa. Eravi fra l'altre figure un vecchio che aveva in testa per farsi ombra una grillanda di ellera, il quale postosi a sedere per mettersi le calze e non potevano entrargli per aver le gambe umide dell'acqua, e sentendo il tumulto de' soldati e le grida et i romori de' tamburini affrettando tirava per forza una calza; et oltra che tutti i muscoli e' nervi della figura si vedevano, faceva uno storcimento di bocca per il quale dimostrava assai quanto e' pativa e che egli si adoperava fin alle punte de' piedi. Eranvi tamburini ancora e figure che coi panni avvolti ignudi correvano verso la baruffa; e di stravaganti attitudini si scorgeva chi ritto, chi ginocchioni o piegato o sospeso a giacere, et in aria attaccati con iscorti difficili. V'erano ancora molte figure aggruppate et in varie maniere abbozzate, chi contornato di carbone, chi disegnato di tratti e chi sfumato e con biacca lumeggiati, volendo egli mostrare quanto sapesse in tale professione. Per il che gli artefici stupiti et ammirati restorono, vedendo l'estremità dell'arte in tal carta per Michelagnolo mostrata loro. Onde, veduto sì divine figure, dicono, alcuni che le viddero, di man sua e d'altri ancora non essere mai più veduto cosa che della divinità dell'arte nessuno altro ingegno possa arrivarla mai. E certamente è da credere, perciò che da poi che fu finito e portato alla sala del papa con gran romore dell'arte e grandissima gloria di Michelagnolo, tutti coloro che su quel cartone studiarono e tal cosa disegnarono, come poi si seguitò molti anni in Fiorenza per forestieri e per terrazzani, diventarono persone in tale arte eccellenti, come vedemo: poiché in tale cartone studiò Aristotile da S. Gallo amico suo, Ridolfo Ghirlandaio, Raffael Sanzio da Urbino, Francesco Granaccio, Baccio Bandinelli et Alonso Berugetta spagnuolo; seguitò Andrea del Sarto, il Francia Bigio, Iacopo Sansovino, il Rosso, Maturino, Lorenzetto, el Tribolo al-lora fanciullo, Iacopo da Puntormo e Pierin del Vaga, i quali tutti ottimi maestri fiorentini furono; per il che essendo questo cartone diventato uno studio d'artefici, fu condotto in casa Medici nella sala grande di sopra, e tal cosa fu cagione che egli troppo a securtà nelle mani degli artefici fu messo: per che nella infermità del duca Giuliano, mentre nessuno badava a tal cosa, fu come s'è detto altrove stracciato, et in molti pezzi diviso, tal che in molti luoghi se n'è sparto, come ne fanno fede alcuni pezzi che si veggono ancora in Mantova in casa di Messer Uberto Strozzi gentiluomo mantovano, i quali con riverenza grande son tenuti. E certo che a vedere e' son più tosto cosa divina che umana.
Era talmente la fama di Michelagnolo per la Pietà fatta, per il gigante di Fiorenza e per il cartone nota, che essendo venuto l'anno 1503 la morte di papa Alessandro VI e creato Giulio Secondo, che allora Michelagnolo era di anni ventinove incirca, fu chiamato con gran suo favore da Giulio II per fargli fare la sepoltura sua, e per suo viatico gli fu pagato scudi cento da' suoi oratori. Dove condottosi a Roma, passò molti mesi innanzi che gli facessi mettere mano a cosa al-cuna. Finalmente si risolvette a un disegno che aveva fatto per tal sepoltura, ottimo testimonio della virtù di Michelagnolo, che di bellezza e di superbia e di grande ornamento e ricchezza di statue passava ogni antica et imperiale sepoltura. Onde cresciuto lo animo a papa Giulio, fu cagione che si risolvé a mettere mano a rifare di nuovo la chiesa di S. Piero di Roma per mettercela drento, come s'è detto altrove. Così Michelagnolo si misse al lavoro con grande animo: e per dargli principio, andò a Carrara a cavare tutti i marmi con dua suoi garzoni, et in Fiorenza da Alamanno Salviati ebbe a quel conto scudi mille, dove consumò in que' monti otto mesi senza altri danari o provisioni, dove ebbe molti capricci di fare in quelle cave, per lasciar memoria di sé, come già avevano fatto gli antichi, statue grandi, invitato da que' massi. Scelto poi la quantità de' marmi et fattoli caricare alla marina e di poi condotti a Roma, empierono la metà della piazza di S. Piero intorno a Santa Caterina e fra la chiesa e 'l corridore che va a Castello, nel qual luogo Michelagnolo aveva fatto la stanza da lavorar le figure et il resto della sepoltura; e perché comodamente potessi venire a vedere lavorare, il Papa aveva fatto fare un ponte levatoio dal corridore alla stanza, e per ciò molto famigliare se l'era fatto, che col tempo questi favori gli dettono gran noia e persecuzione, e gli generorono molta invidia fra gli artefici suoi. Di que-st'opera condusse Michelagnolo, vivente Giulio e dopo la morte sua, quattro statue finite et otto abbozzate, come si dirà al suo luogo, e perché questa opera fu ordinata con grandissima invenzione qui di sotto narreremo l'ordine che egli pigliò. E perché ella dovessi mostrare maggior grandezza volse che ella fussi isolata da poterla vedere da tutt'a quattro le faccie, che in ciascuna era per un verso braccia dodici e per l'altre due braccia diciotto, tanto che la proporzione era un quadro e mezzo. Aveva un ordine di nicchie di fuori a torno a torno, le quali erano tramezzate da termini vestiti dal mezzo in su, che con la testa tenevano la prima cornice, e ciascuno termine con strana e bizzarra attitudine ha legato un prigione ignudo, il qual posava coi piedi in un risalto d'un basamento. Questi prigioni erano tutte le provincie soggiogate da questo Pontefice e fatte obediente alla Chiesa apostolica; et altre statue diverse pur legate erano tutte le virtù et arte ingegnose, che mostravano esser sottoposte alla morte non meno che si fussi quel Pontefice che sì onoratamente le adoperava. Su' canti della prima cornice andava quattro figure grandi: la Vita attiva e la contemplativa, e S. Paulo e Moisè. Ascendeva l'opera sopra la cornice in gradi diminuendo con un fregio di storie di bronzo e con altre figure e putti et ornamenti a torno, e sopra era per fine due figure, che una era il Cielo, che ridendo sosteneva in sulle spalle una bara insieme con Cibele dea della terra, [e] pareva che si dolessi che ella rimanessi al mondo priva d'ogni virtù per la morte di questo uomo, et il Cielo pareva che ridessi che l'anima sua era passata alla gloria celeste. Era accomodato che s'entrava et usciva per le teste della quadratura dell'opera nel mezzo delle nicchie, e drento era caminando a uso di tempio in forma ovale, nel quale aveva nel mezzo la cassa, dove aveva a porsi il corpo morto di quel Papa; e finalmente vi andava in tutta quest'opera quaranta statue di marmo senza l'altre storie, putti et ornamenti e tutte intagliate le cornici e gli altri membri dell'opera d'architettura. Et ordinò Michelagnolo per più facilità che una parte de' marmi gli fussin portati a Fiorenza, dove egli disegnava tal volta farvi la state per fuggire la mala aria di Roma, dove in più pezzi ne condusse di quest'opera una faccia di tutto punto, e di suo mano finì in Roma due prigioni a fatto cosa divina, et altre statue che non s'è mai visto meglio, che non si messono altrimenti in opera (ché furono da lui donati detti prigioni al signor Ruberto Strozzi per trovarsi Michelagnolo malato in casa sua, che furono mandati poi a donare al re Francesco, e' quali sono oggi a Cevan in Francia); et otto statue abozzò in Roma parimente, et a Fiorenza ne abozzò cinque, e finì una Vittoria con un prigion sotto, qual sono oggi appresso del duca Cosimo, stati donati da Lionardo suo nipote a sua eccellenza, che la Vittoria l'ha messa nella sala grande del suo palazzo, dipinta dal Vasari. Finì il Moisè di cinque braccia di marmo, alla quale statua non sarà mai cosa moderna alcuna che possa arrivare di bellezza, e delle antiche ancora si può dire il medesimo, avvenga che egli con gravissima attitudine sedendo, posa un braccio in sulle tavole che egli tiene con una mano, e con l'altra si tiene la barba, la quale nel marmo svellata e lunga è condotta di sorte, che i capegli, dove ha tanta dificultà la scultura, son condotti sottilissimamente piumosi, morbidi e sfilati d'una maniera, che pare impossibile che il ferro sia diventato pennello; et inoltre alla bellezza della faccia, che ha certo aria di vero Santo e terribilissimo principe, pare che mentre lo guardi abbia voglia di chiedergli il velo per coprirgli la faccia, tanto splendida e tanto lucida appare altrui. Et ha sì bene ritratto nel marmo la divinità che Dio aveva messo nel santissimo volto di quello, oltreché vi sono i panni straforati e finiti con bellissimo girar di lembi, e le braccia di muscoli, e le mane di ossature, e' nervi sono a tanta bellezza e perfezzione condotte, e le gambe appresso, e le ginocchia, et i piedi sotto di sì fatti calzari accomodati, et è finito talmente ogni lavoro suo che Moisè può più oggi che mai chiamarsi amico di Dio, poiché tanto innanzi agli altri ha voluto mettere insieme e preparargli il corpo per la sua ressurrezione, per le mani di Michelagnolo; e seguitino gli ebrei di andare, come fanno ogni sabato, a schiera, e maschi e femine, come gli storni a visitarlo et adorarlo: che non cosa umana, ma divina adoreranno.
Dove finalmente pervenne allo accordo e fine di questa opera, la quale delle quattro parti se ne murò poi in San Pie-ro in Vincola una delle minori. Dicesi che mentre che Michelagnolo faceva questa opera, venne a Ripa tutto il restante de' marmi per detta sepoltura che erano rimasti a Carrara, e' quali fur fatti condurre cogl'altri sopra la piazza di San Pietro, e perché bisognava pagarli a chi gli aveva condotti, andò Michelagnolo come era solito al Papa; ma avendo Sua Santità in quel dì cosa che gli importava per le cose di Bologna, tornò a casa e pagò di suo detti marmi pensando averne l'ordine subito da Sua Santità. Tornò un altro giorno per parlarne al Papa, e trovato dificultà a entrare, perché un palafreniere gli disse che avessi pazienzia, che aveva commessione di non metterlo drento, fu detto da un vescovo al palafreniere: “Tu non conosci forse questo uomo”. “Troppo ben lo conosco”, disse il palafrenieri, “ma io son qui per far quel che m'è commesso da' miei superiori e dal Papa”. Dispiacque questo atto a Michelagnolo, e parendogli il contrario di quello che aveva provato innanzi, sdegnato rispose al palafrenieri del Papa, che gli dicessi che da qui innanzi quando lo cercava Sua Santità essere ito altrove, e tornato alla stanza a due ore di notte montò in sulle poste lasciando a due servitori che vendessino tutte le cose di casa ai giudei e lo seguitassero a Fiorenza dove egli s'era avviato. Et arrivato a Poggibonzi, luogo sul fiorentino, sicuro si fermò, né andò guari che cinque corrieri arrivorono con le lettere del Papa per menarlo indietro, che né per preghi, né per la lettera che gli comandava che tornasse a Roma sotto pena della sua disgrazia, al che fare non volse intendere niente: ma i prieghi de' corrieri finalmente lo svolsono a scrivere due parole in risposta a Sua Santità, che gli perdonassi che non era per tornare più alla presenzia sua, poiché l'aveva fatto cacciare via come un tristo, e che la sua fedel servitù non meritava questo, e che si provedessi altrove di chi lo servissi.
Arrivato Michelagnolo a Fiorenza, attese a finire in tre mesi che vi stette il cartone della sala grande, che Pier Soderini gonfaloniere desiderava che lo mettessi in opera. Imperò venne alla Signoria in quel tempo tre brevi che dovessino rimandare Michelagnolo a Roma; per il che egli veduto questa furia del Papa, dubitando di lui ebbe, secondo che si dice, voglia di andarsene in Gostantinopoli a servire il Turco per mezzo di certi frati di San Francesco, che desiderava averlo per fare un ponte che passassi da Gostantinopoli a Pera. Pure, persuaso da Pier Soderini allo andare a trovare il Papa, ancor che non volessi, come persona publica per assicurarlo con titolo d'imbasciadore della città, finalmente lo raccomandò al cardinale Soderini suo fratello, che lo introducessi al Papa, [e] lo inviò a Bologna dove era già di Roma venuto Sua Santità. Dicesi ancora in altro modo questa sua partita di Roma: che il Papa si sdegnassi con Michelagnolo, il quale non voleva lasciar vedere nessuna delle sue cose, e che avendo sospetto de' suoi dubitando come fu più d'una volta che vedde quel che faceva travestito a certe occasioni che Michelagnolo non era in casa o al lavoro, e perché corrompendo una volta i suo' garzoni con danari per entrare a vedere la cappella di Sisto suo zio, che gli fé dipignere come si disse poco innanzi, e che nascostosi Michelagnolo una volta perché egli dubitava del tradimento de' garzoni, tirò con tavole nell'entrare il Papa in cappella, che non pensando chi fussi, lo fece tornare fuora a furia. Basta che o nell'uno modo o nell'altro, egli ebbe sdegno col Papa, e poi paura, che se gli ebbe a levar dinanzi.
Così arrivato in Bologna, né prima trattosi gli stivali che fu da' famigliari del Papa condotto da Sua Santità, che era nel palazzo de' Sedici, accompagnato da uno vescovo del cardinale Soderini, perché essendo malato il cardinale non poté andargli; et arrivati dinanzi al Papa, inginocchiatosi Michelagnolo, lo guardò Sua Santità a traverso e come sdegnato, e gli disse: “In cambio di venire tu a trovare noi, tu hai aspettato che venghiamo a trovar te?”, volendo inferire che Bologna è più vicina a Fiorenza che Roma. Michelagnolo con le mani cortese et a voce alta gli chiese umilmente perdono, scusandosi che quel che aveva fatto era stato per isdegno, non potendo sopportare d'essere cacciato così via, e che avendo errato di nuovo gli perdonassi. Il vescovo che aveva al Papa offerto Michelagnolo, scusandolo diceva a Sua Santità che tali uomini sono ignoranti e che da quell'arte in fuora non valevano in altro, e che volentieri gli perdonassi. Al Papa venne còllora, e con una mazza che avea rifrustò il vescovo dicendogli: “Ignorante sei tu che gli di' villania, che non gliene diciàn noi”. Così dal palafrenieri fu spinto fuori il vescovo con frugoni, e partito, et il Papa sfogato la còllora sopra di lui, benedì Michelagnolo, il quale con doni e speranze fu trattenuto in Bologna tanto, che Sua Santità gli ordinò che dovessi fare una statua di bronzo a similitudine di papa Giulio, cinque braccia d'altezza; nella quale usò arte bellissima nella attitudine, perché nel tutto avea maestà e grandezza, e ne' panni mostrava ricchezza e magnificenza, e nel viso animo, forza, prontezza e terribilità. Questa fu posta in una nicchia sopra la porta di San Petronio. Dicesi che mentre Michelagnolo la lavorava, vi capitò il Francia orefice e pittore eccellentissimo per volerla vedere, avendo tanto sentito delle lodi e della fama di lui e delle opere sue, e non avendone vedute alcuna. Furono adunque messi mezzani, perché vedesse questa, e n'ebbe grazia. Onde veggendo egli l'artificio di Michelagnolo, stupì; per il che fu da lui dimandato che gli pareva di quella figura, rispose il Francia che era un bellissimo getto et una bella materia. Là dove parendo a Michelagnolo che egli avessi lodato più il bronzo che l'artifizio, disse: “Io ho quel medesimo obligo a papa Giulio che me l'ha data, che voi agli speziali che vi danno i colori per dipignere”, e con còllora in presenza di que' gentiluomini disse che egli era un goffo. E di questo proposito medesimo venendogli innanzi un figliuolo del Francia su detto, che era molto bel giovanetto, gli disse: “Tuo padre fa più belle figure vive che dipinte”.
Fra i medesimi gentiluomini fu uno non so chi, che dimandò a Michelagnolo qual credeva che fussi maggiore, o la statua di quel Papa, o un par di bo', et ei rispose: “Secondo che buoi, se di questi bolognesi, oh! senza dubio son minori i nostri da Fiorenza”. Condusse Michelagnolo questa statua finita di terra innanzi che 'l Papa partissi di Bologna per Roma; et andato Sua Santità a vedere, né sapeva che se gli porre nella man sinistra alzando la destra con un atto fiero, che 'l Papa dimandò s'ella dava la benedizione o la maladizione. Rispose Michelagnolo che l'annunziava il popolo di Bologna, perché fussi savio; e richiesto Sua Santità di parere se dovessi porre un libro nella sinistra, gli disse: “Mettivi una spada, che io non so lettere”. Lasciò il Papa in sul banco di Messer Antonmaria da Lignano scudi mille per finirla, la quale fu poi posta nel fine di sedici mesi che penò a condurla, nel frontespizio della chiesa di San Petronio nella facciata dinanzi, come si è detto, e della sua grandezza s'è detto. Questa statua fu rovinata da' Bentivogli, e 'l bronzo di quella venduto al duca Alfonso di Ferrara, che ne fece una artiglieria chiamata la Giulia, salvo la testa, la quale si trova nella sua guardaroba.
Mentre che 'l Papa se n'era tornato a Roma e che Michelagnolo aveva condotto questa statua, nella assenzia di Michelagnolo, Bramante, amico e parente di Raffaello da Urbino, e per questo rispetto poco amico di Michelagnolo, vedendo che il Papa favoriva et ingrandiva l'opere che faceva di scoltura, andaron pensando di levargli dell'animo, che tornando Michelagnolo, Sua Santità non facessi attendere a finire la sepoltura sua, dicendo che pareva uno affrettarsi la morte et augurio cattivo il farsi in vita il sepolcro, e' lo persuasono a far che nel ritorno di Michelagnolo Sua Santità, per memoria di Sisto suo zio, gli dovessi far dipignere la volta della cappella che egli aveva fatta in palazzo, et in que-sto modo pareva a Bramante et altri emuli di Michelagnolo di ritrarlo dalla scoltura ove lo vedeva perfetto, e metterlo in disperazione, pensando col farlo dipignere che dovessi fare, per non avere sperimento ne' colori a fresco, opera men lodata, e che dovessi riuscire da meno che Raffaello; e caso pure che e' riuscissi il farlo, el facessi sdegnare per ogni modo col Papa, dove ne avessi a seguire, o nell'uno modo o nell'altro, l'intento loro di levarselo dinanzi. Così ritornato Michelagnolo a Roma e stando in proposito il Papa di non finire per allora la sua sepoltura, lo ricercò che dipignessi la volta della cappella. Il che Michelagnolo, che desiderava finire la sepoltura e parendogli la volta di quella cappella lavor grande e dificile, e considerando la poca pratica sua ne' colori, cercò con ogni via di scaricarsi questo peso da dos-so, mettendo perciò innanzi Raffaello. Ma tanto quanto più ricusava, tanto maggior voglia ne cresceva al Papa, impetuoso nelle sue imprese, e per arroto di nuovo dagli emuli di Michelagnolo stimolato, e spezialmente da Bramante, che quasi il Papa, che era sùbito, si fu per adirare con Michelagnolo. Là dove visto che perseverava Sua Santità in questo, si risolvé a farla, et a Bramante comandò il Papa che facessi per poterla dipignere il palco: dove lo fece impiccato tutto sopra canapi, bucando la volta; il che da Michelagnolo visto dimandò Bramante come egli avea a fare, finito che avea di dipignerla, a riturare i buchi; il quale disse: “E' vi si penserà poi”, e che non si poteva fare altrimenti. Conobbe Michelagnolo che o Bramante in questo valeva poco, o che egl'era poco amico, e se ne andò dal Papa e gli disse che quel ponte non stava bene, e che Bramante non l'aveva saputo fare; il quale gli rispose in presenzia di Bramante che lo facessi a modo suo. Così ordinò di farlo sopra i sorgozoni che non toccassi il muro, che fu il modo che ha insegnato poi et a Bramante et agli altri di armare le volte e fare molte buone opere. Dove egli fece avanzare a un povero uomo legnaiuolo che lo rifece tanto di canapi, che vendutogli avanzò la dote per una sua figliuola, donandogliene Michelagnolo. Per il che messo mano a fare i cartoni di detta volta, dove volse ancora il Papa che si guastassi le facciate che avevano già dipinto al tempo di Sisto i maestri innanzi a lui, e fermò che per tutto il costo di questa opera avessi quindici mi-la ducati, il quale prezzo fu fatto per Giuliano da San Gallo. Per il che sforzato Michelagnolo dalla grandezza della impresa a risolversi di volere pigliare aiuto, e mandato a Fiorenza per uomini e deliberato mostrare in tal cosa che quei che prima v'avevano dipinto dovevano essere prigioni delle fatiche sue, volse ancora mostrare agli artefici moderni come si disegna e dipigne. Laonde il suggetto della cosa lo spinse a andare tanto alto per la fama e per la salute dell'arte, che cominciò e finì i cartoni, e quella volendo poi colorire a fresco e non avendo fatto più, vennero da Fiorenza in Roma alcuni amici suoi pittori, perché a tal cosa gli porgessero aiuto et ancora per vedere il modo del lavorare a fresco da loro, nel qual v'erano alcuni pratichi, fra i quali furono il Granaccio, Giulian Bugiardini, Iacopo di Sandro, l'Indaco vecchio, Agnolo di Domenico et Aristotile, e dato principio all'opera, fece loro cominciare alcune cose per saggio. Ma veduto le fatiche loro molto lontane dal desiderio suo e non sodisfacendogli, una mattina si risolse gettare a terra ogni cosa che avevano fatto. E rinchiusosi nella cappella non volse mai aprir loro, né manco in casa, dove era, da essi si lasciò vedere. E così da la beffa, la quale pareva loro che troppo durasse, presero partito, e con vergogna se ne tornarono a Fiorenza. Laonde Michelagnolo, preso ordine di far da sé tutta quella opera, a bonissimo termine la ridusse con ogni sollecitudine di fatica e di studio; né mai si lasciava vedere per non dare cagione che tal cosa s'avesse a mostrare; onde negli animi delle genti nasceva ogni dì maggior desiderio di vederla.
Era papa Giulio molto desideroso di vedere le imprese che e' faceva, per il che di questa che gli era nascosa venne in grandissimo desiderio; onde volse un giorno andare a vederla e non gli fu aperto, ché Michelagnolo non averebbe voluto mostrarla. Per la qual cosa nacque il disordine, come s'è ragionato, che s'ebbe a partire di Roma, non volendo mostrarla al Papa; che secondo che io intesi da lui per chiarir questo dubbio, quando e' ne fu condotta il terzo, la gli cominciò a levare certe muffe traendo tramontano una invernata. Ciò fu cagione che la calce di Roma, per essere bianca fatta di trevertino, non secca così presto, e mescolata con la pozzolana, che è di color tanè, fa una mestica scura, e quando l'è liquida, aquosa, e che 'l muro è bagnato bene, fiorisce spesso nel seccarsi; dove che in molti luoghi sputava quello salso umore fiorito, ma col tempo l'aria lo consumava. Era di questa cosa disperato Michelagnolo, né voleva seguitare più, e scusandosi col Papa che quel lavoro non gli riusciva, ci mandò Sua Santità Giuliano da San Gallo, che dettogli da che veniva il difetto, lo confortò a seguitare e gli insegnò a levare le muffe. Là dove condottola fino alla metà, il Papa, che v'era poi andato a vedere alcune volte per certe scale a piuoli aiutato da Michelagnolo, volse che ella si scoprissi, perché era di natura frettoloso et impaziente, e non poteva aspettare ch'ella fussi perfetta et avessi avuto, come si dice, l'ultima mano.
Trasse subito che fu scoperta tutta Roma a vedere, et il Papa fu il primo, non avendo pazienzia che abassassi la polvere per il disfare de' palchi. Dove Raffaello da Urbino, che era molto eccellente in imitare, vistola mutò subito maniera, e fece a un tratto per mostrare la virtù sua i Profeti e le Sibille dell'opera della Pace, e Bramante allora tentò che l'al-tra metà della cappella si desse dal Papa a Raffaello. Il che inteso Michelagnolo si dolse di Bramante e disse al Papa senza avergli rispetto molti difetti, e della vita, e delle opere sue d'architettura, che come s'è visto poi, Michelagnolo nella fabbrica di San Piero n'è stato correttore. Ma il Papa, conoscendo ogni giorno più la virtù di Michelagnolo, volse che seguitasse, e veduto l'opera scoperta, giudicò che Michelagnolo l'altra metà la poteva migliorare assai. E così del tutto condusse alla fine perfettamente in venti mesi da sé solo quell'opera senza aiuto pure di chi gli macinassi i colori. Èssi Michelagnolo doluto talvolta che per la fretta che li faceva il Papa e' non la potessi finire come arebbe voluto a modo suo, dimandandogli il Papa importunamente quando e' finirebbe; dove una volta fra l'altre gli rispose che ella sarebbe finita “quando io arò satisfatto a me nelle cose dell'arte”: “E noi vogliamo”, rispose il Papa, “che satisfacciate a noi nella voglia che aviamo di farla presto”; gli conchiuse finalmente che se non la finiva presto, che lo farebbe gettare giù da quel palco. Dove Michelagnolo, che temeva et aveva da temere la furia del Papa, finì subito senza metter tempo in mezzo quel che ci mancava; e disfatto il resto del palco, la scoperse la mattina d'Ognisanti che 'l Papa andò in cap-pella a cantare la messa, con satisfazione di tutta quella città. Desiderava Michelagnolo ritoccare alcune cose a secco, come avevon fatto que' maestri vecchi nelle storie di sotto, certi campi, e panni, et arie di azzurro oltramarino, et ornamenti d'oro in qualche luogo, acciò gli desse più ricchezza e maggior vista; per che avendo inteso il Papa che ci manca-va ancor questo, desiderava, sentendola lodar tanto da chi l'aveva vista, che la fornissi, ma perché era troppo lunga cosa a Michelagnolo rifare il palco, restò pur così. Il Papa vedendo spesso Michelagnolo gli diceva: “Che la cappella si arrichisca di colori e d'oro, ché l'è povera”. Michelagnolo con domestichezza rispondeva: “Padre Santo, in quel tempo gli uomini non portavano addosso oro, e quegli che son dipinti non furon mai troppo ricchi, ma santi uomini, perch'egli sprezaron le ricchezze”. Fu pagato in più volte a Michelagnolo dal Papa a conto di quest'opera tremila scudi, che ne dovette spendere in colori venticinque. Fu condotta questa opera con suo grandissimo disagio dello stare a lavorare col capo all'insù, e talmente aveva guasto la vista, che non poteva leggere lettere né guardar disegni se non all'insù; che gli durò poi parecchi mesi, et io ne posso fare fede, che avendo lavorato cinque stanze in volta per le camere grandi del palazzo del duca Cosimo, se io non avessi fatto una sedia che s'appoggiava la testa e si stava a giacere lavorando, non le conducevo mai, ché mi ha rovinato la vista et indebolito la testa di maniera, che me ne sento ancora e stupisco che Michelagnolo reggessi tanto a quel disagio. Imperò acceso ogni dì più dal desiderio del fare et allo acquisto e miglioramento che fece, non sentiva fatica né curava disagio.
È il partimento di questa opera accomodato con sei peducci per banda et uno nel mezzo delle faccie da' piè e da capo, ne' quali ha fatto di braccia sei di grandezza, drento Sibille e Profeti, e nel mezzo da la Creazione del mondo fino al Diluvio e la inebriazione di Noè, e nelle lunette tutta la Generazione di Gesù Cristo. Nel partimento non ha usato ordine di prospettive che scortino, né v'è veduta ferma, ma è ito accomodando più il partimento alle figure che le figure al partimento, bastando condurre gli ignudi e' vestiti con perfezzione di disegno, che non si può né fare, né s'è fatto mai opera, et a pena con fatica si può imitare il fatto. Questa opera è stata et è veramente la lucerna dell'arte nostra, che ha fatto tanto giovamento e lume all'arte della pittura, che ha bastato a illuminare il mondo, per tante centinaia d'anni in tenebre stato. E nel vero non curi più chi è pittore di vedere novità et invenzioni, e di attitudini, abbigliamenti addosso a figure, modi nuovi d'aria e terribilità di cose variamente dipinte, perché tutta quella perfezzione che si può dare a cosa che in tal magisterio si faccia a questa ha dato. Ma stupisca ora ogni uomo che in quella sa scorger la bontà delle figure, la perfezzione degli scorti, la stupendissima rotondità di contorni, che hanno in sé grazia e sveltezza, girati con quella bella proporzione che nei belli ignudi si vede, ne' quali per mostrar gli stremi e la perfezzione dell'arte, ve ne fece di tutte l'età, diferenti d'aria e di forma così nel viso come ne' lineamenti, di aver più sveltezza e grossezza nelle membra, come ancora si può conoscere nelle bellissime attitudini che diferente[mente] e' fanno sedendo e girando e sostenendo alcuni festoni di foglie di quercia e di ghiande messe per l'arme e per l'impresa di papa Giulio, denotando che a quel tempo et al governo suo era l'età dell'oro, per non essere allora la Italia ne' travagli e nelle miserie che ella è stata poi. Così in mezzo di loro tengono alcune medaglie drentovi storie in bozza e contrafatte in bronzo e d'oro, cavate dal Libro de' Re. Senza che egli per mostrare la perfezzione dell'arte e la grandezza de Dio, fece nelle istorie il suo dividere la luce dalle tenebre, nelle quale si vede la maestà sua che con le braccia aperte si sostiene sopra sé solo e mostra amore insieme et artifizio. Nella seconda fece con bellissima discrezione et ingegno quando Dio fa il sole e la luna, dove è sostenuto da molti putti e mostrasi molto terribile per lo scorto delle braccia e delle gambe. Il medesimo fece nella medesima storia quando benedetto la terra e fatto gli animali, volando si vede in quella volta una figura che scorta, e dove tu camini per la cappella, continuo gira, e si voltan per ogni verso; così nell'altra quando divide l'acqua dalla terra: figure bellissime et acutezze d'ingegno degne solamente d'essere fatte dalle divinissime mani di Michelagnolo. E così seguitò sotto a questo la creazione di Adamo, dove ha figurato Dio portato da un gruppo di Angioli ignudi e di tenera età, i quali par che sostenghino non solo una figura, ma tutto il peso del mondo, apparente tale mediante la venerabilissima maiestà di quello e la maniera del moto, nel quale con un braccio cigne alcuni putti, quasi che egli si sostenga, e con l'altro porge la mano destra a uno Adamo, figurato di bellezza, di attitudine e di dintorni di qualità che e' par fatto di nuovo dal sommo e primo suo creatore più tosto che dal pennello e disegno d'uno uomo tale. Poco di sotto a questa in una altra istoria fé il suo cavar della costa della madre nostra Eva, nella quale si vede quegli ignudi l'un quasi morto per essere prigion del sonno, e l'altra divenuta viva e fatta vigilantissima per la benedizione di Dio. Si conosce dal pennello di questo ingegnosissimo artefice interamente la diferenza che è dal sonno alla vigilanza, e quanto stabile e ferma possa apparire umanamente parlando la maestà divina. Séguitale di sotto come Adamo, alle persuasioni d'una figura mezza donna e mezza serpe, prende la morte sua e nostra nel pomo, e veggonvisi egli et Eva cacciati di Paradiso. Dove nelle figure dell'Angelo appare con grandezza e nobiltà la esecuzione del mandato d'un Signore adirato, e nella attitudine di Adamo il dispiacere del suo peccato, insieme con la paura della morte; come nella femina similmente si conosce la vergogna, la viltà e la voglia del raccomandarsi, mediante il suo restrignersi nelle braccia, giuntar le mani a palme e mettersi il collo in seno; e nel torcer la testa verso l'Angelo, che ella ha più paura della iustizia che speranza nella misericordia divina. Né di minor bellezza è la storia del sacrificio di Caino et Abel, dove sono chi porta le legne e chi soffia chinato nel fuoco et altri che scannono la vittima; la quale certo non è fatta con meno considerazione et accuratezza che le altre. Usò l'arte medesima et il medesimo giudizio nella storia del Diluvio, dove appariscono diverse morti d'uomini, che spaventati dal terror di quei giorni, cercano il più che possono per diverse vie scampo alle lor vite. Perciò che nelle teste di quelle figure, si conosce la vita esser in preda della morte, non meno che la paura, il terrore et il disprezzo d'ogni cosa. Vedevisi la pietà di molti, aiutandosi l'un l'altro tirarsi al sommo d'un sasso cercando scampo. Tra' quali vi è uno che abracciato un mezzo morto, cerca il più che può di camparlo, che la natura non lo mostra meglio. Non si può dir quanto sia bene espressa la storia di Noè, quando inebriato dal vino dorme scoperto et ha presenti un figliuolo che se ne ride e due che lo ricuoprono; storia e virtù d'artefice incomparabile e da non poter essere vinta se non da se medesimo. Conciò sia che come se ella per le cose fatte insino allora avessi preso animo, risorse e demostrossi molto maggiore nelle cinque Sibille e ne' sette Profeti fatti qui di grandezza di cinque braccia l'uno e più; dove in tutti sono attitudini varie e bellezza di panni e varietà di vestiri, e tutto insomma con invenzione et iudizio miracoloso, onde a chi distingue gli affetti loro appariscono divini.
Vedesi quel Ieremia con le gambe incrocicchiate, tenersi una mano alla barba posando il gomito sopra il ginocchio, l'altra posar nel grembo et aver la testa chinata d'una maniera che ben dimostra la malinconia, i pensieri, la cogitazione e l'amaritudine che egli ha del suo popolo; così medesimamente due putti, che gli sono dietro; e similmente è nella prima Sibilla di sotto a lui verso la porta, nella quale volendo esprimere la vecchiezza, oltra che egli aviluppandola di pan-ni ha voluto mostrare che già i sangui sono agghiacciati dal tempo, et inoltre nel leggere, per avere la vista già logora, li fa accostare il libro alla vista acutissimamente. Sotto a questa figura è Ezechiel profeta vecchio, il quale ha una grazia e movenzia bellissima et è molto di panni abbigliato, che con una mano tiene un ruotolo di profezie, con l'altra sollevata, voltando la testa mostra voler parlar cose alte e grandi, e dietro ha due putti che gli tengono i libri. Seguita sotto questi una Sibilla, che fa il contrario di Eritrea sibilla che di sopra dicemo, perché tenendo il libro lontano cerca voltare una carta mentre ella con un ginocchio sopra l'altro si ferma in sé, pensando con gravità quel ch'ella de' scrivere, fin che un putto che gli è dietro, soffiando in un stizzon di fuoco gli accende la lucerna. La qual figura è di bellezza straordinaria per l'aria del viso e per la acconciatura del capo e per lo abbigliamento de' panni, oltra ch'ella ha le braccia nude, le quali son come l'altre parti. Fece sotto questa Sibilla Ioel profeta, il quale fermatosi sopra di sé ha preso una carta e quella con ogni intenzione et affetto legge. Dove nell'aspetto si conosce che egli si compiace tanto di quel che e' truova scritto, ch'e' pare una persona viva quando ella ha aplicato molto forte i suoi pensieri a qualche cosa. Similmente pose sopra la porta della cappella il vecchio Zacheria, il quale cercando per il libro scritto d'una cosa che egli non truova sta con una gamba alta e l'altra bassa, e mentre che la furia del cercare quel che non truova lo fa stare così, non si ricorda del disagio che egli in così fatta positura patisce. Questa figura è di bellissimo aspetto per la vecchiezza et è di forma alquanto grossa et ha un panno con poche pieghe, che è bellissimo, oltra che e' vi è un'altra Sibilla, che voltando in verso l'altare dall'altra banda col mostrare alcune scritte, non è meno da lodare coi suoi putti che si siano l'altre. Ma chi considererà Isaia profeta che gli è di sopra, il quale stando molto fiso ne' suoi pensieri ha le gambe sopraposte l'una e l'altra, e tenendo una mano dentro al libro per segno del dove egli leggeva ha posato l'altro braccio col gomito sopra il libro et apoggiato la gota alla mano, chiamato da un di quei putti che egli ha dietro, volge solamente la testa senza sconciarsi niente del resto, vedrà tratti veramente tolti dalla natura stessa, vera madre dell'arte, e vedrà una figura che tutta bene studiata può insegnare largamente tutti i precetti del buon pittore. Sopra a questo Profeta è una Sibilla vecchia bellissima che mentre che ella siede studia in un libro con una eccessiva grazia, e non senza belle attitudini di due putti che le sono intorno. Né si può pensare di immaginarsi di poter agiugnere alla eccellenza della figura di un giovane fatto per Daniello, il quale scrivendo in un gran libro cava di certe scritte alcune cose e le copia con una avidità incredibile. E per sostenimento di quel peso gli fece un putto fra le gambe, che lo regge mentre che egli scrive, il che non potrà mai paragonare pennello tenuto da qual si voglia mano; così come la bellissima figura della Libica, la quale avendo scritto un gran volume tratto da molti libri, sta con una attitudine donnesca per levarsi in piedi, et in un medesimo tempo mostra volere alzarsi e serrare il libro: cosa difficilissima per non dire impossibile ad ogni altro che al suo maestro.
Che si può egli dire delle quattro storie da' canti, ne' peducci di quella volta? Dove nell'una Davit, con quella forza puerile che più si può, nella vincita d'un gigante spiccandoli il collo fa stupire alcune teste di soldati che sono intorno al campo; come ancora maravigliare altrui le bellissime attitudini che egli fece nella storia di Iudit, nell'altro canto, nella quale apparisce il tronco di Oloferne, che privo della testa si risente, mentre che ella mette la morta testa in una cesta, in capo a una sua fantesca vecchia, la quale per essere grande di persona si china acciò Iudit la possa aggiugnere per acconciarla bene; e mentre che ella tenendo le mani al peso cerca di ricoprirla, e voltando la testa verso il tronco, il quale così morto nello alzare una gamba et un braccio fa romore dentro nel padiglione, mostra nella vista il timore del campo e la paura del morto: pittura veramente consideratissima. Ma più bella e più divina di questa e di tutte l'altre ancora è la storia delle serpi di Moisè, la quale è sopra il sinistro canto dello altare, conciò sia che in lei si vede la strage che fa de' morti, il piovere, il pugnere et il mordere delle serpi, e vi apparisce quella che Moisè messe di bronzo sopra il legno; nella quale storia vivamente si conosce la diversità delle morti che fanno coloro che privi sono d'ogni speranza per il morso di quelle. Dove si vede il veleno atrocissimo far di spasmo e paura morire infiniti, senza il legare le gambe et avvolgere a le braccia coloro che rimasti in quella attitudine che gli erano non si possono muovere; senza le bellissime teste che gridano et arrovesciate si disperano. Né manco belli di tutti questi sono coloro che riguardando il serpente e sentendosi nel riguardarlo alleggerire il dolore e rendere la vita, lo riguardano con affetto grandissimo, fra' quali si vede una femina che è sostenuta da uno d'una maniera che e' si conosce non meno l'aiuto che l'è porto da chi la regge, che il bisogno di lei in sì subita paura e puntura. Similmente nell'altra, dove Assuero essendo in letto legge i suoi annali, son figure molto belle, e tra l'altre vi si vegon tre figure a una tavola, che mangiano, nelle quali rapresenta il consiglio che e' si fece di liberare il popolo ebreo e di appiccare Aman; la quale figura fu da lui in scorto straordinariamente condotta, avvenga che e' finse il tronco che regge la persona di colui e quel braccio che viene innanzi non dipinti, ma vivi e rilevati infuori, così con quella gamba che manda innanzi e simil parti che vanno dentro; figura certamente fra le dificili e belle bellissima e dificilissima. Che troppo lungo sarebbe a dichiarare le tante belle fantasie d'atti diferenti dove tutta è la geonologia d'i padri cominciando da' figliuoli di Noè per mostrare la Generazione di Gesù Cristo. Nelle qual figure non si può dire la diversità delle cose, come panni, arie di teste et infinità di capricci straordinari e nuovi e bellissimamente considerati; dove non è cosa che con ingegno non sia messa in atto; e tutte le figure che vi sono son di scorti bellissimi et artifiziosi, et ogni cosa che si ammira è lodatissima e divina. Ma chi non amirerà e non resterà smarrito veggendo la terribilità dell'Iona, ultima figura della cappella? Dove con la forza della arte la volta, che per natura viene innanzi girata dalla muraglia, sospinta dalla apparenza di quella figura che si piega indietro, apparisce diritta e vinta dal-l'arte del disegno, ombre e lumi, pare che veramente si pieghi indietro.
O veramente felice età nostra, o beati artefici, che ben così vi dovete chiamare, da che nel tempo vostro avete potuto al fonte di tanta chiarezza rischiarare le tenebrose luci degli occhi e vedere fattovi piano tutto quel che era dificile da sì maraviglioso e singulare artefice! Certamente la gloria delle sue fatiche vi fa conoscere et onorare, da che ha tolto da voi quella benda che avevate innanzi agli occhi della mente, sì di tenebre piena, e v'ha scoperto il vero dal falso, il qua-le v'adombrava l'intelletto. Ringraziate di ciò dunque il Cielo e sforzatevi di imitare Michelagnolo in tutte le cose. Sentissi nel discoprirla correre tutto il mondo d'ogni parte, e questo bastò per fare rimanere le persone trasecolate e mutole; laonde il Papa, di tal cosa ingrandito e dato animo a sé di far maggiore impresa, con danari e ricchi doni rimunerò molto Michelagnolo, il quale diceva alle volte de' favori, che gli faceva quel Papa, tanto grandi che mostrava di conoscere grandemente la virtù sua; e se talvolta per una sua cotale amorevolezza gli faceva villania la medicava con doni e favori segnalati: come fu quando dimandandogli Michelagnolo licenzia una volta di andare a fare il San Giovanni a Fiorenza, e chiestogli per ciò danari, disse: “Be', questa cappella quando sarà fornita?”; “Quando potrò, Padre Santo”; il Papa che aveva una mazza in mano percosse Michelagnolo dicendo: “Quando potrò, quando potrò: te la farò finire bene io”. Però tornato a casa Michelagnolo per mettersi in ordine per ire a Fiorenza, mandò subito il Papa Cursio, suo camerieri, a Michelagnolo con cinquecento scudi, dubitando che non facessi delle sue, a placarlo, facendo scusa del Papa che ciò erano tutti favori et amorevolezze. E perché conosceva la natura del Papa e finalmente l'amava, se ne rideva, vedendo poi finalmente ritornare ogni cosa in favore et util suo, e che procurava quel Pontefice ogni cosa per mantenersi questo uomo amico.
Dove che, finito la cappella et innanzi che venissi quel Papa a morte, ordinò Sua Santità, se morissi, al cardinale Santiquattro et al cardinale Aginense suo nipote che facessi finire la sua sepoltura con minor disegno che 'l primo. Al che fare di nuovo si messe Michelagnolo, e così diede principio volentieri a questa sepoltura per condurla una volta senza tanti impedimenti al fine, che n'ebbe sempre di poi dispiacere e fastidi e travagli più che di cosa che facessi in vita, e ne acquistò per molto tempo in un certo modo nome d'ingrato verso quel Papa, che l'amò e favorì tanto. Di che egli alla sepoltura ritornato, quella di continuo lavorando e parte mettendo in ordine disegni da potere condurre le facciate della cappella, volse la fortuna invidiosa che di tal memoria non si lasciasse quel fine che di tanta perfezzione aveva avuto principio; perché successe in quel tempo la morte di papa Giulio, onde tal cosa si misse in abandono per la creazione di papa Leone Decimo, il quale d'animo e valore non meno splendido che Giulio, aveva desiderio di lasciare nella patria sua per essere stato il primo Pontefice di quella, in memoria di sé e d'uno artefice divino e suo cittadino, quelle maraviglie che un grandissimo principe come esso poteva fare. Per il che dato ordine che la facciata di S. Lorenzo di Fiorenza, chiesa dalla casa de' Medici fabricata, si facesse per lui, fu cagione che il lavoro della sepoltura di Giulio rimase imperfetto, e richiese Michelagnolo di parere e disegno e che dovesse essere egli il capo di questa opera. Dove Michelagnolo fé tutta quella resistenza che potette allegando essere obligato per la sepoltura [a] Santiquattro et Aginense; gli rispose che non pensassi a questo che già aveva pensato egli et operato che Michelagnolo fussi licenziato da loro, promettendo che Michelagnolo lavorerebbe a Fiorenza, come già aveva cominciato, le figure per detta sepoltura; che tutto fu con dispiacere de' cardinali e di Michelagnolo che si partì piangendo.
Onde vari et infiniti furono i ragionamenti che circa ciò seguirono; perché tale opera della facciata averebbono voluto compartire in più persone, e per l'architettura concorsero molti artefici a Roma al Papa, e fecero disegni Baccio d'A-gnolo, Antonio da San Gallo, Andrea et Iacopo Sansovino, il grazioso Raffaello da Urbino, il quale nella venuta del Papa fu poi condotto a Fiorenza per tale effetto. Laonde Michelagnolo si risolse di fare un modello, e non volere altro che lui in tal cosa, superiore o guida dell'architettura. Ma questo non volere aiuto fu cagione che né egli né altri operas-se, e que' maestri disperati ai loro soliti esercizii si ritornassero. E Michelagnolo andando a Carrara [passò da Fiorenza] con una comissione che da Iacopo Salviati gli fussino pagati mille scudi; ma essendo nella giunta sua serrato Iacopo in camera per faccende con alcuni cittadini, Michelagnolo non volle aspettare l'udienza, ma si partì senza far motto e subito andò a Carrara. Intese Iacopo dello arrivo di Michelagnolo, e non lo trovando in Fiorenza gli mandò i mille scudi a Carrara. Voleva il mandato che gli facesse la ricevuta, al quale disse che erano per la spesa del Papa e non per interesso suo, che gli riportasse che non usava far quitanza, né riceute per altri; onde per tema colui ritornò senza a Iacopo.
Mentre che egli era a Carrara e che e' faceva cavar marmi, non meno per la sepoltura di Giulio che per la facciata, pensando pur di finirla, gli fu scritto che avendo inteso papa Leone che nelle montagne di Pietrasanta a Seravezza sul dominio fiorentino, nella altezza del più alto monte chiamato l'Altissimo, erano marmi della medesima bontà e bellezza che quelli di Carrara, e già lo sapeva Michelagnolo, ma pareva che non ci volesse attendere per essere amico del marchese Alberigo signore di Carrara, e per fargli beneficio volessi più tosto cavare de' carraresi che di quegli di Seravezza, o fusse che egli la giudicasse cosa lunga e da perdervi molto tempo, come intervenne; ma pure fu forzato andare a Seravezza, se bene allegava in contrario che ciò fussi di più disagio e spesa, come era, massimamente nel suo principio, e di più che non era forse così. Ma, in effetto, non volse udirne parola, però convenne fare una strada di parecchi miglia per le montagne, e per forza di mazze e picconi rompere massi per ispianare e con palafitta ne' luoghi paludosi, ove spese molti anni Michelagnolo per esseguire la volontà del Papa, e vi si cavò finalmente cinque colonne di giusta grandezza, che una n'è sopra la piazza di San Lorenzo in Fiorenza, l'altre sono alla marina. E per questa cagione il marchese Alberigo, che si vedde guasto l'aviamento, diventò poi gran nemico di Michelagnolo senza sua colpa. Cavò oltre a queste colonne molti marmi, che sono ancora in sulle cave stati più di trenta anni. Ma oggi il duca Cosimo ha dato ordine di finire la strada, che ci è ancora dua miglia a farsi, molto malagevole per condurre questi marmi, e di più da un'altra cava eccellente per marmi che allora fu scoperta da Michelagnolo, per poter finire molte belle imprese, e nel medesimo luogo di Seravezza ha scoperto una montagna di mischii durissimi e molti begli sotto Stazema, villa in quelle montagne, dove ha fatto fare il medesimo duca Cosimo una strada siliciata di più di quattro miglia per condurli alla marina.
E tornando a Michelagnolo, che se ne tornò a Fiorenza perdendo molto tempo ora in questa cosa et ora in quell'altra, et allora fece per il palazzo de' Medici un modello delle finestre inginocchiate a quelle stanze che sono sul canto dove Giovanni da Udine lavorò quella camera di stucco e dipinse, che è cosa lodatissima, e fecevi fare, ma con suo ordine, dal Piloto orefice quelle gelosie di rame straforato che son certo cosa mirabile. Consumò Michelagnolo molti anni in cavar marmi; vero è che mentre si cavavano fece modelli di cera et altre cose per l'Opera. Ma tanto si prolungò questa impresa, che i danari del Papa assegnati a questo lavoro si consumarono nella guerra di Lombardia, e l'opera per la morte di Leone rimase imperfetta, per che altro non vi si fece che il fondamento dinanzi per reggerla, e condussesi da Carrara una colonna grande di marmo su la piazza di San Lorenzo. Spaventò la morte di Leone talmente gli artefici e le arti et in Roma et in Fiorenza, che mentre che Adriano vi visse, Michelagnolo s'attese in Fiorenza alla sepoltura di Giulio. Ma morto Adriano e creato Clemente VII, il quale nelle arti della architettura, della scultura, della pittura, fu non meno desideroso di lasciar fama che Leone e gli altri suo' predecessori, in questo tempo, l'anno 1525, fu condotto Giorgio Vasari fanciullo a Fiorenza dal cardinale di Cortona e messo a stare con Michelagnolo a imparare l'arte. Ma essendo lui chiamato a Roma da papa Clemente VII, perché gli aveva cominciato la libreria di San Lorenzo e la sagrestia nuova per metter le sepolture di marmo de' suoi maggiori che egli faceva, si risolvé che il Vasari andasse a stare con Andrea del Sarto fino a che egli si spediva, et egli proprio venne a bottega di Andrea a raccomandarlo.
Partì per Roma Michelagnolo in fretta, et infestato di nuovo da Francesco Maria duca di Urbino nipote di papa Giulio, il quale si doleva di Michelagnolo dicendo che aveva ricevuto sedici mila scudi per detta sepoltura e che se ne stava in Fiorenza a' suoi piaceri, e lo minacciò malamente che se non vi attendeva lo farebbe capitare male. Giunto a Roma papa Clemente, che se ne voleva servire, lo consigliò che facessi conto cogli agenti del Duca, ché pensava che a quel che gli aveva fatto fussi più tosto creditore che debitore; la cosa restò così. E ragionando insieme di molte cose, si risolsero di finire affatto la sagrestia e libreria nuova di S. Lorenzo di Fiorenza. Laonde, partitosi di Roma, e' voltò la cupola che vi si vede, la quale di vario componimento fece lavorare, et al Piloto orefice fece fare una palla a settantadue facce che è bellissima. Accadde mentre che e' la voltava, che fu domandato da alcuni suoi amici: “Michelagnolo, voi doverete molto variare la vostra lanterna da quella di Filippo Bruneleschi”, et egli rispose loro: “Egli si può ben variare, ma migliorare no”.
Fecevi dentro quattro sepolture per ornamento nelle facce, per li corpi de' padri de' due papi, Lorenzo vecchio e Giuliano suo fratello, e per Giuliano fratello di Leone e per Lorenzo suo nipote. E perché egli la volse fare ad imitazione della sagrestia vecchia, che Filippo Brunelleschi aveva fatto, ma con altro ordine di ornamenti, vi fece dentro uno ornamento composito, nel più vario e più nuovo modo che per tempo alcuno gli antichi et i moderni maestri abbino potuto operare; perché nella novità di sì belle cornici, capitegli e base, porte, tabernacoli e sepolture, fece assai diverso da quello che di misura, ordine e regola facevano gli uomini secondo il comune uso e secondo Vitruvio e le antichità, per non volere a quello agiugnere. La quale licenzia ha dato grande animo a quelli che hanno veduto il far suo di mettersi a imitarlo, e nuove fantasie si sono vedute poi alla grottesca più tosto che a ragione o regola, a' loro ornamenti. Onde gli artefici gli hanno infinito e perpetuo obligo, avendo egli rotti i lacci e le catene delle cose, che per via d'una strada comune eglino di continuo operavano. Ma poi lo mostrò meglio e volse far conoscere tal cosa nella libreria di San Lorenzo nel medesimo luogo, nel bel partimento delle finestre, nello spartimento del palco e nella maravigliosa entrata di quel ricetto. Né si vidde mai grazia più risoluta nel tutto e nelle parti come nelle mensole, ne' tabernacoli e nelle cornici, né scala più comoda: nella quale fece tanto bizzarre rotture di scaglioni e variò tanto da la comune usanza delli altri, che ogni uno se ne stupì. Mandò in quello tempo Pietro Urbano pistolese suo creato a Roma a mettere in opera un Cristo ignudo che tiene la croce, il quale è una figura mirabilissima, che fu posto nella Minerva allato alla cappella maggiore per Messer Antonio Metelli. Seguì intorno a questo tempo il Sacco di Roma, la cacciata de' Medici di Firenze, nel qual mutamento disegnando chi governava rifortificare quella città, feciono Michelagnolo sopra tutte le fortificazioni commessario generale. Dove in più luoghi disegnò e fece fortificar la città, e finalmente il poggio di S. Miniato cinse di bastioni, i quali non colle piote di terra faceva e legnami e stipe alla grossa, come s'usa ordinariamente, ma armadure di sotto intessute di castagni e quercie e di altre buone maniere, et in cambio di piote prese mattoni crudi fatti con capechio e sterco di bestie, spianati con somma diligenza: e perciò fu mandato dalla Signoria di Firenze a Ferrara a vedere le fortificazioni del duca Afonso Primo, e così le sue artiglierie e munizioni; ove ricevé molte cortesie da quel signore, che lo pregò che gli facessi a comodo suo qualche cosa di sua mano, che tutto gli promesse Michelagnolo; il quale tornato andava del continuo anco fortificando la città, e benché avessi questi impedimenti lavorava nondimeno un quadro d'una Leda per quel Duca, colorito a tempera di sua mano, che fu cosa divina, come si dirà a suo luogo, e le statue per le sepolture di San Lorenzo segretamente. Stette Michelagnolo ancora in questo tempo sul monte di San Miniato forse sei mesi per sollecitare quella fortificazione del monte, perché se 'l nemico se ne fussi impadronito era perduta la città, e così con ogni sua diligenza seguitava queste imprese. Et in questo tempo seguitò in detta sagrestia l'opera; che di quella restarono parte finite e parte no sette statue, nelle quali con le invenzioni dell'architettura delle sepolture è forza confessare che egli abbia avanzato ogni uomo in queste tre professioni. Di che ne rendono ancora testimonio quelle statue, che da lui furono abozzate e finite di marmo che in tal luogo si veggono: l'una è la Nostra Donna, la quale nella sua attitudine sedendo manda la gamba ritta adosso alla manca con posar ginocchio sopra ginocchio, et il Putto inforcando le cosce in su quella che è più alta, si storce con attitudine bellissima in verso la madre chiedendo il latte, et ella con tenerlo con una mano e con l'altra apogiandosi si piega per dargliene. Ancora che non siano finite le parti sue, si conosce nell'essere rimasta abozzata e gradinata nella imperfezione della bozza la perfezzione dell'opera. Ma molto più fece stupire ciascuno che considerando nel fare le sepolture del duca Giuliano e del duca Lorenzo de' Medici egli pensassi che non solo la terra fussi per la grandezza loro bastante a dar loro onorata sepoltura, ma volse che tutte le parti del mondo vi fossero, e che gli mettessero in mezzo e coprissero il lor sepolcro quattro statue: a uno pose la Notte et il Giorno, a l'altro l'Aurora et il Crepuscolo; le quali statue sono con bellissime forme di attitudini et artificio di muscoli lavorate, bastanti, se l'arte perduta fosse, a ritornarla nella pristina luce. Vi son fra l'altre statue que' due capitani armati, l'uno il pensoso duca Lorenzo, nel sembiante della saviezza con bellissime gambe talmente fatte che occhio non può veder meglio, l'altro è il duca Giuliano sì fiero con una testa e gola con incassatura di occhi, profilo di naso, sfenditura di bocca e capegli sì divini, mani, braccia, ginocchia e piedi; et insomma tutto quello che quivi fece è da fare che gli occhi né stancare né saziare vi si possono già mai. Veramente chi risguarda la bellezza de' calzari e della corazza, celeste lo crede e non mortale. Ma che dirò io della Aurora femina ignuda e da fare uscire il maninconico dell'animo e smarrire lo stile alla scultura? Nella quale attitudine si conosce il suo sollecito levarsi sonnacchiosa, svilupparsi dalle piume, perché pare che nel destarsi ella abbia trovato serrato gli occhi a quel gran Duca. Onde si storce con amaritudine, dolendosi nella sua continovata bellezza in segno del gran dolore. E che potrò io dire della Notte, statua non rara, ma unica? Chi è quello che abbia per alcun secolo in tale arte veduto mai statue antiche o moderne così fatte? Conoscendosi non solo la quiete di chi dorme, ma il dolore e la malinconia di chi perde cosa onorata e grande. Credasi pure che questa sia quella Notte la quale oscuri tutti coloro che per alcun tempo nella scultura e nel disegno pensavano, non dico di passarlo, ma di paragonarlo già mai. Nella qual figura, quella sonnolenza si scorge che nelle imagini adormentate si vede; per che da persone dottissime furono in lode sua fatti molti versi latini e rime volgari come questi de' quali non si sa l'autore:
La Notte, che tu vedi in sì dolci atti
dormir, fu da uno Angelo scolpita
in questo sasso; e perché dorme, ha vita.
Destala, se non 'l credi, e parleratti.
A' quali in persona della Notte rispose Michelagnolo così:
Grato mi è il sonno, e più l'esser di sasso,
mentre che il danno e la vergogna dura,
non veder, non sentir, m'è gran ventura:
però non mi destar, deh, parla basso.
E certo se la inimicizia ch'è tra la fortuna e la virtù, e la bontà d'una e la invidia dell'altra avesse lasciato condurre tal cosa a fine, poteva mostrare l'arte alla natura, che ella di gran lunga in ogni pensiero l'avanzava. Lavorando egli con sollecitudine e con amore grandissimo tali opere, crebbe, che pur troppo li impedì il fine, lo assedio di Fiorenza, l'anno 1529; il quale fu cagione che poco o nulla egli più vi lavorasse, avendogli i cittadini dato la cura di fortificare oltra al monte di San Miniato, la terra, come s'è detto. Conciò sia che avendo egli prestato a quella republica mille scudi e trovandosi de' Nove della milizia ufizio deputato sopra la guerra, volse tutto il pensiero e lo animo suo a dar perfezione a quelle fortificazioni, et avendola stretta finalmente l'esercito intorno, et a poco a poco mancata la speranza degli aiuti e cresciute le dificultà del mantenersi, e parendogli di trovarsi a strano partito, per sicurtà della persona sua si deliberò partire di Firenze et andarsene a Vinezia senza farsi conoscere per la strada a nessuno. Partì dunque segretamente per la via del monte di San Miniato che nessuno il seppe, menandone seco Antonio Mini suo creato e 'l Piloto orefice amico suo fedele, e con essi portarono sul dosso uno imbottito per uno di scudi ne' giubboni. Et a Ferrara condotti, riposandosi, avvenne che per gli sospetti della guerra e per la lega dello imperatore e del Papa, che erano intorno a Fiorenza, il duca Alfonso da Este teneva ordini in Ferrara e voleva sapere secretamente dagli osti che alloggiavano, i nomi di tutti coloro che ogni dì alloggiavano, e la listra de' forestieri di che nazione si fossero ogni dì si faceva portare. Avvenne dunque che essendo Michelagnolo quivi con animo di non esser conosciuto, e con li suoi scavalcato, fu ciò per questa via noto al Duca, che se ne rallegrò per esser divenuto amico suo. Era quel principe di grande animo e mentre che visse si dilettò continuamente della virtù. Mandò subito alcuni de' primi della sua corte che per parte di sua eccellenza in palazzo e dove era il Duca lo conducessero, et i cavalli et ogni sua cosa levassero e bonissimo alloggiamento in palazzo gli dessero. Michelagnolo trovandosi in forza altrui, fu constretto ubidire, e quel che vender non poteva, donare, et al Duca con coloro andò senza levare le robe dell'osteria. Per che fattogli il Duca accoglienze grandissime e doltosi della sua salvatichezza, et apresso fattogli di ricchi et onorevoli doni, volse con buona provisione in Ferrara fermarlo. Ma egli non avendo a ciò l'animo intento, non vi volle restare; e pregatolo almeno che mentre la guerra durava non si partisse, il Duca di nuovo gli fece offerte di tutto quello che era in poter suo. Onde Michelagnolo, non volendo esser vinto di cortesia, lo ringraziò molto, e voltandosi verso i suoi due disse che aveva portato in Ferrara dodicimila scudi, e che se gli bisognava erano al piacer suo insieme con esso lui. Il Duca lo menò a spasso come aveva fatto altra volta per il palazzo, e quivi gli mostrò ciò che aveva di bello fino a un suo ritratto di mano di Tiziano, il quale fu da lui molto commendato. Né però lo poté mai fermare in palazzo, perché egli alla osteria volse ritornare, onde l'oste che l'alloggiava ebbe sotto mano dal Duca infinite cose da fargli onore e commissione alla partita sua di non pigliare nulla del suo alloggio. Indi si condusse a Vinegia, dove desiderando di conoscerlo molti gentiluomini, egli che sempre ebbe poca fantasia che di tale esercizio s'intendessero, si partì di Giudecca, dove era alloggiato, dove si dice che allora disegnò per quella città, pregato dal doge Gritti, il ponte del Rialto, disegno rarissimo d'invenzione e d'ornamento.
Fu richiamato Michelagnolo con gran preghi alla patria, e fortemente raccomandatogli che non volessi abandonar l'impresa e mandatogli salvo condotto, finalmente vinto dallo amore non senza pericolo della vita, ritornò, et in quel mentre finì la Leda che faceva, come si disse, dimandatali dal duca Alfonso, la quale fu portata poi in Francia per Anton Mini suo creato. Et intanto rimediò al campanile di S. Miniato, torre che offendeva stranamente il campo nimico con due pezzi di artiglieria, di che voltosi a batterlo con cannoni grossi i bombardieri del campo l'avevon quasi lacero e l'arebbono rovinato; onde Michelagnolo, con balle di lana e gagliardi materassi sospesi con corde, lo armò di maniera, che gli è ancora in piedi. Dicono ancora che nel tempo dell'assedio gli nacque occasione per la voglia che prima aveva d'un sasso di marmo di nove braccia venuto da Carrara, che per gara e concorrenza fra loro, papa Clemente lo aveva dato a Baccio Bandinelli; ma per essere tal cosa nel publico, Michelagnolo la chiese al gonfaloniere, et esso glielo die-de che facesse il medesimo, avendo già Baccio fatto il modello e levato di molta pietra per abozzarlo. Onde fece Michelagnolo un modello, il quale fu tenuto maraviglioso e cosa molto vaga, ma nel ritorno de' Medici fu restituito a Baccio. Fatto lo accordo, Baccio Valori comessario del Papa ebbe comissione di far pigliare e mettere al Bargello certi cittadini de' più parziali; e la corte medesima cercò di Michelagnolo a casa, il quale dubitandone s'era fuggito segretamente in casa d'un suo grande amico, ove stette molti giorni nascosto, tanto che passato la furia, ricordandosi papa Clemente della virtù di Michelagnolo, fé fare diligenza di trovarlo, con ordine che non se gli dicessi niente, anzi, che se gli tornassi le solite provisioni, e che egli attendessi all'Opera di S. Lorenzo mettendovi per proveditore Messer Giovanbatista Figiovanni, antico servidore di casa Medici e priore di S. Lorenzo. Dove assicurato Michelagnolo cominciò, per farsi amico Baccio Valori, una figura di tre braccia di marmo che era uno Apollo che si cavava del turcasso una freccia, e lo condusse presso al fine, il quale è oggi nella camera del principe di Fiorenza, cosa rarissima, ancora che non sia finita del tutto.
In questo tempo essendo mandato a Michelagnolo un gentiluomo del duca Alfonso di Ferrara, che aveva inteso che gli aveva fatto qualcosa rara di suo mano, per non perdere una gioia così fatta, arrivato che fu in Fiorenza e trovatolo, gli presentò lettere di credenza da quel signore. Dove Michelagnolo fattogli accoglienze, gli mostrò la Leda dipinta da lui che abraccia il cigno, e Castore e Polluce che uscivano dell'uovo in certo quadro grande dipinto a tempera col fiato; e pensando il mandato del Duca al nome che sentiva fuori di Michelagnolo che dovessi aver fatto qualche gran cosa, non conoscendo né l'artificio, né l'eccellenza di quella figura, disse a Michelagnolo: “Oh, questa è una poca cosa”. Gli dimandò Michelagnolo che mestiero fussi il suo, sapendo egli che niuno meglio può dar giudizio delle cose che si fanno che coloro che vi sono essercitati pur assai drento. Rispose ghignando: “Io son mercante”, credendo non essere stato conosciuto da Michelagnolo per gentiluomo, e quasi fattosi beffe d'una tal dimanda mostrando ancora insieme sprezzare l'industria de' Fiorentini. Michelagnolo che aveva inteso benissimo el parlar così fatto, rispose alla prima: “Voi farete questa mala mercanzia per il vostro signore. Levatevimi dinanzi”. E così in que' giorni Anton Mini suo creato, che ave-va due sorelle da maritarsi, gliene chiese, et egli gliene donò volentieri, con la maggior parte de' disegni e cartoni fatti da lui, ch'erano cosa divina. Così due casse di modegli con gran numero di cartoni finiti per far pitture e parte d'opere fatte, che venutogli fantasia d'andarsene in Francia gli portò seco, e la Leda la vendé al re Francesco per via di mercan-ti, oggi a Fontanableò, et i cartoni e disegni andaron male, perché egli si morì là in poco tempo e gliene fu rubati, dove si privò questo paese di tante e sì utili fatiche che fu danno inestimabile. A Fiorenza è ritornato poi il cartone della Le-da, che l'ha Bernardo Vecchietti, e così quattro pezzi di cartoni della cappella di ignudi e Profeti condotti da Benvenuto Cellini scultore, oggi appresso agli eredi di Girolamo degli Albizi.
Convenne a Michelagnolo andare a Roma a papa Clemente, il quale benché adirato con lui, come amico della virtù gli perdonò ogni cosa e gli diede ordine che tornasse a Fiorenza e che la libreria e sagrestia di S. Lorenzo si finissero del tutto, e per abreviare tal opera una infinità di statue che ci andavano compartirono in altri maestri. Egli n'allogò due al Tribolo, una a Raffaello da Monte Lupo et una a fra' Giovan Agnolo frate de' Servi, tutti scultori, e gli diede aiuto in esse facendo a ciascuno i modelli in bozze di terra, laonde tutti gagliardamente lavorarono et egli ancora alla libreria faceva attendere, onde si finì il palco di quella d'intagli in legnami con suoi modelli, i quali furono fatti per le mani del Carota e del Tasso fiorentini, eccellenti intagliatori e maestri, et ancora di quadro, e similmente i banchi dei libri lavorati allora da Batista del Cinque e Ciapino amico suo, buoni maestri in quella professione. E per darvi ultima fine fu condotto in Fiorenza Giovanni da Udine divino, il quale per lo stucco della tribuna insieme con altri suo lavoranti et ancora maestri fiorentini, vi lavorò. Laonde con sollecitudine cercarono di dare fine a tanta impresa.
Per che volendo Michelagnolo far porre in opera le statue, in questo tempo al Papa venne in animo di volerlo appresso di sé, avendo desiderio di fare le facciate della cappella di Sisto, dove egli aveva dipinto la volta a Giulio II, suo nipote; nelle quali facciate voleva Clemente che nella principale dove è l'altare vi si dipignessi il Giudizio Universale, acciò potessi mostrare in quella storia tutto quello che l'arte del disegno poteva fare; e nell'altra dirimpetto sopra la porta principale gli aveva ordinato che vi facessi quando per la sua superbia Lucifero fu dal Cielo cacciato e precipitati insieme nel centro dello inferno tutti quegli Angeli che peccarono con lui. Delle quali invenzioni molti anni innanzi s'è trovato che aveva fatto schizzi Michelagnolo e varii disegni, un de' quali poi fu posto in opera nella chiesa della Trinità di Roma da un pittore ciciliano, il quale stette molti mesi con Michelagnolo a servirlo e macinar colori. Questa opera è nella croce della chiesa alla cappella di San Gregorio dipinta a fresco, che ancora che sia mal condotta, si vede un certo che di terribile e di vario nelle attitudini e groppi di quegli ignudi che piovono dal cielo e de' cascati nel centro della terra conversi in diverse forme di diavoli molto spaventate e bizzarre, et è certo capricciosa fantasia. Mentre che Michelagnolo dava ordine a far questi disegni e cartoni della prima facciata del Giudizio, non restava giornalmente essere alle mani con gli agenti del duca d'Urbino, dai quali era incaricato aver ricevuto da Giulio II sedicimila scudi per la sepoltura, e non poteva soportare questo carico; e desiderava finirla un giorno quantunque e' fussi già vecchio, e volentieri se ne sarebbe stato a Roma, poiché senza cercarla gli era venuta questa occasione per non tornare più a Fiorenza, avendo molta paura del duca Alessandro de' Medici, il quale pensava gli fusse poco amico; per che avendogli fatto intendere per il signor Alessandro Vitegli che dovessi vedere dove fussi miglior sito per fare il castello e cittadella di Fiorenza, rispose non vi volere andare se non gli era comandato da papa Clemente.
Finalmente fu fatto lo accordo di questa sepoltura, e che così finissi in questo modo: che non si facessi più la sepoltura isolata in forma quadra, ma solamente una di quelle facce sole in quel modo che piaceva a Michelagnolo, e che fussi obligato a metterci di sua mano sei statue, et in questo contratto che si fece col duca d'Urbino concesse sua eccellenzia che Michelagnolo fussi obligato a papa Clemente quattro mesi dell'anno o a Fiorenza, o dove più gli paresse adoperarlo; et ancora che paressi a Michelagnolo d'esser quietato, non finì per questo; perché desiderando Clemente di vedere l'ultima pruova delle forze della sua virtù, lo faceva attendere al cartone del Giudizio. Ma egli mostrando al Papa di essere occupato in quello, non restava però con ogni poter suo, e segretamente lavorava sopra le statue che anda-vano a detta sepoltura. Successe l'anno 1533 la morte di papa Clemente, dove a Fiorenza si fermò l'opera della sagrestia e libreria, la quale con tanto studio cercando si finisse, pure rimase imperfetta. Pensò veramente allora Michelagnolo essere libero e potere attendere a dar fine alla sepoltura di Giulio II; ma essendo creato Paulo Terzo non passò molto che fattolo chiamare a sé, oltra al fargli carezze et offerte, lo ricercò che dovessi servirlo e che lo voleva appresso di sé. Ricusò questo Michelagnolo, dicendo che non poteva fare, essendo per contratto obligato al duca d'Urbino fin che fussi finita la sepoltura di Giulio. Il Papa ne prese còllora dicendo: “Io ho avuto trenta anni questo desiderio et ora che son papa non me lo caverò? Io straccerò il contratto e son disposto che tu mi serva a ogni modo”. Michelagnolo, veduto questa risoluzione, fu tentato di partirsi da Roma et in qualche maniera trovar via da dar fine a questa sepoltura. Tuttavia temendo, come prudente, della grandezza del Papa, andava pensando trattenerlo di sodisfarlo di parole, vedendolo tanto vecchio, fin che qualcosa nascesse. Il Papa, che voleva far fare qualche opera segnalata a Michelagnolo, andò un giorno a trovarlo a casa con dieci cardinali, dove e' volse veder tutte le statue della sepoltura di Giulio che gli parsono miracolose, e particolarmente il Moisè, che dal cardinale di Mantova fu detto che quella sol figura bastava a onorare papa Giulio, e veduto i cartoni e' disegni che ordinava per la facciata della cappella che gli parvono stupendi, di nuovo il Papa lo ricercò con istanzia che dovessi andare a servirlo, promettendogli che farebbe che 'l duca d'Urbino si contenterà di tre statue e che l'altre si faccin fare con suo modegli a altri eccellenti maestri. Per il che procurato ciò con gli agenti del Duca Sua Santità, fecesi di nuovo contratto confermato dal Duca, e Michelagnolo spontaneamente si obligò pagar le tre statue e farla murare; che per ciò depositò in sul banco degli Strozzi ducati millecinquecento ottanta, e' quali arebbe potuto fuggire, e gli parve aver fatto assai a essersi disobligato di sì lunga e dispiacevole impresa, la quale egli la fece poi murare in San Piero in Vincola in questo modo: messe su il primo imbasamento intagliato con quattro piedistalli che risaltavano in fuori tanto quanto prima vi doveva stare un prigione per ciascuno, che in quel cambio vi restava una figura di un termine; e perché da basso veniva povero aveva per ciascun termine messo a' piedi una mensola che posava a rovescio in su. Que' quattro termini mettevano in mezzo tre nicchie, due delle quali erano tonde dalle bande, e vi dovevano andare le Vittorie, in cambio delle quali in una messe Lia figliuola di Laban, per la Vita attiva con uno specchio in mano per la considerazione si deve avere per le azzioni nostre, e nell'altra una grillanda di fiori per le virtù che ornano la vita nostra in vita, e dopo la morte la fanno gloriosa; l'altra fu Rachel sua sorella per la Vita contemplativa con le mani giunte, con un ginocchio piegato, e col volto par che stia elevata in spirito; le quali statue condusse di sua mano Michelagnolo in meno di uno anno. Nel mezzo è l'altra nicchia, ma quadra, che questa doveva essere nel primo disegno una delle porti che entravano nel tempietto ovato della sepoltura quadrata; questa essendo diventata nicchia, vi è posto in sur un dado di marmo la grandissima e bellissima statua di Moisè, della quale a bastanza si è ragionato. Sopra le teste de' termini che fan capitello, è architrave, fregio e cornice che risalta sopra i termini, intagliato con ricchi fregi e fogliami uovoli e dentegli et altri ricchi membri per tutta l'opera; sopra la quale cornice si muove un altro ordine pulito senza intagli, di altri ma variati termini, corrispondendo a dirittura a que' primi a uso di pilastri con varie modanature di cornice, e per tutto questo ordine accompagna et obedisce a quegli di sotto. Vi viene un vano simile a quello che fa nicchia quadra sopra il Moisè, nel quale è posato su' risalti della cornice una cassa di marmo con la statua di papa Giulio a diacere, fatta da Maso dal Bosco scultore, e dritto nella nicchia che vi è, una Nostra Donna che tiene il Figliuolo in collo, condotta da Scherano da Settignano scultore, col modello di Michelagnolo, che sono assai ragionevole statue; et in due altre nicchie quadre sopra la Vita attiva e la contemplativa sono due statue maggiori, un Profeta et una Sibilla a sedere, che ambidue fur fatte da Raffaello da Monte Lupo, come s'è detto nella vita di Baccio suo padre, che fur condotte con poca satisfazione di Michelagnolo. Ebbe per ultimo finimento questa opera una cornice varia che risaltava, come di sotto, per tutto; e sopra i termini era per fine candelieri di marmo e nel mezzo l'arme di papa Giulio, e sopra il Profeta e la Sibilla nel vano della nicchia vi fece per ciascuna una finestra per comodità di que' frati che ufiziano quella chiesa, avendovi fatto il coro dietro, che servono, dicendo il divino ufizio, a mandare le voci in chiesa et a vedere celebrare. E nel vero che tutta questa opera è tornata benissimo, ma non già a gran pezzo come era ordinato il primo disegno. Risolvessi Michelagnolo, poiché non poteva fare altro, di servire papa Paulo, il quale volle che proseguisse l'ordinatogli da Clemente senza alterare niente l'invenzione o concetto che gli era stato dato, avendo rispetto alla virtù di quell'uomo, al quale portava tanto amore e riverenza, che non cercava se non piacergli, come ne aparve segno, che desiderando Sua Santità che sotto il Iona di cappella ove era prima l'arme di papa Giulio II, mettervi la sua, essendone ricerco, per non fare torto a Giulio et a Clemente non ve la volse porre, dicendo non istare bene, e ne restò Sua Santità satisfatto per non gli dispiacere, e conobbe molto bene la bontà di quell'uomo quanto tirava dietro allo onesto et al giusto senza rispetto et adulazione, cosa che loro son soliti provar di rado.
Fece dunque Michelagnolo fare, che non vi era prima, una scarpa di mattoni ben murati e scelti e ben cotti alla facciata di detta cappella, e volse che pendessi dalla somità di sopra un mezzo braccio, perché né polvere né altra bruttura potessi fermare sopra. Né verrò a particolari della invenzione o componimento di questa storia, perché se n'è ritratte e stampate tante e grandi e piccole, che e' non par necessario perdervi tempo a descriverla. Basta che si vede che l'inten-zione di questo uomo singulare non ha voluto entrare in dipignere altro che la perfetta e proporzionatissima composizione del corpo umano et in diversissime attitudini; non sol questo, ma insieme gli affetti delle passioni e contentezze dell'animo, bastandogli satisfare in quella parte di che è stato superiore a tutti i suoi artefici, e mostra la via della gran maniera e degli ignudi e quanto e' sappi nelle dificultà del disegno, e finalmente ha aperto la via alla facilità di questa arte nel principale suo intento, che è il corpo umano, et attendendo a questo fin solo, ha lassato da parte le vaghezze de' colori, i capricci e le nuove fantasie di certe minuzie e delicatezze, che da molti altri pittori non sono interamente, e forse non senza qualche ragione, state neglette. Onde qualcuno non tanto fondato nel disegno ha cerco con la varietà di tinte et ombre di colori e con bizzarre varie e nuove invenzioni, et insomma con questa altra via farsi luogo fra i primi maestri. Ma Michelagnolo stando saldo sempre nella profondità dell'arte, ha mostro a quegli che sanno assai [come] dovevano arrivare al perfetto.
E per tornare alla storia, aveva già condotto Michelagnolo a fine più di tre quarti dell'opera, quando andando papa Paulo a vederla, perché Messer Biagio da Cesena maestro delle cerimonie e persona scrupolosa, che era in cappella col Papa, dimandato quel che gliene paressi, disse essere cosa disonestissima in un luogo tanto onorato avervi fatto tanti ignudi che sì disonestamente mostrano le lor vergogne, e che non era opera da cappella di papa, ma da stufe e d'osterie. Dispiacendo questo a Michelagnolo e volendosi vendicare, subito che fu partito lo ritrasse di naturale senza averlo altrimenti innanzi, nello inferno nella figura di Minòs con una gran serpe avvolta alle gambe fra un monte di diavoli. Né bastò il raccomandarsi di Messer Biagio al Papa et a Michelagnolo che lo levassi, che pure ve lo lassò per quella memoria, dove ancor si vede.
Avenne in questo tempo che egli cascò di non poco alto dal tavolato di questa opera e fattosi male a una gamba, per lo dolore e per la còllora da nessuno non volle essere medicato. Per il che trovandosi allora vivo maestro Baccio Rontini fiorentino, amico suo e medico capriccioso e di quella virtù molto affezionato, venendogli compassione di lui gli andò un giorno a picchiare a casa, e non gli essendo risposto da' vicini né da lui, per alcune vie segrete cercò tanto di salire, che a Michelagnolo di stanza in stanza pervenne, il quale era disperato. Laonde maestro Baccio fin che egli guarito non fu, non lo volle abandonare già mai, né spicarsegli d'intorno. Egli di questo male guarito e ritornato all'opera, et in quella di continuo lavorando, in pochi mesi a ultima fine la ridusse dando tanta forza alle pitture di tal opera, che ha verificato il detto di Dante “Morti li morti, i vivi parean vivi”. E quivi si conosce la miseria dei dannati e l'allegrezza de' beati. Onde scoperto questo Giudizio, mostrò non solo essere vincitore de' primi artefici che lavorato vi avevano, ma ancora nella volta che egli tanto celebrata avea fatta, volse vincere se stesso, et in quella di gran lunga passatosi, superò se medesimo, avendosi egli imaginato il terrore di que' giorni, dove egli fa rappresentare, per più pena di chi non è ben vissuto, tutta la sua Passione; facendo portare in aria da diverse figure ignude la croce, la colonna, la lancia, la spugna, i chiodi e la corona con diverse e varie attitudini molto dificilmente condotte a fine nella facilità loro. Èvvi Cristo il qua-le sedendo con faccia orribile e fiera ai dannati si volge maladicendogli, non senza gran timore della Nostra Donna che ristrettasi nel manto ode e vede tanta rovina. Sonvi infinitissime figure che gli fanno cerchio di Profeti, di Apostoli e particularmente Adamo e Santo Pietro, i quali si stimano che vi sien messi l'uno per l'origine prima delle genti al giudizio, l'altro per essere stato il primo fondamento della cristiana religione. A' piedi gli è un San Bartolomeo bellissimo, il qual mostra la pelle scorticata. Èvvi similmente uno ignudo di San Lorenzo, oltra che senza numero sono infinitissimi Santi e Sante et altre figure maschi e femine intorno, appresso e discosto, i quali si abracciano e fannosi festa avendo per grazia di Dio e per guidardone delle opere loro la beatitudine eterna. Sono sotto i piedi di Cristo i sette Angeli scritti da San Giovanni Evangelista con le sette trombe, che sonando a sentenza, fanno arricciare i capelli a chi gli guarda per la terribilità che essi mostrano nel viso, e fra gl'altri vi son due Angeli che ciascuno ha il libro delle vite in mano; et appresso non senza bellissima considerazione si veggono i sette peccati mortali da una banda combattere in forma di diavoli e tirar giù allo inferno l'anime che volano al cielo, con attitudini bellissimi e scorti molto mirabili. Né ha restato nella ressurrezione de' morti mostrare al mondo come essi della medesima terra ripiglion l'ossa e la carne, e come da altri vivi aiutati vanno volando al cielo, che da alcune anime già beate è lor porto aiuto, non senza vedersi tutte quelle parti di considerazioni che a una tanta opera come quella si possa stimare che si convenga. Per che per lui si è fatto studii e fatiche d'ogni sorte, apparendo egualmente per tutta l'opera, come chiaramente e particularmente ancora nella barca di Caronte si dimostra, il quale con attitudine disperata l'anime tirate dai diavoli giù nella barca batte col remo, ad imitazione di quello che espresse il suo famigliarissimo Dante quando disse:
Caron demonio, con occhi di bragia,
loro accennando, tutte le raccoglie:
batte col remo qualunque si adagia.
Né si può imaginare quanto di varietà sia nelle teste di que' diavoli, mostri veramente d'inferno. Nei peccatori si conosce il peccato e la tema insieme del danno eterno. Et oltra a ogni bellezza straordinaria è il vedere tanta opera sì unitamente dipinta e condotta, che ella pare fatta in un giorno e con quella fine che mai minio nissuno si condusse talmente; e nel vero la moltitudine delle figure, la terribilità e grandezza dell'opera è tale, che non si può descrivere, essendo piena di tutti i possibili umani affetti et avendogli tutti maravigliosamente espressi: avvenga che i superbi, gli invidiosi, gli avari, i lussuriosi e gli altri così fatti si riconoschino agevolmente da ogni bello spirito, per avere osservato ogni decoro, sì d'aria, sì d'attitudini e sì d'ogni altra naturale circostanzia nel figurarli; cosa che, se bene è maravigliosa e grande, non è stata impossibile a questo uomo, per essere stato sempre accorto e savio et avere visto uomini assai et acquistato quella cognizione con la pratica del mondo, che fanno i filosofi con la speculazione e per gli scritti. Talché chi giudicioso e nella pittura intendente si trova, vede la terribilità dell'arte, et in quelle figure scorge i pensieri e gli affetti, i quali mai per altro che per lui non furono dipinti; così vede ancora quivi come si fa il variare delle tante attitudini negli strani e diversi gesti di giovani, vecchi, maschi, femine: nei quali a chi non si mostra il terrore dell'arte insieme con quella grazia che egli aveva dalla natura? Per che fa scuotere i cuori di tutti quegli che non son saputi, come di quegli che sanno in tal mestiero. Vi sono gli scorti che paiono di rilievo, e con la unione, la morbidezza e la finezza nelle parti delle dolcezze da lui dipinte mostrano veramente come hanno da essere le pitture fatte da' buoni e veri pittori; e vedesi nei contorni delle cose girate da lui, per una via che da altri che da lui non potrebbono essere fatte, il vero giudizio e la vera dannazione e ressurressione. E questo, nell'arte nostra, è quello essempio e quella gran pittura mandata da Dio agli uomini in terra, acciò che veggano come il fato fa quando gli intelletti dal supremo grado in terra descendono et hanno in essi infusa la grazia e la divinità del sapere. Questa opera mena prigioni legati quegli che di sapere l'arte si persuado-no, e nel vedere i segni da lui tirati ne' contorni di che cosa essa si sia, trema e teme ogni terribile spirito sia quanto si voglia carico di disegno. E mentre che si guardano le fatiche dell'opera sua, i sensi si stordiscono solo a pensare che cosa possono essere le altre pitture fatte e che si faranno, poste a tal paragone. Età veramente felice chiamar si puote e felicità della memoria di chi ha visto veramente stupenda maraviglia del secol nostro! Beatissimo e fortunatissimo Paulo Terzo, poiché Dio consentì che sotto la protezione sua si ripari il vanto che daranno alla memoria sua e di te le penne degli scrittori! Quanto acquistano i meriti tuoi per le sue virtù? Certo fato bonissimo hanno a questo secolo nel suo nascere gli artefici, da che hanno veduto squarciato il velo delle dificultà di quello che si può fare et imaginare nelle pitture e sculture et architetture fatte da lui.
Penò a condurre questa opera otto anni e la scoperse l'anno 1541 (credo io) il giorno di Natale con stupore e maraviglia di tutta Roma, anzi di tutto il mondo, et io che quell'anno andai a Roma per vederla, che ero a Vinezia, ne rimasi stupito. Aveva papa Paulo fatto fabricare, come s'è detto in Antonio da San Gallo, al medesimo piano una cappella chiamata la Paulina a imitazione di quella di Niccola V, nella quale deliberò che Michelagnolo vi facessi due storie grandi in dua quadroni: che in una fece la conversione di San Paulo con Gesù Cristo in aria e moltitudine di Angeli ignudi con bellissimi moti, e di sotto l'essere sul piano di terra cascato stordito e spaventato Paulo da cavallo con i suoi soldati attorno, chi attento a sollevarlo, altri storditi dalla voce e splendore di Cristo in varie e belle attitudini e movenzie amirati e spaventati si fuggano, et il cavallo che fugendo par che dalla velocità del corso ne meni via chi cerca ritenerlo, e tutta questa storia è condotta con arte e disegno straordinario. Nell'altra è la crocifissione di San Piero, il quale è confitto ignudo sopra la croce, che è una figura rara; mostrando i crocifissori, mentre hanno fatto in terra una buca, volere alzare in alto la croce, acciò rimanga crocifisso co' piedi all'aria; dove sono molte considerazioni notabili e belle. Ha Michelagnolo atteso solo, come s'è detto altrove, alla perfezzione dell'arte, per che né paesi vi sono, né alberi, né casamenti, né anche certe varietà e vaghezze dell'arte vi si veggono, perché non vi attese mai, come quegli che forse non voleva abassare quel suo grande ingegno in simil cose. Queste furono l'ultime pitture condotte da lui d'età d'anni settantacinque, e secondo che egli mi diceva con molta sua gran fatica: avenga che la pittura passato una certa età, e massimamente il lavorare in fresco, non è arte da vecchi. Ordinò Michelagnolo che con i suoi disegni Perino del Vaga pittore eccellentissimo facessi la volta di stucchi e molte cose di pittura, e così era ancora la volontà di papa Paulo III; che mandandolo poi per la lunga non se ne fece altro, come molte cose restano imperfette, quando per colpa degli artefici inrisoluti, quando de' principi poco accurati a sollecitargli.
Aveva papa Paulo dato principio a fortificare Borgo e condotto molti signori con Antonio da San Gallo a questa dieta, ove volse che intervenissi ancora Michelagnolo, come quelli che sapeva che le fortificazioni fatte intorno al monte di San Miniato a Fiorenza erano state ordinate da lui; e dopo molte dispute fu domandato del suo parere. Egli che era d'oppinione contraria al San Gallo et a molti altri lo disse liberamente; dove il San Gallo gli disse che era sua arte la scultura e pittura, non le fortificazioni. Rispose Michelagnolo che di quelle ne sapeva poco, ma che del fortificare, col pensiero che lungo tempo ci aveva avuto sopra, con la sperienzia di quel che aveva fatto, gli pareva sapere più che non aveva saputo né egli né tutti que' di casa sua, mostrandogli in presenzia di tutti che ci aveva fatto molti errori. E moltiplicando di qua e di là le parole, il Papa ebbe a por silenzio, e non andò molto che e' portò disegnata tutta la fortificazione di Borgo, che aperse gli occhi a tutto quello che s'è ordinato e fatto poi; e fu cagione che il portone di Santo Spirito, che era vicino al fine ordinato dal San Gallo, rimase imperfetto.
Non poteva lo spirito e la virtù di Michelagnolo restare senza far qualcosa, e poiché non poteva dipignere, si messe attorno a un pezzo di marmo per cavarvi drento quattro figure tonde maggiori che 'l vivo, facendo in quello Cristo morto per dilettazione e passar tempo, e come egli diceva, perché l'esercitarsi col mazzuolo lo teneva sano del corpo. Era questo Cristo come deposto di croce, sostenuto dalla Nostra Donna entrandoli sotto et aiutando con atto di forza Niccodemo fermato in piede e da una delle Marie che lo aiuta, vedendo mancato la forza nella madre, che vinta dal dolore non può reggere; né si può vedere corpo morto simile a quel di Cristo, che cascando con le membra abbandonate fa attiture tutte diferenti non solo degli altri suoi, ma di quanti se ne fecion mai: opera faticosa, rara in un sasso e veramente divina; e questa, come si dirà di sotto, restò imperfetta et ebbe molte disgrazie; ancora ch'egli avessi avuto animo che la dovessi servire per la sepoltura di lui a' piè di quello altare dove e' pensava di porla.
Avvenne che l'anno 1546 morì Antonio da San Gallo, onde mancato chi guidassi la fabbrica di San Piero, furono varii pareri tra i deputati di quella col Papa a chi dovessino darla. Finalmente credo che Sua Santità spirato da Dio si risolvé di mandare per Michelagnolo; e ricercatolo di metterlo in luogo suo, lo ricusò dicendo, per fuggire questo peso, che l'architettura non era arte sua propria. Finalmente non giovando i preghi, il Papa gli comandò che l'accettassi; dove con sommo suo dispiacere e contra sua voglia bisognò che egli entrassi a quella impresa. Et un giorno fra gli altri andando egli in San Piero a vedere il modello di legname che aveva fatto il San Gallo e la fabbrica per esaminarla, vi trovò tutta la setta sangallesca, che fattosi innanzi, il meglio che seppono dissono a Michelagnolo che si rallegravano che il carico di quella fabbrica avessi a essere suo, e che quel modello era un prato che non vi mancherebbe mai da pascere. “Vuoi dite il vero”, rispose loro Michelagnolo, volendo inferire, come e' dichiarò così a un amico, per le pecore e buoi che non intendono l'arte; et usò dir poi publicamente che il San Gallo l'aveva condotta cieca di lumi, e che aveva di fuori troppi ordini di colonne l'un sopra l'altro, e che con tanti risalti, aguglie e tritumi di membri teneva molto più dell'o-pera todesca, che del buon modo antico o della vaga e bella maniera moderna; et oltre a questo, che e' si poteva risparmiare cinquanta anni di tempo a finirla e più di trecento mila scudi di spesa, e condurla con più maestà e grandezza e facilità, e maggior disegno di ordine, bellezza e comodità. E lo mostrò poi in un modello che e' fece per ridurlo a quella forma che si vede oggi condotta l'opera, e fé conoscere quel che e' diceva essere verissimo. Questo modello gli costò venticinque scudi e fu fatto in quindici dì; quello del San Gallo passò, come s'è detto, quattro mila e durò molti anni. E da questo et altro modo di fare si conobbe che quella fabbrica era una bottega et un trafico da guadagnare, il quale si andava prolongando con intenzione di non finirlo ma' da chi se l'avesse presa per incetta. Questi modi non piacevono a questo uomo da bene, e per levarsegli d'attorno, mentre che 'l Papa lo forzava a pigliare l'ufizio dello architettore di quella opera, disse loro un giorno apertamente che eglino si aiutassino con gli amici e facessino ogni opera che e' non entrassi in quel governo, perché se gli avesse avuto tal cura, non voleva in quella fabbrica nessuno di loro; le quali parole dette in publico l'ebbero per male, come si può credere, e furono cagione che gli posono tanto odio, il quale crescendo ogni dì nel vedere mutare tutto quell'ordine drento e fuori, che non lo lassorono mai vivere, ricercando ogni dì varie e nuove invenzioni per travagliarlo, come si dirà a suo luogo.
Finalmente papa Paulo gli fece un motu proprio, come lo creava capo di quella fabbrica con ogni autorità e che e' potessi fare e disfare quel che v'era, crescere e scemare e variare a suo piacimento ogni cosa, e volse che il governo de' ministri tutti dependessino dalla volontà sua. Dove Michelagnolo, visto tanta sicurtà e fede del Papa verso di lui, volse per mostrare la sua bontà che fussi dichiarato nel motu proprio come egli serviva la fabrica per l'amore de Dio e senza alcun premio, se bene il Papa gli aveva prima dato il passo di Parma del fiume, che gli rendeva da secento scudi, che lo perdé nella morte del duca Pier Luigi Farnese e per scambio gli fu dato una cancelleria di Rimini di manco valore, di che non mostrò curarsi, et ancora che il Papa gli mandassi più volte danari per tal provisione, non gli volse accettar mai, come ne fanno fede Messer Alessandro Ruffini, cameriere allora di quel Papa, e Messer Pier Giovanni Aliotti, vescovo di Furlì. Finalmente fu dal Papa aprovato il modello che aveva fatto Michelagnolo che ritirava San Piero a minor forma, ma sì bene a maggior grandezza, che satisfazione di tutti quelli che hanno giudizio, ancora che certi che fanno professione d'intendenti (ma infatti non sono) non lo aprovano. Trovò che quattro pilastri principali fatti da Bramante e lassati da Antonio da S. Gallo, che avevono a reggere il peso della tribuna, erano deboli, e' quali egli parte riempié facendo due chiocciole o lumache da lato, nelle quali sono scale piane, per le quali i somari vi salgano a portare fino in cima tutte le materie, e parimente gli uomini vi possono ire a cavallo infino in sulla cima del piano degli archi. Condusse la prima cornice sopra gli archi di trevertini, che gira in tondo, che è cosa mirabile, graziosa e molto varia da l'altre, né si può far meglio in quel genere. Diede principio alle due nicchie grandi della crociera; e dove prima per ordine di Bramante, Baldassarre e Raffaello, come s'è detto, verso Camposanto vi facevano otto tabernacoli, e così fu seguitato poi dal S. Gallo, Michelagnolo gli ridusse a tre, e di drento tre cappelle, e sopra con la volta di trevertini et ordine di finestre vive di lumi, che hanno forma varia e terribile grandezza, le quali, poi che sono in essere e van fuori in stampa, non solamente tutti quegli di Michelagnolo, ma quegli del San Gallo ancora, non mi metterò a descrivere per non essere necessario altrimenti; basta che egli con ogni accuratezza si messe a far lavorare per tutti que' luoghi dove la fabrica si aveva a mutare d'ordine, a cagione ch'ella si fermassi stabilissima, di maniera che ella non potessi essere mutata mai più da altri: provedimento di savio e prudente ingegno, perché non basta il far bene se non si assicura ancora, poi che la prosunzione e l'ardire di chi gli pare sapere, se gli è creduto più alle parole che a' fatti, e talvolta il favore di chi non intende, può far nascere di molti inconvenienti.
Aveva il populo romano col favore di quel Papa desiderio di dare qualche bella, utile e commoda forma al Campidoglio, et accomodarlo di ordini, di salite, di scale a sdruccioli e con iscaglioni, e con ornamenti di statue antiche che vi erano per abellire quel luogo; e fu ricerco perciò di consiglio Michelagnolo, il quale fece loro un bellissimo disegno e molto ricco, nel quale da quella parte dove sta il Senatore, che è verso levante, ordinò di trevertini una facciata et una salita di scale che da due bande salgono per trovare un piano, per il quale s'entra nel mezzo della sala di quel palazzo, con ricche rivolte piene di balaustri varii che servano per appoggiatoi e per parapetti. Dove per arricchirla dinanzi vi fece mettere i due fiumi a ghiacere, antichi, di marmo sopra a alcuni basamenti, uno de' quali è il Tevere, l'altro è il Nilo, di braccia nove l'uno, cosa rara, e nel mezzo ha da ire in una gran nicchia un Giove. Seguitò dalla banda di mezzogiorno, dove è il palazzo de' Conservatori, per riquadrarlo, una ricca e varia facciata con una loggia da' piè piena di colonne e nicchie, dove vanno molte statue antiche, et attorno sono varii ornamenti e di porte e finestre, che già n'è posto una parte. E dirimpetto a questa ne ha a seguitare un'altra simile di verso tramontana sotto Araceli; e dinanzi una salita di bastoni di verso ponente, qual sarà piana con un ricinto e parapetto di balaustri, dove sarà l'entrata principale con un ordine e basamenti, sopra i quali va tutta la nobiltà delle statue di che oggi è così ricco il Campidoglio. Nel mezzo della piazza in una basa in forma ovale è posto il cavallo di bronzo tanto nominato, su 'l quale è la statua di Marco Aurelio, la quale il medesimo papa Paulo fece levare dalla piazza di Laterano ove l'aveva posta Sisto Quarto. Il quale edifizio riesce tanto bello oggi, che egli è degno d'essere conumerato fra le cose degne che ha fatto Michelagnolo, et è oggi guidato per condurlo a fine da Messer Tomao de' Cavalieri gentiluomo romano, che è stato et è de' maggiori amici che avessi mai Michelagnolo, come si dirà più basso.
Aveva papa Paulo Terzo fatto tirare innanzi al San Gallo, mentre viveva, il palazzo di casa Farnese, et avendovisi a porre in cima il cornicione per il fine del tetto della parte di fuori, volse che Michelagnolo con suo disegno et ordine lo facessi, il quale non potendo mancare a quel Papa, che lo stimava et accarezzava tanto, fece fare un modello di braccia sei di legname della grandezza che aveva a essere, e quello in su uno de' canti del palazzo fé porre, che mostrassi in effetto quel che aveva a essere l'opera, che piaciuto a Sua Santità et a tutta Roma, è stato poi condotto quella parte che se ne vede a fine, riuscendo il più bello e 'l più vario di quanti se ne sieno mai visti, o antichi, o moderni; e da questo, poiché 'l San Gallo morì, volse il Papa che avessi Michelagnolo cura parimente di quella fabrica, dove egli fece il finestrone di marmo con colonne bellissime di mischio che è sopra la porta principale del palazzo con un'arme grande bellissima e varia di marmo di papa Paulo Terzo fondatore di quel palazzo. Seguitò di dentro, dal primo ordine in su del cortile di quello, gli altri due ordini con le più belle varie e graziose finestre, et ornamenti, et ultimo cornicione che si sien visti mai; là dove per le fatiche et ingegno di quell'uomo, è oggi diventato il più bel cortile di Europa.
Egli allargò e fé maggior la sala grande, e diede ordine al ricetto dinanzi, e con vario e nuovo modo di sesto in forma di mezzo ovato fece condurre le volte di detto ricetto, e perché s'era trovato in quell'anno alle terme Antoniane un marmo di braccia sette per ogni verso, nel quale era stato dagli antichi intagliato Ercole che sopra un monte teneva il toro per le corna con un'altra figura in aiuto suo, et intorno a quel monte varie figure di pastori, ninfe et altri animali, opera certo di straordinaria bellezza per vedere sì perfette figure in un sasso sodo e senza pezzi, che fu giudicato servire per una fontana, Michelagnolo consigliò che si dovessi condurre nel secondo cortile e quivi restaurarlo per fargli nel medesimo modo gettare acque, che tutto piacque. La quale opera è stata fino a oggi da que' signori Farnesi fatta restaurare con diligenzia per tale effetto. Et allora Michelagnolo ordinò che si dovessi a quella dirittura fare un ponte che attraversassi il fiume del Tevere, acciò si potessi andare da quel palazzo in Trastevere a un altro lor giardino e palazzo, perché per la dirittura della porta principale che volta in Campo di Fiore si vedessi a una ochiata il cortile, la fonte, strada Iulia et il ponte e la bellezza dell'altro giardino, fino all'altra porta che riusciva nella strada di Trastevere, cosa rara e degna di quel pontefice e della virtù, giudizio e disegno di Michelagnolo.
E perché l'anno 1547 morì Bastiano Viniziano frate del Piombo, e disegnando papa Paulo che quelle statue antiche per il suo palazzo si restaurassino, Michelagnolo favorì volentieri Guglielmo dalla Porta scultore milanese, il quale giovane di speranza dal sudetto fra' Bastiano era stato raccomandato a Michelagnolo, che piaciutoli il far suo, lo messe innanzi a papa Paulo per acconciare dette statue, e la cosa andò sì innanzi che gli fece dare Michelagnolo l'ufizio del Piombo; che dato poi ordine al restaurarle, come se ne vede ancora oggi in quel palazzo, dove fra' Guglielmo [scordatosi] de' benefizii ricevuti, fu poi uno de' contrari a Michelagnolo. Successe l'anno 1549 la morte di papa Paulo Terzo, dove dopo la creazione di papa Giulio Terzo, il cardinale Farnese ordinò fare una gran sepoltura a papa Paulo suo per le mani di fra' Guglielmo, il quale avendo ordinato di metterla in San Piero sotto il primo arco della nuova chiesa sotto la tribuna, che impediva il piano di quella chiesa e non era in verità il luogo suo, e perché Michelagnolo consigliò giudiziosamente che là non poteva né doveva stare, il frate gli prese odio credendo che lo facessi per invidia, ma ben s'è poi accorto che gli diceva il vero e che il mancamento è stato da lui che ha avuto la comodità e non l'ha finita, come si dirà altrove, et io ne fo fede, avvenga che l'anno 1550 io fussi per ordine di papa Giulio Terzo andato a Roma a servirlo, e volentieri per godermi Michelagnolo, fui per tal consiglio adoperato; dove Michelagnolo desiderava che tal sepoltura si mettessi in una delle nicchie dove è oggi la colonna degli spiritati, che era il luogo suo, et io mi ero adoperato che Giulio Terzo si risolveva, per conrispondenza di quella opera, far la sua nell'altra nicchia col medesimo ordine che quella di papa Paulo; dove il frate che la prese in contrario fu cagione che la sua non s'è mai poi finita e che quella di quello altro Pontefice non si facessi, che tutto fu pronosticato da Michelagnolo.
Voltossi papa Giulio a far fare quell'anno nella chiesa di San Piero a Montorio una cappella di marmo con dua sepolture per Antonio cardinale da' Monti suo zio e Messer Fabbiano, avo del Papa, primo principio della grandezza di quella casa illustre. Della quale avendo il Vasari fatto disegni e modelli, papa Giulio, che stimò sempre la virtù di Michelagnolo et amava il Vasari, volse che Michelagnolo ne facessi il prezzo fra loro, et il Vasari suplicò il Papa a far che Michelagnolo ne pigliassi la protezione, e perché il Vasari aveva proposto per gl'intagli di quella opera Simon Mosca e per le statue Raffael Monte Lupo, consigliò Michelagnolo che non vi si facessi intagli di fogliami né manco ne' membri dell'opera di quadro, dicendo che dove vanno figure di marmo non ci vuole essere altra cosa. Per il che il Vasari dubitò che non lo facessi perché l'opera rimanessi povera; et in effetto poi quando e' la vedde finita confessò che gli avessi avuto giudizio, e grande. Non volse Michelagnolo che il Monte Lupo facessi le statue, avendo visto quanto s'era portato male nelle sue della sepoltura di Giulio Secondo, e si contentò più presto ch'elle fussino date a Bartolomeo Ammannati, quale il Vasari aveva messo innanzi, ancor che il Buonarroto avessi un poco di sdegno particolare seco e con Nanni di Baccio Bigio, nato, se ben si considera, da legger cagione, che essendo giovanetti, mossi dall'afezione dell'arte più che per offenderlo, avevano industriosamente, entrando in casa, levati a Anton Mini creato di Michelagnolo molte carte disegnate, che di poi per via del magistrato de' signori Otto gli furon rendute tutte, né gli volse, per intercessione di Mes-ser Giovanni Norchiati canonico di San Lorenzo amico suo, fargli dare altro gastigo. Dove il Vasari, ragionandogli Michelagnolo di questa cosa, gli disse ridendo che gli pareva che non meritassino biasimo alcuno e che s'egli avessi potuto, arebbe non solamente toltogli parecchi disegni, ma l'arebbe spogliato di tutto quel che gli avessi potuto avere di suo mano solo per imparare l'arte, che s'ha da volere bene a quegli che cercan la virtù, e premiargli ancora, perché non si hanno questi a trattare come quegli che vanno rubando i danari, le robe e l'altre cose importanti. Or così si recò la cosa in burla. Fu ciò cagione che a quella opera di Montorio si diede principio, e che il medesimo anno il Vasari e lo Ammannato andorono a far condurre i marmi da Carrara a Roma per far detto lavoro. Era in quel tempo ogni giorno il Vasari con Michelagnolo; dove una mattina il Papa dispensò per amorevolezza ambidue che facendo le sette chiese a ca-vallo, ch'era l'anno santo, ricevessino il perdono a doppio; dove nel farle ebbono fra l'una e l'altra chiesa molti utili e begli ragionamenti dell'arte et industriosi, che 'l Vasari ne distese un dialogo, che a migliore occasione si manderà fuori con altre cose attenente all'arte.
Autenticò papa Giulio Terzo quell'anno il motu proprio di papa Paulo Terzo sopra la fabbrica di San Piero, et ancora che gli fussi detto molto male dai fautori della setta sangallesca per conto della fabbrica di San Piero, per allora non ne volse udire niente quel Papa avendogli (come era vero) mostro il Vasari ch'egli aveva dato la vita a quella fabrica, et operò con Sua Santità che quella non facessi cosa nessuna attenente al disegno senza il giudizio suo, che l'osservò sempre: perché né alla vigna Iulia fece cosa alcuna senza il suo consiglio, né in Belvedere, dove si rifece la scala che v'è ora in cambio della mezza tonda che veniva innanzi, saliva otto scaglioni et altri otto in giro entrava in dentro, fatta già da Bramante, che era posta nella maggior nicchia in mezzo Belvedere. Michelagnolo vi disegnò e fé fare quella quadra coi balaustri di preperigno che vi è ora, molto bella.
Aveva il Vasari quell'anno finito di stampare l'opera delle vite de' pittori, scultori et architettori in Fiorenza, e di niuno de' vivi aveva fatto la vita, ancor che ci fussi de' vecchi, se non di Michelagnolo; e così gli presentò l'opera, che la ricevé con molta allegrezza, dove molti ricordi di cose aveva avuto dalla voce sua il Vasari come da artefice più vecchio e di giudizio; e non andò guari che avendola letta gli mandò Michelagnolo il presente sonetto fatto da lui, il quale mi piace in memoria delle sue amorevolezze porre in questo luogo:
Se con lo stile o coi colori avete
alla natura pareggiato l'arte,
anzi a quella scemato il pregio in parte,
che 'l bel di lei più bello a noi rendete,
poi che con dotta man posto vi sete
a più degno lavoro, a vergar carte,
quel che vi manca a lei di pregio in parte
nel dar vita ad altrui tutta togliete.
Che se secolo alcuno omai contese
in far bell'opre, almen cedale, poi
che convien ch'al prescritto fine arrive.
Or le memorie altrui, già spente, accese
tornando, fate or che fien quelle e voi,
mal grado d'esse, eternalmente vive.
Partì il Vasari per Fiorenza, e lassò la cura a Michelagnolo del fare fondare a Montorio. Era Messer Bindo Altoviti, allora Consolo della nazione fiorentina, molto amico del Vasari, che in su questa occasione gli disse che sarebbe bene di far condurre questa opera nella chiesa di San Giovanni de' fiorentini, e che ne aveva già parlato con Michelagnolo, il quale favorirebbe la cosa e sarebbe questo cagione di dar fine a quella chiesa. Piacque questo a Messer Bindo, et essendo molto famigliare del Papa gliene ragionò caldamente, mostrando che sarebbe stato bene che le sepolture e la cappella che Sua Santità faceva fare per Montorio l'avesse fatte nella chiesa di San Giovanni de' fiorentini, et aggiugnendo che ciò sarebbe cagione che con questa occasione e sprone la nazione farebbe spesa tale, che la chiesa arebbe la sua fine; e se Sua Santità facesse la cappella maggiore, gli altri mercanti farebbono sei cappelle, e poi di mano in mano il restante. Là dove il Papa si voltò d'animo, et ancora che ne fussi fatto modello e prezzo, andò a Montorio e mandò per Michelagnolo, al quale ogni giorno il Vasari scriveva et aveva secondo l'occasione delle faccende risposta da lui. Scrisse adunque al Vasari Michelagnolo, al primo dì d'agosto 1550, la mutazione che aveva fatto il Papa, e son queste le parole istesse di sua mano:
Messer Giorgio mio caro. Circa al rifondare a San Piero a Montorio come il Papa non volse intendere non ve ne scrissi niente, sapendo voi essere avisato dall'uomo vostro di qua. Ora mi accade dirvi quello che segue, e questo è che ier mattina, sendo il Papa andato a detto Montorio, mandò per me, riscontràlo in sul ponte che tornava: ebbi lungo ragionamento seco circa le sepolture allogatevi, et all'ultimo mi disse che era risoluto non volere mettere dette sepolture in su quel monte, ma nella chiesa de' fiorentini; richiesemi di parere e di disegno, et io ne lo confortai assai, stimando che per questo mezzo detta chiesa s'abbia a finire. Circa le vostre tre ricevute non ho penna da rispondere a tante altezze, ma se avessi caro di essere in qualche parte quello che mi fate, non l'arei caro per altro se non perché voi avessi un servidore che valessi qualcosa. Ma io non mi maraviglio, sendo voi risucitatore di uomini morti, che voi allunghiate vita ai vivi, o vero che i mal vivi furiate per infinito tempo alla morte. E per abreviare, io son tutto, come son, vostro. Michelagnolo Buonaruoti in Roma.
Mentre che queste cose si travagliavano e che la nazione cercava di far danari, nacquero certe difficultà, per che non conclusero niente, e così la cosa si raffreddò. Intanto avendo già fatto il Vasari e l'Ammannato cavare a Carrara tutti i marmi, se ne mandò a Roma gran parte, e così l'Ammannato con essi, scrivendo per lui il Vasari al Buonaruoto che facessi intendere al Papa dove voleva questa sepoltura, e che avendo l'ordine facessi fondare, sùbito che Michelagnolo ebbe la lettera, parlò al nostro signore e scrisse al Vasari questa resoluzione di man sua:
Messer Giorgio mio caro. Sùbito che Bartolomeo fu giunto qua, andai a parlare al Papa, e, visto che voleva fare rifondare a Montorio per le sepolture, provveddi d'un muratore di San Piero. El Tantecose lo seppe e volsevi mandare uno a suo modo; io per non combattere con chi dà le mosse a' venti, mi son tirato adreto, perché essendo uomo leggeri, non vorrei essere trasportato in qualche macchia. Basta che nella chiesa de' fiorentini non mi pare s'abbia più a pensare. Tornate presto e state sano. Altro non mi accade. Addì 13 di ottobre 1550.
Chiamava Michelagnolo il Tantecose monsignor di Furlì, perché voleva fare ogni cosa. Essendo maestro di camera del Papa, provedeva per le medaglie, gioie, camei e figurine di bronzo, pitture, disegni, e voleva che ogni cosa dipendessi da lui. Volentieri fuggiva Michelagnolo questo uomo perché aveva fatto sempre ufizii contrarii al bisogno di Michelagnolo, e perciò dubitava non essere da l'ambizione di questo uomo trasportato in qualche macchia. Basta che la nazione fiorentina perse per quella chiesa una bellissima occasione, che Dio sa quando la racquisterà già mai, et a me ne dolse infinitamente. Non ho voluto mancare di fare questa breve memoria perché si vegga che questo uomo cercò di giovare sempre alla nazione sua et agli amici suoi et all'arte.
Né fu tornato a pena il Vasari a Roma, che innanzi che fussi il principio dell'anno 1551, la setta sangallesca aveva ordinato contro Michelagnolo un trattato, che il Papa dovessi fare congregazione in San Pietro, e ragunare i fabriceri e tutti quegli che avevono la cura per mostrare con false calumnie a Sua Santità che Michelagnolo aveva guasto quella fabrica: perché avendo egli già murato la nicchia del re, dove sono le tre cappelle, e condottole con le tre finestre sopra, né sapendo quel che si voleva fare nella volta, con giudizio debole avevano dato ad intendere al cardinale Salviati vecchio et a Marcello Cervino, che fu poi papa, che San Piero rimaneva con poco lume. Là dove ragunati tutti, il Papa disse a Michelagnolo che i deputati dicevano che quella nicchia arebbe reso poco lume. Gli rispose: “Io vorrei sentire parlare questi deputati”. Il cardinale Marcello rispose: “Siàn noi”. Michelagnolo gli disse: “Monsignore, sopra queste finestre, nella volta che s'ha a fare di trevertini ne va tre altre”. “Voi non ce l'avete mai detto” disse il cardinale, e Michelagnolo soggiunse: “Io non sono, né manco voglio essere obligato a dirlo, né alla signoria vostra né a nessuno, quel che io debbo o voglio fare; l'ufizio vostro è di far venire danari et avere loro cura dai ladri, et a' disegni della fabbrica ne avete a lasciare il carico a me”. E voltossi al Papa e disse: “Padre Santo, vedete quel che io guadagno, che se queste fatiche che io duro non mi giovano all'anima, io perdo tempo e l'opera”. Il Papa, che lo amava, gli messe le mani in sulle spalle e disse: “Voi guadagnate per l'anima e per il corpo, non dubitate”, e per aversegli saputo levare dinanzi, gli crebbe il Papa amore infinitamente e comandò a lui et al Vasari che 'l giorno seguente amendue fussino alla vigna Iulia; nel qual luogo ebbe molti ragionamenti seco, che condussero quell'opera quasi alla bellezza che ella è, né faceva né deliberava cosa nessuna di disegno senza il parere e giudizio suo. Et in fra l'altre volse, perché egli ci andava spesso col Vasari, stando Sua Santità intorno alla fonte dell'Acqua Vergine con dodici cardinali, arrivato Michelagnolo volse (dico) il Papa per forza che Michelagnolo gli sedessi allato, quantunque egli umilissimamente il recusassi, onorando lui sempre, quanto è possibile, la virtù sua.
Fecegli fare un modello d'una facciata per un palazzo che Sua Santità desiderava fare allato a San Rocco, volendosi servire del mausoleo di Augusto per il resto della muraglia; che non si può vedere per disegno di facciata, né il più vario, né il più ornato, né il più nuovo di maniera e di ordine, avenga, come s'è visto in tutte le cose sue, che e' non s'è mai voluto obligare a legge, o antica, o moderna di cose d'architettura, come quegli che ha auto l'ingegno atto a trovare sempre cose nuove e varie e non punto men belle. Questo modello è oggi appresso il duca Cosimo de' Medici, che gli fu donato da papa Pio Quarto, quando gli andò a Roma, che lo tiene fra le sue cose più care. Portò tanto rispetto questo Papa a Michelagnolo, che del continuo prese la sua protezione contro a cardinali et altri che cercavano calunniarlo, e volse che sempre per valenti e reputati che fussino gli artefici andassino a trovarlo a casa, e gli ebbe tanto rispetto e reverenza, che non si ardiva Sua Santità per non gli dare fastidio a richiederlo di molte cose, che Michelagnolo ancor che fussi vecchio poteva fare. Aveva Michelagnolo fino nel tempo di Paulo Terzo per suo ordine dato principio a far rifondare il ponte Santa Maria di Roma, il quale per il corso dell'acqua continuo e per l'antichità sua era indebolito e rovinava. Fu ordinato da Michelagnolo per via di casse il rifondare e fare diligenti ripari alle pile, e di già ne aveva condotto a fine una gran parte e fatto spese grosse in legnami e trevertini a benefizio di quella opera, e venendosi nel tempo di Giulio Terzo in congregazione coi cherici di camera in pratica di dargli fine, fu proposto fra loro da Nanni di Baccio Bigio architetto, che con poco tempo e somma di danari si sarebbe finito, allogando in cottimo a lui; e con certo modo allegavano sotto spezie di bene per isgravar Michelagnolo, perché era vecchio e che non se ne curava, e stando così la cosa non se ne verrebbe mai a fine. Il Papa, che voleva poche brighe, non pensando a quel che poteva nascere, diede autorità a' cherici di camera che come cosa loro n'avessino cura, i quali lo dettono poi, senza che Michelagnolo ne sapessi altro, con tutte quelle materie con patto libero a Nanni; il quale non attese a quelle fortificazioni, come era necessario a rifondarlo, ma lo scaricò di peso per vendere gran numero di trevertini di che era rifiancato e solicato anticamente il ponte, che venivano a gravarlo e facevanlo più forte e sicuro e più gagliardo, mettendovi in quel cambio materia di ghiaie et altri getti, che non si vedeva alcun difetto di drento, e di fuori vi fece sponde et altre cose, che a vederlo pareva rinovato tutto, ma indebolito totalmente e tutto assottigliato. Seguì da poi cinque anni dopo, che venendo la piena del diluvio l'anno 1557, egli rovinò di maniera, che fece conoscere il poco giudizio de' cherici di camera, e 'l danno che ricevé Roma per partirsi dal consiglio di Michelagnolo, il quale predisse questa sua rovina molte volte a' suoi amici et a me, che mi ricordo passandovi insieme a cavallo che mi diceva: “Giorgio, questo ponte ci triema sotto; sollecitiamo il cavalcare, che non rovini in mentre ci siàn su”.
Ma tornando al ragionamento di sopra, finito che fu l'opera di Montorio e con molta mia satisfazione, io tornai a Fiorenza per servizio del duca Cosimo, che fu l'anno 1554. Dolse a Michelagnolo la partita del Vasari e parimente a Giorgio, avenga che ogni giorno que' suoi aversarii ora per una via or per un'altra lo travagliavano: per il che non mancarono giornalmente l'uno a l'altro scriversi, e l'anno medesimo d'aprile dandogli nuova il Vasari che Lionardo nipote di Michelagnolo aveva avuto un figliuolo mastio, e con onorato corteo di donne nobilissime l'avevano accompagnato al battesimo, rinovando il nome del Buonaruoto, Michelagnolo rispose in una lettera al Vasari queste parole:
Giorgio amico caro. Io ho preso grandissimo piacere della vostra, visto che pur vi ricordate del povero vecchio, e più per esservi trovato al trionfo, che mi scrivete d'aver visto rinascere un altro Buonaruoto, del quale aviso vi ringrazio quanto so e posso; ma ben mi dispiace tal pompa, perché l'uomo non dee ridere quando il mondo tutto piange. Però mi pare che Lionardo non abbia a fare tanta festa d'uno che nasce, con quella allegrezza che s'ha a serbare alla morte di chi è ben vissuto. Né vi maravigliate se non rispondo subito: lo fo per non parere mercante. Ora io vi dico che per le molte lode, che per detta mi date, se io ne meritassi sol una, mi parrebbe, quando io mi vi detti in anima et in corpo, avervi dato qualcosa, et aver sadisfatto a qualche minima parte di quel che io vi son debitore; dove vi ricognosco ogni ora creditore di molte più che io non ho da pagare. E perché son vecchio oramai non spero in questa, ma nell'altra vita potere pareggiare il conto: però vi prego di pazienzia, e son vostro, e le cose di qua stan pur così.
Aveva già nel tempo di Paulo Terzo mandato il duca Cosimo il Tribolo a Roma per vedere se egli avesse potuto persuadere Michelagnolo a ritornare a Fiorenza, per dar fine alla sagrestia di San Lorenzo. Ma scusandosi Michelagnolo che invecchiato non poteva più il peso delle fatiche, e con molte ragioni lo escluse, che non poteva partirsi di Roma. Onde il Tribolo dimandò finalmente della scala della libreria di San Lorenzo, della quale Michelagnolo aveva fatto fare molte pietre, e non ce n'era modello né certezza appunto della forma; e quantunque ci fussero segni in terra in un mattonato et altri schizzi di terra, la propria et ultima risoluzione non se ne trovava. Dove per preghi che facessi il Tribolo e ci mescolassi il nome del Duca, non rispose mai altro, se non che non se ne ricordava. Fu dato dal duca Cosimo ordine al Vasari che scrivesse a Michelagnolo che gli mandassi a dire che fine avesse a avere questa scala; ché forse per l'ami-cizia et amore che gli portava, doverebbe dire qualcosa, che sarebbe cagione che venendo tal risoluzione ella si finirebbe. Scrisse il Vasari a Michelagnolo l'animo del Duca, e che tutto quel che si aveva a condurre toccherebbe a lui esserne lo essecutore, il che farebbe con quella fede che sapeva che e' soleva aver cura delle cose sue. Per il che mandò Michelagnolo l'ordine di far detta scala in una lettera di sua mano addì 28 di settembre 1555:
Messer Giorgio amico caro. Circa la scala della libreria, di che m'è stato tanto parlato, crediate che se io mi potessi ricordare come io l'avevo ordinata, che io non mi farei pregare. Mi torna bene nella mente come un sogno una certa scala, ma non credo che sia appunto quella che io pensai allora, perché mi torna cosa goffa; pure la scriverò qui, cioè che i' togliessi una quantità di scatole aovate di fondo d'un palmo l'una, ma non d'una lunghezza e larghezza, e la maggiore e prima ponessi in sul pavimento, lontana dal muro dalla porta tanto quanto volete che la scala sia dolce o cruda; et un'altra ne mettessi sopra questa che fussi tanto minore per ogni verso, che in sulla prima di sotto avanzassi tanto piano, quanto vuole il piè per salire, diminuendole e ritirandole verso la porta fra l'una e l'altra, sempre per salire, e che la diminuzione dell'ultimo grado sia quant'è 'l vano della porta, e detta parte di scala aovata abbi come dua ale, una di qua et una di là, che vi seguitino i medesimi gradi e non aovati. Di queste serva il mezzo per il signore dal mezzo in su di detta scala, e rivolte di dette alie ritornino al muro; dal mezzo in giù insino in sul pavimento si discostino con tutta la scala dal muro circa tre palmi, in modo che l'imbasamento del ricetto non sia occupato in luogo nessuno, e resti libera ogni faccia. Io scrivo cosa da ridere, ma so ben che voi troverete cosa al proposito.
Scrisse ancora Michelagnolo in que' dì al Vasari che essendo morto Giulio Terzo, e creato Marcello, la setta gli era contro, per la nuova creazione di quel Pontefice cominciò di nuovo a travagliarlo; per il che sentendo ciò il Duca, e dispiacendogli questi modi, fece scrivere a Giorgio e dirli che doveva partirsi di Roma e venirsene a stare in Fiorenza, dove quel Duca non desiderava altro, se non talvolta consigliarsi per le sue fabriche secondo i suoi disegni e che arebbe da quel signore tutto quello che e' desiderava, senza far niente di sua mano. E di nuovo gli fu per Messer Lionardo Marinozzi cameriere segreto del duca Cosimo portate lettere scritte da sua eccellenza e così dal Vasari. Dove essendo morto Marcello e creato Paulo Quarto, dal quale di nuovo gli era stato, in quel principio che egli andò a baciare il piede, fatte offerte assai, in desiderio della fine della fabbrica di San Pietro, e l'obligo, che gli pareva avervi, lo tenne fermo, e pigliando certe scuse scrisse al Duca che non poteva per allora servirlo, et una lettera al Vasari con queste parole proprie:
Messer Giorgio amico caro. Io chiamo Iddio in testimonio, come io fu' contra mia voglia con grandissima forza messo da papa Paulo Terzo nella fabbrica di San Pietro di Roma dieci anni sono; e se si fussi seguitato fino a oggi di lavorare in detta fabbrica come si faceva allora, io sarei ora a quello di detta fabbrica, ch'io desidererei tornarmi costà; ma per mancamento di danari la s'è molto allentata, et allentasi quando l'è giunta in più faticose e dificil parti, in modo che abandonandola ora non sarebbe altro che con grandissima vergogna e peccato perdere il premio delle fatiche che io ho durate in detti dieci anni per l'amor de Dio. Io vi ho fatto questo discorso per risposta della vostra, e perché ho una lettera del Duca, m'ha fatto molto maravigliare che sua signoria si sia degnata a scrivere con tanta dolcezza. Ne ringrazio Iddio e sua eccellenza quanto so e posso. Io esco di proposito, perché ho perduto la memoria e 'l cervello, e lo scrivere m'è di grande affanno, perché non è mia arte. La conclusione è questa: di farvi intendere quel che segue dello abandonare la sopra detta fabbrica, e partirsi di qua: la prima cosa contenterei parecchi ladri, e sarei cagione della sua rovina, e forse ancora del serrarsi per sempre.
Seguitando di scrivere Michelagnolo a Giorgio, gli disse per escusazione sua col Duca, che avendo casa e molte cose a comodo suo in Roma, che valevano migliaia di scudi, oltra a l'esser indisposto della vita per renella, fianco e pietra, come hanno tutti e' vecchi e come ne poteva far fede maestro Eraldo suo medico, del quale si lodava dopo Dio avere la vita da lui, per che per queste cagioni non poteva partirsi, e che finalmente non gli bastava l'animo se non di morire. Raccomandavasi al Vasari come per più altre lettere, che ha di suo, che lo raccomandassi al Duca che gli perdonassi oltra a quello che (come ho detto) gli scrisse al Duca in escusazione sua. E se Michelagnolo fussi stato da poter cavalcare sarebbe subito venuto a Fiorenza, onde credo che non si sarebbe saputo poi partire per ritornarsene a Roma, tanto lo mosse la tenerezza e l'amore che portava al Duca; et intanto attendeva a lavorare in detta fabbrica in molti luoghi, per fermarla ch'ella non potesse essere più mossa.
In questo mentre alcuni gli avevon referto che papa Paulo Quarto era d'animo di fargli acconciare la facciata della cappella dove è il Giudizio Universale, perché diceva che quelle figure mostravano le parte vergognose troppo disonestamente: là dove fu fatto intendere l'animo del Papa a Michelagnolo il quale rispose: “Dite al Papa che questa è piccola faccenda, e che facilmente si può acconciare; che acconci egli il mondo, che le pitture si acconciano presto”. Fu tolto a Michelagnolo l'ufizio della cancelleria di Rimini; non volse mai parlare al Papa, che non sapeva la cosa, il quale dal suo coppiere gli fu levato col volergli fare dare per conto della fabbrica di San Piero scudi cento il mese, che fattogli portare una mesata a casa, Michelagnolo non gli accettò. L'anno medesimo gli nacque la morte di Urbino suo servidore, anzi come si può chiamare e come aveva fatto, suo compagno: questo venne a stare con Michelagnolo a Fiorenza l'anno 1530, finito l'assedio, quando Antonio Mini suo discepolo andò in Francia, et usò grandissima servitù a Michelagnolo, tanto che in ventisei anni quella servitù e dimestichezza fece che Michelagnolo lo fé ricco e l'amò tanto, che così vecchio in questa sua malattia lo servì e dormiva la notte vestito a guardarlo. Per il che dopo che fu morto, il Vasari per confortarlo gli scrisse et egli rispose con queste parole:
Messer Giorgio mio caro, io posso male scrivere, pur per risposta della vostra lettera dirò qualche cosa. Voi sapete come Urbino è morto: di che m'è stato grandissima grazia di Dio, ma con grave mio danno et infinito dolore. La grazia è stata che dove in vita mi teneva vivo, morendo m'ha insegnato morire non con dispiacere, ma con desiderio della morte. Io l'ho tenuto ventisei anni e hollo trovato rarissimo e fedele, et ora che lo avevo fatto ricco e che io l'aspettavo bastone e riposo della mia vecchiezza, m'è sparito, né m'è rimasto altra speranza che di rivederlo in Paradiso. E di questo n'ha mostro segno Iddio per la felicissima morte che ha fatto, che più assai che 'l morire gli è incresciuto lasciarmi in questo mondo traditore con tanti affanni; benché la maggior parte di me n'è ita seco, né mi rimane altro che una infinita miseria; e mi vi raccomando.
Fu adoperato al tempo di Paulo Quarto nelle fortificazioni di Roma in più luoghi, e da Salustio Peruzzi, a chi quel Papa, come s'è detto altrove, aveva dato a fare il portone di Castello Santo Agnolo, oggi la metà rovinato; si adoperò ancora a dispensare le statue di quella opera e vedere i modelli degli scultori e correggerli. Et in quel tempo venne vicino a Roma lo esercito franzese, dove pensò Michelagnolo con quella città avere a capitare male; dove Antonio Franzese da Castel Durante, che gli aveva lassato Urbino in casa per servirlo nella sua morte, si risolvé fuggirsi di Roma, e segretamente andò Michelagnolo nelle montagne di Spuleto; dove egli visitando certi luoghi di romitori, nel qual tempo scrivendoli il Vasari e mandandogli una operetta, che Carlo Lenzoni cittadino fiorentino alla morte sua aveva lasciata a Messer Cosimo Bartoli, che dovessi farla stampare e dirizzare a Michelagnolo, finita che ella fu in que' dì la mandò il Vasari a Michelagnolo, che ricevuta, rispose così:
Messer Giorgio amico caro. Io ho ricevuto il libretto di Messer Cosimo che voi mi mandate, et in questa sarà una di ringraziamento; pregovi che gliene diate, et a quella mi raccomando.
Io ho avuto a questi dì con gran disagio e spesa e gran piacere nelle montagne di Spuleti a visitare que' romiti, in modo che io son ritornato men che mezzo a Roma, perché veramente e' non si trova pace se non ne' boschi. Altro non ho che dirvi, mi piace che stiate sano e lieto, e mi vi raccomando. De' 18 di settembre 1556.
Lavorava Michelagnolo quasi ogni giorno per suo passatempo intorno a quella pietra che s'è già ragionato, con le quattro figure, la quale egli spezzò in questo tempo per queste cagioni: perché quel sasso aveva molti smerigli et era duro e faceva spesso fuoco nello scarpello; o fusse pure che il giudizio di quello uomo fussi tanto grande che non si contentava mai di cosa che e' facessi: e che e' sia il vero, delle sue statue se ne vede poche finite nella sua virilità, ché le finite affatto sono state condotte da lui nella sua gioventù, come il Bacco, la Pietà della Febre, il Gigante di Fiorenza, il Cristo della Minerva, che queste non è possibile né crescere né diminuire un grano di panìco senza nuocere loro; l'altre del duca Giuliano e Lorenzo, Notte et Aurora, e 'l Moisè con altre dua in fuori, che non arrivano tutte a undici statue, l'altre dico sono state imperfette, e son molte maggiormente, come quello che usava dire, che se s'avessi avuto a contentare di quel che faceva, n'arebbe mandate poche, anzi, nessuna fuora; vedendosi ch'egli era ito tanto con l'arte e col giudizio innanzi, che com'egli aveva scoperto una figura e conosciutovi un minimo che d'errore, la lasciava stare e correva a manimettere un altro marmo, pensando non avere a venire a quel medesimo; et egli spesso diceva essere questa la cagione che egli diceva d'aver fatto sì poche statue e pitture. Questa Pietà, come fu rotta, la donò a Francesco Bandini. In questo tempo Tiberio Calcagni scultore fiorentino era divenuto molto amico di Michelagnolo, per mezzo di Francesco Bandini e di Messer Donato Giannotti, et essendo un giorno in casa di Michelagnolo dove era rotta questa Pietà, dopo lungo ragionamento li dimandò per che cagione l'avessi rotta e guasto tante maravigliose fatiche: rispose esserne cagione la importunità di Urbino suo servidore, che ogni dì lo sollecitava a finirla, e che fra l'altre cose gli venne levato un pezzo d'un gomito della Madonna, e che prima ancora se l'era recata in odio e ci aveva avuto molte disgrazie attorno di un pelo che v'era; dove scappatogli la pazienzia la roppe, e la voleva rompere affatto, se Antonio suo servidore non se gli fusse raccomandato che così com'era gliene donassi. Dove Tiberio inteso ciò, parlò al Bandino, che desiderava di avere qualcosa di mano sua, et il Bandino operò che Tiberio promettessi a Antonio scudi duecento d'oro, e pregò Michelagnolo che se volessi che con suo aiuto di modelli Tiberio la finissi per il Bandino, saria cagione che quelle fatiche non sarebbono gettate invano, e ne fu contento Michelagnolo; là dove ne fece loro un presente. Questa fu portata via subito e rimessa insieme poi da Tiberio, e rifatto non so che pezzi, ma rimase imperfetta per la morte del Bandino, di Michelagnolo e di Tiberio. Truovasi al presente nelle mani di Pierantonio Bandini, figliuolo di Francesco, alla sua vigna di Monte Cavallo. E tornando a Michelagnolo, fu necessario trovar qualcosa poi di marmo perché e' potessi ogni giorno passar tempo scarpellando, e fu messo un altro pezzo di marmo, dove era stato già abbozzato un'altra Pietà, varia da quella, molto minore.
Era entrato a servire Paulo Quarto Pirro Ligorio architetto, e sopra alla fabbrica di San Piero, e di nuovo travagliava Michelagnolo, et andavano dicendo che egli era rimbambito. Onde sdegnato da queste cose volentieri se ne sarebbe tornato a Fiorenza, e soprastato a tornarsene, fu di nuovo da Giorgio sollecitato con lettere; ma egli conosceva d'esser tanto invecchiato e condotto già alla età di ottantun anno, scrivendo al Vasari in quel tempo per suo ordinario, e mandandogli varii sonetti spirituali, gli diceva che era al fine della vita, che guardassi dove egli teneva i suoi pensieri, leggendo vedrebbe che era alle ventiquattro ore, e non nasceva pensiero in lui che non vi fussi scolpita la morte, dicendo in una sua:
Dio il voglia Vasari che io la tenga a disagio qualche anno, e so che mi direte bene che io sia vecchio e pazzo a voler fare sonetti; ma perché molti dicono che io sono rimbambito, ho voluto fare l'uffizio mio. Per la vostra veggo l'amore che mi portate, e sappiate per cosa certa che io arei caro di riporre queste mie debili ossa a canto a quelle di mio padre, come mi pregate: ma partendo di qua sarei causa d'una gran rovina della fabbrica di San Piero, d'una gran vergogna e d'un grandissimo peccato. Ma come sia stabilita che non possa essere mutata, spero far quanto mi scrivete, se già non è peccato a tenere a disagio parecchi ghiotti che aspettano mi parta presto.
Era con questa lettera scritto pur di suo mano il presente sonetto:
Giunto è già 'l corso della vita mia
con tempestoso mar per fragil barca
al comun porto, ov'a render si varca
conto e ragion d'ogni opra trista e pia.
Onde l'affettuosa fantasia,
che l'arte mi fece idolo e monarca,
cognosco or ben, quant'era d'error carca,
e quel ch'a mal suo grado ognun desia.
Gli amorosi pensier già vani e lieti
che fien or, s'a due morti mi avicino?
D'una son certo, e l'altra mi minaccia.
Né pinger né scolpir fia più che queti
l'anima volta a quello amor divino,
ch'aperse a prender noi in croce le braccia.
Per il che si vedeva che andava ritirando verso Dio e lasciando le cure dell'arte per le persecuzioni de' suoi maligni artefici e per colpa di alcuni soprastanti della fabbrica, che arebbono voluto, come e' diceva, menar le mani. Fu risposto per ordine del duca Cosimo a Michelagnolo dal Vasari con poche parole in una lettera confortandolo al rimpatriarsi, e col sonetto medesimo corrispondente alle rime. Sarebbe volentieri partitosi di Roma Michelagnolo, ma era tanto stracco et invecchiato, che aveva, come si dirà più basso, stabilito tornarsene; ma la volontà era pronta, inferma la carne, che lo riteneva in Roma. Et avvenne di giugno l'anno 1557, avendo egli fatto modello della volta che copriva la nicchia che si faceva di trevertino alla cappella del re, che nacque per non vi potere ire, come soleva, uno errore: che il capo maestro in sul corpo di tutta la volta prese la misura con una centina sola, dove avevano a essere infinite. Michelagnolo, come amico e confidente del Vasari, gli mandò di sua mano disegni con queste parole scritte a piè di dua:
La centina segnata di rosso la prese il capo maestro sul corpo di tutta la volta; di poi, come si cominciò a passar al mezzo tondo, che è nel colmo di detta volta, s'accorse dell'errore che faceva detta centina, come si vede qui nel disegno le segnate di nero. Con questo errore è ita la volta tanto innanzi, che s'ha a disfare un gran numero di pietre, perché in detta volta non ci va nulla di muro, ma tutto trivertino, et il diametro de' tondi, che senza la cornice gli ricigne di ventidue palmi. Questo errore, avendo il modello fatto appunto, come fo d'ogni cosa, è stato fatto per non vi potere andare spesso per la vecchiezza; e dove io credetti che ora fussi finita detta volta, non sarà finita in tutto questo verno; e se si potessi morire di vergogna e dolore, io non sarei vivo. Pregovi che raguagliate il Duca ché io non sono ora a Fiorenza.
E seguitando nell'altro disegno dove egli aveva disegnato la pianta diceva così:
Messer Giorgio, perché sia meglio inteso la dificultà della volta, per osservare il nascimento suo fino di terra, è stato forza dividerla in tre volte in luogo delle finestre da basso divise dai pilastri, come vedete, che e' vanno piramidati in mezzo, dentro del colmo della volta come fa il fondo e' lati delle volte ancora, e bisognò governarle con un numero infinito di centine, e tanto fanno mutazione e per tanti versi di punto in punto, che non ci si può tener regola ferma; e' tondi e' quadri che vengono nel mezzo de' lor fondi hanno a diminuire e crescere per tanti versi et andare a tanti punti, che è dificil cosa a trovare il modo vero. Nondimeno, avendo il modello, come fo di tutte le cose, non si doveva mai pigliare sì grande errore di volere con una centina sola governare tutt'a tre que' gusci, onde n'è nato ch'è bisognato con vergogna e danno disfare, e disfassene ancora un gran numero di pietre. La volta et i conci et i vani è tutta di trivertino, come l'altre cose dabasso, cosa non usata a Roma.
Fu assoluto dal duca Cosimo Michelagnolo, vedendo questi inconvenienti, del suo venire più a Fiorenza, dicendogli che aveva più caro il suo contento, e che seguitasse San Piero, che cosa che potessi avere al mondo, e che si quietassi. Onde Michelagnolo scrisse al Vasari nella medesima carta che ringraziava il Duca quanto sapeva e poteva di tanta carità, dicendo: “Dio mi dia grazia ch'io possa servirlo di questa povera persona”, ché la memoria e 'l cervello erano iti aspettarlo altrove. La data di questa lettera fu d'agosto l'anno 1557; avendo per questo Michelagnolo conosciuto che 'l Duca stimava e la vita e l'onor suo più che egli stesso che l'adorava. Tutte queste cose e molt'altre che non fa di bisogno, aviamo appresso di noi scritte di sua mano. Era ridotto Michelagnolo in un termine, che vedendo che in San Piero si trattava poco, et avendo già tirato innanzi gran parte del fregio delle finestre di dentro e delle colonne doppie di fuora che girano sopra il cornicione tondo, dove s'ha poi a posare la cupola, come si dirà, che confortato da' maggiori amici suoi come dal cardinale di Carpi, da Messer Donato Gianozzi e da Francesco Bandini e da Tomao de' Cavalieri e dal Lottino, lo stringevano che, poi che vedeva il ritardare del volgere la cupola, ne dovessi fare almeno un modello; stette molti mesi di così senza risolversi, alla fine vi diede principio, e ne condusse a poco a poco un piccolo modello di terra per potervi poi con l'esempio di quello e con le piante e profili che aveva disegnati, farne fare un maggiore di legno: il quale, datoli principio, in poco più d'uno anno lo fece condurre a maestro Giovanni franzese con molto suo studio e fatica, e lo fé di grandezza tale, che le misure e proporzioni piccole tornassino parimente col palmo antico romano, nel-l'opera grande all'intera perfezzione, avendo condotto con diligenzia in quello tutti i membri di colonne, base, capitegli, porte, finestre e cornici e risalti, e così ogni minuzia, conoscendo in tale opera non si dover fare meno; poiché fra i cristiani, anzi in tutto il mondo, non si trovi né vegga una fabbrica di maggiore ornamento e grandezza di quella. E mi par necessario, se delle cose minori aviamo perso tempo a notarle, sia molto più utile e debito nostro descrivere questo modo di disegno per dover condurre questa fabbrica e tribuna con la forma et ordine e modo che ha pensato di darli Michelagnolo; però con quella brevità che potrò ne faremo una semplice narrazione, acciò che, se mai accadessi che non consenta Dio, come s'è visto fino a ora essere stata questa opera travagliata in vita di Michelagnolo, così fusse dopo la morte sua dall'invidia e malignità de' presuntuosi, possino questi miei scritti qualunque e' si sieno, giovare ai fedeli che saranno esecutori della mente di questo raro uomo, et ancora raffrenare la volontà de' maligni che volessino alterarle; e così in un medesimo tempo si giovi e diletti et apra la mente a' begli ingegni che sono amici e si dilettano di questa professione.
E per dar principio, dico che questo modello fatto con ordine di Michelagnolo trovo che sarà nel grande tutto il vano della tribuna di dentro palmi 186, parlando della sua larghezza da muro a muro, sopra il cornicione grande che gira di dentro in tondo di trivertino che si posa sopra i quattro pilastri grandi doppi che si muovono di terra, con i suo capitegli intagliati d'ordine corinto accompagnato dal suo architrave, fregio e cornicione pur di trivertino, il quale cornicione girando intorno intorno alle nicchie grande si posa e lieva sopra i quattro grandi archi delle tre nicchie e della entrata che fanno croce a quella fabrica: dove comincia poi a nascere il principio della tribuna, il nascimento della quale comincia un basamento di trivertino con un piano largo palmi sei, dove si camina, e questo basamento gira in tondo a uso di pozzo, et è la sua grossezza palmi 33 et undici oncie, alto fino alla sua cornice palmi 11 once dieci, e la cornice di sopra è palmi 8 incirca, e l'agetto è palmi sei e mezzo. Entrasi per questo basamento tondo per salire nella tribuna per quattro entrate che sono sopra gli archi delle nicchie, et ha diviso la grossezza di questo basamento in tre parti, quello dalla parte di drento è palmi 15, quello di fuori è palmi 11, e quel di mezzo palmi 7 once 11, che fa la grossezza di palmi 33 once 11. Il vano di mezzo è voto e serve per andito, il quale è alto di sfogo duo quadri e gira in tondo unito con una volta a mezza botte et ogni dirittura delle quattro entrate [ha] otto porte, che con quattro scaglion che saglie ciascuna, una ne va al piano della cornice del primo imbasamento larga palmi 6 e mezzo, e l'altra saglie alla cornice di dentro che gira intorno alla tribuna larga 8 palmi e tre quarti, nelle quali per ciascuna si camina agiatamente di dentro e di fuori a quello edifizio; è da una delle entrate a l'altra in giro palmi 201 che essendo 4 spazii viene a girare tutta palmi 806. Séguita per potere salire dal piano di questo imbasamento dove posano le colonne et i pilastri e che fa poi fregio delle finestre di drento intorno intorno, il quale è alto palmi 14 once una, intorno al quale dalla banda di fuori è da' piè un brieve ordine di cornice, e così da capo, che non son da ogetto se non 10 once, et è tutto di trivertino. Nella grossezza della terza parte sopra quella di drento che aviàn detto esser grossa palmi 15 è fatto una scala in ogni quarta parte, la metà della quale saglie per un verso, e l'altra metà per l'altro, larga palmi 4 et un quarto; questa si conduce al piano delle colonne. Comincia sopra questo piano a nascere in sulla dirittura del vivo da l'imbasamento 18 grandissimi pilastroni tutti di trivertino, ornati ciascuno di dua colonne di fuori e pilastri di drento, come si dirà disotto, e fra l'uno e l'altro ci resta tutta la larghezza di dove hanno da essere tutte le finestre che danno lume alle tribune. Questi son volti per fianchi al punto del mezzo della tribuna lunghi palmi 36, e nella faccia dinanzi 19 e mezzo. Ha ciascuno di questi dalla banda di fuori dua colonne, che il dappiè del dado loro è palmi 8 e tre quarti, et alti palmi 1 e mezzo. La basa è larga palmi 5 once 8, alta palmi [...] once 11, il fuso della colonna è 43 palmi e mezzo, il dapiè palmi 5 once 6, e da capo palmi 4 once 9, il capitello corinto alto palmi 6 e mezzo, e nella cimasa palmi 9. Di queste colonne se ne vede 3 quarti, ché l'altro quarto si unisce in su canti accompagnata da la metà d'un pilastro, che fa canto vivo di drento, e lo accompagna nel mezzo di drento una entrata d'una porta in arco larga palmi 5, alta 13 once 5, che fino al capitello de' pilastri e colonne viene poi ripiena di sodo, facendo unione con altri dua pilastri, che sono simili a quegli che fan canto vivo allato alle colonne. Questi ribattono e fanno ornamento a canto a 16 finestre che vanno intorno intorno a detta tribuna, che la luce di ciascuna è larga palmi 12 e mezzo, alte palmi 22 in circa. Queste di fuori vengono ornate di architravi varii, larghi palmi 2 e tre quarti, e di drento sono ornate similmente con ordine vario con suoi frontespizii e quarti tondi, e vengono larghi di fuori e stretti di drento per ricevere più lume, e così sono di drento da piè più basse, perché dian lume sopra il fregio e la cornice ch'è messa in mezzo ciascuna da dua pilastri piani che rispondono di altezza alle colonne di fuori, tal che vengano a essere 36 colonne di fuori e 36 pilastri di drento, sopra a' quali pilastri di drento è l'architrave, ch'è di altezza palmi 4 e 5 quarti, et il fregio 4 e mezzo, e la cornice 4 e dua terzi, e di proietture 5 palmi, sopra la quale va un ordine di balaustri per potervi caminare attorno attorno sicuramente; e per potere salire agiatamente dal piano dove cominciano le colonne sopra la medesima dirittura nella grossezza del vano di 15 palmi, saglie nel medesimo modo e della medesima grandezza con duo branche o salite, una altra scala fino al fine di quanto son alte le colonne, capitello et architrave, fregio e cornicione, tanto che senza impedire la luce delle finestre passa questa scala di sopra in una lumaca della medesima larghezza fino che truova il piano dove ha a cominciare a volgersi la tribuna. Il quale ordine, distribuzione et ornamento è tanto vario, comodo e forte, durabile e ricco, e fa di maniera spalle alle due volte della cupola che vi si avolta sopra, ch'è cosa tanto ingegnosa e ben considerata, e di poi tanto ben condotta di muraglia, che non si può vedere agli occhi di chi sa e di chi intende cosa più vaga, più bella e più artifiziosa, e per le legature e commettiture delle pietre, e per avere in sé ogni parte e fortezza et eternità, e con tanto giudizio aver cavatone l'acque che piovono per molti condotti segreti, e finalmente ridottola a quella perfezzione, che tutte l'altre cose delle fabriche che si son viste e murate fino a oggi reston niente appetto alla grandezza di questa; et è stato grandissimo danno che a chi toccava non mettessi tutto il poter suo perché, innanzi che la morte ci levassi dinanzi sì raro uomo, si dovessi veder voltato sì bella e terribil machina.
Fin qui ha condotto di muraglia Michelagnolo questa opera, e solamente restaci a dar principio al voltare della tribuna, della quale poi che n'è rimasto il modello, seguiteremo di contar l'ordine che gli ha lasciato perché la si conduca. Ha girato il sesto di questa volta con tre punti che fanno triangolo in questo modo:
A. B.
C.
Il punto C, che è più basso et è il principal col quale egli ha girato il primo mezzo tondo della tribuna, col quale e' dà la forma e l'altezza e larghezza di questa volta, la quale egli dà ordine ch'ella si muri tutta di mattoni bene arrotati e cotti, a spina pesce: questa la fa grossa palmi 4 e mezzo tanto grossa da piè quanto da capo, e lascia a canto un vano per il mezzo di palmi 4 e mezzo da piè, il quale ha a servire per la salita delle scale, che hanno a ire alla lanterna movendosi dal piano della cornice dove sono 'balaustri. Et il sesto della parte di drento dell'altra volta che ha a essere lunga da piè, istretta da capo è girato in sul punto segnato B, il qual è da piè per fare la grossezza della volta palmi 4 e mezzo; e l'ul-timo sesto che si ha a girare per fare la parte di fuori che allarghi da piè e stringa da capo, s'ha da mettere in sul punto segnato A, il quale girato ricresce da capo tutto il vano di mezzo del voto di drento, dove vanno le scale per altezza palmi 8 per irvi ritto; e la grossezza della volta viene a diminuire a poco a poco di maniera, che essendo, come s'è detto, da piè palmi 4 e mezzo, torna da capo palmi 3 e mezzo, e torna rilegata di maniera la volta di fuori con la volta di drento con leghe e scale, che l'una regge l'altra, che di 8 parte che ella è partita nella pianta, che quattro sopra gli archi vengono vote per dare manco peso loro, e l'altre quattro vengono rilegate et incatenate con leghe sopra i pilastri, perché possa eternamente aver vita. Le scale di mezzo fra l'una volta e l'altra son condotte in questa forma: queste, dal piano dove la comincia a voltarsi, si muovano in una delle quattro parti, e ciascuna saglie per dua entrate intersegandosi le scale in forma di X, tanto che si conducano alla metà del sesto segnato C sopra la volta, che avendo salito tutto il diritto della metà del sesto, l'altro che resta si saglie poi agevolmente di giro in giro uno scaglione e poi l'altro a dirittura, tanto che si arriva al fine dell'occhio dove comincia il nascimento della lanterna, intorno alla quale fa, secondo la diminuzione dello spartimento che nasce sopra i pilastri, come si dirà di sotto, un ordine minore di pilastri doppi e finestre, simile a quelle che son fatte di drento. Sopra il primo cornicione grande di drento alla tribuna ripiglia da piè per fare lo spartimento degli sfondati, che vanno drento alla volta della tribuna, e' quali sono partiti in sedici costole che risaltano, e son larghe da piè tanto quanto è la larghezza di dua pilastri, che dalla banda disotto tramezzano le finestre sotto alla volta della tribuna, le quali vanno piramidalmente diminuendo fino a l'occhio della lanterna, e da piè posano in su un piedistallo della medesima larghezza, alto palmi 12, e questo piedistallo posa in sul piano della cornice, che s'aggira e cammina intorno intorno alla tribuna, sopra la quale negli sfondati del mezzo fra le costole sono nel vano otto ovati grandi alti l'uno palmi 29, e sopra uno spartimento di quadri, che allargano da piè e stringano da capo, alti 24 palmi, e stringendosi le costole viene di sopra a quadri un tondo di 14 palmi alto: che vengano a essere otto ovati, otto quadri et otto tondi, che fanno ciascuno di loro uno sfondato più basso, il piano de' quali mostra una ricchezza grandissima, perché disegnava Michelagnolo le costole e gli ornamenti di detti ovati, quadri e tondi fargli tutti scorniciati di trivertino. Restaci a far menzione delle superficie et ornamento del sesto della volta dalla banda dove va il tetto, che comincia a volgersi sopra un basamento alto palmi 25 e mezzo, il quale ha da piè un basamento che ha di getto palmi dua, e così la cimasa da capo, la coperta o tetto, della quale e' disegnava coprirla del medesimo piombo che è coperto oggi il tetto del vecchio San Piero, che fa 16 vani da sodo a sodo che cominciono dove finiscono le due colonne che gli mettono in mezzo, ne' quali faceva per ciascuno nel mezzo dua finestre per dar luce al vano di mezzo, dove è la salita delle scale fra le dua volte che sono 32 in tutto. Queste, per via di mensole che reggano un quarto tondo, faceva, sportando fuor, tetto di maniera che difendeva dall'acque piovane l'alta e nuova vista, et a ogni dirittura e mezzo de' sodi delle due colonne sopra dove finiva il cornicione, si partiva la sua costola per ciascuno allargando da piè e stringendo da capo: in tutto 16 costole larghe palmi cinque, nel mezzo delle quali era un canale quadro largo un palmo e mezzo, dov'era drentovi fa[tta] una scala di scaglioni alti un palmo incirca, per le quali si saliva per quelle e scendeva dal piano dove per infino in cima dove comincia la lanterna. Questi vengano fatti di trivertino e murati a cassetta per[ché] le commettiture si difendino dall'acque e dai diacci per l'amore delle pioggie. Fa il disegno della lanterna nella medesima diminuzione che fa tutta l'opera, che battendo le fila alla circunferenza viene ogni cosa a diminuire del pari et a rilevar su con la medesima misura un tempio stietto di colonne tonde a dua a dua, come sta di sotto quelle ne' sodi ribattendo i suoi pilastri per potere caminare a torno a torno e vedere per i mezzi fra i pilastri dove sono le finestre, il didrento della tribuna e della chiesa; et architrave, fregio e cornice di sopra girava in tondo, risaltando sopra la dua colonne alla dirittura delle quali si muovono sopra quelle alcuni viticci che tramezzati da certi nicchioni insieme vanno a trovare il fine della pergamena, che comincia a voltarsi e stringersi un terzo della altezza, a uso di piramide tondo, fino alla palla, [che] dove va questo finimento ultimo va la croce. Molti particulari e minuzie potrei aver conto, come di sfogatoi per i tremuoti, acquidotti, lumi diversi et altre comodità, che le lasso poi che l'opera non è al suo fine, bastando aver tocco le parti principali il meglio che ho possuto. Ma perché tutto è in essere e si vede, basta aver così brevemente fattone uno schizzo che è gran lume a chi non vi ha nessuna cognizione.
Fu la fine di questo modello fatto con grandissima satisfazione non solo di tutti gli amici suoi, ma di tutta Roma, et il fermamento e stabilimento di quella fabbrica. Seguì che morì Paulo Quarto e fu creato dopo lui Pio Quarto, il quale facendo seguitare di murare il palazzetto del bosco di Belvedere a Pirro Ligorio restato architetto del palazzo, fece offerte e carezze assai a Michelagnolo. Il motu proprio avuto prima da Paulo Terzo, e da Iulio Terzo e Paulo Quarto sopra la fabbrica di San Piero, gli confermò e gli rendé una parte delle entrate e provisioni tolte da Paulo Quarto, adoperandolo in molte cose delle sue fabriche, et a quella di S. Piero nel tempo suo fece lavorare gagliardamente. Particolarmente se ne servì nel fare un disegno per la sepoltura del marchese Marignano suo fratello, la quale fu allogata da Sua Santità per porsi nel Duomo di Milano al cavalier Lione Lioni aretino, scultore eccellentissimo, molto amico di Michelagnolo, che a suo luogo si dirà della forma di questa sepoltura. Et in quel tempo il cavaliere Lione ritrasse in una medaglia Michelagnolo molto vivacemente, et a compiacenza di lui gli fece nel rovescio un cieco guidato da un cane con queste lettere attorno: “Docebo iniquos vias tuas et impii ad te convertentur”. E perché gli piacque assai gli donò Michelagnolo un modello d'uno Ercole che scoppia Anteo, di sua mano, di cera con certi suoi disegni. Di Michelagnolo non ci è altri ritratti che duoi di pittura, uno di mano del Bugiardino e l'altro di Iacopo del Conte, et uno di bronzo di tutto rilievo fatto da Daniello Ricciarelli e questo del cavalier Lione, da e' quali se n'è fatte tante copie, che n'ho visto in molti luoghi di Italia e fuori assai numero.
Andò il medesimo anno Giovanni cardinale de' Medici, figliuolo del duca Cosimo, a Roma, per il cappello a Pio Quarto, e convenne, come suo servitore e familiare, al Vasari andar seco, che volentieri vi andò e vi stette circa un me-se per godersi Michelagnolo, che l'ebbe carissimo e di continuo gli fu a torno. Aveva portato seco il Vasari, per ordine di sua eccellenza, il modello di legno di tutto il palazzo ducale di Fiorenza, insieme coi disegni delle stanze nuove, che erano state murate e dipinte da lui, quali desiderava Michelagnolo vedere in modello e disegno, poi che sendo vecchio non poteva vedere l'opere, le quali erano copiose, diverse e con varie invenzioni e capricci, che cominciavano dalla castrazione di Celo, Saturno, Opi, Cerere, Giove, Giunone, Ercole, che in ogni stanza era uno di questi nomi, con le sue istorie in diversi partimenti, come ancora l'altre camere e sale che erano sotto queste avevano il nome degli eroi di casa Medici, cominciando da Cosimo Vecchio, Lorenzo, Leone Decimo, Clemente Settimo, el signor Giovanni, el duca Alessandro e duca Cosimo, nelle quali per ciascuna erano non solamente le storie de' fatti loro, ma loro ritratti e de' figliuoli e di tutte le persone antiche, così di governo come d'arme e di lettere, ritratte di naturale, delle quali aveva scritto il Vasari un dialogo ove si dichiarava tutte le istorie et il fine di tutta l'invenzione, e come le favole di sopra s'accomo-dassino alle istorie di sotto, le quali gli fur lette da Annibal Caro, che n'ebbe grandissimo piacere Michelagnolo. Questo dialogo, come arà più tempo il Vasari, si manderà fuori.
Queste cose causorono che desiderando il Vasari di metter mano alla sala grande, e perché era, come s'è detto altrove, il palco basso che la faceva nana e cieca di lumi, et avendo desiderio di alzarla non si voleva risolvere il duca Cosimo a dargli licenzia ch'ella si alzasse. Non che 'l Duca temesse la spesa, come s'è visto poi, ma il pericolo di alzare i cavagli del tetto 13 braccia sopra; dove sua eccellenza come giudiziosa consentì che s'avessi il parere da Michelagnolo, visto in quel modello la sala come era prima, poi levato tutti que' legni e postovi altri legni con nuova invenzione del palco e delle facciate, come s'è fatto da noi, e disegnata in quella insieme l'invenzione delle istorie, che piaciutagli ne diventò subito non giudice, ma parziale, vedendo anche il modo e la facilità dello alzare i cavagli e 'l tetto et il modo di condurre tutta l'opera in breve tempo. Dove egli scrisse nel ritorno del Vasari al Duca che seguitassi quella impresa, che l'era degna della grandezza sua. Il medesimo anno andò a Roma il duca Cosimo con la signora duchessa Leonora sua consorte, e Michelagnolo, arrivato il Duca, lo andò a vedere subito, il quale fattogli molte carezze, lo fece, stimando la sua gran virtù, sedere a canto a sé, e con molta domestichezza ragionandogli di tutto quello che sua eccellenza aveva fatto fare di pittura e di scultura a Fiorenza, e quello che aveva animo di volere fare, e della sala particularmente, di nuovo Michelagnolo ne lo confortò e si dolse, perché amava quel signore, non essere giovane di età da poterlo servire. E ragionando sua eccellenza che aveva trovato il modo da lavorare il porfido, cosa non creduta da lui, se gli mandò, come s'è detto nel primo capitolo delle Teoriche, la testa del Cristo lavorata da Francesco del Tadda scultore, che ne stupì. E tornò dal Duca più volte mentre che dimorò in Roma con suo grandissima satisfazione, et il medesimo fece andandovi poco dopo lo illustrissimo don Francesco de' Medici suo figliuolo, del quale Michelagnolo si compiacque per le amorevoli accoglienze e carezze fatte da sua eccellenza illustrissima, che gli parlò sempre con la berretta in mano avendo infinita reverenza a sì raro uomo, e scrisse al Vasari che gli incresceva l'essere indisposto e vecchio, che arebbe voluto fare qualcosa per quel signore, et andava cercando comperare qualche anticaglia bella per mandargliene a Fiorenza.
Ricercato a questo tempo Michelagnolo dal Papa per Porta Pia d'un disegno, ne fece tre tutti stravaganti e bellissimi che 'l Papa elesse per porre in opera quello di minore spesa, come si vede oggi murata con molta sua lode. E visto l'u-mor del Papa, perché dovessi restaurare le altre porte di Roma, gli fece molti altri disegni; el medesimo fece richiesto dal medesimo Pontefice per far la nuova chiesa di Santa Maria delli Angioli nelle Terme Diocliziane per ridurle a tempio a uso di cristiani, e prevalse un suo disegno che fece, a molti altri fatti da eccellenti architetti, con tante belle considerazioni per comodità de' frati Certosini, che l'hanno ridotto oggi quasi a perfezzione, che fé stupire Sua Santità e tutti i prelati e' signori di corte delle bellissime considerazioni che aveva fatte con giudizio, servendosi di tutte l'ossature di quelle terme, e se ne vedde cavato un tempio bellissimo et una entrata fuor della openione di tutti gli architetti, dove ne riportò lode et onore infinito. Come anche per questo luogo e' disegnò per Sua Santità di fare un ciborio del Sagramento di bronzo stato gettato gran parte da maestro Iacopo Ciciliano eccellente gettatore di bronzi, che fa che vengono le cose sottilissimamente senza bave, che con poca fatica si rinettano; che in questo genere è raro maestro e molto piaceva a Michelagnolo.
Aveva discorso insieme la nazione fiorentina più volte di dar qualche buon principio alla chiesa di San Giovanni di strada Giulia; dove ragunatosi tutti i capi delle case più ricche promettendo, ciascuna per rata secondo le facultà, sovvenire detta fabbrica, tanto che feciono da riscuotere buona somma di danari, e disputossi fra loro se gli era bene seguitare l'ordine vecchio o far qualche cosa di nuovo migliore, fu risoluto che si dessi ordine sopra i fondamenti vecchi a qualche cosa di nuovo, e finalmente creorono tre sopra questa cura di questa fabbrica che fu Francesco Bandini, Umberto Ubaldini e Tommaso de' Bardi, e' quali richiesano Michelagnolo di disegno raccomandandosegli, sì perché era vergogna della nazione avere gettato via tanti danari, né aver mai profittato niente, che se la virtù sua non gli giovava a finirla, non avevono ricorso alcuno. Promesse loro con tanta amorevolezza di farlo, quanto cosa 'e facessi mai prima, perché volentieri in questa sua vecchiezza si adoperava alle cose sacre che tornassino in onore di Dio, poi per l'amor della sua nazione, qual sempre amò. Aveva seco Michelagnolo a questo parlamento Tiberio Calcagni scultore fiorentino, giovane molto volenteroso di imparare l'arte, il quale essendo andato a Roma s'era volto alle cose d'architettura. Amandolo Michelagnolo, gli aveva dato a finire, come s'è detto, la Pietà di marmo ch'e' roppe, et inoltre una testa di Bruto di marmo col petto maggiore assai del naturale, perché la finisse quale era condotta la testa sola con certe minutissime gradine. Questa l'aveva cavata da un ritratto di esso Bruto intagliato in una corgnola antica, che era apresso al signor Giuliano Ceserino, antichissima, che a' preghi di Messer Donato Gianotti suo amicissimo la faceva Michelagnolo per il cardinale Ridolfi, che è cosa rara.
Michelagnolo dunque, per le cose d'architettura, non possendo disegnare più per la vecchiaia, né tirar linee nette, si andava servendo di Tiberio, perché era molto gentile e discreto: perciò desiderando servirsi di quello in tale impresa, gl'impose che e' levassi la pianta del sito della detta chiesa; la quale levata e portata subito a Michelagnolo, in questo tempo che non si pensava che facessi niente, fece intendere per Tiberio che gli aveva serviti, e finalmente mostrò loro cinque piante di tempii bellissimi, che viste da loro si maravigliorono, e disse loro che scegliessino una a modo loro: e quali non volendo farlo, riportandosene al suo giudizio, volse che si risolvessino pure a modo loro: onde tutti d'uno stesso volere ne presono una più ricca, alla quale risolutosi disse loro Michelagnolo che se conducevano a fine quel disegno, che né romani, né greci mai ne' tempi loro feciono una cosa tale: parole che né prima né poi usciron mai di bocca a Michelagnolo, perché era modestissimo. Finalmente conclusero che l'ordinazione fussi tutta di Michelagnolo, e le fatiche dello esseguire detta opera fussi di Tiberio, che di tutto si contentorono, promettendo loro che egli gli servirebbe benissimo; e così dato la pianta a Tiberio che la riducessi netta e disegnata giusta, gli ordinò i profili di fuori e di drento, e che ne facessi un modello di terra, insegnandogli il modo da condurlo che stessi in piedi. In dieci giorni condusse Tiberio il modello di otto palmi, del quale piaciuto assai a tutta la nazione, ne feciono poi fare un modello di legno, che è oggi nel consolato di detta nazione: cosa tanto rara, quanto tempio nessuno che si sia mai visto, sì per la bellezza, ricchezza e gran varietà sua; del quale fu dato principio e speso scudi 5000, che mancato a quella fabbrica gli assegnamenti è rimasta così, che n'ebbe grandissimo dispiacere. Fece allogare a Tiberio con suo ordine a Santa Maria Maggiore una cappella cominciata per il cardinale di Santa Fiore, restata imperfetta per la morte di quel Cardinale e di Michelagnolo e di Tiberio, che fu di quel giovane grandissimo danno.
Era stato Michelagnolo anni 17 nella fabbrica di San Pietro, e più volte i deputati l'avevon voluto levare da quel governo, e non essendo riuscito loro, andavano pensando ora con questa stranezza et ora con quella opporsegli a ogni cosa, che per istracco se ne levassi, essendo già tanto vecchio che non poteva più. Ove essendovi per soprastante Cesare da Casteldurante, che in que' giorni si morì, Michelagnolo, perché la fabbrica non patissi, vi mandò, per fino che trovassi uno a modo suo, Luigi Gaeta, troppo giovane ma suffizientissimo. E' deputati, una parte de' quali molte volte avevon fatto opera di mettervi Nanni di Baccio Bigio, che gli stimolava e prometteva gran cose, per potere travagliare le cose della fabbrica a loro modo, mandoron via Luigi Gaeta: il che inteso Michelagnolo, quasi sdegnato, non voleva più capitare alla fabbrica; dove e' cominciorono a dar nome fuori che non poteva più, che bisognava dargli un sustituto, e che egli aveva detto che non voleva impacciarsi più di San Piero. Tornò tutto agli orecchi di Michelagnolo, il quale mandò Daniello Ricciarelli da Volterra al vescovo Ferratino, uno de' soprastanti, che aveva detto al cardinale di Carpi che Michelagnolo aveva detto a un suo servitore che non voleva impacciarsi più della fabbrica; che tutto Daniello disse non essere questa la voluntà di Michelagnolo; dolendosi il Ferratino che egli non conferiva il concetto suo, e che era bene che dovessi mettervi un sostituto e volentieri arebbe accettato Daniello, il quale pareva che si contentassi Michelagnolo; dove fatto intendere a' deputati in nome di Michelagnolo che avevono un sustituto, presentò il Ferratino non Daniello, ma in cambio suo Nanni Bigio, che entrato drento et accettato da' soprastanti, non andò guari che dato ordine di fare un ponte di legno dalla parte delle stalle del papa dove è il monte, per salire sopra la nicchia grande che volta a quella parte, fé mozzare alcune travi grosse di abeto dicendo che si consumava nel tirare su la roba troppi canapi, che era meglio il condurla per quella via. Il che inteso Michelagnolo andò subito dal Papa, e romoreggiando perché era sopra la piazza di Campidoglio, lo fé subito andare in camera, dove disse: “Gli è stato messo, Padre Santo, per mio sostituto da' deputati uno che io non so chi egli sia, però se conoscevano loro e la Santità Vostra che io non sia più 'l caso, io me ne tornerò a riposare a Fiorenza, dove goderò quel gran Duca che m'ha tanto desiderato, e finirò la vita in casa mia: però vi chieggo buona licenzia”. Il Papa n'ebbe dispiacere e con buone parole confortandolo gli ordinò che dovessi venire a parlargli il giorno lì in Araceli, dove fatto ragunare i deputati della fabbrica, volse intendere le cagioni di quello che era seguito: dove fu risposto da loro che la fabbrica rovinava e vi si faceva degli errori; il che avendo inteso il Papa non essere il vero, comandò al signor Gabrio Scerbellone che dovessi andare a vedere in sulla fabbrica e che Nanni che proponeva queste cose gliele mostrassi: che ciò fu eseguito. E trovato il signor Gabrio esser ciò tutta malignità e non essere vero, fu cacciato via con parole poco oneste di quella fabbrica in presenza di molti signori, rimproverandogli che per colpa sua rovinò il ponte Santa Maria e che in Ancona volendo con pochi danari far gran cose “per nettare il porto lo riempiesti più in un dì che non fece il mare in dieci anni”; tale fu il fine di Nanni per la fabbrica di San Piero, per la quale Michelagnolo di continuo non attese mai a altro in 17 anni che fermarla per tutto con riscontri, dubitando per queste persecuzioni invidiose non avessi dopo la morte sua a essere mutata; dove è oggi sicurissima da poterla sicuramente voltare. Per il che s'è visto che Iddio, che è protettore de' buoni, l'ha difeso fino ch'egl'è vissuto et ha sempre operato per benefizio di questa fabbrica e difensione di questo uomo fino alla morte. Avvenga che, vivente dopo lui, Pio Quarto ordinò a' soprastanti della fabbrica che non si mutasse niente di quanto aveva ordinato Michelagnolo, e con maggiore autorità lo fece eseguire Pio V suo successore; il quale, perché non nascessi disordine, volse che si eseguissi inviolabilmente i disegni fatti da Michelagnolo, mentre che furono esecutori di quella Pirro Ligorio e Iacopo Vignola architetti, che Pirro volendo presuntuosamente muovere et alterare quell'ordine, fu con poco onor suo levato via da quella fabbrica e lassato il Vignola. E finalmente quel Pontefice, zelantissimo non meno dello onor della fabbrica di San Piero che della Religione cristiana, l'anno 1565 che 'l Vasari andò 'a piedi di Sua Santità, e chiamato di nuovo l'an-no 1566, non si trattò se non al procuratore l'osservazione de' disegni lasciati da Michelagnolo; e per ovviare a tutti e' disordini comandò Sua Santità al Vasari che con Messer Guglielmo Sangalletti, tesauriere segreto di Sua Santità, per ordine di quel Pontefice andassi a trovare il vescovo Ferratino, capo de' fabricieri di San Pietro, che dovessi attendere a tutti gli avvertimenti e ricordi importanti che gli direbbe il Vasari, acciò che mai per il dir di nessuno maligno e presuntuoso s'avessi a muovere segno o ordine lasciato dalla eccellente virtù e memoria di Michelagnolo. Et a ciò fu presente Messer Giovambatista Altoviti, molto amico del Vasari et a queste virtù. Per il che udito il Ferratino un discorso che gli fece il Vasari, accettò volentieri ogni ricordo e promesse inviolabilmente osservare e fare osservare in quella fabbrica ogni ordine e disegno che avesse per ciò lasciato Michelagnolo, et inoltre d'essere protettore, difensore e conservatore delle fatiche di sì grande uomo.
E tornando a Michelagnolo, dico che innanzi la morte un anno incirca, avendosi adoperato il Vasari segretamente che 'l duca Cosimo de' Medici operassi col Papa per ordine di Messer Averardo Serristori suo imbasciadore, che, visto che Michelagnolo era molto cascato, si tenesse diligente cura di chi gli era attorno a governarlo e chi gli praticava in casa, che venendogli qualche subito accidente, come suole venire a' vecchi, facessi provisione che le robe, disegni, cartoni, modelli e danari et ogni suo avere nella morte si fussino inventariati e posti in serbo per dare alla fabbrica di San Piero, se vi fussi stato cose attenenti a lei, così alla sagrestia e libreria di San Lorenzo e facciata, non fussino state trasportate via, come spesso suole avvenire; che finalmente giovò tal diligenza, che tutto fu eseguito in fine.
Desiderava Lionardo suo nipote la quaresima vegnente andare a Roma, come quello che s'indovinava che già Michelagnolo era in fine della vita sua, e lui se ne contentava, quando amalatosi Michelagnolo di una lenta febbre, subito fé scrivere a Daniello che Lionardo andassi: ma il male cresciutogli, ancora che Messer Federigo Donati suo medico e gli altri suoi gli fussino a torno, con conoscimento grandissimo fece testamento di tre parole, che lasciava l'anima sua nelle mane de Iddio, il suo corpo alla terra e la roba a' parenti più prossimi, imponendo a' suoi che nel passare di questa vita gli ricordassino il patire di Gesù Cristo; e così a dì 17 di febraio, l'anno 1563 a ore 23 a uso fiorentino, che al romano sarebbe 1564, spirò per irsene a miglior vita.
Fu Michelagnolo molto inclinato alle fatiche dell'arte, veduto che gli riusciva ogni cosa quantunque dificile, avendo avuto dalla natura l'ingegno molto atto et aplicato a queste virtù eccellentissime del disegno; là dove per esser interamente perfetto, infinite volte fece anatomia scorticando uomini per vedere il principio e legazioni dell'ossature, muscoli, nerbi, vene e moti diversi e tutte le positure del corpo umano, e non solo degli uomini, ma degli animali ancora e particularmente de' cavagli, de' quali si dilettò assai di tenerne; e di tutti volse veder il lor principio et ordine in quanto all'arte, e lo mostrò talmente nelle cose che gli accaddono trattare, che non ne fa più chi non attende a altra cosa che quella. Per il che ha condotto le cose sue così col pennello come con lo scarpello, che son quasi inimmitabili, et ha dato, come s'è detto, tanta arte, grazia et una certa vivacità alle cose sue - e ciò sia detto con pace di tutti - che ha passato e vinto gli antichi avendo saputo cavare della dificultà tanto facilmente le cose, che non paion fatte con fatica, quantunque, [da] chi disegna poi le cose sue, la vi si trovi per imitarla. È stata conosciuta la virtù di Michelagnolo in vita e non come aviene a molti dopo la morte, essendosi visto che Giulio II, Leon X, Clemente VII, Paulo III, e Giulio III, e Paulo IIII e Pio IIII, sommi pontefici, l'hanno sempre voluto appresso e, come si sa, Solimanno imperatore de' Turchi, Francesco Valesio re di Francia, Carlo V imperatore, e la signoria di Vinezia, e finalmente il duca Cosimo de' Medici, come s'è detto, e tutti con onorate provisioni, non per altro che per valersi della sua gran virtù; che ciò non accade se non a uomini di gran valore come era egli, avendo conosciuto e veduto che queste arti, tutt'e tre, erano talmente perfette in lui, che non si trova, né in persone antiche o moderne in tanti e tanti anni che abbia girato il sole, che Dio l'abbi concesso a altri che a lui. Ha avuto l'immaginativa tale e sì perfetta, che le cose propostosi nella idea sono state tali che con le mani, per non potere esprimere sì grandi e terribili concetti, ha spesso abandonato l'opere sue, anzi ne ha guasto molte, come io so che, innanzi che morissi di poco, abruciò gran numero di disegni, schizzi e cartoni fatti di man sua, acciò nessuno vedessi le fatiche durate da lui et i modi di tentare l'ingegno suo, per non apparire se non perfetto, e io ne ho alcuni di sua mano trovati in Fiorenza messi nel nostro libro de' disegni, dove ancora che vi vegga la grandezza di quello ingegno, si conosce che quando e' voleva cavar Minerva della testa di Giove, ci bisognava il martello di Vulcano, imperò egli usò le sue figure farle di nove e di dieci e di dodici teste, non cercando altro che col metterle tutte insieme ci fussi una certa concordanza di grazia nel tutto che non lo fa il naturale, dicendo che bisognava avere le seste negli occhi e non in mano, perché le mani operano e l'occhio giudica: che tale modo tenne ancora nell'architettura. Né paia nuovo a nessuno che Michelagnolo si dilettassi della solitudine, come quello che era innamorato dell'arte sua, che vuol l'uomo per sé solo e cogitativo e perché è necessario che, chi vuole attendere agli studii di quella, fugga le compagnie: avenga che chi attende alle considerazioni dell'arte non è mai solo né senza pensieri, e coloro che gliele attribuivano a fantasticheria et a stranezza, hanno il torto, perché chi vuole operar bene, bisogna allontanarsi da tutte le cure e fastidi, perché la virtù vuol pensamento, solitudine e comodità, e non errare con la mente. Con tutto ciò ha avuto caro l'amici-zie di molte persone grandi e delle dotte e degli uomini ingegnosi a' tempi convenienti e se l'è mantenute, come il grande Ipolito cardinale de' Medici che l'amò grandemente, et inteso che un suo cavallo turco che aveva piaceva per la sua bellezza a Michelagnolo, fu dalla liberalità di quel signore mandato a donare con dieci muli carichi di biada et un servidore che lo governassi, che Michelagnolo volentieri lo accettò. Fu suo amicissimo lo illustrissimo cardinale Polo, innamorato Michelagnolo delle virtù e bontà di lui, il cardinale Farnese e Santacroce, che fu poi papa Marcello, il cardinale Ridolfi, el cardinale Maffeo, e monsignor Bembo, Carpi, e molti altri cardinali e vescovi e prelati, che non accade nominargli, monsignor Claudio Tolomei, el magnifico Messer Ottaviano de' Medici suo compare che gli battezzò un suo figliuolo, e Messer Bindo Altoviti, al quale donò il cartone della cappella, dove Noè inebriato è schernito da un de' figliuoli e ricoperto le vergogne dagli altri dua; Messer Lorenzo Ridolfi e Messer Anibal Caro, e Messer Giovan Francesco Lottini da Volterra; et infinitamente amò più di tutti Messer Tommaso de' Cavalieri gentiluomo romano, quale essendo giovane e molto inclinato a queste virtù, perché egli imparassi a disegnare, gli fece molte carte stupendissime disegnate di lapis nero e rosso di teste divine, e poi gli disegnò un Ganimede rapito in cielo da l'uccel di Giove, un Tizio che l'avvoltoio gli mangia il cuore, la cascata del carro del sole con Fetonte nel Po et una baccanalia di putti, che tutti sono ciascuno per sé cosa rarissima e disegni non mai più visti. Ritrasse Michelagnolo Messer Tommaso in un cartone grande di naturale, che né prima né poi di nessuno fece il ritratto, perché aborriva il fare somigliare il vivo se non era d'infinita bellezza. Queste carte sono state cagione che dilettandosi Messer Tommaso quanto e' fa, che n'ha poi avute una buona partita che già Michelagnolo fece a fra' Bastiano Viniziano, che le messe in opera, che sono miracolose, et invero egli le tiene meritamente per reliquie e n'ha accomodato gentilmente gli artefici. Et invero Michelagnolo collocò sempre l'amor suo a persone nobili, meritevoli e degne, che nel vero ebbe giudizio e gusto in tutte le cose. Ha fatto poi fare Messer Tommaso a Michelagnolo molti disegni per amici, come per il cardinale di Cesis la tavola dove è la Nostra Donna annunziata dall'Angelo, cosa nuova, che poi fu da Marcello Mantovano colorita e posta nella cappella di marmo, che ha fatto fare quel Cardinale nella chiesa della Pace di Roma, come ancora un'altra Nunziata colorita pur di mano di Marcello in una tavola nella chiesa di S. Ianni Laterano, che 'l disegno l'ha il duca Cosimo de' Medici, il quale dopo la morte donò Lionardo Buonarruoti suo nipote a sua eccellenza che gli tien per gioie, insieme con un Cristo che òra nel-l'orto e molti altri disegni e schizzi e cartoni di mano di Michelagnolo, insieme con la statua della Vittoria che ha sotto un prigione, di braccia cinque alta; ma quattro prigioni bozzati, che possano insegnare a cavare de' marmi le figure con un modo sicuro da non istorpiare i sassi, che il modo è questo: che se e' si pigliassi una figura di cera o d'altra materia dura, e si mettessi a diacere in una conca d'acqua, la quale acqua essendo per sua natura nella sua sommità piana e pari, alzando la detta figura a poco a poco del pari, così vengono a scoprirsi prima le parti più rilevate et a nascondersi i fondi, cioè le parti più basse della figura, tanto che nel fine ella così viene scoperta tutta. Nel medesimo modo si debbono cavare con lo scarpello le figure de' marmi, prima scoprendo le parti più rilevate, e di mano in mano le più basse, il qua-le modo si vede osservato da Michelagnolo ne' sopra detti prigioni, i quali sua eccellenzia vuole che servino per esemplo de' suoi accademici.
Amò gli artefici suoi e praticò con essi, come con Iacopo Sansovino, il Rosso, il Puntormo, Daniello da Volterra e Giorgio Vasari aretino, al quale usò infinite amorevolezze e fu cagione che egli attendessi alla architettura con intenzione di servirsene un giorno, e conferiva seco volentieri e discorreva delle cose dell'arte. E questi che dicano che non voleva insegnare, hanno il torto, perché l'usò sempre a' suoi famigliari et a chi dimandava consiglio, e perché mi sono trovato a molti presente, per modestia lo taccio non volendo scoprire i difetti d'altri. Si può ben far giudizio di questo che con coloro che stettono con seco in casa ebbe mala fortuna, perché percosse in subietti poco atti a imitarlo; ché Pie-ro Urbano pistolese suo creato era persona d'ingegno, ma non volse mai affaticarsi; Antonio Mini arebbe voluto, ma non ebbe il cervello atto, e quando la cera è dura non s'imprime bene; Ascanio dalla Ripa Transone durava gran fatiche, ma mai se ne vedde il frutto né in opere, né in disegni, e pestò parecchi anni intorno a una tavola che Michelagnolo gli aveva dato un cartone, nel fine se n'è ito in fummo quella buona aspettazione che si credeva di lui, che mi ricordo che Michelagnolo gli veniva compassione sì dello stento suo e l'aiutava di suo mano, ma giovò poco. E s'egli avessi avuto un subietto, che me lo disse parecchi volte, arebbe speso così vecchio fatto notomia et arebbe scrittovi sopra per giovamento de' suoi artefici, che fu ingannato da parecchi; ma si difidava, per non potere esprimere con gli scritti quel ch'egli arebbe voluto, per non essere egli esercitato nel dire, quantunque egli in prosa nelle lettere sue abbia con poche parole spiegato bene il suo concetto, essendosi egli molto dilettato delle lezzioni de' poeti volgari, e particolarmente di Dante che molto lo amirava et imitava ne' concetti e nelle invenzioni, così 'l Petrarca, dilettatosi di far madrigali, sonetti molto gravi sopra e' quali s'è fatto comenti, e Messer Benedetto Varchi nella Accademia fiorentina fece una lezione onorata sopra quel sonetto che comincia:
Non ha l'ottimo artista alcun concetto,
ch'un marmo solo in sé non circonscriva.
Ma infiniti ne mandò di suo e ricevé risposta di rime e di prose della illustrissima marchesana di Pescara, delle virtù della quale Michelagnolo era innamorato et ella parimente di quelle di lui, e molte volte andò ella a Roma da Viterbo a visitarlo, e le disegnò Michelagnolo una Pietà in grembo alla Nostra Donna con dua Angioletti mirabilissima, et un Cristo confitto in croce, che alzato la testa raccomanda lo spirito al Padre, cosa divina, oltre a un Cristo con la Samaritana al pozzo.
Dilettossi molto della Scrittura Sacra, come ottimo cristiano che egli era, et ebbe in gran venerazione l'opere scritte da fra' Girolamo Savonarola per avere udito la voce di quel frate in pergamo. Amò grandemente le bellezze umane per la imitazione dell'arte per potere scerre il bello dal bello, ché senza questa imitazione non si può far cosa perfetta; ma non in pensieri lascivi e disonesti, che l'ha mostro nel modo del viver suo, che è stato parchissimo, essendosi contentato quando era giovane, per istare intento al lavoro, d'un poco di pane e di vino, avendolo usato sendo vecchio fino che faceva il Giudizio di cappella, col ristorarsi la sera quando aveva finito la giornata, pur parchissimamente; che se bene era ricco viveva da povero, né amico nessuno mai mangiò seco o di rado, né voleva presenti di nessuno, perché pareva, come uno gli donava qualcosa, d'essere sempre obligato a colui. La qual sobrietà lo faceva essere vigilantissimo e di pochissimo sonno, e bene spesso la notte si levava, non potendo dormire, a lavorare con lo scarpello avendo fatto una celata di cartoni, e sopra il mezzo del capo teneva accesa la candela, la quale con questo modo rendeva lume dove egli lavorava senza impedimento delle mani. Et il Vasari, che più volte vidde la celata, considerò che non adoperava cera, ma candele di sevo di capra schietto, che sono eccellenti, e gliene mandò quattro mazzi, che erano quaranta libbre. Il suo servitore garbato gliene portò alle dua ore di notte, e presentategliene, Michelagnolo ricusava che non le voleva, gli disse: “Messere, le m'hanno rotto per di qui in ponte le braccia, né le vo' riportare a casa che dinanzi al vostro uscio ci è una fanghiglia soda e starebbono ritte agevolmente; io le accenderò tutte”. Michelagnolo gli disse: “Posale costì, che io non voglio che tu mi faccia le baie a l'uscio”. Dissemi che molte volte nella sua gioventù dormiva vestito, come quello che stracco dal lavoro non curava di spogliarsi per aver poi a rivestirsi. Sono alcuni che l'hanno tassato essere avaro; questi s'ingannano, perché sì delle cose dell'arte come delle facultà ha mostro il contrario; delle cose dell'arte si vede aver donato, come s'è detto, et a Messer Tommaso de' Cavalieri, a Messer Bindo et a fra' Bastiano disegni che valevano assai; ma a Antonio Mini suo creato tutti i disegni, tutti i cartoni, il quadro della Leda, tutti i suoi modegli e di cera e di terra che fece mai, che come s'è detto, rimasono tutti in Francia a Gherardo Perini gentiluomo fiorentino suo amicissimo; in tre carte alcune teste di matita nera divine, le quali sono dopo la morte di lui venute in mano dello illustrissimo don Francesco principe di Fiorenza, che le tiene per gioie, come le sono. A Bartolommeo Bettini fece e donò un cartone d'una Venere con Cupido che la bacia, che è cosa divina, oggi appresso agli eredi in Fiorenza; e per il marchese del Vasto fece un cartone d'un Noli me tangere, cosa rara, che l'uno e l'altro dipinse eccellentemente il Puntormo, come s'è detto. Donò i duoi prigioni al signor Ruberto Strozzi, et a Antonio suo servitore, et a Francesco Bandini la Pietà che roppe, di marmo. Né so quel che si possa tassar d'avarizia questo uomo, avendo donato tante cose, che se ne sarebbe cavato migliaia di scudi. Che si può egli dire, se non che io so, che mi ci son trovato, che ha fatto più disegni et ito a vedere più pitture e più muraglie, né mai ha voluto niente? Ma veniamo ai danari guadagnati col suo sudore, non con entrate, non con cambi, ma con lo studio e fatica sua, se si può chiamare avaro chi soveniva molti poveri, come faceva egli, e maritava segretamente buon numero di fanciulle, et arricchiva chi lo aiutava nell'opere, e chi lo servì come Urbino suo servidore che lo fece ricchissimo et era suo creato che l'aveva servito molto tempo; e gli disse: “Se io mi muoio, che farai tu?”. Rispose: “Servirò un altro”. “O povero a te”, gli disse Michelagnolo, “io vo' riparare alla tua miseria”, e gli donò scudi dumila in una volta, cosa che è solita da farsi per i Cesari e pontefici grandi; senzaché al nipote ha dato per volta tre e quattro mila scudi, e nel fine gli ha lassato scudi diecimila senza le cose di Roma.
È stato Michelagnolo di una tenace e profonda memoria, che nel vedere le cose altrui una sol volta l'ha ritenute sì fattamente e servitosene in una maniera, che nessuno se n'è mai quasi accorto, né ha mai fatto cosa nessuna delle sue che riscontri l'una con l'altra, perché si ricordava di tutto quello che aveva fatto. Nella sua gioventù sendo con gli amici sua pittori, giucorno una cena a chi faceva una figura che non avessi niente di disegno, che fussi goffa, simile a que' fantocci che fanno coloro che non sanno et imbrattano le mura, Qui si valse della memoria, perché ricordatosi aver visto in un muro una di queste gofferie, la fece come se l'avessi avuta dinanzi di tutto punto, e superò tutti que' pittori; cosa dificile in uno uomo tanto pieno di disegno, avvezzo a cose scelte, che ne potessi uscir netto.
È stato sdegnoso e giustamente verso di chi gli ha fatto ingiuria, non però s'è visto mai esser corso alla vendetta, ma sì bene più tosto pazientissimo et in tutti i costumi modesto, e nel parlare molto prudente e savio, con risposte piene di gravità et alle volte con motti ingegnosi, piacevoli et acuti. Ha detto molte cose che sono state da noi notate, delle quali ne metteremo alcune, perché saria lungo a descriverle tutte.
Essendogli ragionato della morte da un suo amico dicendogli che doveva assai dolergli, sendo stato in continove fatiche per le cose dell'arte, né mai avuto ristoro, rispose che tutto era nulla, perché se la vita ci piace, essendo anco la morte di mano d'un medesimo maestro, quella non ci doverebbe dispiacere. A un cittadino che lo trovò da Or San Michele in Fiorenza che s'era fermato a riguardare la statua del San Marco di Donato, e lo domandò quel che di quella figura gli paresse, Michelagnolo rispose che non vedde mai figura che avessi più aria di uomo da bene di quella e che se San Marco era tale, se gli poteva credere ciò che aveva scritto. Essendogli mostro un disegno e raccomandato un fanciullo che allora imparava a disegnare, scusandolo alcuni che era poco tempo che s'era posto all'arte, rispose: “E' si conosce”. Un simil motto disse a un pittore che aveva dipinto una Pietà e non s'era portato bene, che ell'era proprio una pietà a vederla. Inteso che Sebastiano Viniziano aveva a fare nella cappella di San Piero a Montorio un frate, disse che gli guasterebbe quella opera; domandato della cagione, rispose che avendo eglino guasto il mondo che è sì grande, non sarebbe gran fatto che gli guastassino una cappella sì piccola. Aveva fatto un pittore una opera con grandissima fatica e penatovi molto tempo, e nello scoprirla aveva acquistato assai; fu dimandato Michelagnolo che gli pareva del facitore di quella; rispose: “Mentre che costui vorrà esser ricco, sarà del continuo povero”. Uno amico suo che già diceva messa et era religioso, capitò a Roma tutto pieno di puntali e di drappo e salutò Michelagnolo et egli si finse di non vederlo, per che fu l'amico forzato fargli palese il suo nome; mostrò di maravigliarsi Michelagnolo che fussi in quell'abito, poi soggiunse quasi rallegrandosi: “Oh voi siete bello! Se fossi così drento, come io vi veggio di fuori, buon per l'anima vostra”. Al medesimo che aveva raccomandato uno amico suo a Michelagnolo che gli aveva fatto fare una statua, pregandolo che gli facessi dare qualcosa più, il che amorevolmente fece; ma l'invidia dello amico che richiese Michelagnolo credendo che non lo dovesse fare, veggendo pur che l'aveva fatto, fece che se ne dolse, e tal cosa fu detta a Michelagnolo; onde rispose che gli dispiacevano gli uomini fognati, stando nella metafora della architettura, intendendo che con quegli che hanno due bocche, mal si può praticare. Domandato da uno amico suo quel che gli paresse d'uno che aveva contrafatto di marmo figure antiche delle più celebrate, vantandosi lo immitatore che di gran lunga aveva superato gli antichi; rispose: “Chi va dietro a altri, mai non li passa innanzi, e chi non sa far bene da sé, non può servirsi bene delle cose d'altri”. Aveva non so che pittore [fatto] un'opera, dove era un bue che stava meglio delle altre cose; fu di-mandato perché il pittore aveva fatto più vivo quello che l'altre cose, disse: “Ogni pittore ritrae se medesimo bene”. Passando da San Giovanni di Fiorenza gli fu dimandato il suo parere di quelle porte, egli rispose: “Elle sono tanto belle, che le starebbon bene alle porte del Paradiso”. Serviva un principe che ogni dì variava disegni, né stava fermo; disse Michelagnolo a uno amico suo: “Questo signore ha un cervello come una bandiera di campanile, che ogni vento che vi dà drento la fa girare”. Andò a vedere una opera di scultura che doveva mettersi fuora perché era finita, e si affaticava lo scultore assai in acconciare i lumi delle finestre perch'ella mostrassi bene, dove Michelagnolo gli disse: “Non ti affaticare che l'importanza sarà il lume della piazza”, volendo inferire che come le cose sono in publico, il populo fa giudizio s'elle sono buone o cattive. Era un gran principe che aveva capriccio in Roma d'architetto, et aveva fatto fare certe nicchie per mettervi figure, che erano l'una tre quadri alte con uno anello in cima, e vi provò a mettere dentro statue di-verse, che non vi tornavano bene. Dimandò Michelagnolo quel che vi potessi mettere; rispose: “De' mazzi di anguille appiccate a quello anello”. Fu assunto al governo della fabrica di S. Piero un signore che faceva professione d'intendere Vitruvio e d'essere censore delle cose fatte. Fu detto a Michelagnolo: “Voi avete avuto uno alla fabbrica che ha un grande ingegno”. Rispose Michelagnolo: “Gli è vero, ma gli ha cattivo giudizio”. Aveva un pittore fatto una storia et aveva cavato di diversi luoghi di carte e di pitture molte cose, né era in su quella opera niente che non fussi cavato, e fu mostro a Michelagnolo che veduta, gli fu dimandato da un suo amicissimo quel che gli pareva; rispose: “Bene ha fatto, ma io non so al dì del giudizio, che tutti i corpi piglieranno le lor membra, come farà quella storia, che non ci rimarrà niente”: avvertimento a coloro che fanno l'arte, che s'avezzino a fare da sé. Passando da Modana vedde di mano di maestro Antonio Bigarino modanese scultore, che aveva fatto molte figure belle di terra cotta e colorite di colore di marmo, le quali gli parsono una eccellente cosa, e perché quello scultore non sapeva lavorare il marmo, disse: “Se questa terra diventassi marmo, guai alle statue antiche”. Fu detto a Michelagnolo che doveva risentirsi contro a Nanni di Baccio Bigio, perché voleva ogni dì competere seco; rispose: “Chi combatte con da pochi, non vince a nulla”. Un prete suo amico disse: “Gli è peccato che non aviate tolto donna, perché aresti avuto molti figliuoli e lasciato loro tante fatiche onorate”. Rispose Michelagnolo: “Io ho moglie troppa, che è questa arte che m'ha fatto sempre tribolare, et i miei figliuoli saranno l'opere che io lasserò; che se saranno da niente, si viverà un pezzo. E guai a Lorenzo di Bartoluccio Ghiberti se non faceva le porte di S. Giovanni, perché i figliuoli e' nipoti gli hanno venduto e mandato male tutto quello che lasciò: le porte sono ancora in piedi”. Il Vasari mandato da Giulio Terzo a un'ora di notte per un disegno a casa Michelagnolo, trovò che lavorava sopra la Pietà di marmo che e' ruppe. Conosciutolo Michelagnolo al picchiare della porta, si levò dal lavoro e prese in mano una lucerna dal manico; dove esposto il Vasari quel che voleva, mandò per il disegno Urbino di sopra, et entrati in altro ragionamento, voltò intanto gli occhi il Vasari a guardare una gamba del Cristo sopra la quale lavorava e cercava di mutarla; e per ovviare che 'l Vasari non la vedessi, si lasciò cascare la lucerna di mano, e rimasti al buio, chiamò Urbino che recassi un lume, et in tanto uscito fuori del tavolato, dove ell'era, disse: “Io sono tanto vecchio, che spesso la morte mi tira per la cappa perché io vadia seco, e questa mia persona cascherà un dì come questa lucerna, e sarà spento il lume della vita”. Con tutto ciò aveva piacere di certe sorte uomini a suo gusto, come il Menighella pittore dozzinale e goffo di Valdarno, che era persona piacevolissima, il quale veniva talvolta a Michelagnolo che gli facessi un disegno di San Rocco, di Santo Antonio per dipignere a' contadini. Michelagnolo che era dificile a lavorare per i re, si metteva giù lassando stare ogni lavoro, e gli faceva disegni semplici accomodati alla maniera e volontà, come diceva Menighella, e fra l'altre gli fece fare un modello d'un Crocifisso, che era bellissimo, sopra il quale vi fece un cavo, e ne formava di cartone e d'altre mesture, et in contado gli andava vendendo, che Michelagnolo crepava delle risa; massime che gli intraveniva di bei casi, come con un villano, il quale gli fece dipignere S. Francesco, e dispiaciutoli che 'l Menighella gli aveva fatto la vesta bigia, che l'arebbe voluta di più bel colore, il Menighella gli fece in dosso un piviale di broccato, e lo contentò. Amò parimente Topolino scarpellino, il quale aveva fantasia d'essere valente scultore, ma era debolissimo. Costui stette nelle montagne di Carrara molti anni a mandar marmi a Michelagnolo, né arebbe mai mandato una scafa carica che non avessi mandato sopra tre o quattro figurine bozzate di sua mano, che Michelagnolo moriva delle risa. Finalmente ritornato, et avendo bozzato un Mercurio in un marmo, si messe Topo-lino a finirlo, et un dì che ci mancava poco, volse Michelagnolo lo vedessi e strettamente operò li dicessi l'openion sua. “Tu sei un pazzo, Topolino”, gli disse Michelagnolo “a volere far figure, non vedi che a questo Mercurio dalle ginocchia alli piedi ci manca più di un terzo di braccio, che gli è nano, e che tu l'hai storpiato?”. “O questo non è niente, s'ella non ha altro io ci rimedierò, lassate fare a me.” Rise di nuovo della semplicità sua Michelagnolo, e partito, prese un poco di marmo Topolino e tagliato il Mercurio sotto le ginocchia un quarto, lo incassò nel marmo e lo comesse gentil-mente, facendo un paio di stivaletti a Mercurio, che il fine passava la commettitura e lo allungò il bisogno: che fatto venire poi Michelagnolo e mostrogli l'opera sua di nuovo, rise e si maravigliò che tali goffi stretti dalla necessità piglion di quelle resoluzioni che non fanno i valenti uomini.
Mentre che egli faceva finire la sepoltura di Giulio Secondo, fece a uno squadratore di marmi condurre un termine per porlo nella sepoltura di S. Piero in Vincola, con dire: “Lieva oggi questo, e spiana qui, pulisci qua”; di maniera che senza che colui se n'avedessi, gli fé fare una figura; perché finita colui maravigliosamente la guardava, disse Michelagnolo: “Che te ne pare?”. “Parmi bene”, rispose colui “e v'ho grande obligo”. “Perché”, soggiunse Michelagnolo. “Perché io ho ritrovato per mezzo vostro una virtù che io non sapeva d'averla.”
Ma per abreviare dico che la complessione di questo uomo fu molto sana, perché era asciutta e bene annodata di nerbi, e se bene fu da fanciullo cagionevole e da uomo ebbe dua malattie d'importanza, soportò sempre ogni fatica e non ebbe difetto, salvo nella sua vecchiezza patì dello orinare e di renella, che s'era finalmente convertita in pietra, onde per le mani di maestro Realdo Colombo suo amicissimo si siringò molti anni e lo curò diligentemente. Fu di statura mediocre, nelle spalle largo, ma ben proporzionato con tutto il resto del corpo. Alle gambe portò invecchiando di continuovo stivali di pelle di cane sopra lo ignudo i mesi interi, che quando gli voleva cavare poi nel tirargli ne veniva spesso la pelle. Usava sopra le calze stivali di cordovano afibiati di drento per amore degli umori. La faccia era ritonda, la fronte quadrata e spaziosa con sette linee diritte, e le tempie sportavano in fuori più delle orecchie assai, le quali orecchie erano più presto alquanto grandi e fuor delle guance; il corpo era a proporzione della faccia e più tosto grande, il naso alquanto stiacciato, come si disse nella vita del Torrigiano, che gliene ruppe con un pugno, gli occhi più tosto piccoli che no, di color corneo machiati di scintille giallette azzurricine, le ciglia con pochi peli, le labra sottili e quel di sotto più grossetto et alquanto infuori; il mento ben composto alla proporzione del resto; la barba, e' capegli neri, sparsa con molti peli canuti, lunga non molto e biforcata, e non molto folta.
Certamente fu al mondo la sua venuta, come dissi nel principio, uno esemplo mandato da Dio agli uomini dell'arte nostra, perché s'imparassi da lui nella vita sua i costumi, e nelle opere, come avevano a essere i veri et ottimi artefici. Et io che ho da lodare Dio d'infinite felicità che raro suole accadere negli uomini della professione nostra, annovero fra le maggiori una: esser nato in tempo che Michelagnolo sia stato vivo, e sia stato degno che io l'abbia avuto per padrone e che egli mi sia stato tanto famigliare et amico quanto sa ognuno, e le lettere sue scrittemi ne fanno testimonio apresso di me; e per la verità e per l'obligo che io ho alla sua amorevolezza ho potuto scrivere di lui molte cose e tutte vere, che molti altri non hanno potuto fare. L'altra felicità è, come mi diceva egli: “Giorgio riconosci Dio che t'ha fatto servire il duca Cosimo, che per contentarsi che tu muri e dipinga e metta in opera i suoi pensieri e disegni, non ha curato spesa: dove se tu consideri agli altri di chi tu hai scritto le Vite, non hanno avuto tanto”.
Fu con onoratissime essequie col discorso di tutta l'arte e di tutti gli amici suoi e della nazione fiorentina, dato sepoltura a Michelagnolo in Santo Apostolo in un deposito nel cospetto di tutta Roma, avendo disegnato Sua Santità di farne fare particolare e memoria sepoltura in San Piero di Roma.
Arrivò Lionardo suo nipote che era finito ogni cosa, quantunque andasse in poste; et avutone aviso il duca Cosimo, il quale aveva disegnato che poi che non l'aveva potuto aver vivo et onorarlo, di farlo venire a Fiorenza e non restare con ogni sorte di pompa onorarlo dopo la morte, fu ad uso di mercanzia mandato in una balla segretamente; il quale modo si tenne acciò in Roma non s'avesse a fare romore e forse essere impedito il corpo di Michelagnolo e non lasciato condurre in Fiorenza. Ma innanzi che il corpo venisse, intesa la nuova della morte, ragunatisi insieme a richiesta del luogotenente della loro Accademia i principali pittori, scultori et architetti, fu ricordato loro da esso luogotenente, che allora era il reverendo don Vincenzio Borghini, che erano ubligati in virtù de' loro capitoli ad onorare la morte di tutti i loro fratelli, e che avendo essi ciò fatto sì amorevolmente e con tanta sodisfazione universale nell'essequie di fra' Giovan Agnolo Montorsoli, che primo dopo la creazione dell'Accademia era mancato, vedessero bene quello che fare si convenisse per l'onoranza del Buonarruoto, il quale da tutto il corpo della Compagnia e con tutti i voti favorevoli era stato eletto primo accademico e capo di tutti loro. Alla quale proposta risposero tutti, come ubbligatissimi et affezionatissimi alla virtù di tant'uomo, che per ogni modo si facesse opera di onorarlo in tutti que' modi che per loro si potessino maggiori e migliori. Ciò fatto per non avere ogni giorno a ragunare tante gente insieme con molto scomodo loro, e perché le cose passassero più quietamente, furono eletti sopra l'essequie et onoranza da farsi quattro uomini: Agnolo Bronzino e Giorgio Vasari pittori, Benvenuto Cellini e Bartolomeo Amannati, scultori, tutti di chiaro nome e d'illustre valore nelle lor arti, acciò dico questi consultassono e fermassono fra loro e col luogotenente quanto che e come si avesse a fare ciascuna cosa, con facultà di poter disporre di tutto il corpo della Compagnia et Accademia. Il quale carico presero tanto più volentieri offerendosi, come fecero, di bonissima voglia, tutti i giovani e vecchi, ciascuno nella sua professione, di fare quelle pitture e statue che s'avessono a fare in quell'onoranza. Dopo ordinarono che il luogotenente per debito del suo uffizio et i consoli in nome della Compagnia et Accademia significassero il tutto al signor Duca, e chiedessono quegli aiuti e favori che bisognavano, e specialmente che le dette essequie si potessono fare in San Lorenzo, chiesa dell'illustrissima casa de' Medici, e dove è la maggior parte dell'opere che di mano di Michelagnolo si veggiono in Firenze. E che oltre ciò sua eccellenza si contentasse che Messer Benedetto Varchi facesse e recitasse l'orazione funerale, acciò che l'eccellente virtù di Michelagnolo fusse lodata dall'eccellente eloquenza di tant'uomo, quanto era il Varchi, il quale per essere particularmente a' servigii di sua eccellenza non arebbe preso, senza parola di lei, cotal carico, ancor che come amorevolissimo di natura et affezionatissimo alla memoria di Michelagnolo erano certissimi che, quanto a sé, non l'arebbe mai ricusato. Questo fatto, licenziati che furono gl'accademici, il detto luogotenente scrisse al signor Duca una lettera di questo preciso tenore:
Avendo l'Accademia e Compagnia de' Pittori e Scultori consultato fra loro, quando sia con satisfazione di Vostra Eccellenzia illustrissima di onorare in qualche parte la memoria di Michelagnolo Buonarruoti, sì per il debito generale di tanta virtù, nella loro professione del maggior artefice che forse sia stato mai, e loro particolare, per l'interesse della comune patria, sì ancora per il gran giovamento che queste professioni hanno ricevuto della perfezione dell'opere et invenzioni sue, tal che pare che sia loro obligo mostrarsi amorevoli in quel modo ch'ei possono alla sua virtù, hanno per una loro esposto a Vostra Eccellenzia illustrissima questo loro desiderio e ricercatola come loro proprio refugio di certo aiuto. Io pregato da loro e (come giudico) obligato, per essersi contentata Vostra Eccellenzia illustrissima che io sia ancora questo anno con nome di suo luogotenente in loro compagnia, et aggiunto che la cosa mi pare piena di cortesia e d'animi virtuosi e grati; ma molto più conoscendo quanto Vostra Eccellenzia illustrissima è favoritore della virtù, e come un porto et un unico protettore in questa età delle persone ingegnose, avanzando in questo i suoi antinati, i quali alli eccellenti di queste professioni feciono favori straordinari, avendo per ordine del magnifico Lorenzo Giotto, tanto tempo innanzi morto, ricevuto una statua nel principal tempio, e fra' Filippo un sepolcro bellissimo di marmo, a spese sue proprie, e molti altri in diverse occasioni, utili et onori grandissimi; mosso da tutte queste cagioni, ho preso animo di raccomandare a Vostra Eccellenzia illustrissima la petizione di questa Accademia di potere onorare la virtù di Michelagnolo allievo e creatura particulare della scuola del magnifico Lorenzo, che sarà a loro contento straordinario, grandissima satisfazione all'universale, incitamento non piccolo ai professori di quest'arti et a tutta Italia saggio del bell'animo e pie-no di bontà di Vostra Eccellenzia illustrissima, la quale Dio conservi lungamente felice a beneficio de' popoli suoi e sostentamento della virtù.
Alla quale lettera detto signor Duca rispose così:
Reverendo nostro carissimo. La prontezza che ha dimostrato e dimostra codesta Accademia per onorare la memoria di Michelagnolo Buonarruoti, passato di questa a miglior vita, ci ha dato, dopo la perdita d'un uomo così singolare, molta consolazione; e non solo volemo contentarla di quanto ci ha domandato nel memoriale, ma procurare ancora che l'ossa di lui sieno portate a Firenze, secondo che fu la sua voluntà, per quanto siamo avisati: il che tutto scriviamo all'Accademia prefata [per infiammarla] tanto più a celebrare in tutti i modi la virtù di tanto uomo. E Dio vi contenti.
Della lettera poi, o vero memoriale di cui si fa di sopra menzione, fatta dall'Accademia al signor Duca, fu questo il proprio tenore:
Illustrissimo, etc. L'Accademia e gl'uomini della Compagnia del Disegno, creata per grazia e favore di Vostra Eccellenzia illustrissima, sappiendo con quanto studio et affezione ella abbia fatto per mezzo dell'oratore suo in Roma venire il corpo di Michelagnolo Buonarruoti a Firenze, ragunatisi insieme hanno unitamente diliberato di dovere celebrare le sue essequie in quel modo che saperanno e potranno il migliore. Londe, sappiendo essi che Sua Eccellenzia illustrissima era tanto osservata da Michelagnolo, quanto ella amava lui, la suplicano che le piaccia per l'infinita bontà e liberalità sua concedere loro: prima, che essi possano celebrare dette essequie nella chiesa di San Lorenzo, edificata da' suoi maggiori, e nella quale sono tante e sì bell'opere da lui fatte, così nell'architettura, come nella scultura, e vicino alla quale ha in animo di volere che s'edifichi la stanza che sia quasi un nido et un continuo studio dell'architettura, scultura e pittura a detta Accademia e Compagnia del Disegno; secondamente la pregano che voglia far commettere a Messer Benedetto Varchi che non solo voglia fare l'orazione funerale, ma ancora recitarla di propria bocca, come ha promesso di voler fare liberissimamente, pregato da noi, ogni volta che Vostra Eccellenzia illustrissima se ne contenti. Nel terzo luogo supplicano e pregano quella, che le piaccia, per la medesima bontà e liberalità sua, sovenirgli di tutto quello che in celebrare dette essequie, oltra la loro possibilità, la quale è piccolissima, facesse loro di bisogno. E tutte queste cose e ciascuna d'esse si sono trattate e diliberate alla presenza e con consentimento del molto magnifico e reverendo monsignore Messer Vincenzio Borghini, priore degl'Innocenti, luogotenente di Sua Eccellenzia illustrissima di detta Accademia e Compagnia del Disegno. La quale, etc.
Alla quale lettera dell'Accademia fece il Duca questa risposta:
Carissimi nostri, siamo molto contenti di sodisfare pienamente alle vostre petizioni, tanta è stata sempre l'affezione che noi portiamo alla rara virtù di Michelagnolo Buonarruoti e portiamo ora a tutta la professione vostra; però non lasciate di essequire quanto voi avete in proponimento di fare per l'essequie di lui, ché noi non mancheremo di sovenire a' bisogni vostri; et intanto si è scritto a Messer Benedetto Varchi per l'orazione et allo spedalingo quello di più che ci soviene in questo proposito, e state sani. Di Pisa.
La lettera al Varchi fu questa:
Messer Benedetto nostro carissimo. L'affezione che noi portiamo alla rara virtù di Michelagnolo Buonarruoti, ci fa desiderare che la memoria di lui sia onorata e celebrata in tutti modi; però ci sarà cosa grata che per amore nostro vi pigliate cura di fare l'orazione, che si arà da ricitare nel-l'essequie di lui, secondo l'ordine preso dalli deputati dell'Accademia, e gratissima se sarà recitata per l'organo vostro. E state sano.
Scrisse anco Messer Bernardino Grazini ai detti deputati che nel Duca non si sarebbe potuto disiderare più ardente disiderio intorno a ciò di quello che avea mostrato, e che si promettessino ogni aiuto e favore da sua eccellenzia illustrissima.
Mentre che queste cose si trattavano a Firenze, Lionardo Buonarruoti nipote di Michelagnolo, il quale intesa la malatia del zio si era per le poste trasferito a Roma, ma non l'aveva trovato vivo, avendo inteso da Daniello da Volterra, stato molto familiare amico di Michelagnolo, e da altri ancora che erano stati intorno a quel santo vecchio, che egli aveva chiesto e pregato che il suo corpo fusse portato a Fiorenza, sua nobilissima patria, della quale fu sempre tenerissimo amatore, aveva con prestezza, e perciò buona resoluzione, cautamente cavato il corpo di Roma, e come fusse al-cuna mercanzia inviatolo verso Firenze in una balla. Ma non è qui da tacere che quest'ultima risoluzione di Michelagnolo dichiarò, contra l'openione d'alcuni, quello che era verissimo: cioè che l'essere stato molti anni assente da Firenze, non era per altro stato che per la qualità dell'aria, perciò che la sperienza gli aveva fatto conoscere che quella di Firenze, per essere acuta e sottile, era alla sua complessione nimicissima, e che quella di Roma più dolce e temperata l'a-veva mantenuto sanissimo fino al novantesimo anno, con tutti i sensi così vivaci et interi come fussero stati mai, e con sì fatte forze, secondo quell'età, che insino all'ultimo giorno non aveva lasciato d'operare alcuna cosa. Poi che dunque per così sùbita e quasi improvisa venuta non si poteva far per allora quello che fecero poi, arrivato il corpo di Michelagnolo in Firenze fu messa, come vollono i deputati, la cassa il dì medesimo ch'ella arrivò in Fiorenza, cioè il dì undici di marzo, che fu in sabato, nella Compagnia dell'Assunta, che è sotto l'altar maggiore e sotto le scale di dietro di San Piero Maggiore, senza che fusse tocca di cosa alcuna. Il dì seguente, che fu la domenica della seconda settimana di Quaresima, tutti i pittori, scultori et architetti si ragunarono così dissimulatamente intorno a San Piero, dove non avevano condotto altro che una coperta di velluto, fornita tutta e trapuntata d'oro, che copriva la cassa e tutto il feretro, sopra la quale cassa era una imagine di Crucifisso. Intorno poi a mezza ora di notte, ristretti tutti intorno al corpo, in un subito i più vecchi et eccellenti artefici diedero di mano a una gran quantità di torchi che li erano stati condotti, et i giovani a pigliare il feretro con tanta prontezza, che beato colui che vi si poteva accostare e sotto mettervi le spalle, quasi credendo d'avere nel tempo avenire a poter gloriarsi d'aver portato l'ossa del maggior uomo che mai fusse nell'arti loro. L'esse-re stato veduto intorno a San Piero un certo che di ragunata, aveva fatto, come in simili casi adiviene, fermarvi molte persone, e tanto più essendosi bucinato che il corpo di Michelagnolo era venuto e che si aveva a portare in Santa Croce. E se bene, come ho detto, si fece ogni opera che la cosa non si sapesse, acciò che spargendosi la fama per la città non vi concorresse tanta moltitudine che si potesse fuggire un certo che di tumulto e confusione, et ancora perché desideravano che quel poco che volevan fare per allora venisse fatto con più quiete che pompa, riserbando il resto a più agio e più comodo tempo, l'una e l'altra andò per lo contrario; perciò che quanto alla moltitudine, andando, come s'è detto, la nuova di voce in voce, si empié in modo la chiesa in un batter d'occhio, che in ultimo con grandissima difficultà si condusse quel corpo di chiesa in sagrestia, per sballarlo e metterlo nel suo deposito. E quanto all'essere cosa onorevole, se be-ne non può negarsi che il vedere nelle pompe funerali grande apparecchio di religiosi, gran quantità di cera e gran numero d'imbastiti e vestiti a nero, non sia cosa di magnifica e grande apparenza, non è però che anco non fusse gran cosa vedere così all'improvviso ristretti in un drappello quelli uomini eccellenti che oggi sono in tanto pregio e saranno molto più per l'avvenire, intorno a quel corpo con tanti amorevoli uffizii et affezzione. E di vero il numero di cotanti artefici in Firenze (che tutti vi erano) è grandissimo sempre stato; conciò sia che queste arti sono sempre, per sì fatto modo fiorite in Firenze, che io credo che si possa dire senza ingiurie dell'altre città, che il proprio e principal nido e domicilio di quelle sia Fiorenza, non altrimenti che già fusse delle scienze Atene. Oltre al quale numero d'artefici, erano tanti cittadini loro dietro e tanti dalle bande delle strade dove si passava, che più non ne capivano. E, che è maggior cosa, non si sentiva altro che celebrare da ognuno i meriti di Michelagnolo, e dire la vera virtù avere tanta forza, che poi che è mancata ogni speranza d'utile o onore che si possa da un virtuoso avere, ell'è nondimeno di sua natura e per proprio me-rito amata et onorata. Per le quali cose apparì questa dimostrazione più viva e più preziosa, che ogni pompa d'oro e di drappi che fare si fusse potuta. Con questa bella frequenza, essendo stato quel corpo condotto in Santa Croce, poi che ebbono i frati fornite le cerimonie che si costumano d'intorno ai defunti, fu portato, non senza grandissima difficultà, come s'è detto, per lo concorso de' popoli, in sagrestia; dove il detto luogotenente, che per l'uffizio suo vi era intervenuto, pensando di far cosa grata a molti et anco (come poi confessò) disiderando di vedere morto quello che e' non aveva veduto vivo o l'aveva veduto in età che n'aveva perduta ogni memoria, si risolvé allora di fare aprire la cassa. E così fatto, dove egli e tutti noi presenti credevamo trovare quel corpo già putrefatto e guasto, perché era stato morto giorni venticinque e ventidue nella cassa, lo vedemo così in tutte le sue parti intero e senza alcuno odore cattivo, che stemo per credere che più tosto si riposasse in un dolce e quietissimo sonno. Et oltre che le fattezze del viso erano come a punto quando era vivo (fuori che un poco il colore era come di morto) non aveva niun membro che guasto fusse o mostrasse alcuna schifezza, e la testa e le gote a toccarle erano non altrimenti che se di poche ore innanzi fusse passato.
Passata poi la furia del popolo, si diede ordine di metterlo in un deposito in chiesa a canto all'altare de' Cavalcanti, per me' la porta che va nel chiostro del capitolo. In quel mezzo sparsasi la voce per la città, vi concorse tanta moltitudine di giovani per vederlo, che fu gran fatica il potere chiudere il deposito. E se era di giorno, come fu di notte, sarebbe stato forza lasciarlo stare aperto molte ore, per sodisfare all'universale. La mattina seguente, mentre si cominciava dai pittori e scultori a dare ordine all'onoranza, cominciarono molti belli ingegni, di che è sempre Fiorenza abondantissima, ad appiccare sopra detto deposito versi latini e volgari, e così per buona pezza fu continuato, intanto che quelli componimenti, che allora furono stampati, furono piccola parte a rispetto de' molti che furono fatti.
Ora per venire all'essequie, le quali non si fecero il dì dopo San Giovanni, come si era pensato, ma furono insino al quattordicesimo giorno di luglio prolungate, i tre deputati (perché Benvenuto Cellini, essendosi da principio sentito alquanto indisposto, non era mai fra loro intervenuto), fatto che ebbero proveditore Zanobi Lastricati scultore, si risolverono a far cosa più tosto ingegnosa e degna dell'arti loro, che pomposa e di spesa. “E nel vero, avendosi a onorare” dissero que' deputati et il loro proveditore “un uomo come Michelagnolo, e da uomini della professione che egli ha fatto, e più tosto ricchi di virtù che d'amplissime facultà, si dee ciò fare non con pompa regia o soperchie vanità, ma con invenzioni et opere piene di spirito e di vaghezza, che escano dal sapere della prontezza delle nostre mani e de' nostri artefici, onorando l'arte con l'arte. Perciò che, se bene dall'eccellenza del signor Duca possiamo sperare ogni quantità di danari che fusse di bisogno, avendone già avuta quella quantità che abbiamo domandata, noi nondimeno avemo a tenere per fermo che da noi si aspetta più presto cosa ingegnosa e vaga per invenzione e per arte, che ricca per molta spesa o grandezza di superbo apparato.” Ma ciò nonostante, si vide finalmente che la magnificenza fu uguale all'opere che uscirono delle mani dei detti accademici, e che quella onoranza fu non meno veramente magnifica, che ingegnosa, e piena di capricciose e lodevoli invenzioni.
Fu dunque in ultimo dato questo ordine, che nella navata di mezzo di San Lorenzo, dirimpetto alle due porte de' fianchi, delle quali una va fuori e l'altra nel chiostro, fusse ritto, come si fece, il catafalco di forma quadro, alto braccia ventotto, con una Fama in cima, lungo undici e largo nove. In sul basamento dunque di esso catafalco, alto da terra braccia due, erano nella parte che guarda verso la porta principale della chiesa posti due bellissimi fiumi a giacere, figurati l'uno per Arno e l'altro per lo Tevere. Arno aveva un corno di dovizia pieno di fiori e frutti, significando perciò i frutti che dalla città di Firenze sono nati in queste professioni, i quali sono stati tanti e così fatti, che hanno ripieno il mondo, e particolarmente Roma, di straordinaria bellezza. Il che dimostrava ottimamente l'altro fiume, figurato come si è detto per lo Tevere; perciò che stendendo un braccio, si aveva piene le mani de' fiori e frutti avuti dal corno di dovizia dell'Arno, che gli giaceva a canto e dirimpetto. Veniva a dimostrare ancora, godendo de' frutti d'Arno, che Michelagnolo è vivuto gran parte degl'anni suoi a Roma, e vi ha fatto quelle maraviglie che fanno stupire il mondo. Arno aveva per segno il leone et il Tevere la lupa con i piccioli Romulo e Remo, et erano ambidue colossi di straordinaria grandezza e bellezza, e simili al marmo. L'uno, cioè il Tevere, fu di mano di Giovanni di Benedetto da Castello, allievo del Bandinello, e l'altro di Battista di Benedetto, allievo dell'Ammannato, ambi giovani eccellenti e di somma aspettazione.
Da questo piano si alzava una faccia di cinque braccia e mezzo con le sue cornici di sotto, e sopra, et in su' canti, lasciando nel mezzo lo spazio di quattro quadri. Nel primo de' quali, che veniva a essere nella faccia dove erano i due fiumi, era dipinto di chiaro scuro, sì come erano anche tutte l'altre pitture di questo apparato, il magnifico Lorenzo vecchio de' Medici, che riceveva nel suo giardino, del quale si è in altro luogo favellato, Michelagnolo fanciullo, avendo veduti certi saggi di lui che accennavano, in que' primi fiori, i frutti che poi largamente sono usciti della vivacità e grandezza del suo ingegno. Cotale istoria dunque si conteneva nel detto quadro, il quale fu dipinto da Mirabello e da Girolamo del Crucifissaio, così chiamati, i quali come amicissimi e compagni presono a fare quell'opera insieme, nella quale con vivezza e pronte attitudini si vedeva il detto magnifico Lorenzo, ritratto di naturale, ricevere graziosamente Michelagnolo fanciulletto e tutto reverente nel suo giardino, et essaminatolo, consegnarlo ad alcuni maestri che gl'inse-gnassero. Nella seconda storia, che veniva a essere, continuando il medesimo ordine, volta verso la porta del fianco che va fuori, era figurato papa Clemente, che contra l'openione del volgo, il quale pensava che Sua Santità avesse sdegno con Michelagnolo per conto delle cose dell'assedio di Firenze, non solo lo assicura e se gli mostra amorevole, ma lo mette in opera alla sagrestia nuova et alla libreria di San Lorenzo, ne' quali luoghi quanto divinamente operasse si è già detto. In questo quadro adunque era di mano di Federigo fiamingo, detto del Padoano, dipinto con molta destrezza e dolcissima maniera Michelagnolo che mostra al Papa la pianta della detta sagrestia, e dietro lui parte da alcuni Angioletti, e parte da altre figure, erano portati i modelli della libreria, della sagrestia e delle statue che vi sono oggi finite. Il che tutto era molto bene accomodato e lavorato con diligenza. Nel terzo quadro che posando come gl'altri detti sul primo piano, guardava l'altare maggiore, era un grande epitaffio latino composto dal dottissimo Messer Pier Vettori, il sentimento del quale era tale in lingua fiorentina: “L'Accademia de' pittori, scultori et architettori, col favore et aiuto del duca Cosimo de' Medici, loro capo e sommo protettore di queste arti, ammirando l'eccellente virtù di Michelagnolo Buonarruoti e riconoscendo in parte il beneficio ricevuto dalle divine opere sue, ha dedicato questa memoria, uscita dalle proprie mani e da tutta l'affezzione del cuore, all'eccellenza e virtù del maggior pittore, scultore et architettore che
sia mai stato”. Le parole latine furono queste: “Collegium pictorum, statuariorum, architectorum, auspicio opeque sibi prompta Cosmi ducis, autoris suorum commodorum, suspiciens singularem virtutem Michaëlis Angeli Bonarrotae intelligensque quanto sibi auxilio semper fuerint praeclara ipsius opera, studuit se gratum erga illum ostendere sommum omnium qui unquam fuerint p. s. a. ideoque monumentum hoc suis manibus extructum magno animi ardore ipsius memoriae dedicavit”.
Era questo epitaffio retto da due Angioletti, i quali con volto piangente e spegnendo ciascuno una face, quasi si lamentavano essere spenta tanta e così rara virtù. Nel quadro poi che veniva a essere volto verso la porta che va nel chiostro era quando per l'assedio di Firenze Michelagnolo fece la fortificazione del poggio a San Miniato, che fu tenuta inespugnabile e cosa maravigliosa: e questo fu di mano di Lorenzo Sciorini, allievo del Bronzino, giovane di bonissima speranza. Questa parte più bassa, e come dire la base di tutta la machina, aveva in ciascun canto un piedestallo che risaltava, e sopra ciascun piedestallo era una statua grande più che il naturale, che sotto n'aveva un'altra come soggetta e vinta, di simile grandezza, ma raccolta in diverse attitudini e stravaganti. La prima a man ritta, andando verso l'altare maggiore, era un giovane svelto, e nel sembiante tutto spirito e di bellissima vivacità figurato per l'Ingegno, con due aliette sopra le tempie, nella guisa che si dipigne alcuna volta Mercurio. E sotto a questo giovane fatto con incredibile diligenza, era con orecchi asinini una bellissima figura fatta per l'Ignoranza, mortal nimica dell'Ingegno. Le quali ambedue statue furono di mano di Vincenzio Danti perugino, del quale e dell'opere sue, che sono rare fra i moderni giovani scultori, si parlerà in un altro luogo più lungamente.
Sopra l'altro piedestallo, il quale essendo a man ritta verso l'altare maggiore guardava verso la sagrestia nuova, era una donna, fatta per la Pietà cristiana, la quale essendo d'ogni bontà e religione ripiena, non è altro che un aggregato di tutte quelle virtù che i nostri hanno chiamate teologiche e di quelle che furono dai gentili dette morali; onde meritamente, celebrandosi da' cristiani la virtù d'un cristiano ornata di santissimi costumi, fu dato conveniente et onorevole luogo a questa, che risguarda la legge di Dio e la salute dell'anime, essendo che tutti gl'altri ornamenti del corpo e dell'animo, dove questa manchi, sono da essere poco, anzi nulla stimati. Questa figura, la quale avea sotto sé prostrato e da sé calpestato il Vizio o vero l'Impietà, era di mano di Valerio Cioli, il quale è valente giovane di bellissimo spirito, e merita lode di molto giudizioso e diligente scultore. Dirimpetto a questa, dalla banda della sagrestia vecchia, era un'altra simile figura stata fatta giudiziosamente per la dea Minerva o vero l'Arte, perciò che si può dire con verità che dopo la bontà de' costumi e della vita, la quale dee tener sempre appresso i migliori il primo luogo, l'Arte poi sia stata quella che ha dato a quest'uomo non solo onore e facultà, ma anco tanta gloria che si può dire lui aver in vita goduto que' frutti che a pena dopo morte sogliono dalla fama trarne, mediante l'egregie opere loro, gl'uomini illustri e valorosi; e, quello che è più, aver intanto superata l'invidia, che senza alcuna contradizione, per consenso comune, ha il grado e nome della principale e maggiore eccellenza ottenuto; e per questa cagione aveva sotto i piedi questa figura, l'Invidia, la quale era una vecchia secca e distrutta, con occhi viperini et insomma con viso e fattezze che tutte spiravano tossico e veleno; et oltre ciò, era cinta di serpi et aveva una vipera in mano. Queste due statue erano di mano d'un giovinetto di pochissima età, chiamato Lazzaro Calamech da Carrara, il quale ancor fanciullo ha dato infino a oggi in alcune cose di pittura e scultura gran saggio di bello e vivacissimo ingegno. Di mano d'Andrea Calamech, zio del sopra detto et allievo dell'A-mannato, erano le due statue poste sopra il quarto piedestallo, che era dirimpetto all'organo e risguardava verso le porte principali della chiesa. La prima delle quali era figurata per lo Studio, perciò che quegli che poco e lentamente s'ado-prano non possono venir in pregio già mai, come venne Michelagnolo; conciò sia che dalla sua prima fanciullezza di quindici insino a novanta anni non restò mai, come di sopra si è veduto, di lavorare. Questa statua dello Studio, che ben si convenne a tant'uomo, il quale era un giovane fiero e gagliardo, il quale alla fine del braccio poco sopra la giuntura della mano aveva due aliette, significanti la velocità e spessezza dell'operare, si aveva sotto come prigione cacciata la Pigrizia o vero Ociosità, la quale era una donna lenta e stanca et in tutti i suoi atti grave e dormigliosa. Queste quattro figure disposte nella maniera che s'è detto, facevano un molto vago e magnifico componimento, e parevano tutte di marmo, perché sopra la terra fu dato un bianco che tornò bellissimo. In su questo piano, dove le dette figure posavano, nasceva un altro imbasamento pur quadro et alto braccia quattro in circa, ma di larghezza e lunghezza tanto minore di quel di sotto quanto era l'aggetto e scorniciamento dove posavano le dette figure, et aveva in ogni faccia un quadro di pittura di braccia sei e mezzo per lunghezza e tre d'altezza, e di sopra nasceva un piano nel medesimo modo che quel di sotto, ma minore; e sopra ogni canto sedeva in sul risalto d'un zoccolo una figura quanto di naturale o più; e queste era-no quattro donne, le quali per gli stromenti che avevano erano facilmente conosciute per la Pittura, Scultura, Architettura e Poesia; per le cagioni che di sopra nella narrazione della sua vita si sono vedute. Andandosi dunque dalla principale porta della chiesa verso l'altare maggiore, nel primo quadro del secondo ordine del catafalco, cioè sopra la storia nella quale Lorenzo de' Medici riceve, come si è detto, Michelagnolo nel suo giardino, era con bellissima maniera dipinto, per l'architettura, Michelagnolo innanzi a papa Pio Quarto col modello in mano della stupenda machina della cupola di San Piero di Roma. La quale storia, che fu molta lodata, era stata dipinta da Piero Francia pittore fiorentino, con bella maniera et invenzione. E la statua, o vero simulacro dell'Architettura, che era alla man manca di questa storia, era di mano di Giovanni di Benedetto da Castello, che con tanta sua lode fece anco, come si è detto, il Tevere, uno de' due fiumi che erano dalla parte dinanzi del catafalco. Nel secondo quadro, seguitando d'andare a man ritta verso la porta del fianco che va fuori, per la pittura si vedeva Michelagnolo dipignere quel tanto, ma non mai a bastanza lodato Giudizio, quello dico che è l'esempio degli scorci e di tutte l'altre difficultà dell'arte. Questo quadro, il quale lavorarono i giovani di Michele di Ridolfo con molta grazia e diligenza, aveva la sua imagine e statua della Pittura similmente a man manca, cioè in sul canto che guarda la sagrestia nuova, fatta da Batista del Cavaliere, giovane non meno eccellente nella scultura, che per bontà, modestia e costumi rarissimo. Nel terzo quadro, volto verso l'altare maggiore, cioè in quello che era sopra il già detto epitaffio, per la scultura si vedeva Michelagnolo ragionare con una donna, la quale per molti segni si conosceva essere la Scultura, e parea che si consigliasse con esso lei. Aveva Michelagnolo intorno alcune di quelle opere che eccellentissime ha fatto nella scultura, e la donna in una tavoletta queste parole di Boezio: “Simili sub imagine formans”: allato al qual quadro, che fu opera d'Andrea del Minga e da lui lavorato con bella invenzione e maniera, era in sulla man manca la statua di essa Scultura, stata molto ben fatta da Antonio di Gino Lorenzi scultore. Nella quarta di queste quattro storie, che era volta verso l'organo, si vedeva per la poesia Michelagnolo tutto intento a scrivere alcuna composizione, et intorno a lui, con bellissima grazia e con abiti divisati, secondo che dai poeti sono descritte, le nove Muse et innanzi a esse Appollo con la lira in mano e con la sua corona d'alloro in capo, e con un'altra corona in mano, la quale mostrava di volere porre in capo a Michelagnolo. Al vago e bello componimento di questa storia, stata dipinta con bellissima maniera e con attitudini e vivacità prontissime da Giovanmaria Butteri, era vicina e sulla man manca la statua della Poesia opera di Domenico Poggini, uomo non solo nella scultura e nel fare impronte di monete e medaglie bellissime, ma ancora nel fare di bronzo e nella poesia parimente molto esercitato.
Così fatto, dunque, era l'ornamento del catafalco, il quale, perché andava digradando ne' suoi piani tanto che vi si poteva andare attorno, era quasi a similitudine del mausoleo d'Augusto in Roma, e forse per essere quadro più si assomigliava al Settizonio di Severo, non a quello presso al Campidoglio, che comunemente così è chiamato per errore, ma al vero, che nelle Nuove Rome si vede stampato appresso l'Antoniane. Infin qui, dunque, aveva il detto catafalco tre gradi: dove giacevano i fiumi era il primo, il secondo dove le figure doppie posavano, et il terzo dove avevano il piede le scempie. Et in su questo piano ultimo nasceva una base o vero zoccolo alta un braccio, e molto minore per larghezza e lunghezza del detto ultimo piano; sopra i risalti della quale sedevano le dette figure scempie et intorno alla quale si leggevano queste parole: “Sic ars extollitur arte”. Sopra questa base poi posava una piramide, alta braccia nove, in due parti della quale, cioè in quella che guardava la porta principale et in quella che volgeva verso l'altare maggiore, giù da basso, era in due ovati la testa di Michelagnolo di rilievo ritratta dal naturale e stata molto ben fatta da Santi Buglioni. In testa della piramide era una palla a essa piramide proporzionata, come se in essa fussero state le ceneri di quegli che si onorava, e sopra la palla era, maggiore del naturale, un Fama, finta di marmo, in atto che pareva volasse et insieme facesse per tutto il mondo risonare le lodi et il pregio di tanto artefice, con una tromba la quale finiva in tre bocche. La quale Fama fu di mano di Zanobi Lastricati, il quale, oltre alle fatiche che ebbe come proveditore in tutta l'opera, non volle anco mancare di mostrare con suo molto onore la virtù della mano e dell'ingegno. In modo che dal piano di terra alla testa della Fama era, come si è detto, l'altezza di braccia ventotto.
Oltre al detto catafalco, essendo tutta la chiesa parata di rovesci e rasce nere, appiccate non come si suole alle colonne del mezzo, ma alle cappelle che sono intorno intorno, non era alcun vano, fra i pilastri che mettono in mezzo le dette cappelle e corrispondono alle colonne, che non avesse qualche ornamento di pittura et in quale, facendo bella e vaga et ingegnosa mostra, non porgesse in un medesimo tempo maraviglia e diletto grandissimo.
E per cominciarmi da un capo, nel vano della prima cappella, che è a canto all'altare maggiore andando verso la sagrestia vecchia, era un quadro alto braccia sei e lungo otto, nel quale con nuova e quasi poetica invenzione era Michelagnolo in mezzo, come giunto ne' campi Elisii, dove gl'erano da man destra assai maggiori che il naturale i più famosi e que' tanto celebrati pittori e scultori antichi, ciascuno de' quali si conosceva a qualche notabile segno: Praxitele al Sa-tiro che è nella vigna di papa Giulio Terzo, Apelle al ritratto d'Alessandro Magno, Zeusi a una tavoletta dove era figurata l'uva che ingannò gl'uccelli, e Parrasio con la finta coperta del quadro di pittura. E così come [questi] a questi, così gl'altri ad altri segni erano conosciuti. A man manca erano quegli che in questi nostri secoli da Cimabue in qua sono stati in queste arti illustri: onde vi si conosceva Giotto a una tavoletta in cui si vedeva il ritratto di Dante giovanetto, nella maniera che in Santa Croce si vede essere stato da esso Giotto dipinto; Masaccio al ritratto di naturale; Donatello similmente al suo ritratto et al suo Zuccone del campanile che gl'era a canto; e Filippo Brunelleschi al ritratto della sua cupola di Santa Maria del Fiore. Ritratti poi di naturale, senz'altri segni, vi erano fra' Filippo, Taddeo Gaddi, Paulo Uccello, fra' Giovan Agnolo, Iacopo Puntormo, Francesco Salviati et altri; i quali tutti con le medesime accoglienze che gl'antichi e pieni di amore e maraviglia gl'erano intorno, in quel modo stesso che ricevettero Virgilio gl'altri poeti nel suo ritorno, secondo la finzione del divino poeta Dante, dal quale essendosi presa l'invenzione, si tolse anco il verso che in un breve si leggeva sopra, et in una mano del fiume Arno, che a' piedi di Michelagnolo con attitudine e fattezze bellissime giaceva:
Tutti l'ammiran, tutti onor gli fanno.
Il qual quadro di mano di Alessandro Allori allievo del Bronzino, pittore eccellente e non indegno discepolo e creato di tanto maestro, fu da tutti coloro che il videro, sommamente lodato. Nel vano della cappella del Santissimo Sacramento, in testa della crocera era, in un quadro lungo braccia 5 e largo 4, intorno a Michelagnolo tutta la scuola dell'arti, puttini, fanciulli e giovani di ogni età insino a 24 anni, i quali, come a cosa sacra e divina, offerivano le primizie delle fatiche loro, cioè pitture, sculture e modelli a lui, che gli riceveva cortesemente e gl'ammaestrava nelle cose dell'arti, mentre eglino attentissimamente l'ascoltavano e guardavano con attitudini e volti veramente belli e graziatissimi. E per vero dire non poteva tutto il componimento di questo quadro essere in un certo modo meglio fatto, né in alcuna delle figure alcuna cosa più bella disiderarsi; onde Batista allievo del Puntormo, che l'avea fatto, fu infinitamente lodato. Et i versi che si leggevano a' piè di detta storia dicevano così:
Tu pater, tu rerum inventor, tu patria nobis suppeditas praecepta, tuis ex, inclite, chartis.
Venendosi poi dal luogo dove era il detto quadro verso le porte principali della chiesa, quasi a canto e prima che si arrivasse all'organo, nel quadro che era nel vano d'una cappella, lungo 6 et alto 4 braccia, era dipinto un grandissimo e straordinario favore, che alla rara virtù di Michelagnolo fece papa Giulio Terzo. Il quale volendosi servire in certe fabbriche del giudizio di tant'uomo, l'ebbe a sé nella sua vigna, dove fattoselo sedere allato, ragionarono buona pezza insieme, mentre cardinali, vescovi et altri personaggi di corte che avevano intorno, stettono sempre in piedi. Questo fatto dico si vedeva con tanto buona composizione e con tanto rilievo essere stato dipinto e con tanta vivacità e prontezza di figure, che per aventura non sarebbe migliore uscito delle mani d'uno eccellente vecchio e molto esercitato maestro. Onde Iacopo Zucchi giovane et allievo di Giorgio Vasari, che lo fece con bella maniera, mostrò che di lui si poteva onoratissima riuscita sperare.
Non molto lontano a questo in sulla medesima mano, cioè poco di sotto all'organo, aveva Giovanni Strada fiamingo, valente pittore, in un quadro lungo 6 braccia et alto 4, dipinto quando Michelagnolo nel tempo dell'assedio di Firenze andò a Vinezia: dove standosi nell'appartato di quella nobilissima città che si chiama la Giudecca, Andrea Gritti doge e la Signoria mandarono alcuni gentiluomini et altri a visitarlo e fargli offerte grandissime; nella quale cosa esprimere mostrò il detto pittore, con suo molto onore, gran giudizio e molto sapere, così in tutto il componimento, come in ciascuna parte di esso, perché si vedevano nell'attitudini e vivacità de' volti e ne' movimenti di ciascuna figura invenzione, disegno e bonissima grazia.
Ora tornando all'altare maggiore e volgendo verso la sagrestia nuova, nel primo quadro che si truovava, il quale veniva a essere nel vano della prima cappella, era di mano di Santi Tidi, giovane di bellissimo giudizio e molto esercitato nella pittura in Firenze et in Roma, un altro segnalato favore stato fatto alla virtù di Michelagnolo, come credo aver detto di sopra, dall'illustrissimo signor don Francesco Medici, principe di Firenze, il quale trovandosi in Roma circa tre anni avanti che Michelagnolo morisse, et essendo da lui visitato, subito che entrò esso Buonarruoto si levò il principe in piede, et appresso per onorare un tant'uomo e quella veramente reverenda vecchiezza, colla maggior cortesia che mai facesse giovane principe volle (comeché Michelagnolo, il quale era modestissimo, recusasse) che sedesse nella sua propria sedia, onde s'era egli stesso levato, e stando poi in piedi udirlo con quella attenzione e reverenza che sogliono i figliuoli un ottimo padre. A' piè del principe era un putto, condotto con molta diligenza, il quale aveva un mazzocchio o vero berretta ducale in mano, e d'intorno a loro erano alcuni soldati vestiti all'antica, e fatti con molta prontezza e bella maniera. Ma sopra tutte l'altre erano benissimo fatti e molto vivi e pronti il Principe e Michelagnolo, in tanto che parea veramente che il vecchio proferisse le parole et il giovane attentissimamente l'ascoltasse. In un altro quadro alto braccia 9 e lungo 12, il quale era dirimpetto alla cappella del Sacramento, Bernardo Timante Buontalenti, pittore molto amato e favorito dall'illustrissimo Principe, aveva con bellissima invenzione figurati i fiumi delle tre principali parti del mondo, come venuti tutti mesti e dolenti a dolersi con Arno del comune danno e consolarlo. I detti fiumi erano il Nilo, il Gange et il Po. Aveva per contrasegno il Nilo un coccodrillo e per la fertilità del paese una ghirlanda di spighe; il Gange l'uc-cel grifone et una ghirlanda di gemme, et il Po un cigno et una corona d'ambre nere. Questi fiumi guidati in Toscana dalla Fama, la quale si vedeva in alto quasi volante, si stavano intorno a Arno, coronato di cipresso e tenente il vaso asciutto et elevato con una mano, e nell'altra un ramo d'arcipresso e sotto sé un lione. E per dimostrare l'anima di Michelagnolo essere andata in cielo alla somma felicità, aveva finto l'accorto pittore uno splendore in aria significante il celeste lume, al quale in forma d'Angioletto s'indirizzava la benedetta anima, con questo verso lirico:
Vivens orbe peto laudibus aethera.
Dagli lati sopra due basi erano due figure in atto di tenere aperta una cortina, dentro la quale pareva che fussero i detti fiumi, l'anima di Michelagnolo e la Fama; e ciascuna delle dette due figure n'aveva sotto un'altra. Quella che era a man ritta de' fiumi, figurata per Vulcano, aveva una face in mano, la figura che gli aveva il collo sotto i piedi figurata per l'Odio in atto disagioso e quasi fatigante per uscirgli di sotto, aveva per contrasegno un avoltoio con questo verso:
Surgere quid properas, Odium crudele? Iaceto.
E questo perché le cose sopr'umane e quasi divine non deono in alcun modo essere né odiate né invidiate. L'altra fatta per Aglaia, una delle tre Grazie e moglie di Vulcano, per significare la Proporzione, aveva in mano un giglio, sì perché i fiori sono dedicati alle Grazie, e sì ancora perché si dice il giglio non disconvenirsi ne' mortorii. La figura che sotto questa giaceva e la quale era finta per la Sproporzione, aveva per contrasegno una scimia o vero bertuccia, e sopra questo verso:
Vivus et extinctus docuit sic sternere turpe.
E sotto i fiumi erano questi altri due versi:
Venimus, Arne, tuo confixa en vulnere maesta
flumina, ut ereptum mundo ploremus honorem.
Questo quadro fu tenuto molto bello per l'invenzione, per la bellezza de' versi e per lo componimento di tutta la storia e vaghezza delle figure. E perché il pittore non come gl'altri per commessione con questa sua fatica onorò Michelagnolo, ma spontaneamente, e con quegli aiuti che gli fece la sua virtù da' suoi cortesi et onorati amici, meritò per ciò essere ancora maggiormente comendato.
In un altro quadro, lungo 6 braccia et alto 4, vicino alla porta del fianco, che va fuori, aveva Tommaso da San Fria-no, pittore giovane e di molto valore, dipinto Michelagnolo come ambasciadore della sua patria innanzi a papa Giulio Secondo, come si è detto che andò e per quali cagioni mandato dal Soderino. Non molto lontano dal sopra detto quadro, cioè poco sotto la detta porta del fianco che va fuori, in un altro quadro della medesima grandezza, Stefano Pieri, allievo del Bronzino e giovane molto diligente e studioso, aveva (sì come invero non molto avanti era avenuto più volte in Roma) dipinto Michelagnolo a sedere allato all'illustrissimo signor duca Cosimo in una camera, standosi a ragionare insieme, come di tutto si è detto di sopra a bastanza.
Sopra i detti panni neri di che era parata, come si è detto, tutta la chiesa intorno intorno, dove non erano storie o quadri di pittura, era in ciascuno de' vani delle cappelle imagini di morte, imprese et altre simili cose, tutte diverse da quelle che sogliono farsi, e belle e capricciose. Alcune quasi dolendosi d'avere avuto a privare per forza il mondo d'un così fatt'uomo avevano in un brieve queste parole: “Coëgit dura necessitas”. Et appresso un mondo, al quale era nato sopra un giglio che aveva tre fiori et era tronco nel mezzo con bellissima fantasia et invenzione di Alessandro Allori sopra detto. Altre Morti poi erano fatte con altra invenzione, ma quella fu molto lodata, alla quale, essendo prostrata in terra, l'Eternità con una palma in mano, aveva un de' piedi posto in sul collo e, guardandola con atto sdegnoso, parea che le dicesse la sua necessità o volontà che sia non avere fatto nulla, però che mal suo grado viverà Michelagnolo in ogni modo. Il motto diceva così: “Vicit inclita virtus”, e questa fu invenzione del Vasari. Né tacerò che ciascuna di queste Morti era tramezzata dall'impresa di Michelagnolo, che erano tre corone o vero tre cerchi intrecciati insieme, in guisa che la circonferenza dell'uno passava per lo centro degl'altri due scambievolmente. Il quale segno usò Michelagnolo,
o perché intendesse che le tre professioni di scultura, pittura et architettura fussero intrecciate et in modo legate insieme, che l'una dà e riceve dall'altra comodo et ornamento e ch'elle non si possono né deono spiccar d'insieme, o pure che come uomo d'alto ingegno ci avesse dentro più sottile intendimento. Ma gl'accademici, considerando lui in tutte e tre queste professioni essere stato perfetto, e che l'una ha aiutato et abbellito l'altra, gli mutarono i tre cerchi in tre corone intrecciate insieme, col motto: “Tergeminis tollit honoribus”, volendo perciò dire che meritamente in dette tre professioni se gli deve la corona di somma perfezzione.
Nel pergamo dove il Varchi fece l'orazione funerale, che poi fu stampata, non era ornamento alcuno, perciò che essendo di bronzo e di storie di mezzo e basso rilievo dall'eccellente Donatello stato lavorato, sarebbe stato ogni ornamento, che se gli fusse sopra posto, di gran lunga men bello. Ma era bene in su quell'altro, che gli è dirimpetto e che non era ancor messo in su le colonne, un quadro alto quattro braccia e largo poco più di due, dove con bella invenzione bonissimo disegno era dipinto per la Fama o vero Onore un giovane con bellissima attitudine con una tromba nella man destra e con i piedi addosso al Tempo et alla Morte, per mostrare che la fama e l'onore, mal grado della morte e del tempo, serbano vivi in eterno coloro che virtuosamente in questa vita hanno operato. Il qual quadro fu di mano di Vincenzio Danti perugino scultore, del quale si è parlato e si parlerà altra volta. In cotal modo essendo apparata la chiesa, adorna di lumi e piena di populo inumerabile, per essere ognuno, lasciata ogni altra cura, concorso a così onorato spettacolo, entrarono dietro al detto luogotenente dell'Accademia, accompagnati dal capitano et alabardieri della guardia del Duca, i consoli e gl'accademici et insomma tutti i pittori, scultori et architetti di Firenze. I quali poi che furono a sedere, dove fra il catafalco e l'altare maggiore erano stati buona pezza aspettati da un numero infinito di signori e gentiluomini, che secondo i meriti di ciascuno erano stati a sedere accomodati, si diede principio a una solennissima messa de' morti con musiche e cerimonie d'ogni sorte. La quale finita, salì sopra il pergamo già detto il Varchi, che poi non aveva fatto mai cotale ufficio che egli lo fece per la illustrissima signora duchessa di Ferrara, figliuola del duca Cosimo, e quivi con quella eleganza, con que' modi e con quella voce che proprii e particolari furono, in orando, di tanto uomo, raccontò le lodi, i meriti, la vita e l'opere del divino Michelagnolo Buonarruoti. E nel vero che grandissima fortuna fu quella di Michelagnolo non morire prima che fusse creata la nostra Accademia, da che con tanto onore e con sì magnifica et onorata pompa fu celebrato il suo mortorio. Così a sua gran ventura si dee reputare che avenisse che egli inanzi al Varchi passasse di questa ad eterna e felicissima vita, poi che non poteva da più eloquente e dotto uomo essere lodato. La quale orazione funerale di Messer Benedetto Varchi fu poco appresso stampata, sì come fu anco non molto dopo un'altra similmente bellissima orazione, pure delle lodi di Michelagnolo e della pittura, stata fatta dal nobilissimo e dottissimo Messer Lionardo Salviati, giovane allora di circa ventidue anni, e così raro e felice ingegno in tutte le maniere di componimenti latini e toscani, quanto sa insino a ora e meglio saprà per l'avenire tutto il mondo. Ma che dirò o che posso dire che non sia poco della virtù, bontà e prudenza del molto reverendo signor luogotenente, don Vincenzio Borghini sopra detto, se non che lui capo, lui guida e lui consigliere, celebrarono quell'essequie i virtuosissimi uomini del-l'Accademia e Compagnia del Disegno? Perciò che se bene era bastante ciascuno di loro a fare molto maggior cosa di quello che fecero nell'arti loro, non si conduce nondimeno mai alcuna impresa a perfetto e lodato fine, se non quando un solo a guisa d'esperto nocchiero e capitano ha il governo di tutti e sopra gl'altri maggioranza. E perché non fu possibile che tutta la città in un sol giorno vedesse il detto apparato, come volle il signor Duca fu lasciato stare molte settimane in piedi a sodisfazione de' suoi popoli e de' forestieri, che da' luoghi convicini lo vennero a vedere.
Non porremo in questo luogo una moltitudine grande di epitaffi e di versi latini e toscani fatti da molti valenti uomini in onore di Michelagnolo, sì perché un'opera da se stessi vorrebbono, e perché altrove da altri scrittori sono stati scritti e mandati fuora. Ma non lascerò già di dire in questa ultima parte che, dopo tutti gli onori sopra detti, il Duca ordinò che a Michelagnolo fusse dato un luogo onorato in Santa Croce per la sua sepoltura, nella quale chiesa egli in vita aveva destinato d'esser sepolto per esser quivi la sepoltura de' suoi antichi. Et a Lionardo nipote di Michelagnolo donò sua eccellenza tutti i marmi e mischi per detta sepoltura, la quale col disegno di Giorgio Vasari fu allogata a Batista Lorenzi valente scultore, insieme con la testa di Michelagnolo. E perché vi hanno a essere tre statue, la Pittura, la Scultura e l'Architettura, una di queste fu allogata a Batista sopra detto, una a Giovanni dell'Opera, l'ultima a Valerio Cioli scultori fiorentini, le quali con la sepoltura tuttavia si lavorano, e presto si vedranno finite e poste nel luogo loro. La spesa dopo i marmi ricevuti dal Duca è fatta da Lionardo Buonarruoti sopra detto, ma sua eccellenza, per non mancare in parte alcuna agli onori di tanto uomo, farà porre, sì come egli ha già pensato di fare, la memoria e 'l nome suo insieme con la testa nel duomo, sì come degli altri fiorentini eccellenti vi si veggono i nomi e l'imagini loro.
IL FINE DELLA VITA DI MICHELAGNOLO BUONARRUOTI PITTORE, SCULTORE ET ARCHITETTO FIORENTINO
DESCRIZIONE DELL'OPERE DI FRANCESCO PRIMATICCIO BOLOGNESE ABATE DI S. MARTINO PITTORE ET ARCHITETTO

Avendo in fin qui trattato de' nostri artefici, che non sono più vivi fra noi, cioè di quelli che sono stati dal milledugento insino a questo anno 1567 e posto nell'ultimo luogo Michelagnolo Buonarruoti per molti rispetti, se bene due o tre sono mancati dopo lui, ho pensato che non possa essere se non opera lodevole far parimente menzione in questa nostra opera di molti nobili artefici che sono vivi, e per i loro meriti degnissimi di molta lode, e di essere in fra questi ultimi annoverati. Il che fo tanto più volentieri quanto tutti mi sono amicissimi e fratelli, e già i tre principali tant'oltre con gl'anni, che essendo all'ultima vecchiezza pervenuti, si può poco altro da loro sperare, come che si vadano, per una certa usanza, in alcuna cosa ancora adoperando. Appresso ai quali farò anco brevemente menzione di coloro che sotto la loro disciplina sono tali divenuti, che hanno oggi fra gl'artefici i primi luoghi, e d'altri che similmente caminano alla perfezzione delle nostre arti.
Cominciandomi dunque da Francesco Primaticcio, per dir poi di Tiziano Vecello et Iacopo Sansovini, dico che detto Francesco, essendo nato in Bologna della nobile famiglia de' Primaticci, molto celebrata da fra' Leandro Alberti e dal Pontano, fu indirizzato nella prima fanciullezza alla mercatura, ma piacendogli poco quell'esercizio, indi a non molto, come di animo e spirito elevato, si diede ad esercitare il disegno, al quale si vedeva essere da natura inclinato. E così attendendo a disegnare, e talora a dipignere, non passò molto, che diede saggio d'avere a riuscire eccellente. Andando poi a Mantoa, dove allora lavorava Giulio Romano il palazzo del T al duca Federigo, ebbe tanto mezzo, ch'e' fu messo in compagnia di molti altri giovani che stavano con Giulio a lavorare in quell'opera. Dove, attendendo lo spazio di sei anni con molta fatica e diligenza agli studii dell'arte, imparò a benissimo maneggiare i colori e lavorare di stucco; onde fra tutti gl'altri giovani, che nell'opera detta di quel palazzo s'affaticarono, fu tenuto Francesco de' migliori e quelli che meglio disegnasse e colorisse di tutti, come si può vedere in un camerone grande, nel quale fece intorno due fregiature di stucco una sopra l'altra, con una grande abondanza di figure, che rappresentano la milizia antica de' Romani. Parimente nel medesimo palazzo condusse molte cose che vi si veggiono di pittura, con i disegni di Giulio sopra detto, per le quali cose venne il Primaticcio in tanta grazia di quel Duca, che avendo il re Francesco di Francia inteso con quanti ornamenti avesse fatto condurre l'opera di quel palazzo, e scrittogli che per ogni modo gli mandasse un giovane il quale sapesse lavorare di pitture e di stucco, gli mandò esso Francesco Primaticcio l'anno 1531. Et ancor che fusse andato l'anno innanzi al servigio del medesimo Re il Rosso pittore fiorentino, come si è detto, e vi avesse lavorato molte cose e particolarmente quadri del Bacco e Venere, di Psiche e Cupido, nondimeno i primi stucchi che si facessero in Francia et i primi lavori a fresco di qualche conto ebbero, si dice, principio dal Primaticcio, che lavorò di questa maniera molte camere, sale e logge al detto re; al quale piacendo la maniera et il procedere in tutte le cose di questo pittore, lo mandò l'anno 1540 a Roma a procacciare d'avere alcuni marmi antichi, nel che lo servì con tanta diligenza il Primaticcio, che fra teste, torsi e figure ne comperò in poco tempo centoventicinque pezzi. Et in quel medesimo tempo fece formare da Iacopo Barozzi da Vignuola et altri il cavallo di bronzo che è in Campidoglio; una gran parte delle storie della colonna; la statua del Commodo, la Venere, il Laoconte, il Tevere, il Nilo e la statua di Cleopatra, che sono in Belvedere, per gettarle tutte di bronzo.
Intanto essendo in Francia morto il Rosso, e per ciò rimasa imperfetta una lunga galleria, stata cominciata con suoi disegni et in gran parte ornata di stucchi e di pitture, fu richiamato da Roma il Primaticcio; per che imbarcatosi con i detti marmi e cavi di figure antiche, se ne tornò in Francia, dove innanzi ad ogni altra cosa gettò, secondo che erano in detti cavi e forme, una gran parte di quelle figure antiche; le quali vennono tanto bene, che paiano le stesse antiche, come si può vedere là dove furono poste nel giardino della Reina a Fontanableò, con grandissima sodisfazione di quel Re, che fece in detto luogo quasi una nuova Roma. Ma non tacerò che ebbe il Primaticcio, in far le dette statue, maestri tanto eccellenti nelle cose del getto, che quell'opere vennero, non pure sottili, ma con una pelle così gentile, che non bisognò quasi rinettarle. Ciò fatto, fu commesso al Primaticcio che desse fine alla galleria che il Rosso aveva lasciata imperfetta, onde messovi mano, la diede in poco tempo finita con tanti stucchi e pitture, quante in altro luogo siano sta-te fatte già mai; per che trovandosi il Re ben servito nello spazio di otto anni, che aveva per lui lavorato costui, lo fece mettere nel numero de' suoi camerieri e poco appresso, che fu l'anno 1544, lo fece, parendogli che Francesco il meritasse, abate di San Martino. Ma con tutto ciò non ha mai restato Francesco di fare lavorare molte cose di stucco e di pitture in servigio del suo Re e degl'altri, che dopo Francesco Primo hanno governato quel regno. E fra gl'altri che in ciò l'hanno aiutato, l'ha servito, oltre molti de' suoi bolognesi, Giovambatista figliuolo di Bartolomeo Bagnacavallo, il qua-le non è stato manco valente del padre in molti lavori e storie, che ha messo in opera del Primaticcio. Parimente l'ha servito assai tempo un Ruggieri da Bologna, che ancora sta con esso lui; similmente Prospero Fontana, pittore bolognese, fu chiamato in Francia non ha molto dal Primaticcio, che disegnava servirsene; ma essendovi subito che fu giunto amalato con pericolo della vita, se ne tornò a Bologna. E per vero dire questi due, cioè il Bagnacavallo et il Fontana, sono valent'uomini, et io che dell'uno e dell'altro mi sono assai servito - cioè del primo a Roma e del secondo a Rimini et a Fiorenza - lo posso con verità affermare.
Ma fra tutti coloro che hanno aiutato l'abate Primaticcio, niuno gli ha fatto più onore di Niccolò da Modena, di cui si è altra volta ragionato, perciò che costui con l'eccellenza della sua virtù ha tutti gl'altri superato, avendo condotto di sua mano, con i disegni dell'abate, una sala, detta del ballo, con tanto gran numero di figure, che appena pare che si possano numerare, e tutte grandi quanto il vivo e colorite d'una maniera chiara, che paiano con l'unione de' colori a fresco, lavorate a olio. Dopo quest'opera ha dipinto nella gran galleria, pur con i disegni dell'abate, sessanta storie della vita e fatti d'Ulisse, ma di colorito molto più scuro che non son quelle della sala del ballo. E ciò è avvenuto però che non ha usato altro colore, che le terre in quel modo schiette ch'elle sono prodotte dalla natura, senza mescolarvi si può dire bianco, ma cacciate ne' fondi tanto terribilmente di scuro, che hanno una forza e rilievo grandissimo. Et oltre ciò l'ha condotte con una sì fatta unione per tutto, che paiono quasi fatte tutte in un medesimo giorno, onde merita lode straordinaria e massimamente avendole condotte a fresco senza averle mai ritocche a secco, come oggi molti costumano di fare. La volta similmente di questa galleria è tutta lavorata di stucchi e di pitture, fatte con molta diligenza dai sopra detti et altri pittori giovani, ma però con i disegni dell'abate, sì come è anco la sala vecchia et una bassa galleria, che è sopra lo stagno, la quale è bellissima e meglio e di più bell'opere ornata, che tutto il rimanente di quel luogo, del qual troppo lunga cosa sarebbe voler pienamente ragionare.
A Medone ha fatto il medesimo abate Primaticcio infiniti ornamenti al cardinale di Lorena in un suo grandissimo palazzo chiamato la Grotta, ma tanto straordinario di grandezza, che a somiglianti degl'antichi, così fatti edificii potrebbe chiamarsi le terme, per la infinità e grandezza delle logge, scale e camere publiche e private che vi sono. E per tacere l'altre particolarità, è bellissima una stanza chiamata il padiglione, per essere tutta adorna con partimenti di cornici, che hanno la veduta di sotto in su, piena di molte figure, che scortano nel medesimo modo e sono bellissime. Di sotto è poi una stanza grande con alcune fontane lavorate di stucchi e piene di figure tutte tonde e di spartimenti di conchiglie e altre cose marittime e naturali, che sono cosa maravigliosa e bella oltremodo, e la volta è similmente tutta lavorata di stucchi ottimamente per man di Domenico del Barbieri pittore fiorentino, che è non pure eccellente in questa sorte di rilievi, ma ancora nel disegno, onde in alcune cose che ha colorite ha dato saggio di rarissimo ingegno. Nel medesimo luogo ha lavorato ancora molte figure di stucco pur tonde uno scultore similmente de' nostri paesi, chiamato Ponzio, che si è portato benissimo. Ma perché infinite e varie sono l'opere che in questi luoghi sono state fatte in servigio di que' signori, vo toccando solamente le cose principali dell'abate, per mostrare quanto è raro nella pittura, nel disegno e nelle cose d'architettura, e nel vero non mi parrebbe fatica allargarmi intorno alle cose particolari, se io n'avessi vera e distinta notizia, come ho delle cose di qua. Ma quanto al disegno il Primaticcio è stato et è eccellentissimo, come si può vedere in una carta di sua mano dipinta delle cose del cielo, la quale è nel nostro libro e fu da lui stesso mandata a me, che la tengo, per amor suo e perché è di tutta perfezzione, carissima.
Morto il re Francesco, restò l'abate nel medesimo luogo e grado appresso al re Enrico, e lo servì mentre che visse, e dopo fu dal re Francesco Secondo fatto commessario generale sopra le fabriche di tutto il regno; nel quale uffizio, che è onoratissimo e di molta riputazione, si esercitò già il padre del cardinale della Bordagiera e monsignor di Villaroy. Morto Francesco II, continuando nel medesimo uffizio serve il presente Re, di ordine del quale e della Reina madre ha dato principio il Primaticcio alla sepoltura del detto re Enrico, facendo nel mezzo d'una cappella a sei facce la sepoltura di esso Re et in quattro facce la sepoltura di quattro figliuoli. In una dell'altre due facce della cappella è l'altare e nell'al-tra la porta. E perché vanno in queste opere moltissime statue di marmo e bronzi e storie assai di basso rilievo, ella riuscirà opera degna di tanto e sì gran Re, e dell'eccellenza et ingegno di sì raro artefice, come è questo abate di S. Martino, il quale è stato ne' suoi migliori anni in tutte le cose che appartengono alle nostre arti eccellentissimo et universale, poiché si è adoperato in servigio de' suoi signori non solo nelle fabriche, pitture e stucchi, ma ancora in molti apparati di feste e mascherate con bellissime e capricciose invenzioni; è stato liberalissimo e molto amorevole verso gl'amici e parenti, e parimente verso gl'artefici che l'hanno servito. In Bologna ha fatto molti benefizii ai parenti suoi e comperato loro casamenti onorati, e quelli fatti comodi e molto ornati, sì come è quella dove abita oggi Messer Antonio Anselmi, che ha per donna una delle nipoti di esso abate Primaticcio, il quale ha anco maritata un'altra sua nipote, sorella di que-sta, con buona dote et onoratamente.
È vivuto sempre il Primaticcio non da pittore et artefice, ma da signore, e come ho detto è stato molto amorevole ai nostri artefici. Quando mandò a chiamare, come s'è detto, Prospero Fontana, gli mandò, perché potesse condursi in Francia, una buona somma di danari, la quale, essendosi infermato, non poté Prospero con sue opere e lavori scontare né rendere, per che passando io l'anno 1563 per Bologna, gli raccomandai, per questo conto, Prospero, e fu tanta la cortesia del Primaticcio, che avanti io partissi di Bologna vidi uno scritto dell'abate, nel quale donava liberamente a Prospero tutta quella somma di danari, che per ciò avesse in mano; per le quali cose è tanta la benevolenza ch'egli si ha acquistata appresso gl'artefici, che lo chiamano et onorano come padre. E per dire ancora alcun'altra cosa di esso Prospero, non tacerò che fu già con sua molte lode adoperato in Roma da papa Giulio Terzo in palazzo, alla vigna Giulia et al palazzo di Campo Marzio, che allora era del signor Balduino Monti et oggi è del signor Ernando cardinale de' Medici e figliuolo del duca Cosimo. In Bologna ha fatto il medesimo molte opere a olio et a fresco, e particolarmente nella Madonna del Baracane, in una tavola a olio, una Santa Caterina, che alla presenza del tiranno disputa con filosofi e dottori, che è tenuta molto bell'opera; et ha dipinto il medesimo nel palazzo, dove sta il governatore, nella cappella principale molte pitture a fresco. È anco molto amico del Primaticcio Lorenzo Sabatini pittore eccellente, e se non fusse stato ca-rico di moglie e molti figliuoli, l'arebbe l'abate condotto in Francia, conoscendo che ha bonissima maniera e gran pratica in tutte le cose, come si vede in molte opere che ha fatto in Bologna; e l'anno 1566 se ne servì il Vasari nell'apparato che si fece in Fiorenza per le dette nozze del principe e della serenissima reina Giovanna d'Austria, facendogli fare nel ricetto, che è fra la sala dei dugento e la grande, sei figure a fresco, che sono molto belle e degne veramente di essere lodate. Ma perché questo valente pittore va tuttavia acquistando, non dirò di lui altro, se non che se ne spera, attendendo come fa agli studii dell'arte, onoratissima riuscita.
Ora con l'occasione dell'abate e degl'altri bolognesi, de' quali si è in fin qui fatto menzione, dirò alcuna cosa di Pellegrino bolognese, pittore di somma aspettazione e di bellissimo ingegno. Costui dopo avere ne' suoi primi anni atteso a disegnare l'opere del Vasari, che sono a Bologna nel refettorio di San Michele in Bosco, e quelle d'altri pittori di buon nome, andò a Roma l'anno 1547, dove attese insino all'anno 1550 a disegnare le cose più notabili, lavorando in quel mentre e poi in Castel Sant'Agnolo alcune cose d'intorno all'opere che fece Perino del Vaga. Nella chiesa di San Luigi de' Franzesi fece nella cappella di San Dionigi in mezzo d'una volta una storia a fresco d'una battaglia, nella quale si portò di maniera, che ancor che Iacopo del Conte pittore fiorentino e Girolamo Siciolante da Sermoneta avessero nella medesima cappella molte cose lavorato, non fu loro Pellegrino punto inferiore, anzi pare a molti che si portasse meglio di loro nella fierezza, grazia, colorito e disegno di quelle sue pitture, le quali poi furono cagione che monsignor Poggio si servisse assai di Pellegrino; perciò che avendo in sul monte Esquilino, dove aveva una sua vigna, fabricato un palazzo fuor della porta del Popolo, volle che Pellegrino gli facesse alcune figure nella facciata, e che poi gli dipignesse dentro una loggia, che è volta verso il Tevere, la quale condusse con tanta diligenza, che è tenuta opera molto bella e graziosa. In casa di Francesco Formento, fra la strada del Pellegrino e Parione, fece in un cortile una facciata e due altre figure, e con ordine de' ministri di papa Giulio Terzo lavorò in Belvedere un'arme grande con due figure, e fuora della porta del Popolo alla chiesa di Santo Andrea, la quale avea fatto edificare quel Pontefice, fece un San Piero et un Santo Andrea, che furono due molto lodate figure; il disegno del quale San Piero è nel nostro libro con altre carte disegnate dal medesimo con molta diligenza.
Essendo poi mandato a Bologna da monsignor Poggio, gli dipinse a fresco in un suo palazzo molte storie, fra le quali n'è una bellissima, nella quale si vede, e per molti ignudi e vestiti, e per i leggiadri componimenti delle storie, che superò se stesso, di maniera che non ha anco fatto ma' poi altra opera di questa migliore. In San Iacopo della medesima città cominciò a dipignere pure al cardinale Poggio una cappella, che poi fu finita dal già detto Prospero Fontana. Essendo poi condotto Pellegrino dal cardinale d'Augusta alla Madonna di Loreto, gli fece di stucchi e di pitture una bellissima cappella: nella volta in un ricco partimento di stucchi è la Natività e presentazione di Cristo al tempio nelle braccia di Simeone, e nel mezzo è massimamente il Salvatore trasfigurato in sul monte Tabor, e con esso Moisè, Elia et i discepoli; e nella tavola che è sopra l'altare, dipinse San Giovanni Batista che battezza Cristo, et in questa ritrasse ginocchioni il detto Cardinale. Nelle facciate dagli lati dipinse in una S. Giovanni che predica alle turbe e nell'altra la decollazione del medesimo, e nel Paradiso sotto la chiesa dipinse storie del giudicio et alcune figure di chiaro scuro, dove oggi confessano i Teatini.
Essendo non molto dopo condotto da Giorgio Morato in Ancona, gli fece per la chiesa di Santo Agostino, in una gran tavola a olio, Cristo battezzato da S. Giovanni, e da un lato S. Paulo con altri Santi, e nella predella buon numero di figure piccole, che sono molto graziose. Al medesimo fece nella chiesa di S. Ciriaco sul monte un bellissimo adornamento di stucco alla tavola dell'altar maggiore e dentro un Cristo tutto tondo di rilievo di braccia cinque, che fu molto lodato; parimente ha fatto nella medesima città un ornamento di stucco grandissimo e bellissimo all'altare maggiore di
S. Domenico, et arebbe anco fatto la tavola, ma perché venne in diferenza col padrone di quell'opera, ella fu data a fare a Tiziano Vecello, come si dirà a suo luogo. Ultimamente avendo preso a fare Pellegrino nella medesima città d'Ancona la loggia de' mercanti, che è volta da una parte sopra la marina e dall'altra verso la principale strada della città, ha adornato la volta, che è fabbrica nuova, con molte figure grandi di stucco e pitture. Nella quale opera perché ha posto Pellegrino ogni sua maggior fatica e studio, ell'è riuscita in vero molto bella e graziosa, perciò che oltre che sono tutte le figure belle e ben fatte, vi sono alcuni scorti d'ignudi bellissimi, nei quali si vede che ha imitato l'opere del Buonarruoto, che sono nella cappella di Roma, con molta diligenza. E perché non sono in quelle parti architetti, né ingegni di conto e che più sappiano di lui, ha preso Pellegrino assunto di attendere all'architettura et alla fortificazione de' luoghi di quella provincia; e come quelli che ha conosciuto la pittura più dificile e forse manco utile che l'architettura, lasciato alquanto da un lato il dipignere, ha condotto per la fortificazione d'Ancona molte cose, e per molti altri luoghi dello stato della Chiesa, e massimamente a Ravenna.
Finalmente ha dato principio in Pavia per lo cardinale Bonromeo a un palazzo per la Sapienza, et oggi, perché non ha però del tutto abandonata la pittura, lavora in Ferrara nel refettorio di San Giorgio ai monaci di Monte Oliveto una storia a fresco che sarà molto bella, della quale mi ha esso Pellegrino mostrato non ha molto il disegno, che è bellissimo. Ma perché è giovane di trentacinque anni, e va tuttavia maggiormente acquistando e caminando alla perfezzione, questo di lui basti per ora.
Parimente sarò brieve in ragionare d'Orazio Fumaccini, pittore similmente bolognese, il quale ha fatto, come s'è detto, in Roma sopra una delle porte della sala de' re una storia, che è bonissima, et in Bologna molte lodate pitture; perché anch'esso è giovane e si porta in guisa, che non sarà inferiore ai suoi maggiori, de' quali avemo in queste nostre vite fatto menzione.
I Romagnuoli anch'essi, mossi dall'esempio de' Bolognesi loro vicini, hanno nelle nostre arti molte cose nobilmente operato, perciò che, oltre a Iacopone da Faenza, il quale, come s'è detto, dipinse in Ravenna a la tribuna di San Vitale, vi sono stati e sono molti altri dopo lui che sono eccellenti. Maestro Luca de' Longhi ravignano, uomo di natura buono, quieto e studioso, ha fatto nella sua patria Ravenna e per di fuori molte tavole a olio e ritratti di naturale bellissimi, e fra l'altre sono assai leggiadre due tavolette che gli fece fare non ha molto nella chiesa de' monaci Classi il reverendo don Antonio da Pisa, allora abate di quel monasterio, per non dir nulla d'un infinito numero d'altre opere che ha fatto questo pittore. E per vero dire se maestro Luca fusse uscito di Ravenna, dove si è stato sempre e sta con la sua famiglia, essendo assiduo e molto diligente e di bel giudizio, sarebbe riuscito rarissimo, perché ha fatto e fa le sue cose con pacienza e studio, et io ne posso far fede, che so quanto gli acquistasse quando dimorai due mesi in Ravenna, in praticando e ragionando delle cose dell'arte; né tacerò che una sua figliuola ancora piccola fanciulletta chiamata Barbera disegna molto bene, et ha cominciato a colorire alcuna cosa con assai buona grazia e maniera.
Fu concorrente un tempo di Luca, Livio Agresti da Furlì, il quale, fatto che ebbe per l'abate de' Grassi nella chiesa dello Spirito Santo alcune storie a fresco et alcun'altre opere, si partì di Ravenna et andossene a Roma, dove attendendo con molto studio al disegno, si fece buon pratico, come si può veder in alcune facciate et altri lavori a fresco, che fece in quel tempo; e le sue prime opere, che sono in Narni, hanno assai del buono. Nella chiesa di Santo Spirito di Roma ha dipinto a fresco in una cappella istorie e figure assai, che sono condotte con molto studio e fatica: onde sono da ognuno meritamente lodate. La quale opera fu cagione, come s'è detto, che gli fusse allogata una delle storie minori, che sono sopra le porte, nella sala de' re nel palazzo di Vaticano, nella quale si portò in modo bene, ch'ella può stare a paragone dell'altre.
Ha fatto il medesimo per lo cardinale d'Augusta sette pezzi di storie dipinte sopra tela d'argento, che sono stati tenuti bellissimi in Ispagna, dove sono stati dal detto Cardinale mandati a donare al re Filippo per paramento d'una stanza. Un'altra tela d'argento simile ha dipinto nella medesima maniera, la quale si vede oggi nella chiesa de' Chietini in Furlì; finalmente essendosi fatto buono e fiero disegnatore, pratico coloritore, copioso ne' componimenti delle storie e di maniera universale, è stato condotto con buona provisione dal sopra detto Cardinale in Augusta, dove va facendo continuamente opere degne di molta lode. Ma è rarissimo in alcune cose, fra gl'altri di Romagna, Marco da Faenza (che così, e non altrimenti è chiamato) per ciò che è pratico oltre modo nelle cose a fresco, fiero, risoluto e terribile, e massimamente nella pratica e maniera di far grottesche, non avendo in ciò oggi pari né chi alla sua perfezzione aggiunga. Delle costui opere si vede per tutta Roma; et in Fiorenza è di suo mano la maggior parte degl'ornamenti di venti diverse stanze che sono nel palazzo ducale, e le fregiature del palco della sala maggiore di detto palazzo, stato dipinto da Giorgio Vasari, come si dirà a suo luogo pienamente, senzaché gl'ornamenti del principale cortile di detto palazzo fatti per la venuta della reina Giovanna in poco tempo, furono in gran parte condotti dal medesimo. E questo basti di Marco, essendo ancor vivo et in sul più bello d'acquistare et operare.
In Parma è oggi appresso al signor duca Ottavio Farnese un pittore detto Miruolo, credo di nazione romagnuolo, il quale, oltre ad alcun'opere fatte in Roma, ha dipinto a fresco molte storie in un palazzetto, che ha fatto fare il detto signor Duca nel castello di Parma, dove sono alcune fontane state condotte con bella grazia da Giovanni Boscoli, scultore da Monte Pulciano; il quale avendo molti anni lavorato di stucchi appresso al Vasari nel palazzo del detto signor duca Cosimo di Fiorenza, si è finalmente condotto a' servizii del detto signor Duca di Parma con buona provisione, et ha fatto e va facendo continuamente opere degne del suo raro e bellissimo ingegno.
Sono parimente nelle medesime città e provincie molti altri eccellenti e nobili artefici, ma perché sono anco giovani, si serberà a più comodo tempo a fare di loro quella onorata menzione, che le loro opere e virtù averanno meritato. E questo è il fine dell'opere dell'abate Primaticcio.
Aggiugnerò che essendosi egli fatto ritrarre in disegno di penna da Bartolomeo Passerotto pittore bolognese suo amicissimo, il detto ritratto ci è venuto alle mani e l'avemo nel nostro libro dei disegni di mano di diversi pittori eccellenti.
FINE DELLA VITA DELL'ABATE PRIMATICCIO
DESCRIZIONE DELL'OPERE DI TIZIANO DA CADOR
PITTORE

Essendo nato Tiziano in Cador, piccol castello posto in sulla Piave e lontano cinque miglia dalla chiusa dell'alpe, l'anno 1480, della famiglia de' Vecelli, in quel luogo delle più nobili, pervenuto all'età di dieci anni con bello spirito e prontezza d'ingegno, fu mandato a Vinezia in casa d'un suo zio cittadino onorato, il quale veggendo il putto molto inclinato alla pittura, lo pose con Gianbellino pittore, in quel tempo eccellente e molto famoso, come s'è detto, sotto la cui disciplina attendendo al disegno, mostrò in brieve essere dotato dalla natura di tutte quelle parti d'ingegno e giudizio che necessarie sono all'arte della pittura. E perché in quel tempo Gianbellino e gli altri pittori di quel paese, per non avere studio di cose antiche, usavano molto, anzi non altro, che il ritrarre qualunche cosa facevano dal vivo, ma con maniera secca, cruda e stentata, imparò anco Tiziano per allora quel modo. Ma venuto poi l'anno circa 1507 Giorgione da Castel Franco, non gli piacendo in tutto il detto modo di fare, cominciò a dare alle sue opere più morbidezza e maggiore rilievo con bella maniera, usando nondimeno di cacciar sì avanti le cose vive e naturali e di contrafarle quanto sapeva il meglio con i colori, e macchiarle con le tinte crude e dolci, secondo che il vivo mostrava, senza far disegno, tenendo per fermo che il dipignere solo con i colori stessi, senz'altro studio di disegnare in carta, fusse il vero e miglior modo di fare et il vero disegno. Ma non s'accorgeva che egli è necessario a chi vuol bene disporre i componimenti et accomodare l'invenzioni, ch'e' fa bisogno prima in più modi diferenti porle in carta, per vedere come il tutto torna insieme. Conciò sia che l'idea non può vedere né imaginare perfettamente in se stessa l'invenzioni, se non apre e non mostra il suo concetto agl'occhi corporali, che l'aiutino a farne buon giudizio; senzaché pur bisogna fare grande studio sopra gl'ignudi, a volergli intendere bene, il che non vien fatto né si può senza mettere in carta; et il tenere sempre, che altri colorisce, persone ignude innanzi, o vero vestite, è non piccola servitù, là dove quando altri ha fatto la mano disegnando in carta, si vien poi di mano in mano con più agevolezza a mettere in opera disegnando e dipignendo. E così facendo pratica nell'arte, si fa la maniera et il giudizio perfetto, levando via quella fatica e stento con che si conducono le pitture, di cui si è ragionato di sopra, per non dir nulla, che disegnando in carta si viene a empiere la mente di bei concetti e s'impara a fare a mente tutte le cose della natura, senza avere a tenerle sempre innanzi, o ad avere a nascere sotto la vaghezza de' colori lo stento del non sapere disegnare, nella maniera che fecero molti anni i pittori viniziani, Giorgione, il Palma, il Pordenone et altri che non videro Roma, né altre opere di tutta perfezione.
Tiziano dunque, veduto il fare e la maniera di Giorgione, lasciò la maniera di Gianbellino, ancor che vi avesse molto tempo costumato, e si accostò a quella, così bene imitando in brieve tempo le cose di lui, che furono le sue pitture talvolta scambiate e credute opere di Giorgione, come di sotto si dirà. Cresciuto poi Tiziano in età, pratica e giudizio, condusse a fresco molte cose, le quali non si possono raccontare con ordine, essendo sparse in diversi luoghi; basta, che furono tali, che si fece da molti periti giudizio che dovesse, come poi è avenuto, riuscire eccellentissimo pittore. A principio dunque, che cominciò seguitare la maniera di Giorgione, non avendo più che diciotto anni, fece il ritratto d'un gentiluomo da Ca' Barbarigo amico suo, che fu tenuto molto bello, essendo la somiglianza della carnagione propria e naturale, e sì ben distinti i capelli l'uno dall'altro, che si conterebbono, come anco si farebbono i punti d'un giubone di raso inargentato, che fece in quell'opera; insomma fu tenuto sì ben fatto e con tanta diligenza, che se Tiziano non vi avesse scritto in ombra il suo nome, sarebbe stato tenuto opera di Giorgione. Intanto avendo esso Giorgione condotta la facciata dinanzi del Fondaco de' Tedeschi, per mezzo del Barbarigo furono allogate a Tiziano alcune storie, che sono nella medesima sopra la Merceria. Dopo la quale opera fece un quadro grande di figure simili al vivo, che oggi è nella sala di Messer Andrea Loredano, che sta da San Marcuola; nel qual quadro è dipinta la Nostra Donna che va in Egitto, in mezzo a una gran boscaglia e certi paesi molto ben fatti, per aver dato Tiziano molti mesi opera a fare simili cose, e tenuto perciò in casa alcuni tedeschi eccellenti pittori di paesi e verzure. Similmente nel bosco di detto quadro fece molti animali, i quali ritrasse dal vivo e sono veramente naturali e quasi vivi; dopo, in casa di Messer Giovanni d'Anna gentiluomo e mercante fiamingo suo compare, fece il suo ritratto, che par vivo, et un quadro di Ecce Homo, con molte figure che da Tiziano stesso e da altri è tenuto molto bell'opera. Il medesimo fece un quadro di Nostra Donna, con altre figure come il naturale d'uomini e putti, tutti ritratti dal vivo e da persone di quella casa. L'anno poi 1507 mentre Massimiliano imperadore faceva guerra ai Viniziani, fece Tiziano, secondo che egli stesso racconta, un angelo Raffaello, Tobia et un cane nella chiesa di San Marziliano, con un paese lontano, dove in un boschetto San Giovanni Batista ginocchioni sta orando verso il cielo, donde viene uno splendore che lo illumina. E questa opera si pensa che facesse innanzi che desse principio alla facciata del Fondaco de' Tedeschi; nella quale facciata non sapendo molti gentiluomini che Giorgione non vi lavorasse più, né che la facesse Tiziano, il quale ne aveva scoperto una parte, scontrandosi in Giorgione, come amici si rallegravano seco, dicendo che si portava meglio nella facciata di verso la Merceria, che non avea fatto in quella che è sopra il canal grande. Della qual cosa sentiva tanto sdegno Giorgione, che infino che non ebbe finita Tiziano l'opera del tutto e che non fu notissimo che esso Tiziano aveva fatta quella parte, non si lasciò molto vedere, e da indi in poi non volle che mai più Tiziano praticasse o fusse amico suo.
L'anno appresso 1508 mandò fuori Tiziano in istampa di legno il trionfo della Fede, con una infinità di figure, i primi parenti, i Patriarchi, i Profeti, le Sibille, gl'innocenti, i martiri, gl'Apostoli e Gesù Cristo in sul trionfo, portato dai quattro Evangelisti e dai quattro dottori, con i Santi confessori dietro. Nella quale opera mostrò Tiziano fierezza, bella maniera e sapere tirare via di pratica; e mi ricordo, che fra' Bastiano del Piombo, ragionando di ciò, mi disse che se Tiziano in quel tempo fusse stato a Roma et avesse veduto le cose di Michelagnolo, quelle di Raffaello e le statue antiche, et avesse studiato il disegno, arebbe fatto cose stupendissime, vedendosi la bella pratica che aveva di colorire, e che meritava il vanto d'essere a' tempi nostri il più bello e maggiore imitatore della natura nelle cose de' colori; ché egli arebbe nel fondamento del gran disegno aggiunto all'Urbinate et al Buonarruoto.
Dopo condottosi Tiziano a Vicenza, dipinse a fresco sotto la loggetta dove si tiene ragione all'udienza publica, il giudizio di Salamone, che fu bell'opera; appresso tornato a Vinezia dipinse la facciata de' Grimani, et in Padoa nella chiesa di Santo Antonio alcune storie, pure a fresco, de' fatti di quel Santo. Et in quella di Santo Spirito fece in una piccola tavoletta un San Marco a sedere in mezzo a certi Santi, ne' cui volti sono alcuni ritratti di naturale, fatti a olio con grandissima diligenza; la qual tavola molti hanno creduto che sia di mano di Giorgione. Essendo poi rimasa imperfetta per la morte di Giovan Bellino nella sala del Gran Consiglio una storia, dove Federigo Barbarossa alla porta della chiesa di San Marco sta ginocchioni innanzi a papa Alessandro Quarto, che gli mette il piè sopra la gola, la fornì Tiziano, mutando molte cose e facendovi molti ritratti di naturale di suoi amici et altri, onde meritò da quel senato avere nel Fondaco de' Tedeschi un uffizio, che si chiama la Senseria, che rende trecendo scudi l'anno; il quale ufficio hanno per consuetudine que' signori di dare al più eccellente pittore della loro città; con questo che sia di tempo in tempo ubligato a ritrarre, quando è creato, il principe loro o uno doge, per prezzo solo di otto scudi, che gli paga esso principe; il quale ritratto poi si pone in luogo publico per memoria di lui nel palazzo di San Marco.
Avendo l'anno 1514 il duca Alfonso di Ferrara fatto acconciare un camerino, et in certi spartimenti fatto fare dal Dosso pittore ferrarese istorie di Enea, di Marte e Venere, et in una grotta Vulcano con due fabbri alla fucina, volle che vi fussero anco delle pitture di mano di Gianbellino, il quale fece in un'altra faccia un tino di vin vermiglio con alcune baccanti intorno, sonatori, satiri et altri maschi e femine inebriati, et appresso un Sileno tutto ignudo e molto bello, a cavallo sopra il suo asino, con gente attorno, che hanno piene le mani di frutte e d'uve, la quale opera invero fu con molta diligenza lavorata e colorita, in tanto che è delle più belle opere che mai facesse Gianbellino, se bene nella maniera de' panni è un certo che di tagliente, secondo la maniera tedesca, ma non è gran fatto, perché imitò una tavola d'Alberto Duro fiammingo, che di que' giorni era stata condotta a Vinezia e posta nella chiesa di San Bartolomeo, che è cosa rara e piena di molte belle figure fatte a olio. Scrisse Gianbellino nel detto tino queste parole: “Ioannes Bellinus Venetus pinxit 1514”.
La quale opera non avendo potuta finire del tutto, per essere vecchio, fu mandato per Tiziano, come più eccellente di tutti gl'altri, acciò che la finisse; onde egli essendo disideroso d'acquistare e farsi conoscere, fece con molta diligenza due storie, che mancavano al detto camerino. Nella prima è un fiume di vino vermiglio, a cui sono intorno cantori e sonatori quasi ebri, e così femine come maschi, et una donna nuda che dorme, tanto bella, che pare viva, insieme con altre figure, et in questo quadro scrisse Tiziano il suo nome. Nell'altro che è contiguo a questo e primo rincontro all'entrata, fece molti amorini e putti belli et in diverse attitudini, che molto piacquero a quel signore, sì come fece anco l'altro quadro; ma fra gl'altri è bellissimo uno di detti putti, che piscia in un fiume e si vede nell'acqua, mentre gl'altri sono in-torno a una base che ha forma d'altare, sopra cui è la statua di Venere, con una chiocciola marina nella man ritta e la Grazia e Bellezza intorno, che sono molto belle figure e condotte con incredibile diligenza. Similmente nella porta d'un armario dipinse Tiziano dal mezzo in su una testa di Cristo maravigliosa e stupenda, a cui un villano ebreo mostra la moneta di Cesare. La quale testa et altre pitture di detto camerino, affermano i nostri migliori artefici che sono le migliori e meglio condotte che abbia mai fatto Tiziano, e nel vero sono rarissime, onde meritò essere liberalissimamente riconosciuto e premiato da quel signore, il quale ritrasse ottimamente con un braccio sopra un gran pezzo d'artiglieria.
Similmente ritrasse la signora Laura, che fu poi moglie di quel Duca, che è opera stupenda. E di vero hanno gran forza i doni in coloro che s'affaticano per la virtù, quando sono sollevati dalle liberalità de' principi.
Fece in quel tempo Tiziano amicizia con il divino Messer Lodovico Ariosto, e fu da lui conosciuto per eccellentissimo pittore, e celebrato nel suo Orlando Furioso:
...Tizian, che onora
non men Cador che quei Venezia e Urbino.
Tornato poi Tiziano a Vinezia, fece per lo suocero di Giovanni da Castel Bolognese, in una tela a olio un pastore ignudo et una forese che gli porge certi flauti perché suoni, con un bellissimo paese; il qual quadro è oggi in Faenza in casa il su detto Giovanni. Fece appresso nella chiesa de' frati minori, chiamata la Ca' grande, all'altar maggiore in una tavola la Nostra Donna che va in cielo et i dodici Apostoli a basso, che stanno a vederla salire; ma quest'opera, per essere stata fatta in tela e forse mal custodita, si vede poco. Nella medesima chiesa alla cappella di quelli da Ca' Pesari, fece in una tavola la Madonna col Figliuolo in braccio, un San Piero et un San Giorgio et attorno i padroni ginocchioni, ritratti di naturale, in fra i quali è il vescovo di Baffo et il fratello, allora tornati dalla vittoria che ebbe detto vescovo contra i Turchi. Alla chiesetta di San Niccolò nel medesimo convento, fece in una tavola San Niccolò, San Francesco, Santa Caterina e San Sebastiano ignudo, ritratto dal vivo e senza artificio niuno che si veggia essere stato usato in ritrovare la bellezza delle gambe e del torso, non vi essendo altro che quanto vide nel naturale, di maniera che tutto pare stampato dal vivo, così è carnoso e proprio, ma con tutto ciò è tenuto bello come è anco molto vaga una Nostra Donna col Putto in collo, la quale guardano tutte le dette figure. L'opera della quale tavola fu dallo stesso Tiziano disegnata in legno e poi da altri intagliata e stampata. Per la chiesa di Santo Rocco fece dopo le dette opere, in un quadro, Cristo con la croce in spalla e con una corda al collo tirata da un ebreo, la qual figura, che hanno molti creduta sia di mano di Giorgione, è oggi la maggior divozione di Vinezia, et ha avuto di limosine più scudi che non hanno in tutta la loro vita guadagnato Tiziano e Giorgione.
Dopo essendo chiamato a Roma dal Bembo, che allora era secretario di papa Leone X et il quale aveva già ritratto, acciò che vedesse Roma, Raffaello da Urbino et altri, andò tanto menando Tiziano la cosa d'oggi in domani, che morto Leone e Raffaello l'anno 1520, non v'andò altrimenti. Fece per la chiesa di Santa Maria Maggiore in un quadro un San Giovanni Batista nel deserto fra certi sassi, un Angelo che par vivo et un pezzetto di paese lontano, con alcuni alberi sopra la riva d'un fiume molto graziosi. Ritrasse di naturale il principe Grimani et il Loredano, che furono tenuti mirabili, e non molto dopo il re Francesco, quando partì d'Italia per tornare in Francia, e l'anno che fu creato doge Andrea Gritti fece Tiziano il suo ritratto, che fu cosa rarissima, in un quadro dove è la Nostra Donna, San Marco e Santo Andrea col volto del detto doge, il qual quadro, che è cosa maravigliosissima, è nella sala del collegio. E perché aveva, come s'è detto, obligo di ciò fare, ha ritratto oltre i sopra detti gl'altri dogi, che sono stati secondo i tempi: Pietro Lando, Francesco Donato, Marcantonio Trevisano et il Veniero, ma dai due dogi e fratelli Pauli è stato finalmente assoluto, come vecchissimo, da cotale obligo.
Essendo innanzi al Sacco di Roma andato a stare a Vinezia Pietro Aretino, poeta celeberrimo de' tempi nostri, divenne amicissimo di Tiziano e del Sansovino, il che fu di molto onore et utile a esso Tiziano, perciò che lo fece conoscere tanto lontano quanto si distese la sua penna e massimamente a prìncipi d'importanza, come si dirà a suo luogo. Intanto, per tornare all'opere di Tiziano, egli fece la tavola all'altare di San Piero martire, nella chiesa di San Giovanni e Polo, facendovi maggior del vivo il detto Santo martire dentro a una boscaglia d'alberi grandissimi, cascato in terra et assalito dalla fierezza d'un soldato, che l'ha in modo ferito nella testa, che essendo semivivo se gli vede nel viso l'orrore della morte: mentre in un altro frate, che va innanzi fuggendo, si scorge lo spavento e timore della morte; in aria sono due Angeli nudi, che vengono da un lampo di cielo, il quale dà lume al paese, che è bellissimo, et a tutta l'opera insieme; la quale è la più compiuta, la più celebrata e la maggiore e meglio intesa e condotta, che altra la quale in tutta la sua vita Tiziano abbia fatto ancor mai. Quest'opera vedendo il Gritti, che a Tiziano fu sempre amicissimo, come anco al Sansovino, gli fece allogare nella sala del Gran Consiglio una storia grande della rotta di Chiaradadda, nella quale fece una battaglia e furia di soldati, che combattono mentre una terribile pioggia cade dal cielo; la quale opera, tolta tutta dal vivo, è tenuta la migliore di quante storie sono in questa sala, e la più bella. Nel medesimo palazzo a' piè d'una scala dipinse a fresco una Madonna.
Avendo non molto dopo fatto, a un gentiluomo da Ca' Contarini, in un quadro un bellissimo Cristo che siede a tavola con Cleofas e Luca, parve al gentiluomo che quella fusse opera degna di stare in publico, come è veramente, per che fattone, come amorevolissimo della patria e del publico, dono alla Signoria, fu tenuto molto tempo nelle stanze del doge, ma oggi è in luogo publico e da potere essere veduta da ognuno nella salotta d'oro, dinanzi alla sala del Consiglio de' Dieci sopra la porta. Fece ancora quasi ne' medesimi tempi, per la scuola di Santa Maria della Carità, la Nostra Donna che saglie i gradi del tempio, con teste d'ogni sorte ritratte dal naturale; parimente nella scuola di San Fantino, in una tavoletta un San Girolamo in penitenza, che era dagl'artefici molto lodata, ma fu consumata dal fuoco, due anni so-no, con tutta quella chiesa. Dicesi che l'anno 1530, essendo Carlo Quinto imperatore in Bologna, fu dal cardinale Ipolito de' Medici, Tiziano, per mezzo di Pietro Aretino, chiamato là, dove fece un bellissimo ritratto di sua maestà tutto ar-mato che tanto piacque, che gli fece donare mille scudi, de' quali bisognò che poi desse la metà ad Alfonso Lombardi scultore, che avea fatto un modello, per farlo di marmo, come si disse nella sua vita.
Tornato Tiziano a Vinezia, trovò che molti gentiluomini, i quali avevano tolto a favorire il Pordenone, lodando molto l'opere da lui state fatte nel palco della sala de' Pregai et altrove, gli avevano fatto allogare nella chiesa di San Giovanni elemosinario una tavoletta acciò che egli la facesse a concorrenza di Tiziano, il quale nel medesimo luogo aveva poco innanzi dipinto il detto San Giovanni elemosinario in abito di vescovo. Ma per diligenza che in detta tavola ponesse il Pordenone, non poté paragonare, né giugnere a gran pezzo all'opera di Tiziano, il quale poi fece per la chiesa di Santa Maria degl'Angeli a Murano una bellissima tavola d'una Nunziata. Ma non volendo quelli che l'avea fatta fare spendervi cinquecento scudi, come ne voleva Tiziano, egli la mandò per consiglio di Messer Piero Aretino a donare al detto imperatore Carlo Quinto, che gli fece, piacendogli infinitamente quell'opera, un presente di duemila scudi, e dove aveva a essere posta la detta pittura ne fu messa in suo cambio una di mano del Pordenone. Né passò molto, che tornando Carlo Quinto a Bologna per abboccarsi con papa Clemente quando venne con l'esercito d'Ungheria, volle di nuovo essere ritratto da Tiziano, il quale ritrasse ancora prima che partisse di Bologna il detto cardinale Ipolito de' Medici, con abito all'ungheresca, et in un altro quadro più piccolo il medesimo tutto armato; i quali ambidue sono oggi nella guardaroba del duca Cosimo. Ritrasse in quel medesimo tempo il marchese del Vasto, Alfonso Davalos, et il detto Pietro Aretino, il quale gli fece allora pigliare servitù et amicizia con Federigo Gonzaga, duca di Mantoa; col quale andato Tiziano al suo stato, lo ritrasse che par vivo, e dopo il cardinale suo fratello. E questi finiti, per ornamento d'una stanza, fra quelle di Giulio Romano, fece dodici teste dal mezzo in su de' dodici cesari molto belle, sotto ciascuna delle quali fece poi Giulio detto una storia de' fatti loro.
Ha fatto Tiziano in Cador sua patria una tavola, dentro la quale è una Nostra Donna e San Tiziano vescovo, et egli stesso ritratto ginocchioni. L'anno che papa Paulo Terzo andò a Bologna e di lì a Ferrara, Tiziano andato alla corte ritrasse il detto Papa, che fu opera bellissima, e da quello un altro al cardinale Santa Fiore; i quali ambidue, che gli furo-no molto bene pagati dal Papa, sono in Roma, uno nella guardaroba del cardinale Farnese e l'altro appresso gl'eredi di detto cardinale Santa Fiore. E da questi poi ne sono state cavate molte copie, che sono sparse per Italia. Ritrasse anco quasi ne' medesimi tempi Francesco Maria duca d'Urbino, che fu opera maravigliosa, onde Messer Piero Aretino per questo lo celebrò con un sonetto, che cominciava:
Se il chiaro Apelle con la man dell'arte
rasemplò d'Alessandro il volto e il petto...
Sono nella guardaroba del medesimo Duca di mano di Tiziano due teste di femmina molto vaghe, et una Venere giovanetta a giacere con fiori e certi panni sottili attorno molto belli e ben finiti, et oltre ciò una testa dal mezzo in su d'una Santa Maria Maddalena con i capegli sparsi, che è cosa rara. Vi è parimente il ritratto di Carlo Quinto, del re Francesco quando era giovane, del duca Guidobaldo Secondo, di papa Sisto Quarto, di papa Giulio Secondo, di Paulo Terzo, del cardinal vecchio di Loreno e di Solimano imperatore de' Turchi, i quali ritratti dico sono di mano di Tiziano, e bellissimi. Nella medesima guardaroba, oltre a molte altre cose è un ritratto d'Aniballe cartaginese, intagliato nel cavo d'una corniuola antica, e così una testa di marmo bellissima di mano di Donato.
Fece Tiziano l'anno 1541 ai frati di Santo Spirito di Vinezia la tavola dell'altare maggiore, figurando in essa la venuta dello Spirito Santo sopra gl'Apostoli, con uno Dio finto di fuoco e lo Spirito in colomba. La qual tavola essendosi guasta indi a non molto tempo, dopo avere molto piatito con que' frati, l'ebbe a rifare, ed è quella che è al presente sopra l'altare. In Brescia fece nella chiesa di San Nazzaro la tavola dell'altare maggiore di cinque quadri; in quello del mezzo è Gesù Cristo che risuscita, con alcuni soldati attorno, e dagli lati San Nazzaro, San Bastiano, l'angelo Gabriello e la Vergine annunziata. Nel Duomo di Verona, fece nella facciata da piè in una tavola, un'Assunta di Nostra Donna in cielo e gl'Apostoli in terra, che è tenuta in quella città delle cose moderne la migliore. L'anno 1541 fece il ritratto di don Diego di Mendozza, allora ambasciadore di Carlo Quinto a Vinezia, tutto intero et in piedi, che fu bellissima figura, e da questa cominciò Tiziano quello che è poi venuto in uso, cioè fare alcuni ritratti interi. Nel medesimo modo fece quello del cardinale di Trento allora giovane, et a Francesco Marcolini ritrasse Messer Pietro Aretino, ma non fu già questi sì bello come uno, pure di mano di Tiziano, che esso Aretino di se stesso mandò a donare al duca Cosimo de' Medici, al quale mandò anco la testa del signor Giovanni de' Medici, padre di detto signor Duca. La qual testa fu ritratta da una forma, che fu improntata in sul viso di quel signore quando morì in Mantoa, che era appresso l'Aretino. I quali ambidue ritratti sono in guardaroba del detto signor Duca fra molte altre nobilissime pitture.
L'anno medesimo, essendo stato il Vasari in Vinezia tredici mesi a fare, come s'è detto, un palco a Messer Giovanni Cornaro et alcune cose per la Compagnia della Calza, il Sansovino, che guidava la fabrica di Santo Spirito, gli aveva fatto fare disegni per tre quadri grandi a olio, che andavano nel palco, acciò gli conducesse di pittura; ma essendosi poi partito il Vasari, furono i detti tre quadri allogati a Tiziano, che gli condusse bellissimi per avere atteso con molt'arte a fare scortare le figure al di sotto in su. In uno è Abraam che sacrifica Isaac, nell'altro Davit che spicca il collo a Golia, e nel terzo Abel ucciso da Cain suo fratello. Nel medesimo tempo ritrasse Tiziano se stesso, per lasciare quella memoria di sé ai figliuoli. E venuto l'anno 1546, chiamato dal cardinale Farnese andò a Roma, dove trovò il Vasari che, tornato da Napoli, faceva la sala della Cancelleria al detto Cardinale, per che essendo da quel signore stato raccomandato Tiziano a esso Vasari, gli tenne amorevol compagnia in menarlo a vedere le cose di Roma. E così riposato che si fu Tiziano alquanti giorni, gli furono date stanze in Belvedere, acciò mettesse mano a fare di nuovo il ritratto di papa Paulo intero, quello di Farnese e quello del duca Ottavio, i quali condusse ottimamente e con molta sodisfazione di que' signori, a persuasione de' quali fece, per donare al Papa, un Cristo dal mezzo in su, in forma di Ecce Homo, la quale opera, o fusse che le cose di Michelagnolo, di Raffaello, di Pulidoro e d'altri l'avessono fatto perdere, o qualche altra cagione, non parve ai pittori, tuttoché fusse buon'opera, di quell'eccellenza che molte altre sue e particolarmente i ritratti.
Andando un giorno Michelagnolo et il Vasari a vedere Tiziano in Belvedere, videro in un quadro, che allora avea condotto, una femina ignuda figurata per una Danae, che aveva in grembo Giove trasformato in pioggia d'oro e molto, come si fa in presenza, gliene lodarono. Dopo partiti che furono da lui, ragionandosi del fare di Tiziano, il Buonarruoto lo comendò assai, dicendo che molto gli piaceva il colorito suo e la maniera, ma che era un peccato che a Vinezia non s'imparasse da principio a disegnare bene e che non avessono que' pittori miglior modo nello studio. “Conciò sia” dis-s'egli “che se quest'uomo fusse punto aiutato dall'arte e dal disegno, come è dalla natura, e massimamente nel contrafare il vivo, non si potrebbe far più né meglio, avendo egli bellissimo spirito et una molto vaga e vivace maniera.” Et infatti così è vero, perciò che chi non ha disegnato assai e studiato cose scelte, antiche o moderne, non può fare bene di pratica da sé, né aiutare le cose che si ritranno dal vivo dando loro quella grazia e perfezzione, che dà l'arte fuori del-l'ordine della natura, la quale fa ordinariamente alcune parti che non son belle.
Partito finalmente Tiziano di Roma, con molti doni avuti da que' signori e particolarmente per Pomponio suo figliuolo un benefizio di buona rendita, si mise in cammino per tornare a Vinezia, poi che Orazio suo altro figliuolo ebbe ritratto Messer Batista Ceciliano, eccellente suonatore di violone, che fu molto buon'opera, et egli fatto alcuni altri ritratti al duca Guidobaldo d'Urbino. E giunto a Fiorenza, vedute le rare cose di quella città, rimase stupefatto non meno che avesse fatto di quelle di Roma, et oltre ciò, visitò il duca Cosimo, che era al Poggio a Caiano, offerendosi a fare il suo ritratto, di che non si curò molto sua eccellenza forse per non far torto a tanti nobili artefici della sua città e dominio.
Tiziano adunque, arrivato a Vinezia, finì al marchese del Vasto una locuzione (così la chiamarono) di quel signore a' suoi soldati, e dopo gli fece il ritratto di Carlo Quinto, quello del Re catolico e molti altri. E questi lavori finiti, fece nella chiesa di Santa Maria Nuova di Vinezia in una tavoletta una Nunziata, e poi facendosi aiutare ai suoi giovani, condusse nel refettorio di San Giovanni e Polo un cenacolo, e nella chiesa di San Salvadore all'altar maggiore una tavola, dove è un Cristo trasfigurato in sul monte Tabor, et ad un altro altare della medesima chiesa una Nostra Donna annunziata dall'Angelo. Ma queste opere ultime, ancor che in loro si veggia del buono, non sono molto stimate da lui e non hanno di quella perfezzione che hanno l'altre sue pitture. E perché sono infinite l'opere di Tiziano, e massimamente i ritratti, è quasi impossibile fare di tutti memoria; onde dirò solamente de' più segnalati, ma senz'ordine di tempi, non importando molto sapere qual fusse prima e qual fatto poi.
Ritrasse più volte, come s'è detto, Carlo Quinto, et ultimamente fu per ciò chiamato alla corte, dove lo ritrasse, secondo che era in quegli quasi ultimi anni, e tanto piacque a quello invittissimo Imperadore il fare di Tiziano, che non volse da che prima lo conobbe essere ritratto da altri pittori, e ciascuna volta che lo dipinse ebbe mille scudi d'oro di donativo. Fu da sua maestà fatto cavaliere con provisione di scudi dugento sopra la camera di Napoli. Quando similmente ritrasse Filippo re di Spagna, e di esso Carlo figliuolo, ebbe da lui di ferma provisione altri scudi dugento, di maniera che aggiunti quelli quattrocento alli trecento, che ha in sul Fondaco de' Tedeschi da' signori viniziani, ha senza faticarsi settecento scudi fermi di provisione ciascun anno.
Del quale Carlo Quinto e di esso re Filippo mandò Tiziano i ritratti al signor duca Cosimo, che gli ha nella sua guardaroba. Ritrasse Ferdinando re de' Romani, che poi fu imperatore, e di quello tutti i figliuoli, cioè Massimiliano oggi imperatore et il fratello, ritrasse la reina Maria, e per l'imperatore Carlo il duca di Sassonia, quando era prigione. Ma che perdimento di tempo è questo? Non è stato quasi alcun signore di gran nome, né principe, né gran donna, che non sia stata ritratta da Tiziano, veramente in questa parte eccellentissimo pittore. Ritrasse il re Francesco Primo di Francia, come s'è detto, Francesco Sforza duca di Milano, il marchese di Pescara, Antonio da Leva, Massimiano Stampa, il signor Giovanbatista Castaldo et altri infiniti signori. Parimente in diversi tempi, oltre alle dette, ha fatto molte altre opere: in Vinezia di ordine di Carlo Quinto fece in una gran tavola da altare Dio in Trinità, dentro a un trono la Nostra Donna, e Cristo fanciullo con la colomba sopra, et il campo tutto di fuoco per lo amore, et il Padre cinto di cherubini ardenti; da un lato è il detto Carlo Quinto e dall'altro l'imperatrice, fasciati d'un panno lino, con mani giunte in atto d'orare, fra molti Santi, secondo che gli fu comandato da Cesare, il quale fino allora nel colmo delle vittorie, cominciò a mostrare d'avere animo di ritirarsi, come poi fece, dalle cose mondane, per morire veramente da cristiano timorato de Dio e disideroso della propria salute. La quale pittura disse a Tiziano l'imperatore, che volea metterla in quel monasterio dove poi finì il corso della sua vita. E perché è cosa rarissima, si aspetta che tosto debba uscire fuori stampata. Fece il medesimo un Prometeo alla reina Maria, il quale sta legato al monte Caucaso et è lacerato dall'aquila di Giove, et un Sisifo all'inferno, che porta un sasso, e Tizio stracciato dall'avoltoio. E queste tutte dal Prometeo infuori ebbe sua maestà, e con esse un Tantalo della medesima grandezza, cioè quanto il vivo, in tela et a olio. Fece anco una Venere et Adone, che sono maravigliosi, essendo ella venutasi meno et il giovane in atto di volere partire da lei, con alcuni cani intorno molto naturali. In una tavola della medesima grandezza fece Andromeda legata al sasso e Perseo che la libera dall'orca marina, che non può essere altra pittura più vaga di questa, come è anco un'altra Diana, che standosi in un fonte con le sue ninfe, converte Atteon in cervio. Dipinse parimente un'Europa, che sopra il toro passa il mare. Le quali pitture sono appresso al Re catolico tenute molto care, per la vivacità che ha dato Tiziano alle figure con i colori in farle quasi vive e naturali. Ma è ben vero che il modo di fare che tenne in queste ultime è assai diferente dal fare suo da giovane. Conciò sia che le prime son condotte con una certa finezza e diligenza incredibile e da essere vedute da presso e da lontano, e queste ultime, condotte di colpi, tirate via di grosso e con macchie, di maniera che da presso non si possono vedere e di lontano appariscono perfette; e questo modo è stato cagione che molti, volendo in ciò immitare e mostrare di fare il pratico, hanno fatto di goffe pitture, e ciò adiviene perché se bene a molti pare che elle siano fatte senza fatica, non è così il vero e s'ingannano, perché si conosce che sono rifatte e che si è ritornato loro addosso con i colori tante volte, che la fatica vi si vede. E questo modo sì fatto è giudizioso, bello e stupendo, perché fa parere vive le pitture e fatte con grande arte, nascondendo le fatiche. Fece ultimamente Tiziano in un quadro alto braccia tre e largo quattro, Gesù Cristo fanciullo in grembo alla Nostra Donna et adorato da' Magi, con buon numero di figure d'un braccio l'una, che è opera molto vaga, sì come è ancora un altro quadro, che egli stesso ricavò da questo e diede al cardinale di Ferrara il vecchio. Un'altra tavola, nella quale fece Cristo schernito da' giudei, che è bellissima, fu posta in Milano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a una cappella.
Alla reina di Portogallo in un quadro fece un Cristo poco minore del vivo, battuto da' giudei alla colonna, che è bellissimo. In Ancona, all'altare maggiore di San Domenico fece nella tavola Cristo in croce, et a' piedi la Nostra Donna, San Giovanni e San Domenico bellissimi e di quell'ultima maniera fatta di macchie, come si disse pure ora. È di mano del medesimo nella chiesa de' Crucicchieri in Vinezia la tavola, che è all'altare di San Lorenzo, dentro al quale è il martirio di quel Santo, con un casamento pieno di figure, e San Lorenzo a giacere in iscorto, mezzo sopra la grata, sotto un gran fuoco, et intorno alcuni che l'accendono. E perché ha finto una notte, hanno due serventi in mano due lumiere, che fanno lume dove non arriva il riverbero del fuoco che è sotto la grata, che è spesso e molto vivace; et oltre ciò ha finto un lampo, che venendo di cielo e fendendo le nuvole, vince il lume del fuoco e quello delle lumiere, stando sopra al Santo et all'altre figure principali; et oltre ai detti tre lumi, le genti che ha finto di lontano alle finestre del casamento hanno il lume da lucerne e candele che loro sono vicine, et insomma il tutto è fatto con bell'arte, ingegno e giudizio. Nella chiesa di San Sebastiano all'altare di San Niccolò è di mano dello stesso Tiziano in una tavoletta un San Niccolò che par vivo, a sedere in una sedia finta di pietra, con un Angelo che gli tiene la mitria, la quale opera gli fece fare Mes-ser Niccolò Crasso avocato. Dopo fece Tiziano per mandare al Re cattolico una figura da mezza coscia in su d'una Santa Maria Madalena scapigliata, cioè con i capelli che le cascano sopra le spalle, intorno alla gola e sopra il petto, mentre ella alzando la testa con gl'occhi fissi al cielo mostra compunzione nel rossore degl'occhi, e nelle lacrime dogliezza de' peccati; onde muove questa pittura chiunche la guarda estremamente, e, che è più, ancor che sia bellissima non muove a lascivia, ma a comiserazione. Questa pittura, finita che fu, piacque tanto a [Badoer] Silvio gentiluomo viniziano, che donò a Tiziano per averla cento scudi, come quelli che si diletta sommamente della pittura; là dove Tiziano fu forzato farne un'altra, che non fu men bella, per mandarla al detto Re catolico.
Si veggiono anco ritratti di naturale da Tiziano un cittadino viniziano suo amicissimo chiamato il Sinistri, et un altro nominato Messer Paulo da Ponte, del quale ritrasse anco una figliuola, che allora aveva, bellissima giovane, chiamata la signora Giulia da Ponte, comare di esso Tiziano, e similmente la signora Irene, vergine bellissima, letterata, musica et incaminata nel disegno, la quale morendo circa sette anni sono, fu celebrata quasi da tutte le penne degli scrittori d'Ita-lia. Ritrasse Messer Francesco Filetto oratore di felice memoria, e nel medesimo quadro dinanzi a lui un suo figliuolo, che pare vivo, il qual ritratto è in casa di Messer Matteo Giustiniano amatore di queste arti, che ha fattosi fare da Iacomo da Bassano pittore un quadro che è molto bello, sì come anco sono molte altre opere di esso Bassano, che sono sparse per Vinezia e tenute in buon pregio, e massimamente per cose piccole et animali di tutte le sorti.
Ritrasse Tiziano il Bembo un'altra volta, cioè poi che fu cardinale, il Fracastoro et il cardinale Accolti di Ravenna, che l'ha il duca Cosimo in guardaroba, et il nostro Danese scultore ha in Vinezia in casa sua un ritratto di man di Tiziano d'un gentiluomo da Ca' Delfini. Si vede di mano del medesimo Messer Niccolò Zeno, la Rossa moglie del Gran Turco, d'età d'anni sedici, e Cameria di costei figliuola con abiti et acconciature bellissime. In casa Messer Francesco Sonica, avocato e compare di Tiziano, è il ritratto di esso Messer Francesco di mano dell'istesso, et in un quadrone grande la Nostra Donna, che andando in Egitto, pare discesa dell'asino e postasi a sedere sopra un sasso nella via con San Giuseppo appresso e San Giovannino, che porge a Cristo fanciullo certi fiori colti per man d'un Angelo dai rami d'un albero che è in mezzo a quel bosco pieno d'animali, nel lontano del quale si sta l'asino pascendo; la quale pittura, che è oggi graziosissima, ha posta il detto gentiluomo in un suo palazzo, che ha fatto in Padoa da Santa Iustina. In casa d'un gentiluomo de' Pisani appresso San Marco è di mano di Tiziano il ritratto d'una gentildonna che è cosa maravigliosa. A monsignor Giovanni della Casa fiorentino, stato uomo illustre per chiarezza di sangue e per lettere a' tempi nostri, a-vendo fatto un bellissimo ritratto d'una gentildonna che amò quel signor mentre stette in Vinezia, meritò da lui essere onorato con quel bellissimo sonetto, che comincia:
Ben vegg'io, Tiziano, in forme nove
l'idolo mio, che i begl'occhi apre e gira,
con quello che segue. Ultimamente mandò questo pittore eccellente al detto Re catolico una cena di Cristo con gl'Apo-stoli in un quadro sette braccia lungo, che fu cosa di straordinaria bellezza.
Oltre alle dette cose e molte altre di minor pregio, che ha fatte quest'uomo e si lasciano per brevità, ha in casa l'in-frascritte abbozzate e cominciate: il martirio di San Lorenzo, simile al sopra detto, il quale disegna mandare al Re catolico; una gran tela, dentro la quale è Cristo in croce con i ladroni et i crucifissori a basso, la quale fa per Messer Giovanni d'Anna, et un quadro, che fu cominciato per il doge Grimani, padre del patriarca d'Aquileia. E per la sala del palazzo grande di Brescia ha dato principio a tre quadri grandi, che vanno negl'ornamenti del palco, come s'è detto ragionando di Cristofano e d'un suo fratello, pittori bresciani. Cominciò anco molti anni sono, per Alfonso Primo duca di Ferrara, un quadro d'una giovane ignuda, che s'inchina a Minerva, con un'altra figura a canto, et un mare, dove nel lontano è un Nettunno in mezzo sopra il suo carro, ma per la morte di quel signore, per cui si faceva quest'opera a suo capriccio, non fu finita e si rimase a Tiziano. Ha anco condotto a buon termine, ma non finito, un quadro dove Cristo appare a Maria Madalena nell'orto in forma d'ortolano, di figure quanto il naturale, e così un altro di simile grandezza, dove, presente la Madonna e l'altre Marie, Cristo morto si ripone nel sepolcro, et un quadro parimente d'una Nostra Donna, che è delle buone cose che siano in quella casa; e come s'è detto un suo ritratto, che da lui fu finito quattro anni sono, molto bello e naturale, e finalmente un San Paulo che legge, mezza figura, che pare quello stesso ripieno di Spirito Santo. Queste dico tutte opere ha condotto, con altre molte che si tacciono per non fastidire, infino alla sua età di circa settantasei anni.
È stato Tiziano sanissimo e fortunato quant'alcun altro suo pari sia stato ancor mai, e non ha mai avuto dai cieli se non favori e felicità. Nella sua casa di Vinezia sono stati quanti principi, letterati e galantuomini sono al suo tempo andati o stati a Vinezia, perché egli, oltre all'eccellenza dell'arte, è stato gentilissimo, di bella creanza e dolcissimi costumi e maniere. Ha avuto in Vinezia alcuni concorrenti, ma di non molto valore, onde gl'ha superati agevolmente coll'eccel-lenza dell'arte e sapere trattenersi e farsi grato ai gentiluomini; ha guadagnato assai perché le sue opere gli sono state benissimo pagate, ma sarebbe stato ben fatto che in questi suoi ultimi anni non avesse lavorato se non per passatempo, per non scemarsi coll'opere manco buone la riputazione guadagnatasi negl'anni migliori e quando la natura per la sua declinazione non tendeva all'imperfetto.
Quando il Vasari scrittore della presente storia fu l'anno 1566 a Vinezia, andò a visitare Tiziano come suo amicissimo e lo trovò, ancor che vecchissimo fusse, con i pennelli in mano a dipignere, et ebbe molto piacere di vedere l'opere sue e di ragionare con esso, il quale gli fece conoscere Messer Gian Maria Verdezotti gentiluomo veniziano, giovane pien di virtù, amico di Tiziano et assai ragionevole, disegnatore e dipintore, come mostrò in alcuni paesi disegnati da lui bellissimi. Ha costui di mano di Tiziano, il quale ama et osserva come padre, due figure dipinte a olio in due nicchie, cioè un Apollo et una Diana. Tiziano adunque, avendo d'ottime pitture adornato Vinezia, anzi tutta Italia et altre parti del mondo, merita essere amato et osservato dagl'artefici, et in molte cose ammirato et imitato, come quegli che ha fatto e fa tuttavia opere degne d'infinita lode, e dureranno quanto può la memoria degl'uomini illustri.
Ora se bene molti sono stati con Tiziano per imparare, non è però grande il numero di coloro, che veramente si pos-sano dire suoi discepoli: perciò che non ha molto insegnato, ma ha imparato ciascuno più e meno, secondo che ha saputo pigliare dall'opre fatte da Tiziano. È stato con esso lui fra gli altri un Giovanni fiamingo, che di figure, così piccole come grandi, è stato assai lodato maestro, e nei ritratti maraviglioso, come si vede in Napoli, dove è vivuto alcun tempo e finalmente morto. Furono di man di costui (il che gli doverà in tutti i tempi essere d'onore) i disegni dell'anotomie, che fece intagliare, e mandar fuori con la sua opera, l'eccellentissimo Andrea Vessalio. Ma quegli che più di tutti ha imitato Tiziano è stato Paris Bondone, il quale nato in Trevisi di padre trivisano e madre viniziana, fu condotto d'otto anni a Vinezia in casa alcuni suoi parenti. Dove, imparato che ebbe gramatica e fattosi eccellentissimo musico, andò a stare con Tiziano, ma non vi consumò molti anni, perciò che vedendo quell'uomo non essere molto vago d'insegnare a' suoi giovani, anco pregato da loro sommamente et invitato con la pacienza a portarsi bene, si risolvé a partirsi, dolendosi infinitamente che di quei giorni fusse morto Giorgione, la cui maniera gli piaceva sommamente, ma molto più l'a-ver fama di bene e volentieri insegnare con amore quello che sapeva. Ma poi che altro fare non si poteva, si mise Paris in animo di volere per ogni modo seguitare la maniera di Giorgione. E così, datosi a lavorare et a contrafare dell'opere di colui, si fece tale, che venne in bonissimo credito, onde nella sua età di diciotto anni gli fu allogata una tavola da farsi per la chiesa di San Niccolò de' frati minori; il che avendo inteso Tiziano, fece tanto con mezzi e con favori, che gliele tolse di mano, o per impedirgli che non potesse così tosto mostrare la sua virtù, o pure tirato dal disiderio di guadagnare.
Dopo essendo Paris chiamato a Vicenza a fare una storia a fresco nella loggia di piazza ove si tien ragione, et a canto a quella che aveva già fatta Tiziano del giudizio di Salamone, andò ben volentieri e vi fece una storia di Noè con i figliuoli, che fu tenuta per diligenza e disegno opera ragionevole e non men bella che quella di Tiziano, in tanto che so-no tenute amendue, da chi non sa il vero, d'una mano medesima. Tornato Paris a Vinezia, fece a fresco alcuni ignudi a' piè del ponte di Rialto, per lo qual saggio gli furono fatte fare alcune facciate di case per Vinezia. Chiamato poi a Trevisi, vi fece similmente alcune facciate et altri lavori, et in particolare molti ritratti che piacquero assai: quello del magnifico Messer Alberto Unigo, quello di Messer Marco Seravalle, di Messer Francesco da Quer e del canonico Rovere e monsignor Alberti. Nel Duomo della detta città fece in una tavola nel mezzo della chiesa ad istanza del signor vicario la Natività di Gesù Cristo, et appresso una Ressurezione. In San Francesco fece un'altra tavola al cavaliere Rovere, u-n'altra in San Girolamo et una in Ogni Santi con variate teste di Santi e Sante, e tutte belle e varie nell'attitudini e ne' vestimenti. Fece un'altra tavola in San Lorenzo, et in San Polo fece tre cappelle: nella maggiore delle quali fece Cristo che resuscita, grande quanto è il vivo et accompagnato da gran moltitudine d'Angeli, nell'altra alcuni Santi con molti Angeli attorno, e nella terza Gesù Cristo in una nuvola, con la Nostra Donna che gli presenta San Domenico, le quali tutte opere l'hanno fatto conoscere per valentuomo et amorevole della sua città.
In Vinezia poi, dove quasi sempre è abitato, ha fatto in diversi tempi molte opere, ma la più bella e più notabile e dignissima di lode, che facesse mai Paris, fu una storia nella scuola di San Marco da San Giovanni e Polo, nella quale è quando quel pescatore presenta alla signoria di Vinezia l'anello di San Marco, con un casamento in prospettiva bellissimo, intorno al quale siede il senato con il doge; in fra i quali senatori sono molti ritratti di naturale, vivaci e ben fatti oltre modo. La bellezza di quest'opera, lavorata così bene e colorita a fresco, fu cagione che egli cominciò ad essere adoperato da molti gentiluomini, onde nella casa grande de' Foscari da San Barnaba fece molte pitture e quadri, e fra l'al-tre un Cristo che sceso al limbo, ne cava i Santi Padri, che è tenuta cosa singolare. Nella chiesa di San Iob in Canal reio fece una bellissima tavola, et in San Giovanni in Bragola un'altra, et il medesimo a Santa Maria della Celeste et a Santa Marina. Ma conoscendo Paris che a chi vuole essere adoperato in Vinezia bisogna far troppa servitù in cortegiando questo e quello, si risolvé, come uomo di natura quieto e lontano da certi modi di fare, ad ogni occasione che venisse andare a lavorare di fuori quell'opere che innanzi gli mettesse la fortuna, senza averle a ire mendicando; per che trasferitosi con buona occasione l'anno 1538 in Francia al servizio del re Francesco, gli fece molti ritratti di dame et altri quadri di diverse pitture, e nel medesimo tempo dipinse a monsignor di Guisa un quadro da chiesa bellissimo et uno da camera di Venere e Cupido. Al cardinale di Loreno fece un Cristo ecce homo, et un Giove con Io, e molte altre opere. Mandò al re di Pollonia un quadro, che fu tenuto cosa bellissima, nel quale era Giove con una ninfa. In Fiandra mandò due altri bellissimi quadri: una Santa Maria Madalena nell'eremo, accompagnata da certi Angeli, et una Diana, che si lava con le sue ninfe in un fonte, i quali due quadri gli fece fare il Candiano milanese, medico della reina Maria, per donargli a sua altezza. In Augusta fece in casa de' Fuccheri molte opere nel loro palazzo, di grandissima importanza e per valuta di tremila scudi. E nella medesima città fece per i Prineri, grand'uomini di quel luogo, un quadrone grande, dove in prospettiva mise tutti i cinque ordini d'architettura, che fu opera molto bella; et un altro quadro da camera, il quale è appresso il cardinale d'Augusta. In Crema ha fatto in Santo Agostino due tavole, in una delle quali è ritratto il signor Giulio Manfrone, per un San Giorgio tutto armato. Il medesimo ha fatto molte opere in Civitale di Belluno, che sono lodate, e particolarmente una tavola in Santa Maria et un'altra in San Giosef, che sono bellissime. In Genova mandò al signor Ottaviano Grimaldo un suo ritratto grande quanto il vivo e bellissimo, e con esso un altro quadro simile d'una donna lascivissima.
Andato poi Paris a Milano, fece nella chiesa di San Celso in una tavola alcune figure in aria, e sotto un bellissimo paese, secondo che si dice, a istanza del signor Carlo da Roma, e nel palazzo del medesimo due gran quadri a olio: in uno Venere e Marte sotto la rete di Vulcano, e nell'altro il re Davit che vede lavare Bersabè dalle serve di lei alla fonte, et appresso il ritratto di quel signore e quello della signora Paula Visconti sua consorte, et alcuni pezzi di paesi non molto grandi, ma bellissimi. Nel medesimo tempo dipinse molte favole d'Ovidio al marchese d'Astorga, che le portò seco in Ispagna. Similmente al signor Tommaso Marini dipinse molte cose, delle quali non accade far menzione. E questo basti aver detto di Paris, il quale essendo d'anni settantacinque, se ne sta con sua comodità in casa quietamente, e lavora per piacere a richiesta d'alcuni prìncipi et altri amici suoi, fuggendo la concorrenza e certe vane ambizioni per non essere offeso e perché non gli sia turbata una sua somma tranquillità e pace da coloro che non vanno (come dice egli) in verità, ma con doppie vie, malignamente e con niuna carità, là dove egli è avezzo a vivere semplicemente e con una certa bontà naturale, e non sa sottilizzare, né vivere astutamente. Ha costui ultimamente condotto un bellissimo quadro per la duchessa di Savoia, d'una Venere con Cupido, che dormono custoditi da un servo, tanto ben fatti, che non si possono lodare a bastanza.
Ma qui non è da tacere che quella maniera di pittura, che è quasi dismessa in tutti gl'altri luoghi, si mantien viva dal serenissimo senato di Vinezia, cioè il musaico; perciò che di questo è stato quasi buona e principal cagione Tiziano, il quale quanto è stato in lui ha fatto opera sempre che in Vinezia sia esercitato e fatto dare onorate provisioni a chi ha di ciò lavorato. Onde sono state fatte diverse opere nella chiesa di San Marco e quasi rinovati tutti i vecchi e ridotta questa sorte di pittura a quell'eccellenza che può essere et ad altro termine, ch'ella non fu in Firenze et in Roma al tempo di Giotto, d'Alesso Baldovinetti, del Ghirlandai e di Gherardo miniatore. E tutto che si è fatto in Vinezia è venuto dal disegno di Tiziano e d'altri eccellenti pittori, che n'hanno fatto disegni e cartoni coloriti, acciò l'opere si conducessino a quella perfezzione a che si veggiono condotte quelle del portico di San Marco, dove in una nicchia molto bella è il giudizio di Salamone tanto bello, che non si potrebbe in verità con i colori fare altrimenti. Nel medesimo luogo è l'albero di Nostra Donna di mano di Lodovico Rosso, tutto pieno di Sibille e Profeti fatti d'una gentil maniera, ben commessa e con assai e buon rilievo. Ma niuno ha meglio lavorato di quest'arte a' tempi nostri, che Valerio e Vincenzio Zuccheri trivisani, di mano de' quali si veggiono in San Marco diverse e molte storie, e particolarmente quella dell'Apocalisse, nella quale sono d'intorno al trono di Dio i quattro Evangelisti in forma d'animali, i sette candelabri et altre molte cose, tanto ben condotte, che guardandole da basso paiono fatte di colori con i pennelli a olio; oltra che si vede loro in mano et appresso quadretti piccoli pieni di figurette fatte con grandissima diligenza; in tanto, che paiono non dico pitture, ma cose miniate, e pure sono di pietre commesse. Vi sono anco molti ritratti di Carlo Quinto imperatore, di Ferdinando suo fratello, che a lui succedette nell'imperio, e Massimiliano figliuolo di esso Ferdinando et oggi imperatore. Similmente la testa dell'illustrissimo cardinal Bembo, gloria del secol nostro, e quella del magnifico ... fatte con tanta diligenza et unione e talmente accomodati i lumi, le carni, le tinte, l'ombre e l'altre cose, che non si può veder meglio né più bell'o-pera di simil materia. E di vero è gran peccato che questa arte eccellentissima del fare di musaico, per la sua bellezza et eternità, non sia più in uso di quello che è, e che per opera de' prìncipi, che posson farlo, non ci si attenda.
Oltre ai detti, ha lavorato di musaico in San Marco a concorrenza de' Zuccheri, Bartolomeo Bozzato, il quale si è portato anch'egli nelle sue opere in modo da doverne essere sempre lodato. Ma quello che in ciò fare è stato a tutti di grandissimo aiuto, è stata la presenza e gl'avvertimenti di Tiziano, del quale, oltre i detti e molti altri, è stato discepolo e l'ha aiutato in molte opere un Girolamo (non so il cognome se non di Tiziano).
IL FINE DELLA VITA DI TIZIANO DA CADOR PITTORE
DESCRIZIONE DELL'OPERE DI IACOPO SANSAVINO
SCULTORE FIORENTINO

Mentre che Andrea Contucci scultore dal monte Sansavino, avendo già acquistato in Italia et in Ispagna nome, dopo il Buonarruoto, del più eccellente scultore et architetto che fosse nell'arte, si stava in Firenze per fare le due figure di marmo che dovevano porsi sopra la porta che volta alla Misericordia del tempio di San Giovanni, gli fu dato a imparare l'arte della scultura un giovanetto figliuolo di Antonio di Iacopo Tatti, il quale aveva la natura dotato di grande ingegno e di molta grazia nelle cose che faceva di rilievo, per che conosciuto Andrea quanto nella scultura dovesse il giovane venire eccellente, non mancò con ogni accuratezza insegnargli tutte quelle cose che potevano farlo conoscere per suo discepolo. E così amandolo sommamente et ingegnandosi con amore e dal giovane essendo parimente amato, giudicarono i popoli che dovesse non pure essere eccellente al pari del suo maestro, ma che lo dovesse passare di gran lunga. E fu tanto l'amore e benivolenza reciproca fra questi quasi padre e figliuolo, che Iacopo non più del Tatta, ma del Sansovino cominciò in que' primi anni a essere chiamato, e così è stato e sarà sempre.
Cominciando dunque Iacopo a esercitare, fu talmente aiutato dalla natura nelle cose che egli fece, che ancora che egli non molto studio e diligenzia usasse talvolta nell'operare, si vedeva nondimeno in quello che faceva facilità, dolcezza, grazia et un certo che di leggiadro, molto grato agli occhi degli artefici, in tanto che ogni suo schizzo, o segno, o bozza ha sempre avuto una movenzia e fierezza, che a pochi scoltori suole porgere la natura. Giovò anco pur assai al-l'uno et all'altro la pratica e l'amicizia, che nella loro fanciullezza e poi nella gioventù ebbero insieme Andrea del Sarto et Iacopo Sansovino, i quali seguitando la maniera medesima nel disegno, ebbero la medesima grazia nel fare, l'uno nella pittura e l'altro nella scultura, per che conferendo insieme i dubbii dell'arte e facendo Iacopo per Andrea modelli di figure, s'aiutavano l'un l'altro sommamente. E che ciò sia vero ne fa fede questo, che nella tavola di San Francesco delle monache di via Pentolini è un San Giovanni Evangelista il quale fu ritratto da un bellissimo modello di terra, che in quei giorni il Sansovino fece a concorrenzia di Baccio da Monte Lupo, perché l'Arte di Por Santa Maria voleva fare una statua di braccia quattro di bronzo, in una nicchia al canto di Or San Michele, dirimpetto a' Cimatori; per la quale ancora che Iacopo facesse più bello modello di terra che Baccio, fu allogata nondimeno più volentieri al Montelupo, per esser vecchio maestro, che al Sansovino, ancora che fusse meglio l'opera sua, se bene era giovane. Il qual modello è oggi nelle mani degl'eredi di Nanni Unghero, che è cosa bellissima, al quale Nanni essendo amico allora il Sansovino, gli fece alcuni modelli di putti grandi di terra e d'una figura d'un San Niccola da Tolentino, i quali furno fatti l'uno e l'altro di legno grandi quanto il vivo con aiuto del Sansovino, e posti alla cappella del detto Santo nella chiesa di Santo Spirito.
Essendo per queste cagioni conosciuto Iacopo da tutti gl'artefici di Firenze, e tenuto giovane di bello ingegno et ottimi costumi, fu da Giuliano da San Gallo, architetto di papa Iulio Secondo, condotto a Roma con grandissima satisfazione sua; perciò che piacendogli oltre modo le statue antiche che sono in Belvedere, si mise a disegnarle. Onde Bramante, architetto anch'egli di papa Iulio, che allora teneva il primo luogo et abitava in Belvedere, visto de' disegni di questo giovane e di tondo rilievo uno ignudo a giacere di terra, che egli aveva fatto, il quale teneva un vaso per un calamaio, gli piacque tanto, che lo prese a favorire e gli ordinò che dovesse ritrar di cera grande il Laocoonte, il quale faceva ritrarre anco da altri, per gettarne poi uno di bronzo, cioè da Zaccheria Zachi da Volterra, Alonso Berugetta spagnolo e dal Vecchio da Bologna, i quali quando tutti furono finiti, Bramante fece vederli a Raffaello Sanzio da Urbino, per sapere chi si fusse di quattro portato meglio. Là dove fu giudicato da Raffaello che il Sansovino, così giovane, avesse passato tutti gli altri di gran lunga, onde poi per consiglio di Domenico cardinal Grimani, fu a Bramante ordinato che si dovesse fare gittare di bronzo quel di Iacopo; e così, fatta la forma e gettatolo di metallo, venne benissimo. Là dove rinetto e datolo al cardinale, lo tenne fin che visse non men caro che se fusse l'antico. E venendo a morte, come cosa rarissima lo lasciò alla Signoria serenissima di Vinezia, la quale avendolo tenuto molti anni nell'armario della sala del Consiglio de' Dieci, lo donò finalmente l'anno 1534 al cardinale di Loreno, che lo condusse in Francia.
Mentre che il Sansovino acquistando giornalmente con li studii dell'arte nome in Roma era in molta considerazione, infermandosi Giuliano da San Gallo, il quale lo teneva in casa in Borgo Vecchio, quando partì di Roma per venire a Firenze in ceste e mutare aria, gli fu da Bramante trovata una camera pure in Borgo Vecchio nel palazzo di Domenico dalla Rovere cardinale di San Clemente, dove ancora alloggiava Pietro Perugino, il quale in quel tempo per papa Giulio dipigneva la volta della camera di Torre Borgia; per che avendo visto Pietro la bella maniera del Sansovino, gli fece fare per sé molti modelli di cera, e fra gli altri un Cristo deposto di croce, tutto tondo, con molte scale e figure, che fu cosa bellissima. Il quale insieme con l'altre cose di questa sorte e modelli di varie fantasie, furono poi raccolte tutte da Messer Giovanni Gaddi, e sono oggi nelle sue case in Fiorenza alla piazza di Madonna. Queste cose dico furono cagione che 'l Sansovino pigliò grandissima pratica con maestro Luca Signorelli, pittore cortonese, con Bramantino da Milano, con Bernardino Pinturichio, con Cesare Cesariano, che era allora in pregio per avere comentato Vitruvio, e con molti altri famosi e begli ingegni di quella età.
Bramante adunque, desiderando che 'l Sansovino fusse noto a papa Iulio, ordinò di fargli aconciare alcune anticaglie. Onde egli messovi mano mostrò nel rassettarle tanta grazia e diligenza, che 'l Papa e chiunque le vidde giudicò che non si potesse far meglio. Le quali lode, perché avanzasse se stesso, spronarono di maniera il Sansovino, che datosi oltra modo alli studii, essendo anco gentiletto di complessione, con qualche trasordine addosso di quelli che fanno i giovani, s'amalò di maniera, che fu forzato per salute della vita ritornare a Fiorenza, dove giovandoli l'aria nativa, l'aiuto d'esser giovane e la diligenzia e cura de' medici, guarì del tutto in poco tempo. Per lo che parve a Messer Piero Pitti, il quale procurava allora che nella facciata dove è l'oriuolo di Mercato Nuovo in Firenze si dovesse fare una Nostra Donna di marmo, che essendo in Fiorenza molti giovani valenti et ancora maestri vecchi, si dovesse dare quel lavoro a chi di questi facesse meglio un modello. Là dove fattone fare uno a Baccio da Montelupo, un altro a Zaccheria Zatii da Volterra, che era anch'egli il medesimo anno tornato a Fiorenza, un altro a Baccio Bandinelli et un altro al Sansovino, posti in giudizio, fu da Lorenzo Credi, pittore eccellente e persona di giudizio e di bontà, dato l'onore e l'opera al Sansovino, e così dagl'altri giudici, artefici et intendenti. Ma se bene gli fu perciò allogata questa opera, fu nondimeno indugiato tanto a provedergli e condurgli il marmo per opera et invidia d'Averardo da Filicaia, il quale favoriva grandemente il Bandinello et odiava il Sansovino, che veduta quella lunghezza, fu da altri cittadini ordinato che dovesse fare uno degl'Apostoli di marmo grandi che andavano nella chiesa di Santa Maria del Fiore. Onde fatto il modello d'un San Iacopo, il quale modello ebbe, finito che fu l'opera, Messer Bindo Altoviti, cominciò quella figura e continovando di lavorarla con ogni diligenzia e studio, la condusse a fine tanto perfettamente, che ella è figura miracolosa e mostra in tutte le parti essere stata lavorata con incredibile studio e diligenzia ne' panni, nelle braccia e mani traforate e condotte con tant'arte e con tanta grazia, che non si può nel marmo veder meglio. Onde il Sansovino mostrò in che modo si lavoravano i panni traforati, avendo quelli condotti tanto sottilmente e sì naturali, che in alcuni luoghi ha campato nel marmo la grossezza che 'l naturale fa nelle pieghe et in su' lembi e nella fine de' vivagni del panno: modo dificile, e che vuole gran tempo e pacienza a volere che riesca in modo che mostri la perfezzione dell'arte; la quale figura è stata nel-l'Opera da quel tempo che fu finita dal Sansovino fin a l'anno 1565. Nel qual tempo del mese di dicembre fu messa nella chiesa di Santa Maria del Fiore, per onorare la venuta della reina Giovanna d'Austria, moglie di don Francesco de' Medici principe di Fiorenza e di Siena, dove è tenuta cosa rarissima, insieme con gli altri Apostoli pure di marmo, fatti a concorrenzia da altri artefici, come s'è detto nelle vite loro.
Fece in questo tempo medesimo per Messer Giovanni Gaddi una Venere di marmo in sur un nicchio, bellissima, sì come era anco il modello che era in casa Messer Francesco Montevarchi, amico di queste arti, e gli mandò male per l'innundazione del fiume d'Arno l'anno 1558. Fece ancora un putto di stoppa et un cecero bellissimo quanto si può di marmo per il medesimo Messer Giovanni Gaddi con molt'altre cose, che sono in casa sua, et a Messer Bindo Altoviti fece fare un camino di spesa grandissima, tutto di macigno intagliato da Benedetto da Rovezzano, che fu posto nelle case sue di Firenze; dove al Sansovino fece fare una storia di figure piccole per metterla nel fregio di detto camino, con Vulcano et altri dei, che fu cosa rarissima. Ma molto più begli sono due putti di marmo che erano sopra il fornimento di questo camino, i quali tenevano alcune arme delli Altoviti in mano, i quali ne sono stati levati dal signor don Luigi di Toledo, che abita la casa di detto Messer Bindo, e posti intorno a una fontana nel suo giardino in Fiorenza dietro a' frati de' Servi. Due altri putti pur di marmo di straordinaria bellezza sono di mano del medesimo in casa Giovanfrancesco Ridolfi, i quali tengono similmente un'arme.
Le quali tutte opere feciono tenere il Sansovino da tutta Fiorenza e da quelli dell'arte eccellentissimo e grazioso maestro. Per lo che Giovanni Bartolini, avendo fatto murare nel suo giardino di Gualfonda una casotta, volse che il Sansovino gli facesse di marmo un Bacco giovinetto quanto il vivo, per che dal Sansovino fattone il modello, piacque tanto a Giovanni, che fattogli consegnare il marmo, Iacopo lo cominciò con tanta voglia, che lavorando volava con le mani e con l'ingegno. Studiò dico quest'opera di maniera, per farla perfetta, che si mise a ritrarre dal vivo ancor che fusse di verno un suo garzone, chiamato Pippo del Fabbro, facendolo stare ignudo buona parte del giorno, il quale Pippo sarebbe riuscito valente uomo perché si sforzava con ogni fatica d'imitare il maestro. Ma o fusse lo stare nudo e con la testa scoperta in quella stagione, o pure il troppo studiare e patir disagi, non fu finito il Bacco, che egli impazzò in sulla maniera del fare l'attitudini, e lo mostrò, perché un giorno che pioveva dirottamente, chiamando il Sansovino Pippo et egli non rispondendo, lo vidde poi salito sopra il tetto in cima d'un camino, ignudo, che faceva l'attitudine del suo Bacco; altre volte pigliando lenzuola o altri panni grandi, e' quali bagnati se gli recava adosso all'ignudo come fusse un modello di terra o cenci et acconciava le pieghe, poi salendo in certi luoghi strani et arrecandosi in attitudini or d'una or d'altra maniera, di profeta, d'apostolo, di soldato o d'altro, si faceva ritrarre, stando così lo spazio di due ore senza favellare e non altrimenti che se fusse stato una statua immobile. Molte altre simili piacevoli pazzie fece il povero Pippo, ma sopra tutto mai non si poté dimenticare il Bacco che avea fatto il Sansovino, se non quando in pochi anni si morì.
Ma tornando alla statua, condotta che fu a fine fu tenuta la più bella opera che fusse mai fatta da maestro moderno, atteso che 'l Sansovino mostrò in essa una difficultà, non più usata, nel fare spiccato intorno intorno un braccio in aria che tiene una tazza del medesimo marmo traforata tra le dita, tanto sottilmente che se ne tien molto poco, oltre che per ogni verso è tanto ben disposta et accordata quella attitudine e tanto ben proporzionate e belle le gambe e le braccia attaccate a quel torso, che pare nel vederlo e toccarlo molto più simile alla carne. In tanto che quel nome che gl'ha, da chi lo vede se gli conviene, et ancor molto più. Quest'opera dico, finita che fu, mentre che visse Giovanni fu visitata in quel cortile di Gualfonda da tutti i terrazzani e forestieri, e molto lodata.
Ma poi essendo Giovanni morto, Gherardo Bartolini suo fratello la donò al duca Cosimo, il quale come cosa rara la tiene nelle sue stanze con altre bellissime statue che ha di marmo. Fece al detto Giovanni un Crocifisso di legno molto bello, che è in casa loro, e molte cose antiche e di man di Michelagnolo. Avendosi poi l'anno 1514 a fare un ricchissimo apparato in Fiorenza per la venuta di papa Leone X, fu dato ordine dalla Signoria e da Giuliano de' Medici che si facessero molti archi trionfali di legno in diversi luoghi della città. Onde il Sansovino non solo fece i disegni di molti, ma tolse in compagnia di Andrea del Sarto a fare egli stesso la facciata di Santa Maria del Fiore, tutta di legno, con statue e con istorie et ordine d'architettura, nel modo a punto che sarebbe ben fatto ch'ella stesse, per torne via quello che vi è di componimento et ordine tedesco; per che messovi mano (per non dire ora alcuna cosa della coperta di tela, che per San Giovanni et altre feste solennissime soleva coprire la piazza di Santa Maria del Fiore e di esso San Giovanni, essendosi di ciò in altro luogo favellato a bastanza), dico che sotto queste tende aveva ordinato il Sansovino la detta facciata di lavoro corinto, e che fattala a guisa d'arco trionfale, aveva messo sopra un grandissimo imbasamento da ogni banda le colonne doppie con certi nicchioni fra loro pieni di figure tutte tonde, che figuravano gl'Apostoli, e sopra erano alcune storie grandi di mezzo rilievo, finte di bronzo, di cose del Vecchio Testamento, alcune delle quali ancora si veggiono lungarno in casa de' Lanfredini. Sopra seguitavano gl'architravi, fregi e cornicioni, che risaltavano, et appresso varii e bellissimi frontespizii. Negl'angoli poi degl'archi, nelle grossezze e sotto, erano storie dipinte di chiaro scuro di mano d'Andrea del Sarto, e bellissime. Et in somma questa opera del Sansovino fu tale, che veggendola papa Leone disse che era un peccato che così fatta non fusse la vera facciata di quel tempio, che fu cominciata da Arnolfo tedesco.
Fece il medesimo Sansovino nel detto apparato per la venuta di Leone X, oltre la detta facciata, un cavallo di tondo rilievo, tutto di terra e cimatura, sopra un basamento murato, in atto di saltare e con una figura sotto di braccia nove. La quale opera fu fatta con tanta bravura e fierezza, che piacque e fu molto lodata da papa Leone, onde esso Sansovino fu da Iacopo Salviati menato a baciare i piedi al Papa, che gli fece molte carezze. Partito il Papa di Firenze et abboccatosi a Bologna con il re Francesco Primo di Francia, si risolvé tornarsene a Firenze, onde fu dato ordine al Sansovino che facesse un arco trionfale alla porta San Gallo, onde egli non discordando punto da se medesimo, lo condusse simile al-l'altre cose che aveva fatte, cioè bello a maraviglia, pieno di statue e di quadri di pitture ottimamente lavorati. Avendo poi deliberato Sua Santità che si facesse di marmo la facciata di San Lorenzo, mentre che s'aspettava da Roma Raffaello da Urbino et il Buonarruoto, il Sansovino d'ordine del Papa fece un disegno di quella, il quale piacendo assai ne fu fatto fare da Baccio d'Agnolo un modello di legno bellissimo. Et intanto avendone fatto un altro il Buonarruoto, fu a lui et al Sansovino ordinato che andassero a Pietra Santa; dove avendo trovati molti marmi, ma difficili a condursi, persono tanto tempo, che tornati a Firenze trovarono il Papa partito per Roma. Per che andatigli amendue dietro con i loro modelli ciascuno da per sé, giunse a punto Iacopo quando il modello del Buonarruoto si mostrava a Sua Santità in Torre Borgia; ma non gli venne fatto quello che si pensava, perciò che, dove credeva di dovere almeno sotto Michelagnolo far parte di quelle statue, che andavano in detta opera, avendogliene fatto parole il Papa e datogliene intenzione Michelagnolo, s'avide giunto in Roma che esso Buonarruoto voleva essere solo.
Tuttavia, essendosi condotto a Roma, per non tornarsene a Firenze invano, si risolvé fermarsi in Roma e quivi attendere alla scultura et architettura. E così avendo tolta a fare per Giovanfrancesco Martelli fiorentino una Nostra Donna di marmo, maggiore del naturale, la condusse bellissima col putto in braccio, e fu posta sopra un altare dentro alla porta principale di Santo Agostino quando s'entra a man ritta. Il modello di terra della quale statua donò al priore di Roma de' Salviati, che lo pose in una cappella del suo palazzo, sul canto della piazza di San Piero al principio di Borgo Nuovo. Fece poi, non passò molto, per la cappella che aveva fatta fare il reverendissimo cardinale Albonrense nella chiesa delli Spagnuoli in Roma, sopra l'altare una statua di marmo di braccia quattro oltra modo lodatissima, d'un San Iacopo, il quale ha una movenzia molto graziosa et è condotto con perfezzione e giudizio, onde gli arecò grandissima fama, e mentre che faceva queste statue, fece la pianta e modello e poi cominciò a fare murare la chiesa di San Marcello de' frati de' Servi, opera certo bellissima. E seguitando d'essere adoperato nelle cose d'architettura, fece a Messer Marco Coscia una loggia bellissima sulla strada che va a Roma, a Ponte Molle nella via Appia; per la Compagnia del Crocifisso della chiesa di San Marcello un Crocifisso di legno da portare a processione molto grazioso, e per Antonio cardinale di Monte cominciò una gran fabbrica alla sua vigna fuor di Roma, in su l'Acqua vergine. E forse è di mano di Iacopo un molto bel ritratto di marmo di detto cardinal vecchio di Monte, che oggi è nel palazzo del signor Fabiano al Monte San Savino sopra la porta della camera principale di sala. Fece fare ancora la casa di Messer Luigi Leoni molto comoda, et in Banchi un palazzo, che è dalla casa de' Gaddi, il quale fu poi compero da Filippo Strozzi, che certo è comodo e bellissimo e con molti ornamenti.
Essendosi in questo tempo col favore di papa Leone levato sù la nazione fiorentina, a concorrenzia de' Tedeschi e delli Spagnuoli e de' Franzesi, i quali avevono chi finito e chi cominciato in Roma le chiese delle loro nazioni e quelle fatte adornare e cominciate a sfiziare solennemente, aveva chiesto di poter fare ancor essa una chiesa. Di che avendo dato ordine il Papa a Lodovico Capponi, allora consolo della nazione, fu deliberato che dietro Banchi al principio di strada Iulia in sulla riva del Tevere, si facesse una grandissima chiesa e si dedicasse a San Giovanni Batista, la quale per magnificenza, grandezza, spesa, ornamenti e disegno, quella di tutte l'altre nazioni avanzasse. Concorrendo dunque in fare disegni per quest'opera, Raffaello da Urbino, Antonio da San Gallo e Baldassarre da Siena et il Sansovino, veduto che il Papa ebbe i disegni di tutti, lodò come migliore quello del Sansovino, per avere egli oltre all'altre cose fatto su quattro canti di quella chiesa per ciascuno una tribuna e nel mezzo una maggiore tribuna, simile a quella pianta che Sebastiano Serlio pose nel suo secondo libro di architettura. Là onde, concorrendo col volere del Papa tutti i capi della nazione fiorentina con molto favore del Sansovino, si cominciò a fondare una parte di questa chiesa, lunga tutta ventidue canne; ma non vi essendo spazio e volendo pur fare la facciata di detta chiesa in sulla dirittura delle case di strada Iulia, erano necessitati entrare nel fiume del Tevere almeno quindici canne, il che piacendo a molti, per essere maggiore spesa e più superba il fare i fondamenti nel fiume, si mise mano a farli e vi spesero più di quarantamila scudi, che sarebbono bastanti a fare la metà della muraglia della chiesa. Intanto il Sansovino che era capo di questa fabbrica, mentre che di mano in mano si fondava, cascò, e fattosi male d'importanza, si fece dopo alcuni giorni portare a Fiorenza per curar-si, lasciando a quella cura, come s'è detto, per fondare il resto Antonio da San Gallo. Ma non andò molto, che avendo per la morte di Leone perduto la nazione uno apoggio sì grande et un principe tanto splendido, si abandonò la fabrica per quanto durò la vita di papa Adriano VI; poi creato Clemente, per seguitare il medesimo ordine e disegno fu ordinato che il Sansovino ritornasse e seguitasse quella fabrica nel medesimo modo che l'aveva ordinata prima, e così fu rimesso mano a lavorare. Et intanto egli prese a fare la sepoltura del cardinale d'Aragonia, e quella del cardinale Aginense, e fatto già cominciare a lavorare i marmi per gli ornamenti, e fatti molti modelli per le figure, aveva già Roma in poter suo e faceva molte cose per tutti quei signori importantissime, quando Dio per castigo di quella città e per abassare la superbia delli abitatori di Roma permise che venisse Borbone con l'esercito, a' sei giorni di maggio 1527, e che fusse messo a sacco e ferro e fuoco tutta quella città; nella quale rovina, oltre a molti altri belli ingegni che capitarono male, fu forzato il Sansovino a partirsi con suo gran danno di Roma et a fuggirsi in Vinezia, per indi passare in Francia a' servigi del Re, dove era già stato chiamato. Ma trattenendosi in quella città per provedersi molte cose, che di tutte era spogliato, e mettersi a ordine, fu detto al principe Andrea Griti, il quale era molto amico alle virtù, che quivi era Iacopo Sansovino; onde venuto in desiderio di parlargli, perché a punto in que' giorni Domenico cardinale Grimani gli aveva fatto intendere che 'l Sansovino sarebbe stato a proposito per le cupole di San Marco, lor chiesa principale, le quali, e dal fondamento debole, e dalla vecchiaia, e da essere male incatenate, erano tutte aperte e minacciavano rovina, lo fece chiamare, e dopo molte accoglienze e lunghi ragionamenti avuti, gli disse che voleva, e ne lo pregava, che riparasse alla rovina di queste tribune, il che promise il Sansovino di fare e rimediarvi; e così, preso a fare quest'opera, vi fece mettere mano; et accomodato tutte l'armadure di drento e fatto travate a guisa di stelle, puntellò nel cavo del legno di mezzo tutti i legni che tenevano il cielo della tribuna, e con cortine di legnami le ricinse di drento in guisa, che poi di fuora e con catene di ferro stringendole e rinfiancandole con altri muri, e di sotto facendo nuovi fondamenti a' pilastri che le reggevano, le fortificò et asicurò per sempre. Nel che fare fece stupire Vinezia e restare sodisfatto non pure il Gritti, e, che fu più, a quello serenissimo senato rendé tanta chiarezza della virtù sua, che essendo (finita l'opera) morto il protomaestro de' signori procuratori di San Marco, che è il primo luogo che danno quei signori agli ingegnieri et architetti loro, lo diedero a lui con la casa solita e con provisione assai conveniente. Là dove, accettatolo il Sansovino ben volentieri e fermato l'animo, divenne capo di tutte le fabbriche loro, con suo onore e commodo. Fece dunque primamente la fabbrica publica della Zecca, la quale egli disegnò e spartì dentro con tanto ordine e comodità per servizio e comodo di tanti manifattori, che non è in luogo nessuno un erario tanto bene ordinato, né con maggior fortezza di quello, il quale adornò tutto con ordine rustico molto bello, il quale modo, non si essendo usato prima in quella città, rese maraviglia assai agli uomini di quel luogo. Per lo che, conosciuto l'ingegno del Sansovino essere per servizio di quella città atto a ogni loro bisogno, lo feciono attendere molti anni alle fortificazioni dello stato loro. Né passò molto, che seguitò per ordine del Consiglio de' Dieci la bellissima e ricchissima fabrica della libreria di San Marco incontro al palazzo della Signoria, con tanto ordine d'intaglio, di cornici, di colonne, capitegli e mezze figure per tutta l'opera, che è una maraviglia. E tutto si è fatto senza risparmio niuno di spesa, onde costa infino a oggi centocinquantamila ducati et è tenuto molto in pregio in quella città per essere piena di ricchissimi pavimenti, di stucchi e di storie per le sale di quel luogo, e scale publiche adornate di varie pitture, come s'è ragionato nella vita di Batista Franco, oltre a molte altre belle comodità e ricchi ornamenti che ha nella entrata della porta principale, che rendono e maestà e grandezza, mostrando la virtù del Sansovino; il qual modo di fare fu cagione che in quella città, nella quale infino allora non era entrato mai modo se non di fare le case et i palazzi loro con un medesimo ordine, seguitando sempre ciascuno le medesime cose con la medesima misura et usanza vecchia, senza variare secondo il sito che si truovavano o secondo la comodità, fu cagione dico, che si cominciassero a fabricare con nuovi disegni e migliore ordine le cose publiche e le private. Et il primo palazzo che facesse fu quello di Messer Giorgio Cornaro, cosa bellissima e fatta con comodi et ornamenti condecenti, di spesa di scudi settantamila. Da che mosso un altro gentiluomo da Ca' Delfino, ne fece fare al Sansovino un altro minore con spesa di trentamila scudi, lodatissimo e bellissimo. E dopo fece quello del Moro con spesa di ventimila scudi, che fu similmente molto lodato, et appresso molti altri di minore spesa nella città e nel contado. In tanto che si può dire quella magnifica città oggi per quantità e qualità di sontuosi e bene intesi edifizii risplendere et essere in questa parte quello ch'el-l'è per ingegno, industria e virtù di Iacopo Sansovino, che per ciò merita grandissima laude. Essendo con queste opere è stato cagione che i gentiluomini viniziani hanno condotta l'architettura moderna nella loro città, perciò che non solo vi si è fatto quello che è passato per le sue mani, ma molte, anzi infinite altre cose, che sono state condotte da altri maestri che là sono andati ad abitare et hannovi magnifiche cose operato.
Fece ancora Iacopo la fabrica della loggia della piazza di San Marco d'ordine corinto, che è a' piedi del campanile di detto San Marco, con ornamento ricchissimo di colonne e quattro nicchie, nelle quali sono quattro figure grandi quanto il naturale, di bronzo e di somma bellezza. E fa quest'opera quasi una bellissima basa al detto campanile, il quale è largo da piè una delle faccie piedi trentacinque, che tanto incirca è l'ornamento del Sansovino, et alto da terra fino alla cornice dove sono le finestre delle campane piedi centosessanta, dal piano di detta cornice fin all'altra di sopra dove è il corridore sono piedi venticinque, e l'altro dado di sopra è alto piedi ventotto e mezzo; e da questo piano dal corridore fino alla piramide, pigna, o punta che se la chiamino, sono piedi sessanta; in cima della quale punta il quadricello sopra il quale posa l'Angiolo è alto piedi sei; et il detto Angiolo che gira è alto dieci piedi, di maniera che tutta l'altezza viene ad essere piedi duecentonovantadue. Diede ancora il disegno e condusse per la scuola, o vero Fraternita e Compagnia della Misericordia, la fabrica di quel luogo grandissima e di spesa di centocinquantamila scudi. Rifece la chiesa di San Francesco della Vigna, dove stanno i frati de' Zoccoli, opera grandissima e d'importanza. Né per questo, mentre che ha atteso a tante fabriche, ha mai restato che per suo diletto non abbia fatto giornalmente opere grandissime e belle di scultura, di marmo e di bronzo. Sopra la pila dell'acqua santa ne' frati della Ca' Grande è di sua mano una statua fatta di marmo per un San Giovanni Batista, molto bella e lodatissima.
A Padova alla cappella del Santo è una storia grande di marmo, di mano del medesimo, di figure di mezzo rilievo bellissime d'un miracolo di Santo Antonio di Padova, la quale in quel luogo è stimata assai. All'entrare delle scale del palazzo di San Marco fa tuttavia di marmo in forma di due giganti bellissimi, di braccia sette l'uno, un Nettunno et un Marte, mostrando le forze che ha in terra et in mare quella serenissima republica. Fece una bellissima statua d'un Ercole al duca di Ferrara, e nella chiesa di S. Marco fece quattro storie di bronzo di mezzo rilievo, alte un braccio e lunghe uno e mezzo, per mettere a un pergamo, con istorie di quello Evangelista, tenute molto in pregio per la varietà loro. E sopra la porta del medesimo San Marco ha fatto una Nostra Donna di marmo grande quanto il naturale, tenuta cosa bellissima, et alla porta della sagrestia di detto loco è di sua mano la porta di bronzo, divisa in due parti bellissime e con istorie di Gesù Cristo, tutte di mezzo rilievo e lavorate eccellentissimamente; e sopra la porta dello arsenale ha fatto una bellissima Nostra Donna di marmo, che tiene il Figliolo in collo. Le quali tutte opere non solo hanno illustrato et adornato quella republica, ma hanno fatto conoscere giornalmente il Sansovino per eccellentissimo artefice et amare et onorare dalla magnificenza e liberalità di que' signori, e parimente dagl'altri artefici, referendosi a lui tutto quello di scultura et architettura che è stato in quella città al suo tempo operato. E nel vero ha meritato l'eccellenza di Iacopo di essere tenuta nel primo grado in quella città fra gl'artefici del disegno, e che la sua virtù sia stata amata et osservata universalmente dai nobili e dai plebei. Perciò che oltre all'altre cose egli ha, come s'è detto, fatto col suo sapere e giudizio che si è quasi del tutto rinovata quella città et imparato il vero e buon modo di fabricare.
Ma se ella ha ricevuto da lui bellezza et ornamento, egli all'incontro è da lei stato molto benificato. Conciò sia che oltre all'altre cose, egli è vivuto in essa da che prima vi andò insino all'età di settantotto anni sanissimo e gagliardo, e gli ha tanto conferito l'aria e quel cielo, che non ne mostra in un certo modo più che quaranta. E ha veduto e vede d'un suo virtuosissimo figliuolo, uomo di lettere, due nipoti, un maschio et una femmina, sanissimi e belli, con somma sua contentezza. E, che se è più, vive ancora felicissimamente e con tutti que' comodi et agi, che maggiori può avere un par suo. Ha sempre amato gl'artefici, et in particolare è stato amicissimo dell'eccellente e famoso Tiziano, come fu anco, mentre visse, di Messer Pietro Aretino, per le quali cose ho giudicato ben fatto, se bene vive, fare di lui questa onorata memoria, e massimamente che oggimai è per far poco nella scultura.
Ha avuto il Sansovino molti discepoli in Fiorenza: Niccolò detto il Tribolo, come s'è detto, il Solosmeo da Settignano, che finì dalle figure grandi in fuori tutta la sepoltura di marmo ch'è a Monte Casino, dove è il corpo di Piero de' Medici, che affogò nel fiume del Garigliano. Similmente è stato suo discepolo Girolamo da Ferrara detto il Lombardo, del quale s'è ragionato nella vita di Benvenuto Garofalo ferrarese, et il quale, e dal primo Sansovino, e da questo secondo ha imparato l'arte, di maniera che oltre alle cose di Loreto, delle quali si è favellato, e di marmo e di bronzo, ha in Vinezia molte opere lavorato. Costui se bene capitò sotto il Sansovino d'età di trenta anni e con poco disegno, ancora che avesse innanzi lavorato di scultura alcune cose, essendo più tosto uomo di lettere e di corte, che scultore, attese nondimeno di maniera, che in pochi anni fece quel profitto che si vede nelle sue opere di mezzo rilievo che sono nelle fabriche della libreria e loggia del campanile di San Marco, nelle quali opere si portò tanto bene, che poté poi fare da sé solo le statue di marmo et i Profeti che lavorò, come si disse, alla Madonna di Loreto.
Fu ancora discepolo del Sansovino Iacopo Colonna, che morì a Bologna già trenta anni sono lavorando un'opera d'importanza. Costui fece in Vinezia nella chiesa di San Salvadore un San Girolamo di marmo ignudo, che si vede ancora in una nicchia intorno all'organo, che fu bella figura e molto lodata; et a Santa Croce della Giudecca fece un Cristo, pure ignudo di marmo, che mostra le piaghe, con bello artifizio, e parimente a San Giovanni Nuovo tre figure: Santa Dorotea, Santa Lucia e Santa Caterina; et in Santa Marina si vede di sua mano un cavallo con un capitano armato sopra; le quali opere possono stare al pari con quante ne sono in Vinezia. In Padova nella chiesa di Santo Antonio fece di stucco detto Santo e San Bernardino vestiti. Della medesima materia fece a Messer Luigi Cornaro una Minerva, una Venere et una Diana, maggiori del naturale e tutte tonde; di marmo un Mercurio, e di terra cotta un Marzio ignudo e giovinetto, che si cava una spina d'un piè, anzi, mostrando averla cavata, tiene con una mano il piè, guardando la ferita, e con l'altra pare che si voglia nettare la ferita con un panno, la quale opera, perché è la migliore che mai facesse costui, disegna il detto Messer Luigi farla gettare di bronzo. Al medesimo fece un altro Mercurio di pietra, il quale fu poi do-nato al duca Federigo di Mantova.
Fu parimente discepolo del Sansovino Tiziano da Padova, scultore, il quale nella loggia del campanile di San Marco di Vinezia scolpì di marmo alcune figurette, e nella chiesa del medesimo San Marco si vede pur da lui scolpito e gettato di bronzo un bello e gran coperchio di pila di bronzo nella cappella di San Giovanni. Aveva costui fatto la statua d'un San Giovanni, nel quale sono i quattro Evangelisti e quattro storie di San Giovanni con bello artifizio, per gettarla di bronzo, ma morendosi d'anni trentacinque, rimase il mondo privo d'un eccellente e valoroso artefice. È di mano di costui la volta della cappella di Santo Antonino da Padova, con molto ricco partimento di stucco. Aveva cominciato per la medesima un serraglio di cinque archi di bronzo, che erano pieni di storie di quel Santo, con altre figure di mezzo e basso rilievo, ma rimase anco questo per la sua morte imperfetto, e per discordia di coloro che avevano cura di farla fa-re; e n'erano già stati gettati molti pezzi, che riuscivano bellissimi, e fatte le cere per molti altri, quando costui si morì e rimase per le dette cagioni ogni cosa adietro. Il medesimo Tiziano, quando il Vasari fece il già detto apparato per i signori della Compagnia della Calza in Canareio, fece in quello alcune statue di terra e molti termini, e fu molte volte adoperato in ornamenti di scene, teatri, archi et altre cose simili, con suo molto onore, avendo fatto cose tutte piene d'in-venzioni, capricci e varietà, e sopra tutto con molta prestezza.
Pietro da Salò fu anch'egli discepolo del Sansovino, et avendo durato a intagliare fogliami infino alla sua età di trenta anni, finalmente aiutato dal Sansovino, che gli insegnò, si diede a fare figure di marmo. Nel che si compiacque e studiò di maniera, che in due anni faceva da sé, come ne fanno fede alcune opere assai buone, che di sua mano sono nella tribuna di San Marco; e la statua d'un Marte maggiore del naturale, che è nella facciata del palazzo publico, la quale statua è in compagnia di tre altre di mano di buoni artefici. Fece ancora nelle stanze del Consiglio de' Dieci due figure, una di maschio e l'altra di femina, in compagnia d'altre due fatte dal Danese Cataneo, scultore di somma lode, il quale, come si dirà, fu anch'egli discepolo del Sansovino, le quali figure sono per ornamento d'un camino. Fece oltre ciò Pietro tre figure che sono a Santo Antonio, maggiori del vivo e tutte tonde, e sono una Giustizia, una Fortezza e la statua d'un capitano generale dell'armata viniziana, condotte con buona pratica. Fece ancora la statua d'una Iustizia che ha bella attitudine e buon disegno, posta sopra una colonna nella piazza di Murano, et un'altra nella piazza del Rialto di Vinezia, per sostegno di quella pietra dove si fanno i bandi publici, che si chiama il Gobbo di Rialto, le quali opere hanno fatto costui conoscere per bonissimo scultore. In Padova nel Santo fece una Tetide molto bella et un Bacco che prieme un grappol d'uva in una tazza, e questa, la quale fu la più dificile figura che mai facesse e la migliore, morendo lassò a' suoi figliuoli, che l'hanno ancora in casa per venderla a chi meglio conoscerà e pagherà le fatiche, che in quella fece il loro padre.
Fu parimente discepolo di Iacopo, Alessandro Vittoria da Trento, scultore molto eccellente et amicissimo degli studii, il quale con bellissima maniera ha mostro in molte cose che ha fatto, così di stucco, come di marmo, vivezza d'in-gegno e bella maniera, e che le sue opere sono da essere tenute in pregio. E di mano di costui sono in Vinezia alla porta principale della libreria di S. Marco due feminone di pietra alte palmi dieci l'una, che sono molto belle, graziose e da esser molto lodate. Ha fatto nel Santo di Padova alla sepoltura Conterina quattro figure: duoi schiavi o vero prigioni con una Fama et una Tetis tutte di pietra; et uno Angiolo piedi dieci alto, il quale è stato posto sopra il campanile del Duomo di Verona, che è molto bella statua; et in Dalmazia mandò pure di pietra quattro Apostoli nel Duomo di Treù, alti cinque piedi l'uno. Fece ancora alcune figure d'argento per la scuola di San Giovanni Evangelista di Vinezia, molto graziose, le quali erano tutte di tondo rilievo, et un San Teodoro d'argento di piedi due, tutto tondo; lavorò di marmo nella cappella Grimana a San Sebastiano due figure, alte tre piedi l'una, et appresso fece una Pietà con due figure di pietra tenute buone, che sono a San Salvadore in Vinezia. Fece un Mercurio al pergamo di palazzo di San Marco, che risponde sopra la piazza, tenuto buona figura. Et a San Francesco della Vigna fece tre figure grandi quanto il naturale, tutte di pietra, molto belle, graziose e ben condotte, Santo Antonio, San Sebastiano e Santo Rocco, e nella chiesa de' Crocicchieri fece di stucco due figure alte sei piedi l'una, poste all'altare maggiore, molto belle, e della medesima materia fece, come già s'è detto, tutti gli ornamenti che sono nelle volte delle scale nuove del palazzo di San Marco, con vari partimenti di stucchi, dove Batista Franco dipinse poi ne' vani dove sono le storie, le figure e le grottesche che vi sono. Parimente fece Alessandro quelle delle scale della libreria di San Marco, tutte opere di gran fattura, e ne' frati minori una cappella, e nella tavola di marmo, che è bellissima e grandissima, l'assunzione della Nostra Donna di mezzo rilievo con cinque figurone a basso, che hanno del grande e son fatte con bella maniera, grave e bello andare di panni e condotte con diligenzia. Le quali figure di marmo sono San Ieronimo, San Giovanbatista, San Pietro, Santo Andrea e San Lionardo, alte sei piedi l'una, e le migliori di quante opere ha fatto infin a ora. Nel finimento di questa cappella sul frontespizio sono due figure pure di marmo, molto graziose et alte otto piedi l'una. Il medesimo Vittoria ha fatto molti ritratti di marmo e bellissime teste e somigliano, cioè quella del signor Giovanbatista Feredo, posta nella chiesa di Santo Stefano, quella di Camillo Trevisano oratore, posta nella chiesa di San Giovanni e Polo, il clarissimo Marcantonio Grima-ni, anch'egli posto nella chiesa di San Sebastiano, et in San Gimignano il piovano di detta chiesa. Ha parimente ritratto Messer Andrea Loredano, Messer Priamo da Lagie, e dua fratelli da Ca' Pellegrini oratori, cioè Messer Vincenzio e Messer Giovanbatista. E perché il Vittoria è giovane e lavora volentieri, virtuoso, affabile, disideroso d'acquistare nome e fama et insomma gentilissimo, si può credere che vivendo si abbia a vedere di lui ogni giorno bellissime opere e degne del suo cognome Vettoria, e che vivendo abbia a essere eccellentissimo scultore e meritare sopra gl'altri di quel pa-ese la palma.
Ecci ancora un Tommaso da Lugano scultore, che è stato anch'egli molti anni col Sansovino et ha fatto con lo scarpello molte figure nella libreria di San Marco in compagnia d'altri, come s'è detto, e molto belle. E poi, partito dal Sansovino, ha fatto da sé una Nostra Donna col Fanciullo in braccio et a' piedi San Giovannino, che sono figure tutte e tre di sì bella forma, attitudine e maniera, che possono stare fra tutte l'altre statue moderne belle che sono in Venezia, la quale opera è posta nella chiesa di San Bastiano. Et una testa di Carlo Quinto imperatore, la quale fece costui di marmo dal mezzo in su, è stata tenuta cosa maravigliosa e fu molto grata a sua maestà. Ma perché Tommaso si è dilettato più tosto di lavorare di stucco che di marmo o bronzo, sono di sua mano infinite bellissime figure et opere fatte da lui di cotal materia in casa diversi gentiluomini di Vinezia; e questo basti avere detto di lui.
Finalmente de' lombardi ci resta a far memoria di Iacopo bresciano giovane di ventiquattro anni che s'è partito non è molto dal Sansovino, et il quale ha dato saggio a Vinezia in molti anni che v'è stato di essere ingegnoso e di dovere riuscire eccellente, come poi è riuscito nell'opere che ha fatto in Brescia sua patria, e particolarmente nel palazzo publico: ma se studia e vive si vedranno anco di sua mano cose maggiori e migliori, essendo spiritoso e di bellissimo ingegno.
De' nostri toscani è stato discepolo del Sansovino Bartolomeo Amannati fiorentino, del quale in molti luoghi di que-st'opera s'è già fatto memoria. Costui dico lavorò sotto il Sansovino in Vinezia e poi in Padova per Messer Marco da Mantova, eccellentissimo dottore di medicina, in casa del quale fece un grandissimo gigante nel suo cortile di un pezzo di pietra e la sua sepoltura con molte statue. Dopo venuto l'Amannato a Roma l'anno 1550, gli furono allogate da Giorgio Vasari quattro statue di braccia quattro l'una di marmo per la sepoltura del cardinale de' Monti vecchio, la quale papa Iulio Terzo aveva allogata a esso Giorgio nella chiesa di San Pietro a Montorio, come si dirà, le quali statue furono tenute molto belle, per che avendogli il Vasari posto amore, lo fece conoscere al detto Iulio Terzo, il quale avendo ordinato quello fusse da fare, lo fece mettere in opera, e così ambidue, cioè il Vasari e l'Amannato, per un pezzo lavorarono insieme alla vigna. Ma non molto dopo che il Vasari fu venuto a servire il duca Cosimo a Fiorenza, essendo morto il detto Papa, l'Amannato, che si trovava senza lavoro et in Roma da quel Pontefice essere male stato sodisfatto delle sue fatiche, scrisse al Vasari, pregandolo che come l'aveva aiutato in Roma, così volesse aiutarlo in Fiorenza appresso al Duca. Onde el Vasari adoperandosi in ciò caldamente, lo condusse al servizio di sua eccellenza per cui ha molte statue di marmo e di bronzo, che ancora non sono in opera, lavorate. Per lo giardino di Castello ha fatto due figure di bronzo maggiori del vivo, cioè Ercole che fa scoppiare Anteo, al quale Anteo, invece dello spirito, esce acqua in gran copia per bocca. Finalmente ha condotto l'Amannato il colosso di Nettunno di marmo che è in piazza, alto braccia dieci e mezzo. Ma perché l'opera della fonte a cui ha da stare in mezzo il detto Nettunno non è finita, non ne dirò altro. Il medesimo Amannato, come architetto, attende, con suo molto onore e lode, alla fabbrica de' Pitti, nella quale opera ha grande occasione di mostrare la virtù e grandezza dell'animo suo, e la magnificenza e grande animo del duca Cosimo. Direi molti particolari di questo scultore, ma perché mi è amico, et altri secondo che intendo scrive le cose sue, non dirò altro per non mettere mano a quello che da altri fie meglio, che io forse non saprei raccontarlo.
Restaci per ultimo de' discepoli del Sansovino a far menzione del Danese Cataneo scultore da Carrara, il quale essendo anco piccol fanciullo stette con esso lui a Vinezia, e partitosi d'anni diciannove dal detto suo maestro, fece da per sé in San Marco un fanciullo di marmo, et un San Lorenzo nella chiesa de' frati minori, a San Salvadore un altro fanciullo di marmo, et a San Giovanni e Polo la statua d'un Bacco ignudo, che preme un grappol d'uva d'una vite che s'ag-gira intorno a un tronco che ha dietro alle gambe, la quale statua è oggi in casa de' Mozzanighi da San Barnaba. Ha lavorato molte figure per la libreria di San Marco e per la loggia del campanile insieme con altri, de' quali si è di sopra favellato, et oltre le dette, quelle due che già si disse essere nelle stanze del Consiglio de' Dieci. Ritrasse di marmo il cardinale Bembo et il Contarino capitan generale dell'armata viniziana, i quali ambidue sono in Santo Antonio di Padova, con belli e ricchi ornamenti a torno. E nella medesima città di Padova in San Giovanni di Verdara è di mano del medesimo il ritratto di Messer Girolamo Gigante iureconsulto dottissimo. A Vinezia ha fatto in Santo Antonio della Giudecca il ritratto naturalissimo del Giustiniano, luogotenente del gran mastro di Malta, e quello del Tiepolo stato tre volte generale: ma queste non sono anco state messe ai luoghi loro. Ma la maggiore opera e più segnalata che abbia fatta il Danese è stato in Verona a Santa Anastasia una cappella di marmi ricca, e con figure grandi, al signor Ercole Fregoso in memoria del signor Iano, già signor di Genova e poi capitano generale de' viniziani, al servizio de' quali morì. Questa opera è d'ordine corinto in guisa d'arco trionfale, e divisata da quattro gran colonne tonde striate, con i capitegli a foglie di oliva, che posano sopra un basamento di conveniente altezza, facendo il vano del mezzo largo una volta più che uno di quelli dalle bande, con un arco fra le colonne, sopra il quale posa in su capitegli l'architrave e la cornice, e nel mezzo dentro all'arco uno ornamento molto bello di pilastri con cornice e frontespizio, col campo d'una tavola di paragone nero bellissimo, dove è la statua d'un Cristo ignudo maggior del vivo, tutta tonda e molto buona figura, la quale statua sta in atto di mostrare le sue piaghe, con un pezzo di panno rilegato nei fianchi fra le gambe e fino in terra. Sopra gl'angoli dell'arco sono segni della sua Passione, e tra le due colonne, che sono dal lato destro, sta sopra un basamento una statua tutta tonda, fatta per il signor Iano Fregoso tutta armata all'antica, salvo che mostra le braccia e le gambe nude, e tiene la man manca sopra il pomo della spada, che ha cinta, e con la destra il bastone [di] generale, a-vendo dietro per investitura, che va dreto alle colonne, una Minerva di mezzo rilievo, che stando in aria tiene con una mano una bacchetta ducale, come quella de' dogi di Vinezia, e con l'altra una bandiera, drentovi l'insegna di San Marco, e tra l'altre due colonne nell'altra investitura è la Virtù militare armata col cimiero in capo, con il semprevivo sopra e con l'impresa nella corazza d'uno ermellino che sta sopra uno scoglio circondato dal fango, con lettere che dicano: “Potius mori quam faedari”, e con l'insegna Fregosa; e sopra è una Vittoria con una ghirlanda di lauro et una palma nelle mani. Sopra la colonna, architrave, fregio e cornice è un altro ordine di pilastri, sopra le cimase de' quali stanno due figure di marmo tonde e due trofei pur tondi e della grandezza delle altre figure.
Di queste due statue una è la Fama in atto di levarsi a volo, accennando con la man dritta al cielo e con una tromba che suona, e questa ha sottili e bellissimi panni attorno e tutto il resto ignuda, e l'altra è fatta per la Eternità, la quale è vestita con abito più grave e sta in maestà, tenendo nella man manca un cerchio dove ella guarda, e con la destra piglia un lembo di panno dentrovi palle, che denotano vari secoli, con la sfera celeste cinta dalla serpe, che con la bocca piglia la coda; nello spazio del mezzo sopra il cornicione che fa fare e mette in mezzo queste due parti, sono tre scaglioni do-ve seggano due putti grandi et ignudi, i quali tengono un grande scudo con l'elmo sopra, drentovi l'insegna Fregosa, e sotto i detti scalini è di paragone un epitaffio di lettere grandi dorate. La quale tutta opera è veramente degna d'essere lodata, avendola il Danese condotta con molta diligenza, e dato bella proporzione e grazia a quel componimento, e fatto con gran studio ciascuna figura. È il Danese non pure, come s'è detto, eccellente scultore, ma anco buono e molto lodato poeta, come l'opere sue ne dimostrano apertamente, onde ha sempre praticato et avuto stretta amicizia con i maggiori uomini e più virtuosi dell'età nostra. E di ciò anco sia argomento questa detta opera, da lui stata fatta molto poeticamente. È di mano del Danese nel cortile della Zecca di Vinezia, sopra l'ornamento del pozzo, la statua del Sole ignuda, in cambio della quale vi volevano que' signori una Iustizia, ma il Danese considerò che in quel luogo il Sole è più a proposito. Questa ha una verga d'oro nella mano manca et uno scetro nella destra, a sommo al quale fece un occhio, et i razzi solari attorno alla testa, e sopra la palla del mondo, circondata dalla serpe che si tiene in bocca la coda, con alcuni monticelli d'oro per detta palla generati da lui. Arebbevi voluto fare il Danese due altre statue, e quella della Luna per l'argento e quella del Sole per l'oro, et un'altra per lo rame, ma bastò a que' signori che vi fusse quella dell'oro, come del più perfetto di tutti gl'altri metalli.
Ha cominciato il medesimo Danese un'altra opera in memoria del principe Loredano, doge di Vinezia, nella quale si spera che di gran lunga abbia a passare d'invenzione e capriccio tutte l'altre sue cose. La quale opera deve essere posta nella chiesa di San Giovanni e Polo di Vinezia. Ma perché costui vive e va tuttavia lavorando a benefizio del mondo e dell'arte, non dirò altro di lui, né d'altri discepoli del Sansovino. Non lascerò già di dire brevemente d'alcuni altri eccellenti artefici scultori e pittori di quelle parti di Vinezia, con l'occasione dei sopra detti, per porre fine a ragionare di loro in questa vita del Sansovino.
Ha dunque avuto Vicenza in diversi tempi ancor ch'essa, scultori, pittori et architetti, d'una parte de' quali si fece memoria nella vita di Vittore Scarpaccia, e massimamente di quei che fiorirono al tempo del Mantegna e che da lui impararono a disegnare, come furono Bartolomeo Mantegna, Francesco Veruzio e Giovanni Speranza pittori. Di mano de' quali sono molte pitture sparse per Vicenza. Ora nella medesima città sono molte sculture di mano d'un Giovanni intagliatore et architetto, che sono ragionevoli ancor che la sua propria professione sia stata di fare ottimamente fogliami et animali, come ancora fa, se bene è vecchio. Parimente Girolamo Pironi vicentino ha fatto in molti luoghi della sua città opere lodevoli di scultura e pittura. Ma fra tutti i vicentini merita di essere sommamente lodato Andrea Palladio architetto, per essere uomo di singolare ingegno e giudizio, come ne dimostrano molte opere fatte nella sua patria et altrove, e particolarmente la fabrica del palazzo della Comunità, che è molto lodata, con due portici di componimento dorico fatti con bellissime colonne. Il medesimo ha fatto un palazzo molto bello e grandissimo oltre ogni credere al conte Ottavio de' Vieri, con infiniti ricchissimi ornamenti. Et un altro simile al conte Giuseppo di Porto, che non può essere né più magnifico, né più bello, né più degno d'ogni gran principe di quello che è. Et un altro se ne fa tuttavia con ordine del medesimo al conte Valerio Coricatto, molto simile per maestà e grandezza all'antiche fabriche tanto lodate. Similmente ai conti di Valmorana ha già quasi condotto a fine un altro superbissimo palazzo, che non cede a niuno dei sopra detti in parte veruna.
Nella medesima città, sopra la piazza detta volgarmente l'Isola, ha fatto un'altra molto magnifica fabbrica al signor Valerio Chireggiolo, et a Pugliano villa del Vicentino una bellissima casa al Signor Bonifazio Pugliana cavaliere, e nel medesimo contado di Vicenza, al Finale, ha fatto a Messer Biagio Saraceni un'altra fabbrica, et una a Bagnolo al signor Vittore Pisani con ricchissimo e gran cortile d'ordine dorico, con bellissime colonne. Presso a Vicenza nella villa di Lisiera ha fabricato al signor Giovanfrancesco Valmorana un altro molto ricco edifizio con quattro torri in sui canti, che fanno bellissimo vedere. A Meledo altresì ha principiato al conte Francesco Trissino e Lodovico suo fratello un magnifico palazzo, sopra un colle assai rilevato, con molti spartimenti di loggie, scale et altre comodità da villa. A Campiglia, pure sul Vicentino, fa al signor Mario Ropetta un'altra simile abitura, con tanti comodi, ricchi partimenti di stanze, loggie e cortili e camere dedicate a diverse Virtù, ch'ella sarà tosto condotta che fie al suo fine stanza più regia che signorile. A Lunede n'ha fatto un'altra da villa al signor Girolamo de' Godi, et a Ugurano un'altra al conte Iacopo Angarano che è veramente bellissima, come che paia piccola cosa al grande animo di quel signore. A Quinto, presso a Vicenza fabricò anco, non ha molto, un altro palagio al conte Marcantonio Triene, che ha del grande e del magnifico quanto più non saprei dire. Insomma ha tante grandissime e belle fabriche fatto il Palladio dentro e fuori di Vicenza, che quando non vi fussero altre, possono bastare a fare una città onoratissima et un bellissimo contado.
In Vinezia ha principiato il medesimo molte fabriche, ma una sopra tutte, che è maravigliosa e notabilissima, a imitazione delle case che solevano far gl'antichi, nel monasterio della Carità. L'atrio di questa è largo piedi quaranta e lungo 54, che tanto è a punto il diametro del quadrato, essendo le sue ali una delle tre parti e mezzo della lunghezza. Le colonne, che sono corinte, sono grosse piedi tre e mezzo et altre 35. Dall'atrio si va nel peristilio, cioè in un claustro (così chiamano i frati i loro cortili) il quale dalla parte di verso l'atrio è diviso in cinque parti e dai fianchi in sette, con tre ordini di colonne l'un sopra l'altro, che il dorico è di sotto, e sopra il ionico et il corinto. Dirimpetto all'atrio è il refettorio, lungo due quadri e alto insino al piano del peristilio, con le sue officine intorno commodissime. Le scale sono a lumaca et in forma ovale, e non hanno né muro, né colonna, né parte di mezzo che le regga, sono larghe piedi tredici, e gli scalini nel posare si reggono l'un l'altro per essere fitti nel muro. Questo edifizio è tutto fatto di pietre cotte, cioè mattoni, salvo le base delle colonne, i capitegli, l'imposte degl'archi, le scale, le superficie delle cornici e le finestre tutte e le porte.
Il medesimo Palladio ai monaci neri di San Benedetto, nel loro monasterio di San Giorgio Maggiore di Vinezia, ha fatto un grandissimo e bellissimo refettorio col suo ricetto innanzi, et ha cominciato a fondare una nuova chiesa, con sì bell'ordine, secondo che mostra il modello, che se fie condotto a fine riuscirà opera stupenda e bellissima. Ha oltre ciò cominciato la facciata della chiesa di S. Francesco della Vigna, la quale fa fare di pietra istriana il reverendissimo Grimani, patriarca d'Aquileia, con molto magnifica spesa. Sono le colonne larghe da piè palmi quattro et alte quaranta d'ordine corinto, e di già è murato da piè tutto l'imbasamento. Alle Gambaraie, luogo vicino a Vinezia sette miglia, in sul fiume della Brenta ha fatto l'istesso Palladio una molto comoda abitazione a Messer Niccolò e Messer Luigi Foscari, gentiluomini viniziani. Un'altra n'ha fatta a Marocco villa del Mestrino al cavalier Mozzenigo. A Piombino una a Messer Giorgio Cornaro, una alla Montagnama al magnifico Messer Francesco Pisani, et a Zigogiari in sul Padovano una al conte Adovardo da Tiene gentiluomo vicentino; in Udine del Friuli una al signor Floriano Antimini; alla Mota, castel pure del Friuli, una al magnifico Messer Marco Zeno, con bellissimo cortile e portici intorno intorno. Alla Fratta, castel del Polesine, una gran fabrica al signor Francesco Badoaro, con alcune logge bellissime e capricciose; similmente vicino ad Asolo, castello del Trevisano, ha condotto una molto comoda abitazione al reverendissimo signor Daniello Barbaro, eletto d'Aquileia, che ha scritto sopra Vitruvio, et al clarissimo Messer Marcantonio suo fratello, con tanto bell'ordine, che meglio e più non si può imaginare, e fra l'altre cose vi ha fatto una fontana molto simile a quella che fece fare papa Giulio in Roma alla sua vigna Giulia, con ornamenti per tutto di stucchi e pitture fatti da maestri eccellenti. In Genova ha fatto Messer Luca Giustiniano una fabrica con disegno del Palladio, che è tenuta bellissima, come sono anco tutte le sopra scritte, delle quali sarebbe stata lunghissima storia voler raccontare molti particolari di belle e strane invenzioni e capricci. E perché tosto verrà in luce un'opera del Palladio, dove saranno stampati due libri d'edifizii antichi et uno di quelli che ha fatto egli stesso edificare, non dirò altro di lui, perché questa basterà a farlo conoscere per quello eccellente architetto ch'egli è tenuto da chiunche vede l'opere sue bellissime, senzaché essendo anco giovane et attendendo continuamente agli studii dell'arte, si possono sperare ogni giorno di lui cose maggiori.
Non tacerò che a tanta virtù ha congiunta una sì affabile e gentil natura, che lo rende appresso d'ognuno amabilissimo. Onde ha meritato d'essere stato accettato nel numero degl'Accademici del disegno fiorentini, insieme col Danese, Giuseppo Salviati, il Tintoretto e Batista Farinato da Verona, come si dirà in altro luogo, parlando di detti Accademici.
Bonifazio pittore viniziano, del quale non ho prima avuto cognizione, è degno anch'esso di essere nel numero di tanti eccellenti artefici annoverato per essere molto pratico e valente coloritore. Costui oltre a molti quadri e ritratti, che sono per Vinezia, ha fatto nella chiesa de' Servi della medesima città, all'altare delle reliquie, una tavola dove è un Cristo con gl'Apostoli intorno, e Filippo che par che dica: “Domine ostende nobis patrem”; la quale è condotta con molto bella e buona maniera. E nella chiesa delle monache dello Spirito Santo, all'altare della Madonna, ha fatto un'altra bellissima tavola con una infinità d'uomini, donne e putti d'ogni età, che adorano insieme con la Vergine un Dio Padre che è in aria con molti Angeli attorno.
E anco pittore di assai buon nome in Vinezia Iacopo Fallaro, il quale ha nella chiesa degl'Ingesuati fatto ne' portegli dell'organo il beato Giovanni Colombini che riceve in Concistoro l'abito del Papa con buon numero di cardinali. Un altro Iacopo, detto Pisbolica, in Santa Maria Maggiore di Vinezia ha fatto una tavola nella quale è Cristo in aria con molti Angeli, et a basso la Nostra Donna con gl'Apostoli; et un Fabrizio viniziano nella chiesa di Santa Maria Sebenico ha dipinto nella facciata d'una cappella una benedizione della fonte del battesimo, con molti ritratti di naturale fatti con bella grazia e buona maniera.
IL FINE DELLA VITA DI IACOPO SANSOVINO SCULTORE FIORENTINO
VITA DI LIONE LIONI ARETINO
E D'ALTRI SCULTORI ET ARCHITETTI
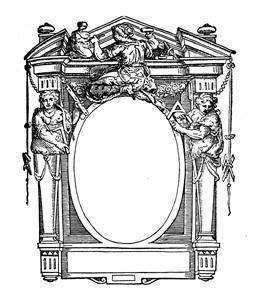
Perché quello che si è detto sparsamente di sopra del cavalier Lione scultore aretino si è detto incidentemente, non fia se non bene che qui si ragioni con ordine dell'opere sue, degne veramente di essere celebrate e di passare alla memoria degl'uomini. Costui dunque avendo a principio atteso all'orefice e fatto in sua giovanezza molte bell'opere, e particolarmente ritratti di naturale in conii d'acciaio per medaglie, divenne in pochi anni in modo eccellente, che venne in cognizione di molti prìncipi e grand'uomini, et in particolare di Carlo Quinto imperatore, dal quale fu messo, conosciuta la sua virtù, in opere di maggiore importanza che le medaglie non sono.
Conciò sia che fece, non molto dopo che venne in cognizione di Sua Maestà, la statua di esso Imperatore tutta tonda di bronzo maggiore del vivo, e quella poi con due gusci sottilissimi vestì d'una molto gentile armatura, che se gli lieva e veste facilmente e con tanta grazia, che chi la vede vestita non s'accorge e non può quasi credere ch'ella sia ignuda, e quando è nuda niuno crederebbe agevolmente ch'ella potesse così bene armarsi già mai. Questa statua posa la gamba sinistra e con la destra calca il Furore, il quale è una statua a giacere incatenata con la face e con arme sotto di varie sor-ti. Nella base di quest'opera, la quale è oggi in Madril, sono scritte queste parole: “Caesaris virtute Furor domitus”.
Fece dopo queste statue Lione un conio grande per stampare medaglie di Sua Maestà con il rovescio de' giganti fulminati da Giove. Per le quali opere donò l'Imperatore a Lione un'entrata di centocinquanta ducati l'anno in sulla Zecca di Milano, una comodissima casa nella contrada de' Moroni, e lo fece cavaliere e di sua famiglia con dargli molti privilegii di nobiltà per i suoi descendenti. E mentre stette Lione con Sua Maestà in Bruselles ebbe le stanze nel proprio palazzo dell'Imperatore che talvolta per diporto l'andava a vedere lavorare. Fece non molto dopo di marmo un'altra statua pur dell'Imperatore, e quelle dell'Imperatrice, del re Filippo et un busto dell'istesso Imperatore da porsi in alto in mezzo a due quadri di bronzo. Fece similmente di bronzo la testa della reina Maria, quella di Ferdinando allora re de' romani, e di Massimiliano suo figliuolo, oggi Imperatore, quella della reina Leonora e molti altri, che furono poste nella galleria del palazzo di Bindisi da essa reina Maria, che le fé fare. Ma non vi stettono molto, perché Enrico re di Francia vi apiccò fuoco per vendetta, lasciandovi scritto queste parole: “Vela Fole Maria”; dico per vendetta, perciò che essa Reina pochi anni innanzi aveva fatto a lui il medesimo. Comunche fusse l'opera di detta galleria non andò innanzi, e le dette statue sono oggi parte in palazzo del Re catolico a Madril e parte in Alicante, porto di mare. Donde le voleva Sua Maestà far porre in Granata, dove sono le sepolture di tutti i re di Spagna. Nel tornare Lione di Spagna se ne portò duemila scudi contanti, oltre a molti altri doni e favori, che gli furono fatti in quella corte.
Ha fatto Lione al duca d'Alva la testa di lui, quella di Carlo Quinto e quella del re Filippo. Al reverendissimo d'A-ras, oggi gran cardinale, detto Granvela, ha fatto alcuni pezzi di bronzo in forma ovale di braccia due l'uno, con ricchi partimenti e mezze statue dentrovi. In uno è Carlo Quinto, in un altro il re Filippo, e nel terzo esso Cardinale, ritratti di naturale, e tutte hanno imbasamenti di figurette graziosissime. Al signor Vespasiano Gonzaga ha fatto sopra un gran busto di bronzo il ritratto d'Alva, il quale ha posto nelle sue case a Sabbioneto. Al signor Cesare Gonzaga ha fatto pur di metallo una statua di quattro braccia, che ha sotto un'altra figura che è aviticchiata con un'Idra, per figurare don Ferrante suo padre, il quale con la sua virtù e valore superò il vizio e l'invidia, che avevano cercato porlo in disgrazia di Carlo, per le cose del governo di Milano. Questa statua, che è togata e parte armata all'antica e parte alla moderna, deve essere portata e posta a Guastalla per memoria di esso don Ferrante, capitano valorosissimo. Il medesimo ha fatto, come s'è detto in altro luogo, la sepoltura del signore Giovanni Iacopo Medici marchese di Marignano, fratello di papa Pio Quarto, che è posta nel Duomo di Milano, lunga ventotto palmi in circa et alta quaranta. Questa è tutta di marmo di Carrara et ornata di quattro colonne, due nere e bianche, che come cosa rara furono dal Papa mandate da Roma a Milano, e due altre maggiori, che sono di pietra macchiata, simile al diaspro. Le quali tutte e quatro sono concordate sotto una medesima cornice, con artifizio non più usato, come volle quel Pontefice, che fece fare il tutto con ordine di Michelagnolo, eccetto però le cinque figure di bronzo, che vi sono di mano di Lione. La prima delle quali, maggiore di tutte, è la statua di esso Marchese in piedi e maggiore del vivo, che ha nella destra il bastone del generalato, e l'altra sopra un elmo, che è in sur un tronco molto riccamente ornato; alla sinistra di questa è una statua minore, per la Pace et alla destra un'altra fatta per la Virtù militare: e queste sono a sedere et in aspetto tutte meste e dogliose; l'altre due, che sono in alto, una è la Providenza e l'altra la Fama, e nel mezzo al pari di queste è in bronzo una bellissima Natività di Cristo di basso rilievo. In fine di tutta l'opera sono due figure di marmo, che reggono un'arme di palle di quel signore. Questa opera fu pagata scudi 7800 secondo che furono d'accordo in Roma l'illustrissimo cardinal Morone et il signor Agabrio Serbelloni. Il medesimo ha fatto al signor Giovambatista Castaldo una statua pur di bronzo che dee esser posta in non so qual monasterio, con alcuni ornamenti.
Al detto Re catolico ha fatto un Cristo di marmo, alto più di tre braccia, con la croce e con altri misteri della Passione, che è molto lodata. E finalmente ha fra mano la statua del signor Alfonso Davalo, marchese famosissimo del Guasto, statagli allogata dal marchese di Pescara suo figliuolo, alta quattro braccia e da dover riuscire ottima figura di getto, per la diligenza che mette in farla, e buona fortuna che ha sempre avuto Lione ne' suoi getti. Il quale Lione per mostrare la grandezza del suo animo, il bello ingegno che ha avuto dalla natura et il favore della fortuna, ha con molta spesa condotto di bellissima architettura un casotto nella contrada de' Moroni, pieno in modo di capricciose invenzioni, che non n'è forse un altro simile in tutto Milano. Nel partimento della facciata sono sopra a' pilastri sei prigioni di braccia sei l'uno tutti di pietra viva, e fra essi in alcune nicchie, fatte a imitazione degl'antichi, con terminetti, finestre e cornici tutte varie da quel che s'usa e molto graziose, e tutte le parti di sotto corrispondono con bell'ordine a quelle di sopra, le fregiature sono tutte di varii stromenti dell'arti del disegno. Dalla porta principale, mediante un andito si entra in un cortile, dove nel mezzo, sopra quattro colonne, è il cavallo con la statua di Marco Aurelio formato di gesso da quel proprio che è in Campidoglio. Dalla quale statua ha voluto che quella sua casa sia dedicata a Marco Aurelio. E quanto ai prigioni, quel suo capriccio da diversi è diversamente interpretato. Oltre al qual cavallo, come in altro luogo s'è detto, ha in quella sua bella e comodissima abitazione formate di gesso quant'opere lodate di scultura o di getto ha potuto avere,
o moderne, o antiche.
Un figliuolo di costui chiamato Pompeo, il quale è oggi al servizio del re Filippo di Spagna, non è punto inferiore al padre in lavorare conii di medaglie d'acciaio e far di getto figure maravigliose. Onde in quella corte è stato concorrente di Giovanpaulo Poggini fiorentino, il quale sta anch'egli a' servigi di quel Re et ha fatto medaglie bellissime. Ma Pompeo avendo molti anni servito quel Re, disegna tornarsene a Milano a godere la sua casa aureliana e l'altre fatiche del suo eccellente padre, amorevolissimo di tutti gl'uomini virtuosi.
E per dir ora alcuna cosa delle medaglie e de' conii d'acciaio con che si fanno, io credo che si possa con verità affermare i moderni ingegni avere operato quanto già facessero gl'antichi romani nella bontà delle figure, e che nelle lettere et altre parti gl'abbiano superato. Il che si può vedere chiaramente, oltre molti altri, in dodici rovesci che ha fatto ultimamente Pietro Paulo Galeotti nelle medaglie del duca Cosimo, e sono questi: Pisa quasi tornata nel suo primo essere, per opera del Duca, avendole egli asciutto il paese intorno e seccati i luoghi paludosi e fattole altri assai miglioramenti; l'acque condotte in Firenze da luoghi diversi; la fabrica de' magistrati ornata e magnifica per comodità publica; l'unione degli stati di Fiorenza e Siena; l'edificazione d'una città e dua fortezze nell'Elba; la colonna condotta da Roma e posta in Fiorenza in sulla piazza di Santa Trinita; la conservazione fine et augumentazione della libreria di San Lorenzo per utilità publica; la fondazione de' cavalieri di Santo Stefano; la rinunzia del governo al principe; le fortificazioni dello stato; la milizia o vero bande del suo stato; il palazzo de' Pitti con giardini, acque e fabrica, condotto sì magnifico e regio, de' quali rovesci non metto qui né le lettere che hanno a torno né la dichiarazion loro, avendo a trattarne in altro luogo. I quali tutti dodici rovesci sono belli affatto e condotti con molta grazia e diligenza, come è anco la testa del Duca, che è di tutta bellezza; parimente i lavori e medaglie di stucchi, come ho detto altra volta, si fanno oggi di tutta perfezzione.
Et ultimamente Mario Capocaccia anconetano ha fatti di stucchi di colore in scatolette ritratti e teste veramente bellissime, come sono un ritratto di papa Pio Quinto, ch'io vidi non ha molto, e quello del cardinale Alessandrino. Ho veduto anco di mano de' figliuoli di Pulidoro pittore perugino ritratti della medesima sorte bellissimi.
Ma per tornare a Milano, riveggendo io un anno fa le cose del Gobbo scultore, del quale altrove si è ragionato, non viddi cosa che fussi se non ordinaria, eccetto un Adamo et Eva, una Iudith et una Santa Elena di marmo che sono intorno al Duomo con altre statue di due morti, fatte per Lodovico detto il Moro e Beatrice sua moglie, le quali dovevano essere poste a un sepolcro di mano di Giovan Iacomo dalla Porta, scultore et architetto del Duomo di Milano, il quale lavorò nella sua giovanezza molte cose sotto il detto Gobbo. E le sopra dette, che dovevano andare al detto sepolcro, sono condotte con molta pulitezza. Il medesimo Giovan Iacomo ha fatto molte bell'opere alla Certosa di Pavia, e particolarmente nel sepolcro del conte di Virtù e nella facciata della chiesa. Da costui imparò l'arte un suo nipote, chiamato Guglielmo, il quale in Milano attese con molto studio a ritrarre le cose di Lionardo da Vinci, circa l'anno 1530, che gli fecero grandissimo giovamento; per che andato con Giovan Iacomo a Genova, quando l'anno 1531 fu chiamato là a fare la sepoltura di San Giovanni Batista, attese al disegno con gran studio sotto Perino del Vaga, e non lasciando perciò la scultura, fece uno dei sedici piedistalli che sono in detto sepolcro. Là onde, veduto che si portava benissimo, gli furono fatti fare tutti gl'altri. Dopo condusse due Angeli di marmo, che sono nella Compagnia di San Giovanni. Et al vescovo di Servega fece due ritratti di marmo et un Moisè maggiore del vivo, il quale fu posto nella chiesa di San Lorenzo. Et appresso, fatta che ebbe una Cerere di marmo, che fu posta sopra la porta della casa d'Ansaldo Grimaldi, fece sopra la porta della Cazzuola di quella città una statua di Santa Caterina grande quanto il naturale, e dopo le tre Grazie con quattro putti di marmo, che furono mandati in Fiandra al gran scudiero di Carlo Quinto imperatore insieme con un'altra Cerere grande quanto il vivo. Avendo Guglielmo in sei anni fatte quest'opere, l'anno 1537 si condusse a Roma, dove da Giovan Iacomo suo zio fu molto raccomandato a fra' Bastiano pittore viniziano suo amico, acciò esso il raccomandassi, come fece, a Michelagnolo Buonarruoti, il quale Michelagnolo veggendo Guglielmo fiero e molto assiduo alle fatiche, cominciò a porgli affezione, et innanzi a ogni altra cosa gli fece restaurare alcune cose antiche in casa Farnese, nelle quali si portò di maniera, che Michelagnolo lo mise al servigio del Papa, essendosi anco avuto prima saggio di lui in una sepoltura, che avea condotta dalle Botteghe Oscure per la più parte di metallo al vescovo Sulisse, con molte figure e storie di basso rilievo, cioè le Virtù cardinali et altre fatte con molta grazia, et oltre a quelle la figura di esso Vescovo, che poi andò a Salamanca in Ispagna.
Mentre dunque Guglielmo andava restaurando le statue, che sono oggi nel palazzo de' Farnesi nella loggia che è dinanzi alla sala di sopra, morì l'anno 1547 fra' Bastiano viniziano, che lavorava come s'è detto l'uffizio del Piombo, onde tanto operò Guglielmo col favore di Michelagnolo e d'altri col Papa, che ebbe il detto uffizio del Piombo, con carico di fare la sepoltura di esso papa Paulo Terzo, da porsi in San Piero. Dove con miglior disegno s'accomodò nel modello delle storie e figure delle Virtù teologiche e cardinali, che aveva fatto per lo detto vescovo Sulisse, mettendo in su' canti quattro putti in quattro tramezzi e quattro cartelle, e facendo oltre ciò di metallo la statua di detto Pontefice a sedere in atto di pace; la quale statua fu alta palmi diciassette. Ma dubitando per la grandezza del getto che il metallo non raffreddasse, onde ella non riuscisse, messe il metallo nel bagno da basso, per venire aberevando di sotto in sopra. E con questo modo inusitato venne quel getto benissimo e netto come era la cera, onde la stessa pelle, che venne dal fuoco, non ebbe punto bisogno d'essere rinetta, come in essa statua può vedersi, la quale è posta sotto i primi archi che reggono la tribuna del nuovo San Piero.
Avevano a essere messe a questa sepoltura, la quale secondo un suo disegno doveva essere isolata, quattro figure, che egli fece di marmo con belle invenzioni, secondo che gli fu ordinato da Messer Annibale Caro, che ebbe di ciò cura dal Papa e dal cardinal Farnese. Una fu la Giustizia, che è una figura nuda sopra un panno a giacere, con la cintura della spada attraverso al petto, e la spada ascosa; in una mano ha i fasci della Iustizia consolare e nell'altra una fiamma di fuoco, è giovane nel viso, ha i capegli avvolti, il naso aquilino e d'aspetto sensitivo. La seconda fu la Prudenza in forma di matrona, d'aspetto giovane, con uno specchio in mano, un libro chiuso, e parte ignuda e parte vestita. La terza fu l'Abbondanza, una donna giovane, coronata di spighe, con un corno di dovizia in mano e lo staio antico nell'altra, et in modo vestita, che mostra l'ignudo sotto i panni. L'ultima e quarta fu la Pace, la quale è una matrona con un putto, che ha cavato gl'occhi e col caduceo di Mercurio. Fecevi similmente una storia pur di metallo e con ordine del detto Caro, che aveva a essere messa in opera con due fiumi, l'uno fatto per un lago e l'altro per un fiume, che è nello stato de' Farnesi. Et oltre a tutte queste cose, vi andava un monte pieno di gigli con l'arco vergine. Ma tutto non fu poi messo in opera, per le cagioni che si sono dette nella vita di Michelagnolo. E si può credere che come queste parti in sé son belle e fatte con molto giudizio, così sarebbe riuscito il tutto insieme, tuttavia l'aria della piazza è quella che dà il vero lume e fa far retto giudizio dell'opere.
Il medesimo fra' Guglielmo ha condotto nello spazio di molti anni quattordici storie per farle di bronzo, della vita di Cristo, ciascuna delle quali è larga palmi quattro et alta sei, eccetto però una, che è palmi dodici alta e larga sei, dove è la Natività di Gesù Cristo con bellissime fantasie di figure; nell'altre tredici sono: l'andata di Maria con Cristo putto in Ierusalem in su l'asino, con due figure di gran rilievo e molte di mezzo e basso; la Cena con tredici figure ben composte et un casamento ricchissimo; il lavare i piedi ai discepoli; l'orare nell'orto con cinque figure et una turba da basso molto varia; quando è menato ad Anna, con sei figure grandi, e molte di basso et un lontano; lo essere battuto alla colonna; quando è coronato di spine; l'Ecce homo; Pilato che si lava le mani; Cristo che porta la croce, con quindici figure et altre lontane, che vanno al Monte Calvario; Cristo crucifisso, con diciotto figure, e quando è levato di croce. Le quali tutte istorie, se fussono gettate, sarebbono una rarissima opera, veggendosi che è fatta con molto studio e fatica. Aveva disegnato papa Pio Quarto farle condurre per una delle porte di San Piero, ma non ebbe tempo, sopravenuto dalla mor-te. Ultimamente ha condotto fra' Guglielmo modelli di cera per tre altari di San Piero, Cristo deposto di croce, il ricevere Pietro le chiavi della Chiesa e la venuta dello Spirito Santo, che tutte sarebbono belle storie.
Insomma ha costui avuto et ha occasione grandissima di affaticarsi e fare dell'opere, avenga che l'uffizio del Piombo è di tanto gran rendita, che si può studiare et affaticarsi per la gloria, il che non può fare chi non ha tante comodità. E nondimeno non ha condotto fra' Guglielmo opere finite dal 1547 infino a questo anno 1567, ma è proprietà di chi ha quell'uffizio impigrire e diventare infingardo. E che ciò sia vero, costui innanzi che fusse frate del Piombo condusse molte teste di marmo et altri lavori, oltre quelli che abbiàn detto. È ben vero che ha fatto quattro gran Profeti di stucco, che sono nelle nicchie fra i pilastri del primo arco grande di San Piero; si adoperò anco assai ne' carri della festa di Testaccio et altre mascherate, che già molti anni sono si fecero in Roma. È stato creato di costui un Guglielmo Tedesco, che fra l'altre opere ha fatto un molto bello e ricco ornamento di statue piccoline di bronzo, imitate dall'antiche migliori, a uno studio di legname (così gli chiamano), che il conte di Pitigliano donò al signor duca Cosimo; le quali figurette son queste: il cavallo di Campidoglio, quelli di Monte Cavallo, gl'Ercoli di Farnese, l'Antimo et Apollo di Belvedere, e le teste de' dodici imperatori con altre tutte ben fatte e simili altre proprie.
Ha aùto ancora Milano un altro scultore che è morto questo anno, chiamato Tommaso Porta, il quale ha lavorato di marmo eccellentemente, e particolarmente ha contrafatto teste antiche di marmo che sono state vendute per antiche, e le maschere l'ha fatte tanto bene, che nessuno l'ha paragonato, et io ne ho una di sua mano di marmo posta nel camino di casa mia d'Arezzo, che ogni uno la crede antica. Costui fece di marmo quanto in naturale le dodici teste degli imperatori che furono cosa rarissima, le quali papa Giulio Terzo le tolse e gli fece dono della segnatura d'uno uffizio di scudi cento l'anno, e tenne non so che mesi le teste in camera sua, come cosa rara. Le quali, per opera si crede di fra' Guglielmo su detto e d'altri che l'invidiavano, operorono contra di lui di maniera, che non riguardando alla degnità del dono fattogli da quel Pontefice gli furono rimandate a casa, dove poi con miglior condizione gli fur pagate da mercanti e mandate in Ispagna. Nessuno di questi imitatori delle cose antiche valse più di costui, del quale m'è parso degno che si faccia memoria di lui tanto più quanto egli è passato a miglior vita, lasciando fama e nome della virtù sua.
Ha similmente molte cose lavorato in Roma un Lionardo milanese, il quale ha ultimamente condotto due statue di marmo, San Piero e San Paulo, nella cappella del cardinale Giovanni Riccio da Monte Pulciano, che sono molto lodate e tenute belle e buone figure. Et Iacopo e Tommaso Casignuola scultori hanno fatto per la chiesa della Minerva alla cappella de' Caraffi la sepoltura di papa Paulo Quarto, con una statua di pezzi (oltre agl'altri ornamenti) che rappresenta quel Papa, col manto di mischio brocatello, et il fregio et altre cose di mischi di diversi colori, che la rendono maravigliosa. E così veggiamo questa giunta all'altre industrie degl'ingegni moderni, e che i scultori con i colori vanno nella scultura imitando la pittura. Il quale sepolcro ha fatto fare la santità e molta bontà e gratitudine di papa Pio Quinto, padre e pontefice veramente beatissimo, santissimo e di lunga vita degnissimo.
Nanni di Baccio Bigio scultore fiorentino, oltre quello che in altri luoghi s'è detto di lui, dico che nella sua giovanezza sotto Raffaello da Monte Lupo attese di maniera alla scultura, che diede in alcune cose piccole, che fece di marmo, gran speranza d'aver a essere valent'uomo. Et andato a Roma sotto Lorenzetto scultore, mentre attese, come il padre avea fatto, anco all'architettura, fece la statua di papa Clemente Settimo, che è nel coro della Minerva, et una Pietà di marmo, cavata da quella di Michelagnolo, la quale fu posta in Santa Maria de Anima, chiesa de' Tedeschi, come opera che è veramente bellissima. Un'altra simile, indi a non molto, ne fece a Luigi del Riccio, mercante fiorentino, che è oggi in Santo Spirito di Firenze a una cappella di detto Luigi, il quale è non meno lodato di questa Pietà verso la patria, che Nanni d'aver condotta la statua con molta diligenza et amore. Si diede poi Nanni sotto Antonio da San Gallo con più studio all'architettura, et attese, mentre Antonio visse, alla fabrica di San Piero, dove cascando da un ponte alto sessanta braccia e sfragellandosi, rimase vivo per miracolo. Ha Nanni condotto in Roma e fuori molti edifizii, e cercato di più e maggiori averne, come s'è detto nella vita di Michelagnolo. È sua opera il palazzo del cardinal Monte Pulciano in strada Iulia, et una porta del Monte San Savino fatta fare da Giulio Terzo, con un ricetto d'acqua non finito, una loggia et altre stanze del palazzo stato già fatto dal cardinal vecchio di Monte. È parimente opera di Nanni la casa de' Mattei et altre molte fabriche, che sono state fatte e si fanno in Roma tuttavia.
È anco oggi fra gl'altri famoso e molto celebre architettore Galeazzo Alessi perugino, il quale, servendo in sua giovanezza il cardinale di Rimini, del quale fu cameriero, fece fra le sue prime opere, come volle detto signore, la riedificazione delle stanze della fortezza di Perugia, con tante comodità e bellezza, che in luogo sì piccolo fu uno stupore, e pure sono state capaci già più volte del Papa, con tutta la corte. Appresso, per avere altre molte opere che fece al detto Cardinale, fu chiamato dai genovesi con suo molto onore a' servigii di quella republica, per la quale la prima opera che facesse si fu racconciare e fortificare il porto et il molo, anzi quasi farlo un altro da quello che era prima. Conciò sia che allargandosi in mare per buono spazio, fece fare un bellissimo portone, che giace in mezzo circolo, molto adorno di colonne rustiche e di nicchie a quelle intorno. All'estremità del qual circolo si congiungono due baluardotti, che difendono detto portone. In sulla piazza poi, sopra il molo, alle spalle di detto portone, verso la città fece un portico grandissimo, il quale riceve il corpo della guardia, d'ordine dorico, e sopra esso, quanto è lo spazio che egli tiene, et insieme i due baluardi e porta, resta una piazza spedita per comodo dell'artiglieria, la quale a guisa di cavaliere sta sopra il molo e difende il porto dentro e fuora. Et oltre questo che è fatto, si dà ordine per suo disegno, e già dalla Signoria è stato approvato il modello, all'accrescimento della città, con molta lode di Galeazzo, che in queste et altre opere ha mostrato di essere ingegnosissimo. Il medesimo ha fatto la strada nuova di Genova, con tanti palazzi fatti con suo disegno alla moderna, che molti affermano in niun'altra città d'Italia trovarsi una strada più di questa magnifica e grande, né più ripiena di ricchissimi palazzi, stati fatti da que' signori a persuasione e con ordine di Galeazzo, al quale confessano tutti avere obligo grandissimo, poiché è stato inventore et essecutore d'opere che, quanto agl'edifizii, rendono senza comparazione la loro città molto più magnifica e grande ch'ella non era.
Ha fatto il medesimo altre strade fuori di Genova, e tra l'altre quella che si parte da Ponte Decimo per andare in Lombardia. Ha restaurato le mura della città verso il mare e la fabrica del Duomo, facendogli la tribuna e la cupola. Ha fatto anco molte fabriche private, il palazzo in villa di Messer Luca Iustiniano, quello del signor Ottaviano Grimaldi, i palazzi di due dogi, uno al signor Batista Grimaldi et altri molti, de' quali non accade ragionare. Già non tacerò che ha fatto il lago et isola del signor Adamo Centurioni, copiosissimo d'acque e fontane, fatte in diversi modi belli e capricciosi. La fonte del capitan Larcaro, vicina alla città, che è cosa notabilissima. Ma sopra tutte le diverse maniere di fonti che ha fatte a molti, è bellissimo il bagno che ha fatto in casa del signor Giovan Batista Grimaldi in Bisagno. Questo, ch'è di forma tondo, ha nel mezzo un laghetto, nel quale si possono bagnare comodamente otto o dieci persone, il quale laghetto ha l'acqua calda da quattro teste di mostri marini, che pare che escano del lago, e la fredda da altre tante rane, che sono sopra le dette teste de' mostri; gira intorno al detto lago, a cui si scende per tre gradi in cerchio, uno spazio quanto a due persone può bastare a passeggiare commodamente, il muro di tutto il circuito è partito in otto spazii: in quattro sono quattro gran nicchie, ciascuna delle quali riceve un vaso tondo, che alzandosi poco da terra, mezzo entra nella nicchia e mezzo resta fuora, et in mezzo di ciascun d'essi può bagnarsi un uomo, venendo l'acqua fredda e calda da un mascherone, che la getta per le corna e la ripiglia quando bisogna per bocca. In una dell'altre quatro parti è la porta, e nell'altre tre sono finestre e luoghi da sedere, e tutte l'otto parti sono divise da termini che reggono la cornice, dove posa la volta ritonda di tutto il bagno. Di mezzo alla qual volta pende una gran palla di vetro cristallino, nella quale è dipinta la sfera del cielo, e dentro essa il globo della terra, e da questa in alcune parti, quando altri usa il bagno di notte, viene chiarissimo lume, che rende il luogo luminoso come fusse di mezzo giorno; lascio di dire il comodo dell'antiba-gno, lo spogliatoio, il bagnetto quali son pieni di istucchi, e le pitture ch'adornano il luogo, per non esser più lungo di quello che bisogni. Basta, che non son punto disformi a tant'opera. In Milano con ordine del medesimo Galeazzo s'è fatto il palazzo del signor Tommaso Marini duca di Terranuova, e per avventura la facciata della fabrica, che si fa ora di S. Celso, l'auditorio del Cambio in forma ritonda, la già cominciata chiesa di S. Vittore et altri molti edifizi. Ha mandato l'istesso dove non è potuto egli esser impersona, disegni per tutta Italia e fuori, di molti edifizii, palazzi e tempii de' quali non dirò altro: questo potendo bastare a farlo conoscere per virtuoso e molto eccellente architetto.
Non tacerò ancora, poiché è nostro italiano, se bene non so il particolare dell'opere sue, che in Francia, secondo che intendo, è molto eccellente architetto et in particolare nelle cose di fortificazioni, Rocco Guerrini da Marradi, il quale in queste ultime guerre di quel regno ha fatto con suo molto utile et onore molte opere ingegnose e laudabili.
E così ho in quest'ultimo, per non defraudare niuno del proprio merito della virtù, favellato d'alcuni scultori et architetti vivi, de' quali non ho prima avuto occasione di comodamente ragionare.
IL FINE DELLA VITA DI LIONE LIONI SCULTOR ARETINO
VITA DI DON GIULIO CLOVIO
MINIATORE
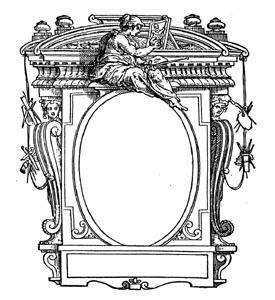
Non è mai stato, né sarà per aventura in molti secoli, né il più raro, né il più eccellente miniatore, o vogliamo dire dipintore di cose piccole, di don Giulio Clovio, poiché ha di gran lunga superato quanti altri mai si sono in questa maniera di pitture esercitati.
Nacque costui nella provincia di Schiavonia, o vero Crovazia, in una villa detta Grisone, nella diocesi di Madrucci, ancor che i suoi maggiori, della famiglia de' Clovi, fussero venuti di Macedonia, et il nome suo al battesimo fu Giorgio Iulio. Attese da fanciullo alle lettere, e poi, per istinto naturale, al disegno. E pervenuto all'età di diciotto anni, disideroso d'acquistare, se ne venne in Italia e si mise a' servigii di Marino cardinal Grimani, appresso al quale attese lo spazio di tre anni a disegnare di maniera, che fece molto migliore riuscita che per aventura non era insino a quel tempo stata aspettata di lui, come si vide in alcuni disegni di medaglie e rovesci, che fece per quel signore, disegnati di penna minutissimamente e con estrema e quasi incredibile diligenza.
Onde veduto che più era aiutato dalla natura nelle piccole cose che nelle grandi, si risolvé, e saviamente, di volere attendere a miniare, poiché erano le sue opere di questa sorte graziosissime e belle a maraviglia, consigliato anco a ciò da molti amici, et in particolare da Giulio Romano, pittore di chiara fama, il quale fu quegli che primo d'ogni altro gl'insegnò il modo di adoperare le tinte et i colori a gomma et a tempera. E le prime cose che il Clovio colorisse, fu una Nostra Donna, la quale ritrasse come ingegnoso e di bello spirito dal libro della vita di essa Vergine, la quale opera fu intagliata in istampa di legno nelle prime carte d'Alberto Duro. Per che essendosi portato bene in questa prima opera, si condusse per mezzo del signor Alberto da Carpi, il quale allora serviva in Ungheria, al servizio del re Lodovico e della reina Maria, sorella di Carlo Quinto. Al quale Re condusse un giudizio di Paris di chiaro scuro che piacque molto, et alla Reina una Lucrezia romana che s'uccideva, con alcune altre cose, che furono tenute bellissime.
Seguendo poi la morte di quel Re e la rovina delle cose d'Ungheria, fu forzato Giorgio Iulio tornarsene in Italia. Dove non fu a pena arrivato che il cardinale Campeggio vecchio lo prese al suo servizio, onde, accomodatosi a modo suo, fece una Madonna di minio a quel signore et alcun'altre cosette, e si dispose voler attendere per ogni modo con maggiore studio alle cose dell'arte. E così si mise a disegnare et a cercare d'imitare con ogni sforzo l'opere di Michelagnolo. Ma fu interrotto quel suo buon proposito dall'infelice Sacco di Roma l'anno 1527, perché trovandosi il povero uomo prigione degli Spagnuoli e mal condotto, in tanta miseria ricorse all'aiuto divino, facendo voto, se usciva salvo di quella rovina miserabile e di mano a que' nuovi farisei, di subito farsi frate. Onde essendosi salvato per grazia di Dio, e condottosi a Mantova, si fece religioso nel monasterio di San Ruffino dell'Ordine de' canonici regolari Scopetini, essendogli stato promesso, oltre alla quiete e riposo della mente e tranquill'ozio di servire a Dio, che arebbe comodità di attendere alle volte quasi per passatempo a lavorare di minio. Preso dunque l'abito e chiamatosi don Giulio, fece in capo all'anno professione e poi per ispazio di tre anni si stette assai quietamente fra que' padri, mutandosi d'uno in altro monasterio, secondo che più a lui piaceva, come altrove s'è detto, e sempre alcuna cosa lavorando. Nel qual tempo condusse un libro grande da coro con minii sottili e bellissime fregiature, facendovi fra l'altre cose un Cristo che appare in forma d'ortolano a Madalena, che fu tenuto cosa singolare; per che cresciutogli l'animo fece, ma di figure molto maggiori, la storia dell'adultera accusata da' giudei a Cristo, con buon numero di figure. Il che tutto ritrasse da una pittura, la quale di que' giorni avea fatta Tiziano Vecello pittore eccellentissimo. Non molto dopo avvenne che tramutandosi don Giulio da un monasterio a un altro, come fanno i monaci o i frati, si ruppe sgraziatamente una gamba, per che condotto da que' padri, acciò meglio fusse curato, al monasterio di Candiana, vi dimorò senza guarire alcun tempo, essendo forse male stato trattato, come s'usa, non meno dai padri che da' medici. La qual cosa intendendo il cardinal Grimani, che molto l'amava, per la sua virtù ottenne dal Papa di poterlo tenere a' suoi servigii e farlo curare. Onde cavatosi don Giulio l'abito e guarito della gamba andò a Perugia col Cardinale, che là era Legato, e lavorando gli condusse di minio que-st'opere: un uffizio di Nostra Donna con quattro bellissime storie, et in uno epistolario tre storie grandi di San Paulo apostolo, una delle quali indi a non molto fu mandata in Ispagna. Gli fece anco una bellissima Pietà et un Crucifisso, che dopo la morte del Grimani capitò alle mani di messer Giovanni Gaddi, cherico di camera. Le quali tutte opere fecero conoscere in Roma don Giulio per eccellente e furono cagione che Alessandro cardinal Farnese, il quale ha sempre aiutato, favorito e voluto appresso di sé uomini rari e virtuosi, inteso la fama di lui e vedute l'opere, lo prese al suo servizio, dove è poi stato sempre e sta ancora così vecchio. Al quale signore dico ha condotti infiniti minii rarissimi, d'una parte de' quali farò qui menzione, perché di tutti non è quasi possibile.
In un quadretto piccolo ha dipinta la Nostra Donna col Figliuolo in braccio, con molti Santi e figure attorno, e ginocchioni papa Paulo Terzo, ritratto di naturale tanto bene che par vivo nella piccolezza di quel minio. Et all'altre figure similmente non pare che manchi altro che lo spirito e la parola. Il quale quadrotto, come cosa che è veramente rarissima, fu mandato in Ispagna a Carlo Quinto imperatore, che ne restò stupefatto. Dopo quest'opera gli fece il cardinale mettere mano a far di minio le storie d'un uffizio della Madonna, scritto di lettera formata dal Monterchi, che in ciò è raro. Onde risolutosi don Giulio di voler che quest'opera fusse l'estremo di sua possa, vi si misse con tanto studio e diligenza, che niun'altra fu mai fatta con maggiore. Onde ha condotto col pennello cose tanto stupende, che non par possibile vi si possa con l'occhio né con la mano arrivare.
Ha spartito questa sua fatica don Giulio in ventisei storiette, dua carte a canto l'una all'altra, che è la figura et il figurato, e ciascuna storietta ha l'ornamento attorno vario dall'altra con figure e bizzarrie approposito della storia che egli tratta. Né vo' che mi paia fatica raccontarle brevemente, atteso che ogni uno nol può vedere. Nella prima faccia dove comincia il mattutino è l'Angelo che annunzia la Vergine Maria, con una fregiatura nell'ornamento piena di puttini che son miracolosi, e nell'altra storia Esaia, che parla col re Achaz. Nella seconda alle laude è la visitazione della Vergine a Elisabeta, che ha l'ornamento finto di metallo, nella storia dirimpetto è la Iustizia e la Pace che si abracciano. La prima è la Natività di Cristo e dirimpetto nel paradiso terrestre Adamo et Eva che mangiano il pomo, con ornamenti l'uno e l'altro pieno di ignudi et altre figure et animali ritratti di naturale. A terza vi ha fatto i pastori che l'Angelo appar loro e dirimpetto Triburtina Sibilla che mostra a Ottaviano imperatore la Vergine con Cristo nato in cielo, adorno l'uno e l'al-tro di fregiature e figure varie tutte colorite, e dentro il ritratto di Alessandro Magno et Alessandro cardinal Farnese. A sesta vi è la circuncisione di Cristo, dov'è ritratto per Simeone papa Paulo Terzo, e dentro alla storia il ritratto della Mancina e della Settimia gentil donne romane, che furono di somma bellezza, et un fregio bene ornato atorno quella, che fascia parimente col medesimo ordine l'altra storia, che gli è a canto, dov'è San Giovanni Batista che battezza Cristo, storia piena di ignudi. A nona vi ha fatto i Magi che adorano Cristo e dirimpetto Salamone adorato dalla regina Sabba, con fregiature all'una e l'altra ricche e varie, e dentro a questa da' piè, condotto di figure manco che formiche, tutta la festa di Testaccio, che è cosa stupenda a vedere, che sì minuta cosa si possa condur perfetta con una punta di pennello, che è delle gran cose che possa fare una mano e vedere un occhio mortale, nella quale sono tutte le livree che fece allora il cardinale Farnese. A vespro è la Nostra Donna che fugge con Cristo in Egitto e dirimpetto è la sommersione di Faraone nel Mar Rosso, con le sue fregiature varie da' lati. A compieta è l'incoronazione della Nostra Donna in cielo, con moltitudine d'Angeli, e dirimpetto nell'altra storia Assuero che incorona Ester con le sue fregiature a proposito; alla messa della Madonna, ha posto innanzi in una fregiatura finta di cameo che è Gabriello che annunzia il verbo alla Vergine, e le due storie sono la Nostra Donna con Gesù Cristo in collo, e nell'altra Dio Padre che crea il cielo e la terra. Dinanzi a' salmi penitenziali è la battaglia nella quale per comandamento di Davit re fu morto Uria Eteo, dove sono cavagli e gente ferita e morta ch'è miracolosa, e dirimpetto nell'altra storia Davit in penitenzia, con ornamenti et apresso grotteschine; ma chi vuol finire di stupire guardi nelle tanìe, dove minutamente ha fatto intrigaro con le lettere de' nomi de' Santi, dove di sopra nella margine è un cielo pieno di Angeli intorno alla Santissima Trinità, e di mano in mano gl'Apostoli e gl'altri Santi, e dall'altra banda séguita il cielo con la Nostra Donna e tutte le Sante vergini; nella margine di sotto, ha condotto poi di minutissime figure la processione che fa Roma per la solennità del corpo di Cristo piena di ofiziali con le torce, vescovi e cardinali, el Santissimo Sacramento portato dal papa, col il resto della corte e guardia de' lanzi, e finalmente Castello Sant'Agnolo che tira artiglierie: cosa tutta da fare stupire e maravigliare ogni acutissimo ingegno. Nel principio dello ofizio de' morti son dua storie: la Morte che trionfa sopra tutti e mortali potenti di stati e regni, come la bassa plebe, dirimpetto nell'altra storia è la resurrezione di Lazzaro, e dreto la Morte che combatte con alcuni a cavallo. Nello ofizio della Croce ha fatto Cristo crucifisso e dirimpetto Moisè con la pioggia delle serpe e lui che mette in alto quella di bronzo. A quello dello Spirito Santo è quando gli scende sopra gl'Apostoli, e dirimpetto il murar la torre di Babilonia da Nebrot. La quale opera fu condotta con tanto studio e fatica da don Giulio nello spazio di nove anni, che non si potrebbe, per modo di dire, pagare questa opera con alcun prezzo già mai. E non è possibile vedere per tutte le storie la più strana e bella varietà di bizzarri ornamenti, e diversi atti e positure d'ignudi, maschi e femine, studiati e ben ricerchi in tutte le parti, e poste con proposito attorno in detti fregi per arricchirne quel-l'opera. La quale diversità di cose spargono per tutta quell'opera tanta bellezza, che ella pare cosa divina e non umana, e massimamente avendo con i colori e con la maniera fatto sfuggire et allontanare le figure, i casamenti et i paesi, con tutte quelle parti che richiede la prospettiva e con la maggior perfezzione che si possa. Intanto che così da presso come lontano fanno restare ciascun maravigliato, per non dire nulla di mille varie sorti d'alberi tanto ben fatti, che paiono fatti in paradiso. Nelle storie et invenzioni si vede disegno, nel componimento ordine e varietà, e ricchezza negl'abiti, condotti con sì bella grazia e maniera, che par impossibile siano condotti per mano d'uomini, onde possiàn dire che don Giulio abbia, come si disse a principio, superato in questo gl'antichi e moderni, e che sia stato a' tempi nostri un piccolo e nuovo Michelagnolo.
Il medesimo fece già un quadrotto di figure piccole al Cardinale di Trento, sì vago e bello che quel signore ne fece dono all'imperatore Carlo Quinto; e dopo al medesimo ne fece un altro di Nostra Donna et insieme il ritratto del re Filippo, che furono bellissimi e per ciò donati al detto Re catolico. Al medesimo cardinal Farnese fece in un quadrotto la Nostra Donna col Figliuolo in braccio, Santa Lisabetta, San Giovannino et altre figure, che fu mandato in Ispagna a Rigomes. In un altro che oggi l'ha il detto Cardinale, fece San Giovanni Batista nel deserto con paesi et animali bellissimi, et un altro simile ne fece poi al medesimo, per mandare al re Filippo. Una Pietà, che fece con la Madonna et altre molte figure, fu dal detto Farnese donata a papa Paulo Quarto, che mentre visse la volle sempre appresso di sé. Una storia do-ve Davit taglia la testa a Golia gigante fu dal medesimo Cardinale donata a madama Margherita d'Austria, che la mandò al re Filippo suo fratello, insieme con un altro che per compagnia di quello gli fece fare quella illustrissima signora, do-ve Iudit tagliava il capo ad Oloferne.
Dimorò già molti anni sono don Giulio appresso al duca Cosimo molti mesi, et in detto tempo gli fece alcun'opere, parte delle quali furono mandate all'Imperatore et altri signori e parte ne rimasero appresso sua eccellenza illustrissima, che fra l'altre cose gli fece ritrarre una testa piccola d'un Cristo da una che n'ha egli stesso antichissima, la quale fu già di Gottifredi Buglioni re di Ierusalem, la quale dicono essere più simile alla vera effigie del Salvatore che alcun'altra che sia. Fece don Giulio al detto signor Duca un Crucifisso con la Madalena a' piedi, che è cosa maravigliosa, et un quadro piccolo d'una Pietà, del quale abbiamo il disegno nel nostro libro insieme con un altro, pure di mano di don Giulio, d'una Nostra Donna ritta col Figliuolo in collo, vestita all'ebrea, con un coro d'Angeli intorno e molte anime nude in atto di raccomandarsi.
Ma per tornare al signor Duca, egli ha sempre molto amato la virtù di don Giulio e cercato d'avere delle sue opere. E se non fusse stato il rispetto che ha avuto a Farnese, non l'arebbe lasciato da sé partire, quanto stette, come ho detto, alcuni mesi al suo servizio in Firenze. Ha dunque il Duca, oltre le cose dette, un quadretto di mano di don Giulio, dentro al quale è Ganimede portato in cielo da Giove converso in aquila. Il quale fu ritratto da quello che già disegnò Michelagnolo, il quale è oggi appresso Tomaso de' Cavalieri, come s'è detto altrove. Ha similmente il Duca nel suo scrittoio un San Giovanni Batista, che siede sopra un sasso, et alcuni ritratti di mano del medesimo che sono mirabili. Fece già don Giulio un quadro d'una Pietà, con le Marie et altre figure attorno, alla Marchesana di Pescara, et un altro simile in tutto al cardinale Farnese, che lo mandò all'Imperatrice, che è oggi moglie di Massimiliano e sorella del re Filippo. Et un altro quadretto di mano del medesimo mandò a sua maestà cesarea, dentro al quale è in un paesotto bellissimo San Giorgio che amazza il serpente, fatto con estrema diligenza; ma fu passato questo di bellezza e di disegno da un quadro maggiore, che don Giulio fece a un gentiluomo spagnuolo, nel quale è Traiano imperatore, secondo che si vede nelle medaglie, e col rovescio della provincia di Giudea. Il quale quadro fu mandato al sopra detto Massimiliano oggi imperatore.
Al detto cardinale Farnese ha fatto due altri quadretti, in uno è Gesù Cristo ignudo con la croce in mano, e nell'altro è il medesimo menato da' giudei et accompagnato da una infinità di popoli al Monte Calvario con la croce in ispalla, e dietro la Nostra Donna e l'altre Marie in atti graziosi e da muovere a pietà un cuor di sasso. Et in due carte grandi, per un messale, ha fatto allo stesso Cardinale Gesù Cristo che ammaestra nella dottrina del Santo Evangelio gl'Apostoli, e nell'altra il Giudizio Universale tanto bello, anzi ammirabile e stupendo, che io mi confondo a pensarlo, e tengo per fermo che non si possa, non dico fare, ma vedere, né imaginarsi per minio, cosa più bella. È gran cosa che in molte di queste opere, e massimamente nel detto ufficio della Madonna, abbia fatto don Giulio alcune figurine non più grandi che una ben piccola formica, con tutte le membra sì espresse e sì distinte, che più non si sarebbe potuto in figure grandi quanto il vivo; e che per tutto siano sparsi ritratti naturali d'uomini e donne, non meno simili al vero che se fussero da Tiziano o dal Bronzino stati fatti naturalissimi e grandi quanto il vivo; senzaché in alcune figure di fregi si veggiono alcune figurette nude et in altre maniere, fatte simili a camei, che per piccolissime che sieno sembrano in quel loro essere grandissimi giganti, cotanta è la virtù e strema diligenzia che in operando mette don Giulio.
Del quale ho voluto dare al mondo questa notizia acciò che sappiano alcuna cosa di lui quei che non possono, né potranno delle sue opere vedere, per essere quasi tutte in mano di grandissimi signori e personaggi. Dico quasi tutte, perché so alcuni privati avere in scatolette ritratti bellissimi di mano di costui, di signori, d'amici o di donne da loro amate. Ma comunche sia, basta che l'opere di sì fatti uomini non sono publiche, né in luogo da potere essere vedute da ognuno, come le pitture, sculture e fabriche degl'altri artefici di queste nostre arti. Ora ancor che don Giulio sia vecchio e non studi, né attenda ad altro che procacciarsi con opere sante e buone e con una vita tutta lontana dalle cose del mondo la salute dell'anima sua, e sia vecchio affatto, pur va lavorando continuamente alcuna cosa, là dove stassi in molta quiete e ben governato nel palazzo de' Farnesi, dove è cortesissimo in mostrando ben volentieri le cose sue a chiunche va a visitarlo e vederlo, come si fanno l'altre maraviglie di Roma.
IL FINE DELLA VITA DI DON GIULIO CLOVIO MINIATORE
DI
DIVERSI ARTEFICI ITALIANI
Vive anco in Roma, e certo è molto eccellente nella sua professione, Girolamo Siciolante da Sermoneta, del quale se bene si è detto alcuna cosa nella vita di Perino del Vaga, di cui fu discepolo e l'aiutò nell'opere di Castel Sant'Agnolo e molte altre, non sia però se non bene dirne anco qui quanto la sua molta virtù merita veramente.
Fra le prime opere adunque che costui fece da sé fu una tavola alta dodici palmi, che egli fece a olio di venti anni, la quale è oggi nella badia di Santo Stefano, vicino alla terra di Sermoneta sua patria, nella quale sono quanto il vivo San Pietro, Santo Stefano e San Giovanni Batista, con certi putti. Dopo la quale tavola, che molto fu lodata, fece nella chiesa di Santo Apostolo di Roma, in una tavola a olio, Cristo morto, la Nostra Donna, San Giovanni e la Madalena con altre figure condotte con diligenza. Nella Pace condusse poi alla cappella di marmo, che fece fare il cardinale Cesis, tutta la volta lavorata di stucchi, in un partimento di quattro quadri, facendovi il Nascere di Gesù Cristo, l'adorazione de' Magi, il fuggire in Egitto e l'uccisione de' fanciulli innocenti, che tutto fu opera molto laudabile e fatta con invenzione, giudizio e diligenza. Nella medesima chiesa fece, non molto dopo, il medesimo Girolamo in una tavola alta quindici palmi, appresso all'altare maggiore, la Natività di Gesù Cristo, che fu bellissima. E dopo per la sagrestia della chiesa di Santo Spirito di Roma, in un'altra tavola a olio, la venuta dello Spirito Santo sopra gl'Apostoli, che è molto graziosa opera. Similmente nella chiesa Santa Maria de Anima, chiesa della nazione tedesca, dipinse a fresco tutta la cappella de' Fuccheri, dove Giulio Romano già fece la tavola con istorie grandi della vita di Nostra Donna. Et in San Iacopo degli Spagnuoli, all'altare maggiore, fece in una gran tavola un bellissimo Crucifisso, con alcuni Angeli attorno, la Nostra Donna, San Giovanni et oltre ciò due gran quadri, che la mettono in mezzo, con una figura per quadro alta nove palmi, cioè San Iacopo apostolo e Santo Alfonso vescovo, nei quali quadri si vede che mise molto studio e diligenza.
A piazza Giudea, nella chiesa di San Tommaso, ha dipinto tutta una cappella a fresco, che risponde nella corte di casa Cenci, facendovi la natività della Madonna, l'essere annunziata dall'Angelo et il partorire il Salvatore Gesù Cristo. Al cardinal Capodiferro ha dipinto nel suo palazzo un salotto molto bello de' fatti degl'antichi Romani. Et in Bologna fece già nella chiesa di San Martino la tavola dell'altare maggiore, che fu molto comendata. Al signor Pierluigi Farnese, duca di Parma e Piacenza, il quale servì alcun tempo, fece molte opere et in particolare un quadro, che è in Piacenza fatto per una cappella, dentro al quale è la Nostra Donna, San Giuseppo, San Michele, San Giovanni Batista et un Angelo di palmi otto.
Dopo il suo ritorno di Lombardia fece nella Minerva, cioè nell'andito della sagrestia, un Crucifisso, e nella chiesa un altro. E dopo fece a olio una Santa Caterina et una Santa Agata. Et in San Luigi fece una storia a fresco a concorrenza di Pellegrino Pellegrini bolognese, e di Iacopo del Conte fiorentino. In una tavola a olio, alta palmi sedici, fatta nella chiesa di Santo Alò, dirimpetto alla Misericordia, Compagnia de' Fiorentini, dipinse non ha molto la Nostra Donna, San Iacopo apostolo, Santo Alò e San Martino vescovi, et in San Lorenzo in Lucina, alla cappella della contessa di Carpi, fece a fresco un San Francesco che riceve le stimate. E nella sala de' re fece al tempo di papa Pio Quarto, come s'è detto, una storia a fresco sopra la porta della cappella di Sisto, nella quale storia, che fu molto lodata, Pipino re de' Franchi dona Ravenna alla Chiesa romana e mena prigione Astulfo re de' Longobardi, e di questa abbiamo il disegno di propria mano di Girolamo nel nostro libro, con molti altri del medesimo.
E finalmente ha oggi fra mano la cappella del cardinale Cesis in Santa Maria Maggiore, dove ha già fatto in una gran tavola il martirio di Santa Caterina fra le ruote, che è bellissima pittura, come sono l'altre che quivi et altrove va continuamente e con suo molto studio lavorando. Non farò menzione de' ritratti, quadri et altre opere piccole di Girolamo, perché oltre che sono infiniti, queste possono bastare a farlo conoscere per eccellente e valoroso pittore.
Avendo detto di sopra, nella vita di Perino del Vaga, che Marcello pittore mantovano operò molti anni sotto di lui cose che gli dierono gran nome, dico al presente, venendo più al particolare, che egli già dipinse nella chiesa di Santo Spirito la tavola e tutta la cappella di San Giovanni Evangelista col ritratto di un commendatore di detto Santo Spirito, che murò quella chiesa e fece la detta cappella. Il quale ritratto è molto simile e la tavola bellissima; onde, veduta la bella maniera di costui, un frate del Piombo gli fece dipignere a fresco nella Pace, sopra la porta che di chiesa entra in convento, un Gesù Cristo fanciullo, che nel tempio disputa con i dottori, che è opera bellissima. Ma perché si è dilettato sempre costui di fare ritratti e cose piccole, lasciando l'opere maggiori, n'ha fatto infiniti, onde se ne veggiono alcuni di papa Paulo Terzo belli e simili affatto. Similmente con disegni di Michelagnolo e di sue opere ha fatto una infinità di cose similmente piccole, e fra l'altre in una sua opera ha fatta tutta la facciata del Giudizio, che è cosa rara e condotta ottimamente, e nel vero, per cose piccole di pittura, non si può far meglio. Per lo che gli ha finalmente il gentilissimo Messer Tommaso de' Cavalieri, che sempre l'ha favorito, fatto dipignere con disegni di Michelagnolo una tavola per la chiesa di San Giovanni Laterano, d'una Vergine annunziata bellissima. Il quale disegno di man propria del Buonarruoto, da costui imitato, donò al signor duca Cosimo, Lionardo Buonarruoti, nipote di esso Michelagnolo, insieme con alcuni altri, di fortificazioni, d'architettura et altre cose rarissime. E questo basti di Marcello, che per ultimo attende a lavorare cose piccole, conducendole con veramente estrema et incredibile pacienza.
Di Iacopo del Conte fiorentino, il quale sì come i sopra detti abita in Roma, si sarà detto a bastanza fra in questo et in altri luoghi, se ancora se ne dirà alcun altro particolare. Costui dunque essendo stato in fin dalla sua giovanezza molto inclinato a ritrarre di naturale, ha voluto che questa sia stata sua principale professione, ancora che abbia secondo l'occasioni fatto tavole e lavori in fresco pure assai in Roma e fuori. Ma de' ritratti, per non dire di tutti, che sarebbe lunghissima storia, dirò solamente che egli ha ritratto da papa Paulo Terzo in qua tutti i pontefici che sono stati, e tutti i signori et ambasciatori d'importanza che sono stati a quella corte. E similmente capitani d'eserciti e grand'uomini di casa Colonna e degli Orsini, il signor Piero Strozzi et una infinità di vescovi, cardinali et altri gran prelati e signori, senza molti letterati et altri galantuomini, che gl'hanno fatto acquistare in Roma nome, onore et utile. Onde si sta in quella città con sua famiglia molto agiata et onoratamente. Costui da giovanetto disegnava tanto bene, che diede speranza, se avesse seguitato, di farsi eccellentissimo, e saria stato veramente, ma, come ho detto, si voltò a quello a che si sentiva da natura inclinato. Nondimeno non si possono le cose sue se non lodare. È di sua mano una sua tavola, che è nella chiesa del Popolo, un Cristo morto; et in un'altra, che ha fatta in San Luigi, alla cappella di San Dionigi, con storie, è quel Santo. Ma la più bell'opera che mai facesse si fu dua storie a fresco, che già fece, come s'è detto in altro luogo, nella Compagnia della Misericordia de' Fiorentini, con una tavola d'un Deposto di croce, con i ladroni confitti e lo svenimento di Nostra Donna, colorita a olio, molto belle e condotte con diligenzia e con suo molto onore. Ha fatto per Roma molti quadri e figure in varie maniere e fatto assai ritratti interi vestiti e nudi d'uomini e di donne, che sono stati bellissimi, però che così erano i naturali. Ha ritratto anco secondo l'occasioni molte teste di signore, gentildonne e principesse, che sono state a Roma. E fra l'altre so che già ritrasse la signora Livia Colonna, nobilissima donna, per chiarezza di sangue, virtù e bellezza incomparabile. E questo basti di Iacopo del Conte, il quale vive e va continuamente operando.
Arei potuto ancora di molti nostri toscani e d'altri luoghi d'Italia fare noto il nome e l'opere loro, che me la son passata di leggieri, perché molti hanno finito, per esser vecchi, di operare et altri, che son giovani che si vanno sperimentando, i quali faranno conoscersi più con le opere che con gli scritti. E perché ancor vive et opera Adoni Doni d'Ascesi, del quale se bene feci memoria di lui nella vita di Cristofano Gherardi, dirò alcune particolarità dell'opere sue, quali et in Perugia e per tutta l'Umbria, e particolarmente in Fuligno sono molte tavole, ma l'opere sue migliori sono in Ascesi a Santa Maria degl'Angeli nella cappelletta dove morì San Francesco, dove sono alcune storie de' fatti di quel Santo lavorate a olio nel muro, le quali son lodate assai, oltre che ha nella testa del refettorio di quel convento lavorato a fresco la Passione di Cristo, oltre a molte opere che gli han fatto onore; e lo fanno tenere e cortese e liberale la gentilezza e cortesia sua.
In Orvieto sono ancora di quella cura dua giovani, uno pittore chiamato Cesare del Nebbia e l'altro scultore..., ambidua per una gran via da far che la loro città che fino a oggi ha chiamato del continuo a ornarla maestri forestieri, che seguitando i princìpi che hanno presi, non aranno a cercar più d'altri maestri.
Lavora in Orvieto in Santa Maria, Duomo di quella città, Niccolò dalle Pomarancie, pittore giovane, il quale avendo condotto una tavola dove Cristo resuscita Lazzaro, ha mostro insieme con altre cose a fresco di racconciar nome apresso agli altri su detti. E perché de' nostri maestri italiani [le] vite siano alla fine, dirò solo che avendo sentito non minore un Lodovico scultore fiorentino, quale in Inghilterra et in Bari ha fatto, secondo che m'è detto, cose notabili, per non aver io trovato qua né parenti, né cognome, né visto l'opere sue, non posso come vorrei farne altra memoria che questa del nominarlo.
DI
DIVERSI ARTEFICI FIAMMINGHI
Ora ancor che in molti luoghi, ma però confusamente si sia ragionato dell'opere d'alcuni eccellenti pittori fiamminghi e dei loro intagli, non tacerò i nomi d'alcun'altri, poiché non ho potuto avere intera notizia dell'opere, i quali sono stati in Italia, et io gl'ho conosciuti la maggior parte, per apprendere la maniera italiana, parendomi che così meriti la loro industria e fatica usata nelle nostre arti.
Lasciando adunque da parte Martino d'Olanda, Giovanni Eick da Bruggia et Uberto suo fratello, che nel 1410 mise in luce l'invenzione e modo di colorire a olio, come altrove s'è detto, e lasciò molte opere di sua mano in Guanto, in Ipri et in Bruggia, dove visse e morì onoratamente, dico che dopo costoro seguitò Ruggieri Vander Vueiden di Bruselles, il quale fece molte opere in più luoghi, ma principalmente nella sua patria e nel palazzo de' Signori quattro tavole a olio bellissime di cose pertinenti alla Iustizia.
Di costui fu discepolo Havesse, del quale abbiàn, come si disse, in Fiorenza in un quadretto piccolo che è in man del Duca, la Passione di Cristo. A costui successero Lodovico da Lovano, Luven fiammingo, Pietro Ghrista, Giusto da Guanto, Ugo d'Anversa et altri molti, i quali, perché mai non uscirono di loro paese, tennero sempre la maniera fiamminga. E se bene venne già in Italia Alberto Durero, del quale si è parlato lungamente, egli tenne nondimeno sempre la sua medesima maniera, se bene fu nelle teste massimamente pronto e vivace, come è notissimo a tutta Europa. Ma lasciando costoro et insieme con essi Luca d'Olanda et altri, conobbi nel 1532 in Roma un Michele Cockisien, il quale attese assai alla maniera italiana e condusse in quella città molte opere a fresco, e particolarmente in Santa Maria de Anima due cappelle. Tornato poi al paese e fattosi conoscere per valent'uomo, odo che fra l'altre opere ritrasse al re Filippo di Spagna una tavola da una di Giovanni Eick su detto, che è in Guanto. Nella quale ritratta che fu portata in Ispagna è il trionfo dell'Agnus Dei. Studiò poco dopo in Roma Martino Emskerck, buon maestro di figure e paesi, il quale ha fatto in Fiandra molte pitture e molti disegni di stampe di rame, che sono state, come s'è detto altrove, intagliate da Ieronomo Cocca, il quale conobbi in Roma mentre io serviva il cardinale Ipolito de' Medici. E questi tutti sono stati bellissimi inventori di storie e molto osservatori della maniera italiana.
Conobbi ancora in Napoli, e fu mio amicissimo, l'anno 1545, Giovanni di Calker pittore fiammingo, molto raro e tanto pratico nella maniera d'Italia, che le sue opere non erano conosciute per mano di Fiammingo. Ma costui morì giovane in Napoli, mentre si sperava gran cose di lui, il quale disegnò la sua notomia al Vessalio.
Ma innanzi a questi fu molto in pregio Divik da Lovano, in quella maniera buon maestro, e Quintino della medesima terra, il quale nelle sue figure osservò sempre più che poté il naturale, come anche fece un suo figliuolo chiamato Giovanni. Similmente Gios di Cleves fu gran coloritore e raro in far ritratti di naturale, nel che servì assai il re Francesco di Francia, in far molti ritratti di diversi signori e dame.
Sono anco stati famosi pittori e parte sono, della medesima provincia, Giovanni d'Hemsen, Mattias Cook d'Anversa, Bernardo di Burselles, Giovanni Cornelis d'Amsterdam, Lamberto della medesima terra, Enrico da Binat, Giovachino di Patenier di Bovines e Giovanni Scorle canonico di Utrecht, il quale portò in Fiandra molti nuovi modi di pitture cavati d'Italia. Oltre questi, Giovanni Bella Gamba di Douai, Dirick d'Harlem della medesima, e Francesco Mostaret, che valse assai in fare paesi a olio, fantasticherie, bizzarrie, sogni et imaginazioni.
Girolamo Hertoglien Bos e Pietro Bruveghel di Breda furono imitatori di costui, e Lancilotto è stato eccellente in far fuochi, notti, splendori, diavoli e cose somiglianti. Piero Covek ha avuto molta invenzione nelle storie e fatto bellissimi cartoni per tapezzerie e panni d'arazzo, e buona maniera e pratica nelle cose d'architettura. Onde ha tradotto in lingua teutonica l'opere d'architettura di Sebastiano Serlio bolognese. E Giovanni di Malengt fu quasi il primo che portas-se d'Italia in Fiandra il vero modo di fare storie piene di figure ignude e di poesie, e di sua mano in Silanda è una gran tribuna nella badia di Midelborgo. De' quali tutti si è avuto notizia da maestro Giovanni della Strada di Brucies, pittore, e da Giovanni Bologna de Douai, scultore, ambi fiaminghi et eccellenti come diremo nel trattato degl'Accademici.
Ora quanto a quelli della medesima provincia, che sono vivi et in pregio, il primo è fra loro, per opere di pittura e per molte carte intagliate in rame, Francesco Floris d'Anversa, discepolo del già detto Lamberto Lombardo. Costui dunque, il quale è tenuto eccellentissimo, ha operato di maniera in tutte le cose della sua professione, che niuno ha meglio (dicono essi) espressi gl'affetti dell'animo, il dolore, la letizia e l'altre passioni, con bellissime e bizzarre invenzioni di lui, intanto che lo chiamano, agguagliandolo all'Urbino, Raffaello fiammingo; vero è che ciò a noi non dimostrano interamente le carte stampate, perciò che chi intaglia, sia quanto vuole valent'uomo, non mai arriva a gran pezza all'o-pere et al disegno e maniera di chi ha disegnato. È stato condiscepolo di costui, e sotto la disciplina d'un medesimo maestro ha imparato, Guglielmo Cay di Breda pur d'Anversa, uomo moderato, grave, di giudizio, e molto imitatore del vivo e delle cose della natura, et oltre ciò assai accomodato inventore, e quegli che più d'ogni altro conduce le sue pitture sfumate e tutte piene di dolcezza e di grazia, e se bene non ha la fierezza e facilità e terribilità del suo condiscepolo Floro, ad ogni modo è tenuto eccellentissimo.
Michel Cockisien, del quale ho favellato di sopra e detto che portò in Fiandra la maniera italiana, è molto fra gl'arte-fici fiaminghi celebrato, per essere tutto grave e fare le sue figure che hanno del virile e del severo. Onde Messer Domenico Lampsonio fiamingo, del quale si parlerà a suo luogo, ragionando dei due sopra detti e di costui, gl'agguaglia a una bella musica di tre, nella quale faccia ciascun la sua parte con eccellenza.
Fra i medesimi è anco stimato assai Antonio Moro di Utrech in Olanda, pittore del Re catolico, i colori del quale nel ritrarre ciò che vuole di naturale, dicono contendere con la natura et ingannare gl'occhi benissimo. Scrivemi il detto Lampsonio, che il Moro, il quale è di gentilissimi costumi e molto amato, ha fatto una tavola bellisima d'un Cristo che risuscita con due Angeli e San Piero e San Paulo, che è cosa maravigliosa. Et anco è tenuto buono inventore e coloritore Martino di Vos, il quale ritrae ottimamente di naturale.
Ma quanto al fare bellissimi paesi, non ha pari Iacopo Gimer, Hanz Bolz et altri tutti d'Anversa e valent'uomini, de' quali non ho così potuto sapere ogni particolare. Pietro Arsen, detto Pietro Lungo, fece una tavola con le sue ale nella sua patria Asterdam, dentrovi la Nostra Donna et altri Santi, la quale tutta opera costò duemila scudi. Celebrano ancora per buon pittore Lamberto d'Asterdam, che abitò in Vinezia molti anni et aveva benissimo la maniera italiana (questo fu padre di Federigo, del quale per essere nostro accademico se ne farà memoria a suo luogo), e parimente Pietro Broghel d'Anversa, maestro eccellente, Lamberto Van Hort d'Amersfert d'Olanda; e per buono architetto Gilis Mostaret, fratello di Francesco su detto, e Pietro Pourbs giovinetto ha dato saggio di dover riuscire eccellente pittore.
Ora, acciò sappiamo alcuna cosa de' miniatori di que' paesi, dicono che questi vi sono stati eccellenti: Marino di Sireffa, Luca Hurenbout di Guanto, Simone Benich da Bruggia e Gherardo. E parimente alcune donne: Susanna sorella del detto Luca, che fu chiamata perciò ai servigii d'Enrico Ottavo re d'Inghilterra e vi stette onoratamente tutto il tempo di sua vita; Clara Skeysers di Guanto, che d'ottanta anni morì, come dicono, vergine; Anna figliuola di maestro Segher medico; Levina figlia di maestro Simone da Bruggia su detto, che dal detto Enrico d'Inghilterra fu maritata nobilmente, et avuta in pregio dalla reina Maria, sì come ancora è dalla reina Lisabetta. Similmente Caterina figliuola di maestro Giovanni da Hemsen, andò già in Ispagna al servigio della Reina d'Ungheria con buona provisione. Et insomma mol-t'altre sono state in quelle parti eccellenti miniatrici.
Nelle cose de' vetri e far finestre sono nella medesima provincia stati molti valent'uomini: Art Van Hort di Nimega, Borghese d'Anversa, Iacobs Felart, Divick Stas di Campen, Giovanni Ack d'Anversa, di mano del quale sono nella chiesa di Santa Gudula di Bruselles le finestre della cappella del Sacramento; e qua in Toscana hanno fatto al duca di Fiorenza molte finestre di vetri a fuoco bellissime Gualtieri e Giorgio fiaminghi e valent'uomini, con i disegni del Vasari. Nell'architettura e scultura i più celebrati fiaminghi sono Sebastiano d'Oia d'Utrech, il quale servì Carlo V in alcune fortificazioni e poi il re Filippo, Guglielmo d'Anversa, Guglielmo Cucur d'Olanda, buono architetto e scultore, Giovanni di Dale scultore, poeta et architetto, Iacobo Bruca scultore et architetto che fece molte opere alla Reina d'Ungheria reggente, et il quale fu maestro di Giovanni Bologna da Douai, nostro accademico, di cui poco appresso parleremo.
È anco tenuto buono architetto Giovanni di Minescheren da Guanto, et eccellente scultore Matteo Manemacken d'Anversa, il quale sta col Re de' Romani; e Cornelio Flores, fratello del sopra detto Francesco, è altresì scultore et architetto eccellente et è quelli che prima ha condotto in Fiandra il modo di fare le grottesche.
Attendono anco alla scultura con loro molto onore Guglielmo Palidamo, fratello d'Enrico predetto, scultore studiosissimo e diligente, Giovanni di Sart di Himegha, Simone di Delft e Gios Iason d'Amsterdam. E Lamberto Suave da Liege è bonissimo architetto et intagliatore di stampe col bulino, in che l'ha seguitato Giorgio Robin d'Ipri, Divick Volcaerts e Filippo Galle, amendue d'Arlem, e Luca Leidem con molti altri, che tutti sono stati in Italia a imparare e disegnare le cose antiche per tornarsene, sì come hanno fatto la più parte, a casa eccellenti. Ma di tutti i sopra detti è stato maggiore Lamberto Lombardo da Liege, gran letterato, giudizioso pittore et architetto eccellentissimo, maestro di Francesco Floris e di Guglielmo Cai, delle virtù del quale Lamberto e d'altri mi ha dato molta notizia per sue lettere Messer Domenico Lampsonio da Legie, uomo di bellissime lettere e molto giudizio in tutte le cose, il quale fu famigliare del cardinale Polo d'Inghilterra, mentre visse, et ora è segretario di monsignor vescovo e prencipe di Lege; costui, dico, mi mandò già scritta latinamente la vita di detto Lamberto, e più volte mi ha salutato a nome di molti de' nostri artefici di quella provincia. Et una lettera, che tengo di suo, data a dì trenta d'ottobre 1564, è di questo tenore:
Quattro anni sono ho avuto continuamente animo di ringraziare Vostra Signoria di due grandissimi benefizii, che ho ricevuto da lei (so che que-sto le parrà strano esordio d'uno che non l'abbia mai vista, né conosciuta; certo sarebbe strano se io non l'avessi conosciuta). Il che è stato in fin d'allora, che la mia buona ventura volse, anzi il Signor Dio, farmi grazia che mi venissero alle mani, non so in che modo, i vostri eccellentissimi scritti degl'architettori, pittori e scultori. Ma io allora non sapea pure una parola italiana, dove ora, con tutto che io non abbia mai veduto l'Italia, la Dio mercé, con leggere detti vostri scritti, n'ho imparato quel poco che mi ha fatto ardito a scrivervi questa. Et a questo desiderio d'imparare detta lingua mi hanno indotto essi vostri scritti, il che forse non averebbono mai fatto quei d'altro nessuno; tirandomi a volergli intendere uno incredibile e naturale amore, che fin da piccolo ho portato a queste tre bellissime arti, ma più alla piacevolissima ad ogni sesso, età e grado et a nessuno nociva arte vostra, la pittura. Della quale ancora era io allora del tutto ignorante e privo di giudizio, et ora, per il mezzo della spesso reiterata lettura de' vostri scritti, n'intendo tanto, che per poco che sia o quasi niente, è pur quanto basta a fare che io meno vita piacevole e lieta e lo stimo più che tutti gl'onori, agi e ricchezze di questo mondo. È questo poco, dico, tanto che io ritrarrei di colori a olio, come con qual si voglia disegnatoio, le cose naturali, e massimamente ignudi et abiti d'ogni sorte, non mi essendo bastato l'animo d'intromettermi più oltre, come dire a dipigner cose più incerte che ricercano la mano più esercitata e sicura, quali sono paesaggi, alberi, acque, nuvole, splendori, fuochi, etc.; nelle quali cose ancora, sì come anco nell'invenzioni fino a un certo che, forse e per un bisogno potrei mostrare d'aver fatto qualche poco d'avanzo per mezzo di detta lettura. Pur mi sono contento nel sopra detto termine di far solamente ritratti, e tanto maggiormente che le molte occupazioni, le quali l'uffizio mio porta necessariamente seco, non me lo permettono. E per mostrarmi grato e conoscente in alcun modo di questi benefizii d'avere, per vostro mezzo, apparato una bellissima lingua et a dipignere, vi arei mandato con questa un ritrattino del mio volto, che ho cavato dallo specchio, se io non avessi dubitato se questa mia vi troverà in Roma, o no, che forse potreste stare ora in Fiorenza, o vero in Arezzo vostra patria.
Questa lettera contiene, oltre ciò, molti altri particolari che non fanno a proposito. In altre poi mi ha pregato a nome di molti galant'uomini di que' paesi, i quali hanno inteso che queste vite si ristampano, che io ci faccia tre trattati della scultura, pittura et architettura, con disegni di figure, per dichiarare secondo l'occasioni et insegnare le cose dell'arti, come ha fatto Alberto Duro, il Serlio e Leonbatista Alberti, stato tradotto da Messer Cosimo Bartoli, gentiluomo et accademico fiorentino. La qual cosa arei fatto più che volentieri, ma la mia intenzione è stata di solamente voler scrivere le vite e l'opere degli artefici nostri e non d'insegnare l'arti, col modo di tirare le linee, della pittura, architettura e scultura, senza che essendomi l'opera cresciuta fra mano per molte cagioni, ella sarà per aventura, senza altri trattati, lunga da vantaggio. Ma io non poteva e non doveva fare altrimenti di quello che ho fatto, né defraudare niuno delle debite lo-di et onori, né il mondo del piacere et utile, che spero abbia a trarre di queste fatiche.
DEGL'ACCADEMICI DEL DISEGNO PITTORI, SCULTORI ET ARCHITETTI E DELL'OPERE LORO E PRIMA DEL BRONZINO
Avendo io scritto in fin qui le vite et opere de' pittori, scultori et architetti più eccellenti che sono da Cimabue insino a oggi passati a miglior vita, e con l'occasioni che mi sono venute favellato di molti vivi, rimane ora che io dica alcune cose degl'artefici della nostra Accademia di Firenze, de' quali non mi è occorso in sin qui parlare a bastanza.
E cominciandomi dai principali e più vecchi, dirò prima d'Agnolo detto il Bronzino, pittore fiorentino veramente rarissimo e degno di tutte le lodi. Costui, essendo stato molti anni col Puntormo, come s'è detto, prese tanto quella maniera et in guisa immitò l'opere di colui, che elle sono state molte volte tolte l'une per l'altre, così furono per un pezzo somiglianti. E certo è maraviglia come il Bronzino così bene apprendesse la maniera del Puntormo, conciò sia che Iacopo fu eziandio co' suoi più cari discepoli anzi alquanto salvatico e strano che non, come quegli che a niuno lasciava mai vedere le sue opere, se non finite del tutto. Ma ciò nonostante fu tanta la pacienza et amorevolezza d'Agnolo verso il Puntormo, che colui fu forzato a sempre volergli bene et amarlo come figliuolo. Le prime opere di conto che facesse il Bronzino, essendo ancor giovane, furono alla Certosa di Firenze, sopra una porta che va dal chiostro grande in capitolo, in due archi, cioè l'uno di fuori e l'altro dentro: nel difuori è una Pietà con due Angeli a fresco, e di dentro un San Lorenzo ignudo sopra la grata, colorita a olio nel muro, le quali opere furono un gran saggio di quell'eccellenza che ne-gl'anni maturi si è veduta poi nell'opere di questo pittore. Alla cappella di Lodovico Capponi in Santa Felicita di Firenze fece il Bronzino, come s'è detto in altro luogo, in due tondi a olio due Evangelisti, e nella volta colorì alcune figure. Nella Badia di Firenze de' monaci neri fece nel chiostro di sopra a fresco una storia della vita di San Benedetto, cioè quando si getta nudo sopra le spine, che è bonissima pittura. Nell'orto delle suore dette le Poverine dipinse a fresco un bellissimo tabernacolo, nel qual è Cristo che appare a Madalena in forma d'ortolano. In Santa Trinita pur di Firenze si vede di mano del medesimo in un quadro a olio, al primo pilastro a man ritta, un Cristo morto, la Nostra Donna, San Giovanni e Santa Maria Madalena, condotti con bella maniera e molta diligenzia. Nei quali detti tempi che fece queste opere, fece anco molti ritratti di diversi, e quadri che gli diedero gran nome. Passato poi l'assedio di Firenze e fatto l'ac-cordo, andò come altrove s'è detto a Pesero, dove appresso Guidobaldo duca d'Urbino fece, oltre la detta cassa d'Arpi-cordo piena di figure, che fu cosa rara, il ritratto di quel signore e d'una figliuola di Matteo Sofferoni, che fu veramente bellissima e molto lodata pittura. Lavorò anche all'Imperiale, villa del detto Duca, alcune figure a olio ne' peducci d'una volta, e più n'averebbe fatto, se da Iacopo Puntormo suo maestro non fusse stato richiamato a Firenze perché gl'aiutasse a finire la sala del Poggio a Caiano. Et arrivato in Firenze, fece quasi per passatempo a Messer Giovanni de Statis, auditore del duca Alessandro, un quadretto di Nostra Donna, che fu opera lodatissima, e poco dopo a monsignor Giovio, amico suo, il ritratto d'Andrea Doria, et a Bartolomeo Bettini, per empiere alcune lunette d'una sua camera, il ritratto di Dante, Petrarca e Boccaccio, figure dal mezzo in su bellissime. I quali quadri finiti, ritrasse Bonacorso Pinadori, Ugolino Martelli, Messer Lorenzo Lenzi oggi vescovo di Fermo, e Pierantonio Bandini e la moglie con tanti altri, che lunga opera sarebbe voler di tutti fare menzione. Basta che tutti furono naturalissimi, fatti con incredibile diligenza e di maniera finiti, che più non si può disiderare.
A Bartolomeo Panciatichi fece due quadri grandi di Nostre Donne con altre figure, belli a maraviglia e condotti con infinita diligenza, et oltre ciò i ritratti di lui e della moglie, tanto naturali che paiono vivi veramente e che non manchi loro se non lo spirito. Al medesimo ha fatto in un quadro un Cristo crucifisso, che è condotto con molto studio e fatica, onde ben si conosce che lo ritrasse da un vero corpo morto confitto in croce, cotanto è in tutte le sue parti di somma perfezzione e bontà. Per Matteo Strozzi fece alla sua villa di San Casciano, in un tabernacolo a fresco, una Pietà con alcuni Angeli, che fu opera bellissima. A Filippo d'Averardo Salviati fece in un quadrotto una Natività di Cristo in figure piccole tanto bella, che non ha pari, come sa ognuno, essendo oggi la detta opera in stampa. Et a maestro Francesco Montevarchi, fisico eccellentissimo, fece un bellissimo quadro di Nostra Donna et alcuni altri quadretti piccoli molto graziosi. Al Puntormo suo maestro aiutò a fare, come si disse di sopra, l'opera di Careggi, dove condusse di sua mano ne' peducci delle volte cinque figure: la Fortuna, la Fama, la Pace, la Iustizia e la Prudenza, con alcuni putti fatti ottimamente.
Morto poi il duca Alessandro e creato Cosimo, aiutò Bronzino al medesimo Puntormo nell'opera della loggia di Castello. E nelle nozze dell'illustrissima donna Leonora di Tolledo, moglie già del duca Cosimo, fece due storie di chiaro scuro nel cortile di casa Medici, e nel basamento che reggeva il cavallo del Tribolo, come si disse, alcune storie finte di bronzo de' fatti del signor Giovanni de' Medici, che tutte furon le migliori pitture che fussero fatte in quell'apparato. Là dove il Duca, conosciuta la virtù di quest'uomo, gli fece metter mano a fare nel suo ducal palazzo una cappella non molto grande per la detta signora Duchessa, donna nel vero, fra quante furono mai, valorosa, e per infiniti meriti, degna d'eterna lode. Nella qual cappella fece il Bronzino nella volta un partimento, con putti bellissimi e quattro figure, ciascuna delle quali volta i piedi alle facce, San Francesco, San Ieronimo, San Michelagnolo e San Giovanni, condotte tutte con diligenzia et amore grandissimo. E nell'altre tre facce (due delle quali sono rotte dalla porta e dalla finestra) fece tre storie di Moisè, cioè una per faccia. Dove è la porta fece la storia delle bisce, o vero serpi, che piovono sopra il po-polo, con molte belle considerazioni di figure morse, che parte muoiono, parte sono morte, et alcune guardando nel serpente di bronzo guariscono. Nell'altra, cioè nella faccia della finestra, è la pioggia della manna, e nell'altra faccia intera quando passa il Mare Rosso e la sommersione di Faraone, la quale storia è stata stampata in Anversa; et insomma que-sta opera, per cosa lavorata in fresco, non ha pari et è condotta con tutto quella diligenza e studio che si poté maggiore. Nella tavola di questa cappella, fatta a olio, che fu posta sopra l'altare, era Cristo deposto di croce in grembo alla madre; ma ne fu levata dal duca Cosimo per mandarla, come cosa rarissima, a donare a Gran Vela, maggiore uomo che già fusse appresso Carlo Quinto imperadore. In luogo della qual tavola ne ha fatto una simile il medesimo e postala sopra l'al-tare in mezzo a due quadri non manco belli che la tavola, dentro i quali sono l'angelo Gabriello e la Vergine da lui annunziata. Ma in cambio di questi, quando ne fu levata la prima tavola, erano un San Giovanni Batista et un San Cosimo, che furono messi in guardaroba quando la signora Duchessa, mutato pensiero, fece fare questi altri due. Il signor Duca, veduta in queste et altre opere l'eccellenza di questo pittore, e particolarmente che era suo proprio ritrarre dal naturale quanto con più diligenzia si può imaginare, fece ritrarre sé, che allora era giovane, armato tutto d'arme bianche e con una mano sopra l'elmo, in un altro quadro la signora Duchessa sua consorte, et in un altro quadro il signor don Francesco loro figliuolo e prencipe di Fiorenza. E non andò molto che ritrasse, sì come piacque a lei, un'altra volta la detta signora Duchessa, in vario modo dal primo, col signor don Giovanni suo figliuolo appresso. Ritrasse anche la Bia fanciulletta e figliuola naturale del Duca; e dopo, alcuni di nuovo et altri la seconda volta, tutti i figliuoli del Duca, la signora donna Maria, grandissima fanciulla, bellissima veramente, il prencipe don Francesco, il signor don Giovanni, don Garzia e don Arnaldo in più quadri, che tutti sono in guardaroba di sua eccellenzia insieme con ritratto di don Francesco di Tolledo, della signora Maria madre del Duca e d'Ercole Secondo duca di Ferrara con altri molti.
Fece anco in palazzo quasi ne' medesimi tempi, due anni alla fila per carnovale, due scene e prospettive per come-die, che furono tenute bellissime. Fece un quadro di singolare bellezza, che fu mandato in Francia al re Francesco, dentro al quale era una Venere ignuda con Cupido che la baciava, et il Piacere da un lato et il Giuoco con altri amori, e dal-l'altro la Fraude, la Gelosia et altre passioni d'amore.
Avendo fatto il signor Duca cominciare dal Puntormo i cartoni de' panni d'arazzo di seta e d'oro per la sala del Consiglio de' Dugento, e fattone fare due delle storie di Ioseffo ebreo dal detto et uno al Salviati, diede ordine che il Bronzino facessi il resto. Onde ne condusse quattordici pezzi di quella perfezzione e bontà che sa chiunque gli ha veduti. Ma perché questa era soverchia fatica al Bronzino, che vi perdeva troppo tempo, si servì nella maggior parte di questi cartoni, facendo esso i disegni, di Raffaello dal Colle, pittore dal Borgo a San Sepolcro, che si portò ottimamente.
Avendo poi fatto Giovanni Zanchini dirimpetto alla cappella de' Dini in Santa Croce di Firenze, cioè nella facciata dinanzi entrando in chiesa per la porta del mezzo a man manca, una cappella molto ricca di conci, con sue sepolture di marmo, allogò la tavola al Bronzino, acciò vi facesse dentro un Cristo disceso al Limbo per trarne i Santi Padri. Messovi dunque mano condusse Agnolo quell'opera con tutta quella possibile estrema diligenza che può mettere chi desidera acquistar gloria in simigliante fatica. Onde vi sono ignudi bellissimi, maschi, femine, putti, vecchi e giovani, con diverse fattezze et attitudini d'uomini che vi sono ritratti molto naturali, fra' quali è Iacopo Puntormo, Giovanbatista Gello, assai famoso accademico fiorentino, et il Bacchiacca dipintore, del quale si è favellato di sopra. E fra le donne vi ritrasse due nobili e veramente bellissime giovani fiorentine, degne per la incredibile bellezza et onestà loro d'eterna lode e di memoria: madonna Gostanza da Somaia, moglie di Giovanbatista Doni, che ancor vive, e madonna Camilla Tedaldi del Corno, oggi passata a miglior vita. Non molto dopo fece in un'altra tavola grande e bellissima la Ressurezzione di Gesù Cristo, che fu posta intorno al coro della chiesa de' Servi, cioè nella Nunziata, alla cappella di Iacopo e Filippo Guadagni. Et in questo medesimo tempo fece la tavola che in palazzo fu messa nella cappella, onde era stata levata quella che fu mandata a Gran Vela, che certo è pittura bellissima e degna di quel luogo. Fece poi Bronzino al signor Alamanno Salviati una Venere con un satiro appresso, tanto bella che par Venere veramente dea della bellezza.
Andato poi a Pisa, dove fu chiamato dal Duca, fece per sua eccellenzia alcuni ritratti, et a Luca Martini suo amicissimo, anzi non pure di lui solo, ma di tutti i virtuosi affezionatissimo veramente, un quadro di Nostra Donna molto bello, nel quale ritrasse detto Luca con una cesta di frutte, per essere stato colui ministro e proveditore per lo detto signor Duca nella diseccazione de' paduli et altre acque, che tenevano infermo il paese d'intorno a Pisa, e conseguentemente per averlo renduto fertile e copioso di frutti. E non partì di Pisa il Bronzino, che gli fu allogata per mezzo del Martini da Raffaello del Setaiuolo, Operaio del Duomo, la tavola d'una delle cappelle del detto Duomo; nella quale fece Cristo ignudo con la croce et intorno a lui molti Santi, fra i quali è un San Bartolomeo scorticato, che pare una vera notomia et un uomo scorticato da dovero, così è naturale et imitato da una notomia con diligenza; la quale tavola, che è bella in tutte le parti, fu posta da una capella, come ho detto, donde ne levarono un'altra di mano di Benedetto da Pescia, discepolo di Giulio Romano. Ritrasse poi Bronzino al duca Cosimo Morgante nano ignudo tutto intero, et in due modi, cioè da un lato del quadro il dinanzi e dall'altro il di dietro, con quella stravaganza di membra mostruose che ha quel nano, la qual pittura in quel genere è bella e maravigliosa. A ser Carlo Gherardi da Pistoia, che in fin da giovinetto fu amico del Bronzino, fece in più tempi, oltre al ritratto di esso ser Carlo, una bellissima Iudit, che mette la testa di Oloferne in una sporta; nel coperchio che chiude questo quadro a uso di spera, fece una Prudenza che si specchia. Al medesimo fece un quadro di Nostra Donna, che è delle belle cose che abbia mai fatto, perché ha disegno e rilievo straordinario. Il medesimo fece il ritratto del Duca, pervenuto che fu sua eccellenzia all'età di quaranta anni, e così la signora Duchessa, che l'uno e l'altro somigliano quanto è possibile. Avendo Giovambatista Cavalcanti fatto fare di bellissimi mischi, venuti d'oltra mare con grandissima spesa, una cappella in Santo Spirito di Firenze e quivi riposte l'ossa di Tommaso suo padre, fece fare la testa col busto di esso suo padre a fra' Giovan Agnolo Montorsoli, e la tavola dipinse Bronzino, facendovi Cristo che in forma d'ortolano appare a Maria Madalena e più lontane due altre Marie, tutte figure fatte con incredibile diligenza.
Avendo alla sua morte lasciata Iacopo Puntormo imperfetta la cappella di San Lorenzo, et avendo ordinato il signor Duca che Bronzino la finisse, egli vi finì dalla parte del Diluvio molti ignudi, che mancavano a basso, e diede perfezzione a quella parte e dall'altra, dove a' piè della Ressurrezione de' morti mancavano nello spazio d'un braccio incirca per altezza, nel largo di tutta la facciata, molte figure, le fece tutte bellissime e della maniera che si veggiono; et a basso fra le finestre in uno spazio che vi restava non dipinto, finì un San Lorenzo ignudo sopra una grata, con certi putti in-torno. Nella quale tutt'opera fece conoscere che aveva con molto miglior giudizio condotte in quel luogo le cose sue, che non aveva fatto il Puntormo suo maestro le sue pitture di quell'opera. Il ritratto del qual Puntormo fece di sua mano il Bronzino in un canto della detta cappella a man ritta del San Lorenzo. Dopo diede ordine il Duca a Bronzino che facesse due tavole grandi, una per mandare a Porto Feraio nell'isola dell'Elba alla città di Cosmopoli, nel convento de' fra-ti Zoccolanti, edificato da sua eccellenzia, dentrovi una Deposizione di Cristo di croce con buon numero di figure, et un'altra per la nuova chiesa de' Cavalieri di Santo Stefano, che poi si è edificata in Pisa insieme col palazzo e spedale loro con ordine e disegno di Giorgio Vasari, nella qual tavola dipinse Bronzino dentrovi la Natività di Nostro Signore Gesù Cristo. Le quali amendue tavole sono state finite con tanta arte, diligenzia, disegno, invenzione e somma vaghezza di colorito, che non si può far più. E certo non si doveva meno in una chiesa edificata da un tanto principe, che ha fondata e dotata la detta Religione de' Cavalieri.
In alcuni quadretti piccoli, fatti di piastra di stagno e tutti d'una grandezza medesima, ha dipinto il medesimo tutti gl'uomini grandi di casa Medici, cominciando da Giovanni di Bicci e Cosimo Vecchio insino alla Reina di Francia, per quella linea, e nell'altra da Lorenzo fratello di Cosimo Vecchio insino al duca Cosimo e suoi figliuoli, i quali tutti ritratti sono, per ordine, dietro la porta d'uno studiolo che il Vasari ha fatto fare nell'appartamento delle stanze nuove nel palazzo ducale, dove è gran numero di statue antiche di marmi e bronzi e moderne pitture piccole, minii rarissimi et una infinità di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, accomodate con bellissimo ordine. Questi ritratti dunque degl'uomini illustri di casa Medici sono tutti naturali, vivaci e somigliantissimi al vero, ma è gran cosa che dove sogliono molti ne-gl'ultimi anni far manco bene che non hanno fatto per l'addietro, costui fa così bene e meglio ora, che quando era nel meglio della virilità, come ne dimostrano l'opere che fa giornalmente.
Fece anco non ha molto il Bronzino a don Silvano Razzi monaco di Camaldoli nel monasterio degl'Angeli di Firenze, che è molto suo amico, in un quadro alto quasi un braccio e mezzo una Santa Caterina tanto bella e ben fatta, ch'ella non è inferiore a niun'altra pittura di mano di questo nobile artefice. Intanto che non pare che le manchi se non lo spirito e quella voce che con[fuse] il tiranno e confessò Cristo suo sposo dilettissimo insino all'ultimo fiato. Onde niuna cosa ha quel padre, come gentile che è veramente, la quale egli più stimi et abbia in pregio, che quel quadro.
Fece Agnolo un ritratto di don Giovanni cardinale de' Medici, figliuolo del duca Cosimo, che fu mandato in corte dell'imperatore alla reina Giovanna; e dopo quello del signor don Francesco prencipe di Fiorenza, che fu pittura molto simile al vero e fatta con tanta diligenza, che par miniata.
Nelle nozze della reina Giovanna d'Austria, moglie del detto Principe, dipinse in tre tele grandi, che furono poste al ponte alla Carraia, come si dirà in fine, alcune storie delle nozze d'Imeneo, in modo belle che non parvero cose da feste, ma da essere poste in luogo onorato per sempre, così erano finite e condotte con diligenza. Et al detto signor Prencipe ha dipinto, sono pochi mesi, un quadretto di piccole figure, che non ha pari, e si può dire che sia di minio veramente. E perché in questa sua presente età d'anni sessantacinque non è meno inamorato delle cose dell'arte che fusse da giovane, ha tolto a fare finalmente, come ha voluto il Duca, nella chiesa di San Lorenzo, due storie a fresco nella facciata a canto all'organo, nelle quali non ha dubbio che riuscirà quell'eccellente Bronzino che è stato sempre.
Si è dilettato costui e dilettasi ancora assai della poesia, onde ha fatto molti capitoli e sonetti, una parte de' quali so-no stampati. Ma sopra tutto (quanto alla poesia) è maraviglioso nello stile e capitoli bernieschi, intanto che non è oggi chi faccia in questo genere di versi meglio, né cose più bizarre e capricciose di lui, come un giorno si vedrà, se tutte le sue opere, come si crede e spera, si stamperanno.
È stato et è il Bronzino dolcissimo e molto cortese amico, di piacevole conversazione, et in tutti i suoi affari è molto onorato; è stato liberale et amorevole delle sue cose quanto più può essere un artefice e nobile come è egli. È stato di natura quieto e non ha mai fatto ingiuria a niuno, et ha sempre amato tutti i valent'uomini della sua professione, come sappiamo noi che abbiam tenuta insieme stretta amicizia anni quarantatré, cioè dal 1524 insino a questo anno, perciò che cominciai in detto tempo a conoscerlo et amarlo, allora che lavorava alla Certosa col Puntormo, l'opere del quale andava io giovinetto a disegnare in quel luogo.
Molti sono stati i creati e' discepoli del Bronzino. Ma il primo (per dire ora degl'accademici nostri) è Alessandro Allori, il quale è stato amato sempre dal suo maestro, non come discepolo, ma come proprio figliuolo, e sono vivuti e vivono insieme con quello stesso amore fra l'uno e l'altro che è fra buon padre e figliuolo. Ha mostrato Alessandro in molti quadri e ritratti, che ha fatto insino a questa sua età di trenta anni, esser degno discepolo di tanto maestro e che cerca con la diligenza e continuo studio di venire a quella più rara perfezzione, che dai begli et elevati ingegni si disidera.
Ha dipinta e condotta tutta di sua mano con molta diligenza la cappella de' Montaguti, nella chiesa della Nunziata, cioè la tavola a olio e le facce e la volta a fresco; nella tavola è Cristo in alto e la Madonna in atto di giudicare, con molte figure in diverse attitudini e ben fatte, ritratte dal Giudizio di Michelagnolo Buonarroti; d'intorno a detta tavola, due di sotto e due di sopra, sono nella medesima facciata quattro figure grandi in forma di Profeti o vero Evangelisti, e nella volta sono alcune Sibille e Profeti condotti con molta fatica e studio e diligenza, avendo cerco imitare negli ignudi Michelagnolo. Nella facciata che è a man manca guardando l'altare, è Cristo fanciullo che disputa nel tempio in mezzo a' Dottori. Il qual putto in buona attitudine mostra arguire a' quisiti loro; et i Dottori et altri, che stanno attentamente a udirlo, sono tutti variati di volti, d'attitudini e d'abiti, e fra essi sono ritratti di naturale molti degl'amici di esso Alessandro, che somigliano. Dirimpetto a questa, nell'altra faccia, è Cristo che caccia del tempio coloro che ne facevano, vendendo e comperando, un mercato et una piazza, con molte cose degne di considerazione e di lode. E sopra queste due sono alcune storie della Madonna, nella volta figure e non molto grandi, ma sì bene assai acconciamente graziose, con alcuni edifizii e paesi, che mostrano nel loro essere l'amore che porta all'arte e 'l cercare la perfezzione del disegno et invenzione. E dirimpetto alla tavola, su in alto, è una storia d'Ezechia quando vide una gran moltitudine d'ossa ripigliare la carne e rivestirsi le membra; nella quale ha mostro questo giovane quando egli desideri posseder la notomia del corpo umano, e d'averci atteso, e studiarla, e nel vero in questa prima opera d'importanza ha mostro, nelle nozze di sua altezza con figure di rilievo e storie dipinte, e dato gran saggio e speranza di sé e va continuando, d'avere a farsi eccellente pittore, avendo questa et alcune altre opere minori, come ultimamente in un quadretto pieno di figure piccole a uso di minio che ha fatto per don Francesco principe di Fiorenza, che è lodatissimo, et altri quadri e ritratti ha condotto con grande studio e diligenza per farsi pratico et acquistare gran maniera.
Ha anco mostro buona pratica e molta destrezza un altro giovane, pur creato del Bronzino nostro accademico, chiamato Giovanmaria Butteri, per quel che fece, oltre a molti quadri et altre opere minori, nell'essequie di Michelagnolo e nella venuta della detta serenissima reina Giovanna a Fiorenza.
È stato anco discepolo, prima del Puntormo e poi del Bronzino, Cristofano dell'Altissimo pittore, il quale, dopo aver fatto in sua giovanezza molti quadri a olio et alcuni ritratti, fu mandato dal signor duca Cosimo a Como a ritrarre dal museo di monsignor Giovio molti quadri di persone illustri fra una infinità che in quel luogo ne raccolse quell'uomo raro de' tempi nostri, oltre a molti che ha provisti di più, con la fatica di Giorgio Vasari, il duca Cosimo, che di tutti questi ritratti se ne farà uno indice nella tavola di questo libro per non occupare in questo ragionamento troppo luogo; nel che fare si adoperò Cristofano con molta diligenza e di maniera in questi ritratti, che quelli che ha ricavato insino a oggi, e che sono in tre fregiature d'una guardaroba di detto signor Duca, come si dirà altrove de' sua ornamenti, passano il numero di dugentoottanta, fra pontefici, imperatori, re et altri principi, capitani d'eserciti, uomini di lettere, et insomma per alcuna cagione illustri e famosi. E per vero dire abbiàn grande obligo a questa fatica e diligenza del Giovio e del Duca, perciò che non solamente le stanze de' principi, ma quelle di molti privati si vanno adornando de' ritratti o d'uno
o d'altro di detti uomini illustri, secondo le patrie, famiglie et affezione di ciascuno. Cristofano adunque fermatosi in questa maniera di pitture, che è secondo il genio suo o vero inclinazione, ha fatto poco altro, come quegli che dee trarre di questa onore et utile a bastanza.
Sono ancora creati del Bronzino Stefano Pieri e Lorenzo dello Sciorina, che l'uno e l'altro hanno nelle esequie di Michelagnolo e nelle nozze di sua altezza adoperato sì, che sono stati conumerati fra i nostri accademici.
Della medesima scuola del Puntormo e Bronzino è anche uscito Batista Naldini, di cui si è in altro luogo favellato, il quale dopo la morte del Puntormo, essendo stato in Roma alcun tempo et atteso con molto studio all'arte, ha molto acquistato e si è fatto pratico e fiero dipintore, come molte cose ne mostrano che ha fatto al molto reverendo don Vincenzio Borghini, il quale se n'è molto servito et ha aiutatolo insieme con Francesco da Poppi, giovane di grande speranza e nostro accademico, che s'è portato bene nelle nozze di sua altezza, et altri suoi giovani, i quali don Vincenzio va continuamente esercitandogli et aiutandogli. Di Batista si è servito già più di due anni e serve ancora il Vasari nell'ope-re del palazzo ducale di Firenze, dove, per la concorrenza di molti altri che nel medesimo luogo lavoravano, ha molto acquistato, di maniera che oggi è pari a qual si voglia altro giovane della nostra Accademia. E quello che molto piace a chi di ciò ha giudizio, si è che egli è spedito e fa l'opere sue senza stento. Ha fatto Batista in una tavola a olio, che è in una cappella della Badia di Fiorenza de' monaci neri, un Cristo che porta la croce, nella quale opera sono molto buone figure, e tuttavia ha fra mano altre opere, che lo faranno conoscere per valent'uomo.
Ma non è a niuno de' sopra detti inferiore per ingegno, virtù e merito Maso Mazzuoli, detto Maso da San Friano, giovane di circa trenta o trentadue anni, il quale ebbe i suoi primi principii da Pierfrancesco di Iacopo di Sandro nostro accademico, di cui si è in altro luogo favellato. Costui, dico, oltre all'avere mostro quanto sa e quanto si può di lui sperare in molti quadri e pitture minori, l'ha finalmente mostrato in due tavole con molto suo onore e piena sodisfazione dell'universale, avendo in esse mostrato invenzione, disegno, maniera, grazia et unione nel colorito. Delle quali tavole in una, che è nella chiesa di Santo Apostolo di Firenze, è la Natività di Gesù Cristo. E nell'altra, posta nella chiesa di San Piero Maggiore, che è bella quanto più non l'arebbe potuta fare un ben pratico e vecchio maestro, è la Visitazione di Nostra Donna a Santa Lisabetta, fatta con molte belle considerazioni e giudizio; onde le teste, i panni, l'attitudini, i casamenti et ogni altra cosa è piena di vaghezza e di grazia. Costui nell'esequie del Buonarruoto, come accademico et amorevole, e poi nelle nozze della reina Giovanna in alcune storie si portò bene oltre modo.
Ora perché non solo nella vita di Ridolfo Ghirlandaio si è ragionato di Michele suo discepolo e di Carlo da Loro, ma anco in altri luoghi, qui non dirò altro di loro ancor che sieno de' nostri accademici, essendosene detto a bastanza.
Già non tacerò che sono similmente stati discepoli e creati del Ghirlandaio, Andrea del Minga, ancor esso de' nostri accademici, che ha fatto e fa molte opere, e Girolamo di Francesco crucifissaio, giovane di ventisei anni, e Mirabello di Salincorno pittori, i quali hanno fatto e fanno così fatte opere di pittura a olio, in fresco e ritratti che si può di loro sperare onoratissima riuscita. Questi due fecero insieme, già sono parecchi anni, alcune pitture a fresco nella chiesa de' Scapuccini fuor di Fiorenza, che sono ragionevoli. E nell'esequie di Michelagnolo e nozze sopra dette si fecero anch'es-si molto onore. Ha Mirabello fatto molti ritratti e particolarmente quello dell'illustrissimo Prencipe più d'una volta, e molti altri che sono in mano di diversi gentiluomini fiorentini. Ha anco molto onorato la nostra Accademia e se stesso Federigo di Lamberto d'Asterdam fiammingo, genero del padoano Cartaro, nelle dette esequie e nell'apparato delle nozze del Prencipe; et oltre ciò ha mostro in molti quadri di pitture a olio grandi e piccoli et altre opere, che ha fatto buona maniera e buon disegno e giudizio. E se ha meritato lode in sin qui, più ne meriterà per l'avenire, adoperandosi egli con molto acquisto continuamente in Fiorenza, la quale par che si abbia eletta per patria, e dove è ai giovani di molto giovamento la concorrenza e l'emulazione.
Si è anco fatto conoscere di bello ingegno et universalmente copioso di buoni capricci Bernardo Timante Buonacorsi, il quale ebbe nella sua fanciullezza i primi principii della pittura dal Vasari, poi continuando ha tanto acquistato, che ha già servito molti anni e serve con molto favore l'illustrissimo signor don Francesco Medici principe di Firenze. Il quale l'ha fatto e fa continuamente lavorare, onde ha condotto per sua eccellenza molte opere miniate, secondo il modo di don Giulio Clovio, come sono molti ritratti e storie di figure piccole, condotte con molta diligenza.
Il medesimo ha fatto con bell'architettura ordinatagli dal detto Prencipe uno studiolo con partimenti d'ebano e colonne di elitropie e diaspri orientali e di lapislazzari, che hanno base e capitelli d'argento intagliati, et oltre ciò ha l'ordi-ne di quel lavoro, per tutto ripieno di gioie e vaghissimi ornamenti d'argento, con belle figurette. Dentro ai quali ornamenti vanno miniature, e fra' termini accoppiati figure tonde d'argento e d'oro, tramezzate da altri partimenti di agate, diaspri, elitropie, sardoni, corniuole et altre pietre finissime, che il tutto qui raccontare sarebbe lunghissima storia. Basta che in questa opera, la quale è presso al fine, ha mostrato Bernardo bellissimo ingegno et atto a tutte le cose; servendosene quel signore a molte sue ingegnose fantasie di tirari per pesi d'argani e di linee, oltra che ha con facilità trovato il modo di fondere il cristallo di montagna e purificarlo e fattone istorie e vasi di più colori, che a tutto Bernardo s'intermette, come ancora si vedrà nel condurre in poco tempo vasi di porcellana, che hanno tutta la perfezzione che più antichi e perfetti; che di questo n'è oggi maestro eccellentissimo Giulio da Urbino, quale si trova appresso allo illustrissimo duca Alfonso Secondo di Ferrara, che fa cose stupende di vasi di terre di più sorte, et a quegli di porcellana dà garbi bellissimi, oltre al condurre della medesima terra duri e con pulimento straordinario quadrini et ottangoli e tondi per far pavimenti contrafatti che paiono pietre mischie, che di queste cose ha il modo il Principe nostro da farne.
Ha dato sua eccellenzia principio ancora a fare un tavolino di gioie con ricco ornamento per accompagnarne un altro del duca Cosimo suo padre, finito non è molto col disegno del Vasari, che è cosa rara, commesso tutto nello alabastro orientale e ne' pezzi grandi di diaspri e chiropie, corgnole, lapislazzari et agate con altre pietre e gioie di pregio che vagliono ventimila scudi; questo tavolino è stato condotto da Bernardino di Porfirio da Leccio, del contado di Fiorenza, il quale è eccellente in questo, che condusse a Messer Bindo Altoviti parimente di diaspri un ottangolo commessi nel-l'ebano et avorio col disegno del medesimo Vasari, il quale Bernardino è oggi al servigio di loro eccellenzie.
E per tornare a Bernardo dico che nella pittura il medesimo mostrò altresì, fuori dell'aspettazione di molti, che sa non meno fare le figure grandi che le piccole, quando fece quella gran tela, di cui si è ragionato, nell'essequie di Michelagnolo. Fu anco adoperato Bernardo con suo molto onore nelle nozze del suo e nostro Prencipe, in alcune mascherate, nel Trionfo de' Sogni, come si dirà, negl'intermedii della commedia, che fu recitata in palazzo, come da altri è stato raccontato distesamente. E se avesse costui quando era giovinetto (se bene non passa anco trenta anni) atteso agli studii dell'arte, sì come attese al modo di fortificare, in che spese assai tempo, egli sarebbe oggi per aventura a tal grado d'ec-cellenza che altri ne stupirebbe, tuttavia si crede abbia a conseguire per ogni modo il medesimo fine, se bene alquanto più tardi, perciò che è tutto ingegno e virtù. A che si aggiugne l'essere sempre esercitato et adoperato dal suo signore et in cose onoratissime.
È anco nostro accademico Giovanni della Strada fiammingo, il quale ha buon disegno, bonissimi capricci, molta invenzione e buon modo di colorire. Et avendo molto acquistato in dieci anni che ha lavorato in palazzo a tempera, a fresco et a olio, con ordine e disegni di Giorgio Vasari, può stare a paragone di quanti pittori ha al suo servizio il detto signor Duca. Ma oggi la principal cura di costui si è fare cartoni per diversi panni d'arazzo, che fa fare pur con l'ordine del Vasari il Duca et il Principe di diverse sorte, secondo le storie che hanno in alto di pittura le camere e stanze dipinte dal Vasari in palazzo, per ornamento delle quali si fanno, acciò corrisponda il parato da basso d'arazzi con le pitture di sopra. Per le stanze di Saturno, d'Opi, di Cerere, di Giove e d'Ercole ha fatto vaghissimi cartoni per circa trenta pezzi d'arazzi. E per le stanze di sopra, dove abita la Principessa, che sono quattro dedicate alla virtù delle donne, con istorie di Romane, Ebree, Greche e Toscane, cioè le Sabine, Ester, Penelope e Gualdrada, ha fatto similmente cartoni per pan-ni bellissimi, e similmente per dieci panni d'un salotto, nei quali è la vita dell'uomo. Et il simile ha fatto per le cinque stanze di sotto, dove abita il Principe, dedicate a Davit, Salamone, Ciro et altri. E per venti stanze del palazzo del Poggio a Caiano, che se ne fanno i panni giornalmente, ha fatto con l'invenzione del Duca ne' cartoni le cacce che si fanno di tutti gl'animali et i modi d'uccellare e pescare, con le più strane e belle invenzioni del mondo. Nelle quali varietà d'a-nimali, d'ucelli, di pesci, di paesi e di vestiri, con cacciatori a piedi et a cavallo, et uccellatori in diversi abiti e pescatori ignudi, ha mostrato e mostra di essere veramente valent'uomo e d'aver bene appreso la maniera italiana con pensiero di vivere e morire a Fiorenza in servigio de' suoi illustrissimi signori, in compagnia del Vasari e degl'altri accademici.
È nella medesima maniera creato del Vasari et accademico Iacopo di maestro Piero Zucca fiorentino, giovane di venticinque o ventisei anni, il quale, avendo aiutato al Vasari fare la maggior parte delle cose di palazzo et in particolare il palco della sala maggiore, ha tanto acquistato nel disegno e nella pratica de' colori, con molta sua fatica, studio et assiduità, che si può oggi annoverare fra i primi giovani pittori della nostra Accademia. E l'opere che ha fatto da sé solo nell'essequie di Michelagnolo, nelle nozze dell'illustrissimo signor Principe et altre a diversi amici suoi, nelle quali ha mostro intelligenza, fierezza, diligenza, grazia e buon giudizio, l'hanno fatto conoscere per giovane virtuoso e valente dipintore, ma più lo faranno quelle che da lui si possono sperare nell'avenire, con tanto onore della sua patria quanto gli abbia fatto in alcun tempo altro pittore.
Parimente fra gl'altri giovani pittori dell'Accademia si può dire ingegnoso e valente Santi Tidi, il quale, come in altri luoghi s'è detto, dopo essersi molti anni esercitato in Roma, è tornato finalmente a godersi Fiorenza, la quale ha per sua patria, se bene i suoi maggiori sono dal Borgo San Sepolcro et in quella città d'assai orrevole famiglia. Costui nell'esse-quie del Buonarruoto, e nelle dette nozze della serenissima Principessa, si portò certo nelle cose che dipinse bene affatto, ma maggiormente e con molta et incredibile fatica nelle storie che dipinse nel teatro, che fece per le medesime nozze all'illustrissimo signor Paol Giordano Orsino, duca di Bracciano, in sulla piazza di San Lorenzo, nel quale dipinse di chiaro scuro in più pezzi di tele grandissime istorie de' fatti d'i più uomini illustri di casa Orsina. Ma quello che vaglia si può meglio vedere in due tavole che sono fuori di sua mano, una delle quali è in Ogni Santi o vero San Salvadore di Firenze (che così è chiamato oggi) già chiesa de' padri Umiliati et oggi de' Zoccolanti, nella quale è la Madonna in alto et a basso San Giovanni, San Girolamo et altri Santi. E nell'altra, che è in San Giuseppo dietro a Santa Croce, alla cap-pella de' Guardi, è una Natività del Signore fatta con molta diligenzia e con molti ritratti di naturale, senza molti quadri di Madonne et altri ritratti, che ha fatto in Roma et in Fiorenza e pitture lavorate in Vaticano, come s'è detto di sopra. Sono anco della medesima Accademia alcun'altri giovani pittori, che si sono adoperati negl'apparati sopra detti, parte fiorentini e parte dello stato.
Alessandro del Barbiere fiorentino, giovane di venticinque anni, oltre a molte altre cose, dipinse in palazzo per le dette nozze, con disegni et ordine del Vasari, le tele delle facciate della sala grande, dove sono ritratte le piazze di tutte le città del dominio del signor Duca, nelle quali si portò certo molto bene e mostrossi giovane giudizioso e da sperare ogni riuscita.
Hanno similmente aiutato al Vasari in queste et altre opere molti altri suoi creati et amici: Domenico Benci, Alessandro Fortori d'Arezzo, Stefano Veltroni suo cugino et Orazio Porta, amendue dal Monte San Savino, Tomaso del Verrocchio.
Nella medesima Accademia sono anco molti eccellenti artefici forestieri de' quali si è parlato a lungo di sopra in più luoghi; e però basterà che qui si sappino i nomi, acciò siano fra gl'altri accademici in questa parte annoverati. Sono dunque Federigo Zucchero, Prospero Fontana e Lorenzo Sabatini bolognesi, Marco da Faenza, Tiziano Vecello, Paulo Veronese, Giuseppo Salviati, il Tintoretto, Alessandro Vittoria, il Danese scultori, Batista Farinato veronese pittore, et Andrea Palladio architetto.
Ora per dire similmente alcuna cosa degli scultori accademici e dell'opere loro, nelle quali non intendo molto volere allargarmi, per esser essi vivi e per lo più di chiarissima fama e nomea, dico che Benvenuto Cellini cittadino fiorentino (per cominciarmi dai più vecchi e più onorati), oggi scultore, quando attese all'orefice in sua giovanezza, non ebbe pari, né aveva forse in molti anni in quella professione et in fare bellissime figure di tondo e basso rilievo e tutte altre opere di quel mestiero: legò gioie et adornò di castoni maravigliosi, con figurine tanto ben fatte et alcuna volta tanto bizzarre e capricciose, che non si può, né più, né meglio imaginare. Le medaglie ancora, che in sua gioventù fece d'oro e d'ar-gento, furono condotte con incredibile diligenza, né si possono tanto lodare che basti. Fece in Roma a papa Clemente Settimo un bottone da piviale bellissimo accomodandovi ottimamente una punta di diamante intornata da alcuni putti fatti di piastra d'oro et un Dio Padre mirabilmente lavorato, onde oltre al pagamento ebbe in dono da quel Papa l'ufizio d'una mazza.
Essendogli poi dal medesimo Pontefice dato a fare un calice d'oro, la coppa del quale dovea esser retta da figure rappresentanti le Virtù teologiche, lo condusse assai vicino al fine con artifizio maravigliosissimo. Ne' medesimi tempi non fu chi facesse meglio, fra molti che si provarono, le medaglie di quel Papa di lui, come ben sanno coloro che le videro e n'hanno. E perché ebbe per queste cagioni cura di fare i conii della Zecca di Roma, non sono mai state vedute più belle monete di quelle che allora furono stampate in Roma. E perciò dopo la morte di Clemente, tornato Benvenuto a Firenze, fece similmente i conii con la testa del duca Alessandro per le monete per la Zecca di Firenze, così belli e con tanta diligenza, che alcune di esse si serbano oggi come bellissime medaglie antiche e meritamente, perciò che in queste vinse se stesso. Datosi finalmente Benvenuto alla scultura et al fare di getto, fece in Francia molte cose di bronzo, d'argento e d'oro mentre stette al servizio del re Francesco in quel regno. Tornato poi alla patria e messosi al servizio del duca Cosimo, fu prima adoperato in alcune cose da orefice, et in ultimo datogli a fare alcune cose di scultura, onde condusse di metallo la statua del Perseo, che ha tagliata la testa a Medusa, la quale è in piazza del Duca vicina alla porta del palazzo del Duca, sopra una basa di marmo con alcune figure di bronzo bellissime alte circa un braccio et un terzo l'una, la quale tutta opera fu condotta veramente con quanto studio e diligenza si può maggiore a perfezzione e posta in detto luogo degnamente a paragone della Iudit di mano di Donato, così famoso e celebrato scultore. E certo fu maraviglia, che essendosi Benvenuto esercitato tanti anni in far figure piccole, ci condusse poi con tanta eccellenza una statua così grande.
Il medesimo ha fatto un Crucifisso di marmo tutto tondo e grande quanto il vivo, che per simile è la più rara e bella scultura che si possa vedere. Onde lo tiene il signor Duca, come cosa a sé carissima, nel palazzo de' Pitti, per collocarlo alla cappella o vero chiesetta che fa in detto luogo, la qual chiesetta non poteva a questi tempi avere altra cosa più di sé e di sì gran prencipe; et insomma non si può quest'opera tanto lodare, che basti.
Ora, se bene potrei molto più allargarmi nell'opere di Benvenuto, il quale è stato in tutte le sue cose animoso, fiero, vivace, prontissimo e terribilissimo, e persona che ha saputo purtroppo dire il fatto suo con i prìncipi, non meno che le mani e l'ingegno adoperare nelle cose dell'arti, non ne dirò qui altro, atteso che egli stesso ha scritto la vita e l'opere sue, et un trattato dell'oreficeria e del fondere e gettar di metallo con altre cose attenenti a tali arti e della scultura con molto più eloquenza et ordine che io qui per aventura non saprei fare. E però quanto a lui, basti questo breve sommario delle sue più rare opere principali.
Francesco di Giuliano da San Gallo scultore, architetto et accademico, di età oggi di settanta anni, ha condotto, come si è detto nella vita di suo padre et altrove, molte opere di scultura: le tre figure di marmo alquanto maggior del vivo, che sono sopra l'altare della chiesa d'Or San Michele, Santa Anna, la Vergine e Cristo fanciullo, che sono molto lo-date figure. Alcun'altre statue, pur di marmo, alla sepoltura di Piero de' Medici a Monte Casino; la sepoltura, che è nella Nunziata, del vescovo de' Marzi, e quella di monsignor Giovio, scrittore delle storie de' suoi tempi. Similmente d'archi-tettura ha fatto il medesimo, et in Fiorenza et altrove, molte belle e buon'opere et ha meritato, per le sue buone qualità, di esser sempre stato come loro creatura favorito della casa de' Medici, per la servitù di Giuliano suo padre, onde il duca Cosimo, dopo la morte di Baccio d'Agnolo, gli diede il luogo che colui aveva d'architettore del duomo di Firenze.
Dell'Amannato, che è anch'egli fra i primi de' nostri accademici, essendosi detto a bastanza nella descrizione dell'o-pere di Iacopo Sansovino, non fa bisogno parlarne qui altrimenti.
Dirò bene che sono suoi creati et accademici Andrea Calamech da Carrara, scultore molto pratico, che ha sotto esso Amannato condotto molte figure et il quale dopo la morte di Martino sopra detto è stato chiamato a Messina nel luogo che là tenne già fra' Giovan Agnolo, nel qual luogo s'è morto. E Batista di Benedetto, giovane che ha dato saggio di dovere, come farà, riuscire eccellente, avendo già mostro in molte opere che non è meno del detto Andrea, né di qual si vogl'altro de' giovani scultori accademici, di bell'ingegno e giudizio.
Vincenzio de' Rossi da Fiesole scultore, anch'egli architetto et accademico fiorentino, è degno che in questo luogo si faccia di lui alcuna memoria, oltre quello che se n'è detto nella vita di Baccio Bandinelli, di cui fu discepolo. Poi dunque che si fu partito da lui, diede gran saggio di sé in Roma, ancor che fusse assai giovane, nella statua che fece nella Ritonda d'un S. Giuseppo con Cristo fanciullo di dieci anni, ambidue figure fatte con buona pratica e bella maniera. Fece poi nella chiesa di Santa Maria della Pace due sepolture, con i simulacri di coloro che vi son dentro sopra le casse e di fuori nella facciata alcuni Profeti di marmo di mezzo rilievo e grandi quanto il vivo, che gl'acquistarono nome di eccellente scultore, onde gli fu poi allogata dal popolo romano la statua che fece di papa Paulo Quarto, che fu posta in Campidoglio, la quale condusse ottimamente. Ma ebbe quell'opera poco vita, perciò che, morto quel Papa, fu rovinata e gettata per terra dalla plebaccia, che oggi quegli stessi perseguita fieramente che ieri aveva posti in cielo. Fece Vincenzio dopo la detta figura, in uno stesso marmo, due statue poco maggiori del vivo, cioè un Teseo re d'Atene, che ha rapito Elena e se la tiene in braccio in atto di conoscerla, con una troia sotto i piedi. Delle quali figure non è possibile farne altre con più diligenza, studio, fatica e grazia. Per che andando il duca Cosimo de' Medici a Roma, et andando a vedere non meno le cose moderne degne d'essere vedute, che l'antiche, vide, mostrandogliene Vincenzio, le dette statue, e le lodò sommamente, come meritavano; onde Vincenzio, che è gentile, le donò cortesemente, et insieme gl'offerse in quello potesse l'opera sua. Ma sua eccellenza avendole condotte indi a non molto a Firenze nel suo palazzo de' Pitti, gliel'ha pagate buon pregio. Et avendo seco menato esso Vincenzio, gli diede non molto dopo a fare di marmo, in figure maggiori del vivo e tutte tonde, le fatiche d'Ercole, nelle quali va spendendo il tempo, e già n'ha condotte a fine quando egli uccide Cacco e quando combatte con il Centauro. La quale tutta opera, come è di suggetto altissima e faticosa, così si spera debba essere per artificio et eccellente opera, essendo Vincenzio di bellissimo ingegno, di molto giudizio, et in tutte le sue cose d'importanza molto considerato.
Né tacerò che sotto la costui disciplina attende con sua molta lode alla scultura Illarione Ruspoli, giovane e cittadin fiorentino, il quale non meno degli altri suoi pari accademici ha mostro di sapere et avere disegno e buona pratica in fare statue, quando insieme con gl'altri n'ha avuto occasione nell'essequie di Michelagnolo e nell'apparato delle nozze sopra dette.
Francesco Camilliani, scultore fiorentino et accademico, il quale fu discepolo di Baccio Bandinelli, dopo aver dato in molte cose saggio di essere buono scultore, ha consumato quindici anni negl'ornamenti delle fonti, dove n'è una stupendissima, che ha fatto fare il signor don Luigi di Tolledo al suo giardino di Fiorenza. I quali ornamenti intorno a ciò sono diverse statue d'uomini e d'animali in diverse maniere, ma tutti ricchi e veramente reali e fatti senza risparmio di spesa. Ma in fra l'altre statue che ha fatto Francesco in quel luogo, due maggiori del vivo, che rappresentano Arno e Mugnone fiumi, sono di somma bellezza, e particolarmente il Mugnone, che può stare al paragone di qual si voglia statua di maestro eccellente. Insomma tutta l'architettura et ornamenti di quel giardino sono opera di Francesco il quale l'ha fatto per ricchezza di diverse varie fontane sì fatto, che non ha pari in Fiorenza, né forse in Italia. E la fonte principale, che si va tuttavia conducendo a fine, sarà la più ricca e sontuosa che si possa in alcun luogo vedere, per tutti quelli ornamenti che più ricchi e maggiori possono immaginarsi e per gran copia d'acque, che vi saranno abbondantissime d'ogni tempo.
È anco accademico, e molto in grazia de' nostri prìncipi per le sue virtù, Giovan Bologna da Douay, scultore fiamingo, giovane veramente rarissimo. Il quale ha condotto con bellissimi ornamenti di metallo la fonte che nuovamente si è fatta in sulla piazza di San Petronio di Bologna, dinanzi al palazzo de' Signori, nella quale sono, oltre gl'altri ornamenti, quattro Serene in su' canti bellissime, con varii putti attorno a maschere bizzarre e straordinarie; ma quello che più importa, ha condotto sopra e nel mezzo di detta fonte un Nettunno di braccia sei, che è un bellissimo getto, e figura studiata e condotta perfettamente.
Il medesimo, per non dire ora quante opere ha fatto di terra cruda e cotta, di cera e d'altre misture, ha fatto di marmo una bellissima Venere, e quasi condotto a fine al signor Prencipe un Sansone, grande quanto il vivo, il quale combatte a piedi con due Filistei, e di bronzo ha fatto la statua d'un Bacco maggior del vivo e tutta tonda, et un Mercurio in atto di volare, molto ingegnoso, reggendosi tutto sopra una gamba et in punta di piè, che è stata mandata all'imperatore Massimiliano come cosa che certo è rarissima. Ma se in fin qui ha fatto molte opere e belle, ne farà molto più per l'avenire e bellissime, avendolo ultimamente fatto il signor Prencipe accomodare di stanze in palazzo e datoli a fare una statua di braccia cinque d'una Vittoria con un prigione, che va nella sala grande dirimpetto a un'altra di mano di Michelagnolo. Farà per quel Principe opere grandi e d'importanza, nelle quali averà largo campo di mostrare la sua molta virtù. Hanno di mano di costui molte opere e bellissimi modelli di cose diverse Messer Bernardo Vecchietti gentiluomo fiorentino, e maestro Bernardo di monna Mattea muratore ducale, che ha condotto tutte le fabriche disegnate dal Vasari con gran eccellenza.
Ma non meno di costui i suoi amici e d'altri scultori accademici è giovane veramente raro e di bello ingegno Vincenzio Danti perugino, il quale si ha eletto, sotto la protezzione del duca Cosimo, Fiorenza per patria. Attese costui essendo giovinetto all'orefice, e fece in quella professione cose da non credere. E poi datosi a fare di getto, gli bastò l'a-nimo, di venti anni, gettare di bronzo la statua di papa Giulio Terzo alta quattro braccia, che sedendo dà la benedizione, la quale statua, che è ragionevolissima, è oggi in sulla piazza di Perugia. Venuto poi a Fiorenza al servizio del signor duca Cosimo, fece un modello di cera bellissimo maggior del vivo d'un Ercole che fa scoppiare Anteo, per farne una figura di bronzo, da dovere essere posta sopra la fonte principale del giardino di Castello, villa del detto signor Duca; ma fatta la forma addosso al detto modello, nel volere gettarla di bronzo non venne fatta, ancora che due volte si rimetessi, o per mala fortuna, o perché il metallo fusse abruciato, o altra cagione.
Voltosi dunque, per non sottoporre le fatiche al volere della fortuna, a lavorare di marmo, condusse in poco tempo di un pezzo solo di marmo due figure, cioè l'Onore, che ha sotto l'Inganno, con tanta diligenza, che parve non avesse mai fatto altro che maneggiare i scarpelli et il mazzuolo. Onde alla testa di quell'Onore, che è bella, fece i capegli ricci tanto ben traforati, che paiono naturali e proprii mostrando, oltre ciò, di benissimo intendere gl'ignudi, la quale statua è oggi nel cortile della casa del signore Sforza Almieri, nella via de' Servi. A Fiesole, per lo medesimo signore Sforza, fece molti ornamenti in un suo giardino et intorno a certe fontane. Dopo condusse al signor Duca alcuni bassi rilievi di marmo e di bronzo, che furono tenuti bellissimi, per essere egli in questa maniera di sculture per aventura non inferiore a qualunche altro. Appresso gettò, pur di bronzo, la grata della nuova cappella fatta in palazzo nelle stanze nuove, di-pinte da Giorgio Vasari, e con essa un quadro di molte figure di basso rilievo, che serra un armario dove stanno scritture d'importanza del Duca. Et un altro quadro alto un braccio e mezzo e largo due e mezzo, dentrovi Moisè che per guarire il popolo ebreo dal morso delle serpi, ne pone una sopra il legno. Le quali tutte cose sono appresso detto signore, di ordine del quale fece la porta della sagrestia della pieve di Prato, e sopra essa una cassa di marmo con una Nostra Donna alta tre braccia e mezzo, col Figliuolo ignudo appresso e due puttini, che mettono in mezzo la testa di basso rilievo di Messer Carlo de' Medici, figliuolo naturale di Cosimo Vecchio e già proposto di Prato, le cui ossa, dopo esser state lungo tempo in un deposito di mattoni, ha fatto porre il duca Cosimo in detta cassa et onoratolo di quel sepolcro. Ben è vero che la detta Madonna et il basso rilievo di detta testa, che è bellissima, avendo cattivo lume non mostrano a gran pezzo quel che sono.
Il medesimo Vincenzio ha poi fatto per ornarne la fabrica de' magistrati alla Zecca, nella testata sopra la loggia che è sul fiume d'Arno, un'arme del Duca messa in mezzo da due figure nude, maggiori del vivo, l'una fatta per l'Equità e l'altra per lo Rigore. E d'ora in ora aspetta il marmo per fare la statua di esso signore Duca, maggiore assai del vivo, di cui ha fatto un modello, la quale va posta a sedere sopra detta arme, per compimento di quell'opera, la quale si doverrà murare di corto insieme col resto della facciata, che tuttavia ordina il Vasari che è architetto di quella fabrica. Ha anco fra mano e condotta a bonissimo termine una Madonna di marmo maggiore del vivo, ritta e col figliuolo Gesù di tre mesi in braccio, che sarà cosa bellissima. Le quali opere lavora insieme con altre nel monasterio degl'Angeli di Firenze, dove si sta quietamente in compagnia di que' monaci suoi amicissimi, nelle stanze che già quivi tenne Messer Benedetto Varchi, di cui fa esso Vincenzio un ritratto di basso rilievo, che sarà bellissimo. Ha Vincenzio un suo fratello nel-l'Ordine de' frati Predicatori, chiamato frate Ignazio Danti quale nelle cose di cosmografia eccellentissimo e di raro ingegno e tanto che il duca Cosimo de' Medici gli fa condurre un'opera che di quella professione non è stato mai per tempo nessuno fatta, né la maggiore, né la più perfetta; e questo è che sua eccellenzia con l'ordine del Vasari, sul secondo piano delle stanze del suo palazzo ducale, ha di nuovo murato a posta et aggiunto alla guardaroba una sala assai grande, et intorno a quella ha accomodata di armari alti braccia sette con ricchi intagli di legnami di noce, per riporvi dentro le più importanti cose e di pregio e di bellezza che abbi sua eccellenzia; questi ha nelle porte di detti armari spartito dentro agl'ornamenti di quegli cinquantasette quadri d'altezza di braccia due incirca e larghi a proporzione, dentro a' quali sono con grandissima diligenzia fatte in sul legname a uso di minii dipinte a olio le tavole di Tolomeo misurate perfettamente tutte, e ricorrette secondo gli autori nuovi e con le carte giuste delle navigazioni, con somma diligenzia fatte le scale loro da misurare, et i gradi dove sono in quelle, e' nomi antichi e moderni. E la sua divisione di questi quadri sta in que-sto modo: all'entrata principale di detta sala sono negli sguanci e grossezza degli armarini, in quattro quadri, quattro mezze palle in prospettiva: nelle due da basso son l'universale della terra e nelle due di sopra l'universale del cielo, con le sue imagini e figure celesti; poi come s'entra dentro a man ritta è tutta l'Europa in 14 tavole e quadri, una dreto all'al-tra fino al mezzo della facciata che è a sommo dirimpetto alla porta principale, nel qual mezzo s'è posto l'oriolo con le ruote e con le spere de' pianeti che giornalmente fanno entrando i lor moti: quest'è quel tanto famoso e nominato oriolo fatto da Lorenzo della Volpaia fiorentino. Di sopra a queste tavole è l'Affrica in 11 tavole, fino a detto oriolo; séguita poi di là dal detto oriolo l'Asia nell'ordine da basso, e camina parimente in 14 tavole dell'Asia, in altre 14 tavole, seguitano le Indie Occidentali cominciando come le altre dall'oriolo e seguitando fino alla detta porta principale, in tutto tavole 57; è poi ordinato nel basamento da basso in altretanti quadri attorno a torno, che vi saranno a dirittura a piombo di dette tavole tutte l'erbe e tutti gli animali ritratti di naturale secondo la qualità che producano que' paesi. Sopra la cornice di detti armari, ch'è la fine, vi va sopra alcuni risalti che dividono detti quadri che vi si porranno alcune teste antiche di marmo di quegli imperatori e prìncipi che l'hanno possedute, che sono in essere, e nelle facce piane fino alla cornice del palco, quale tutto di legname intagliato, et in 12 gran quadri dipinto per ciascuno quattro immagini celesti, che farà 48, e grandi poco men del vivo con le loro stelle; sono sotto (come ho detto) in dette facce 300 ritratti naturali di persone segnalate da 500 anni in qua o più dipinte in quadri a olio (come se ne farà nota nella tavola de' ritratti, per non far ora sì lunga storia con i nomi loro) tutti d'una grandezza e con un medesimo ornamento intagliato di legno di noce, cosa rarissima. Nelli due quadri di mezzo del palco larghi braccia quattro l'uno, dove sono le immagini celesti, e' quali con facilità si aprono senza veder dove si nascondano, in un luogo a uso di cielo saranno riposte due gran palle alte ciascuna braccia tre e mezzo, nell'una delle quali anderà tutta la terra distintamente, e questa si calerà con un arganetto che non vedrà fino a basso e poserà in un piede bilicato che ferma si vedrà ribattere tutte le tavole che sono a torno ne' quadri degli armari et aranno un contrasegno nella palla da poterle ritrovar facilmente. Nell'altra palla saranno le 48 immagini celesti accomodate in modo che con essa saranno tutte le operazioni dello astrolabio perfettissimamente.
Questo capriccio et invenzione è nata dal duca Cosimo per mettere insieme una volta queste cose del cielo e della terra giustissime e senza errori e da poterle misurare e vedere, et a parte e tutte insieme come piacerà a chi si diletta e studia questa bellissima professione, del che m'è parso debito mio come cosa degna di esser nominata farne in questo luogo per la virtù di frate Ignazio memoria, e per la grandezza di questo Principe che ci fa degni di godere sì onorate fatiche e si sappia per tutto il mondo.
E tornando agl'uomini della nostra Accademia, dico, ancora che nella vita del Tribolo si sia parlato d'Antonio di Gino Lorenzi da Settignano scultore, dico qui con più ordine, come in suo luogo, che egli condusse sotto esso Tribolo suo maestro la detta statua d'Esculapio che è a Castello e quattro putti che sono nella fonte maggiore di detto luogo, e poi ha fatto alcune teste et ornamenti che sono d'intorno al nuovo vivaio di Castello, che è lassù alto in mezzo a diverse sorti d'arbori di perpetua verzura. Et ultimamente ha fatto, nel bellissimo giardino delle stalle vicino a San Marco, bellissimi ornamenti a una fontana isolata, con molti animali acquatici fatti di marmo e di mischi bellissimi. Et in Pisa condusse già con ordine del Tribolo sopra detto la sepoltura del Corte filosofo e medico eccellentissimo con la sua statua e due putti di marmo bellissimi. Et oltre a queste va tuttavia nuove opere facendo per il Duca di animali di mischi et uccelli per fonti, lavori dificilissimi, che lo fanno degnissimo di essere nel numero di questi altri accademici.
Parimente un fratello di costui, detto Stoldo di Gino Lorenzi, giovane di trenta anni, si è portato di maniera infino a ora in molte opere di sculture, che si può con verità oggi annoverare fra i primi giovani della sua professione e porre fra loro ne' luoghi più onorati. Ha fatto in Pisa di marmo una Madonna annunziata dall'Angelo, che l'ha fatto conoscere per giovane di bello ingegno e giudizio. Et un'altra bellissima statua gli fece fare Luca Martini in Pisa, che poi dalla signora duchessa Leonora fu donata al signor don Garzia di Tolledo suo fratello, che l'ha posta in Napoli al suo giardino di Chiaia. Ha fatto il medesimo con ordine di Giorgio Vasari, nel mezzo della facciata del palazzo de' Cavalieri di Santo Stefano in Pisa e sopra la porta principale, un'arme del signor Duca gran Mastro, di marmo, grandissima, messa in mezzo da due statue tutte tonde, la Religione e la Giustizia, che sono veramente bellissime e lodatissime da tutti coloro che se n'intendono. Gli ha poi fatto fare il medesimo signore, per lo suo giardino de' Pitti, una fontana simile al bellissimo trionfo di Nettunno, che si vide nella superbissima mascherata che fece sua eccellenza nelle dette nozze del signor Principe illustrissimo. E questo basti quanto a Stoldo Lorenzi, il quale è giovane e va continuamente lavorando et acquistandosi maggiormente, fra' suoi compagni accademici, fama et onore.
Della medesima famiglia de' Lorenzi da Settignano è Batista, detto del Cavaliere, per esser stato discepolo del cavaliere Baccio Bandinelli; il quale ha condotto di marmo tre statue grandi quanto il vivo, le quali gli ha fatto fare Bastiano del Pace cittadin fiorentino, per i Guadagni, che stanno in Francia, e' quali l'hanno poste in un loro giardino, e sono una Primavera ignuda, una State et un Verno, che deono essere accompagnate da un Autunno, le quali statue da molti che l'hanno vedute sono state tenute belle e ben fatte oltre modo. Onde ha meritato Batista di essere stato eletto dal signor Duca a fare la cassa con gl'ornamenti et una delle tre statue che vanno alla sepoltura di Michelagnolo Buonarruoti, le quali fanno con disegno di Giorgio Vasari sua eccellenza e Lionardo Buonarruoti; la quale opera si vede che Batista va conducendo ottimamente a fine con alcuni putti e la figura di esso Buonarruoto dal mezzo in su.
La seconda delle dette tre figure che vanno al detto sepolcro, che hanno a essere la Pittura, Scultura et Architettura, si è data a fare a Giovanni di Benedetto da Castello, discepolo di Baccio Bandinelli et accademico, il quale lavora per l'Opera di Santa Maria del Fiore l'opere di basso rilievo che vanno d'intorno al coro, che oggimai è vicino alla sua perfezzione, nelle quali va molto imitando il suo maestro e si porta in modo, che di lui spera ottima riuscita; né avverrà altrimenti, perciò che è molto assiduo a lavorare et agli studii della sua professione.
E la terza si è allogata a Valerio Cioli da Settignano, scultore et accademico, perciò che l'altre opere che ha fatto in sin qui sono state tali, che si pensa abbia a riuscire la detta figura sì fatta, che non fia se non degna di essere al sepolcro di tant'uomo collocata. Valerio, il quale è giovane di ventisei anni, ha in Roma al giardino del cardinale di Ferrara a Monte Cavallo restaurate molte antiche statue di marmo, rifacendo a chi braccia, a chi piedi, et ad altra altre parti, che mancavano. Et il simile ha fatto poi nel palazzo de' Pitti a molte statue, che v'ha condotto per ornamento d'una gran sala il Duca, il quale ha fatte fare al medesimo di marmo la statua di Morgante nano ignuda, la quale è tanto bella e così simile al vero riuscita, che forse non è mai stato veduto altro mostro così ben fatto, né condotto con tanta diligenza simile al naturale e proprio; e parimente gl'ha fatto condurre la statua di Pietro detto Barbino, nano ingegnoso, letterato e molto gentile, favorito dal Duca nostro. Per le quali dico tutte cagioni ha meritato Valerio che gli sia stata allogata da sua eccellenza la detta statua che va alla sepoltura del Buonarruoto, unico maestro di tutti questi accademici valent'uomini.
Quanto a Francesco Moschino scultore fiorentino, essendosi di lui in altro luogo favellato a bastanza, basta dir qui che anch'egli è accademico, e che sotto la protezzione del duca Cosimo va continuando di lavorare nel Duomo di Pisa e che nell'apparato delle nozze si portò ottimamente negl'ornamenti della porta principale del palazzo ducale.
Di Domenico Poggini similmente, essendosi detto di sopra che è scultore valent'uomo e che ha fatto una infinità di medaglie molto simili al vero et alcun'opere di marmo e di getto, non dirò qui altro di lui se non che meritamente è de' nostri accademici, che in dette nozze fece alcune statue molto belle, le quali furono poste sopra l'arco della Religione al canto alla Paglia, e che ultimamente ha fatto una nuova medaglia del Duca similissima al naturale e molto bella e continuamente va lavorando.
Giovanni Fancegli, o vero, come altri il chiamano, Giovanni da Stocco, accademico, ha fatto molte cose di marmo e di pietra, che sono riuscite buone sculture, e fra l'altre è molto lodata un'arme di palle con due putti et altri ornamenti, posta in alto sopra le due finestre inginocchiate della facciata di ser Giovanni Conti in Firenze.
Et il medesimo dico di Zanobi Lastricati il quale come buono e valente scultore ha condotto e tuttavia lavora molte opere di marmo e di getto, che l'hanno fatto dignissimo d'essere nell'Accademia in compagnia de' sopradetti. E fra l'al-tre sue cose è molto lodato un Mercurio di bronzo, che è nel cortile del palazzo di Messer Lorenzo Ridolfi, per esser figura stata condotta con tutte quell'avvertenze che si richieggiono.
Finalmente sono stati accettati nell'Accademia alcuni giovani scultori, che nell'apparato detto delle nozze di sua altezza hanno fatto opere onorate e lodevoli. E questi sono stati fra' Giovan Vincenzio de' Servi, discepolo di fra' Giovan Agnolo, Ottaviano del Collettaio, creato di Zanobi Lastricati, e Pompilio Lancia, figliuolo di Baldassarre da Urbino architetto e creato di Girolamo Genga. Il quale Pompilio nella mascherata detta della Geneologia degli dei, ordinata per lo più e quanto alle machine dal detto Baldassarre suo padre, si portò in alcune cose ottimamente.
DESCRIZIONE DELL'OPERE DI GIORGIO VASARI
PITTORE ET ARCHITETTO ARETINO

Avendo io in fin qui ragionato dell'opere altrui, con quella maggior diligenza e sincerità che ha saputo e potuto l'in-gegno mio, voglio anco nel fine di queste mie fatiche raccòrre insieme e far note al mondo l'opere che la divina bontà mi ha fatto grazia di condurre; perciò che, se bene elle non sono di quella perfezzione che io vorrei, si vedrà nondimeno da chi vorrà con sano occhio riguardarle, che elle sono state da me con istudio, diligenza et amorevole fatica lavorate, e perciò, se non degne di lode, almeno di scusa; sanzaché, essendo pur fuori e veggendosi, non le posso nascondere. E però che potrebbono, per aventura, essere scritte da qualcun altro, è pur meglio che io confessi il vero, et accusi da me stesso la mia imperfezzione, la quale conosco da vantaggio; sicuro di questo, che se, come ho detto, in loro non si vedrà eccellenza e perfezzione, vi si scorgerà per lo meno un ardente disiderio di bene operare, et una grande et indefessa fatica, e l'amore grandissimo che io porto alle nostre arti. Onde averrà secondo le leggi, confessando io apertamente il mio difetto, che me ne sarà una gran parte perdonato.
Per cominciarmi dunque dai miei principii, dico che avendo a bastanza favellato dell'origine della mia famiglia, del-la mia nascita e fanciullezza, e quanto io fussi da Antonio mio padre con ogni sorte d'amorevolezza incaminato nella via delle virtù, et in particolare del disegno, al quale mi vedeva molto inclinato, nella vita di Luca Signorelli da Cortona, mio parente, in quella di Francesco Salviati et in molti altri luoghi della presente opera, con buone occasioni non starò a replicar le medesime cose. Dirò bene, che dopo avere io ne' miei primi anni disegnato quante buone pitture sono per le chiese d'Arezzo, mi furono insegnati i primi principii, con qualche ordine, da Guglielmo da Marzilla franzese, di cui avemo di sopra raccontato l'opere e la vita. Condotto poi l'anno 1524 a Fiorenza da Silvio Passerini cardinale di Cortona, attesi qualche poco al disegno sotto Michelagnolo, Andrea del Sarto et altri. Ma essendo l'anno 1527 stati cacciati i Medici di Firenze, et in particolare Alessandro et Ippolito, coi quali aveva così fanciullo gran servitù per mezzo di detto Cardinale, mi fece tornare in Arezzo don Antonio mio zio paterno, essendo di poco avanti morto mio padre di peste; il quale don Antonio tenendomi lontano dalla città, perché io non appestassi, fu cagione, che per fuggire l'ozio, mi andai esercitando pel contado d'Arezzo, vicino ai nostri luoghi, in dipignere alcune cose a fresco ai contadini del pa-ese, ancor che io non avessi quasi ancor mai tocco colori; nel che fare m'avvidi che il provarsi e fare da sé aiuta, insegna e fa che altri fa bonissima pratica. L'anno poi 1528, finita la peste, la prima opera che io feci fu una tavoletta nella chiesa di San Piero d'Arezzo de' frati de' Servi, nella quale, che è appoggiata a un pilastro, sono tre mezze figure: San-t'Agata, San Rocco e San Bastiano. La qual pittura, vedendola il Rosso, pittore famosissimo, che di que' giorni venne in Arezzo, fu cagione che conoscendovi qualche cosa di buono, cavata dal naturale, mi volle conoscere e che poi m'aiutò di disegni e di consiglio. Né passò molto che per suo mezzo mi diede Messer Lorenzo Gamurrini a fare una tavola, del-la quale mi fece il Rosso il disegno, et io poi la condussi con quanto più studio, fatica e diligenza mi fu possibile, per imparare et acquistarmi un poco di nome. E se il potere avesse agguagliato il volere sarei tosto divenuto pittore ragionevole, cotanto mi affaticava e studiava le cose dell'arte, ma io trovava le difficultà molto maggiori di quello che a principio aveva stimato.
Tuttavia, non perdendomi d'animo, tornai a Fiorenza, dove, veggendo non poter se non con lunghezza di tempo di-venir tale che io aiutassi tre sorelle e due fratelli minori di me, statimi lasciati da mio padre, mi posi all'orefice; ma vi stetti poco, perciò che venuto il campo a Fiorenza l'anno 1529, me n'andai con Manno orefice e mio amicissimo a Pisa, dove, lasciato da parte l'esercizio dell'orefice, dipinsi a fresco l'arco che è sopra la porta della Compagnia vecchia de' Fiorentini, et alcuni quadri a olio, che mi furono fatti fare per mezzo di don Miniato Pitti, abbate allora d'Agnano fuor di Pisa, e di Luigi Guicciardini, che in quel tempo era in Pisa. Crescendo poi più ogni giorno la guerra, mi risolvei tornarmene in Arezzo, ma non potendo per la diritta via et ordinaria, mi condussi per le montagne di Modena a Bologna; dove, trovando che si facevano per la coronazione di Carlo Quinto alcuni archi trionfali di pittura, ebbi così giovinetto da lavorare con mio utile et onore. E perché io disegnava assai acconciamente, arei trovato da starvi e da lavorare, ma il disiderio che io aveva di riveder la mia famiglia e' parenti, fu cagione che, trovata buona compagnia, me ne tornai in Arezzo, dove, trovato in buono essere le cose mie, per la diligente custodia avutane dal detto don Antonio mio zio, quietai l'animo et attesi al disegno, facendo anco alcune cosette a olio di non molta importanza.
Intanto, essendo il detto don Miniato Pitti fatto non so se abbate o priore di Santa Anna, monasterio di Monte Oliveto in quel di Siena, mandò per me; e così feci a lui et all'Albenga loro generale alcuni quadri et altre pitture. Poi, essendo il medesimo fatto abbate di San Bernardo d'Arezzo, gli feci nel poggiuolo dell'organo, in due quadri a olio, Iobbe e Moisè. Per che, piaciuta a que' monaci l'opera, mi feciono fare innanzi alla porta principale della chiesa nella volta e facciate d'un portico alcune pitture a fresco, cioè i quattro Evangelisti con Dio Padre nella volta et alcun'altre figure grandi quanto il vivo, nelle quali se bene, come giovane poco sperto, non feci tutto che arebbe fatto un più pratico, feci nondimeno quello che io seppi e cosa che non dispiacque a que' padri, avuto rispetto alla mia poca età e sperienza.
Ma non sì tosto ebbi compiuta quell'opera, che, passando il cardinale Ipolito de' Medici per Arezzo in poste, mi condusse a Roma a' suoi servigii, come s'è detto nella vita del Salviati, là dove ebbi commodità, per cortesia di quel signore, di attendere molti mesi allo studio del disegno. E potrei dire con verità questa comodità e lo studio di questo tempo essere stato il mio vero e principal maestro in questa arte, se bene per innanzi mi aveano non poco giovato i sopra nominati, e non mi s'era mai partito del cuore un ardente desiderio d'imparare et uno indefesso studio di sempre disegnare giorno e notte. Mi furono anco di grande aiuto in que' tempi le concorrenze de' giovani miei eguali e compagni, che poi sono stati per lo più eccellentissimi nella nostra arte. Non mi fu anco se non assai pungente stimolo il disiderio della gloria et il vedere molti esser riusciti rarissimi e venuti a gradi et onori. Onde diceva fra me stesso alcuna volta: “Perché non è in mio potere con assidua fatica e studio procacciarmi delle grandezze e gradi che s'hanno acquistato tan-ti altri? Furono pure anch'essi di carne e d'ossa, come son io”. Cacciato dunque da tanti e sì fieri stimoli e dal bisogno che io vedeva avere di me la mia famiglia, mi disposi a non volere perdonare a niuna fatica, disagio, vigilia e stento per conseguire questo fine. E così propostomi nell'animo, non rimase cosa notabile allora in Roma, né poi in Fiorenza et altri luoghi ove dimorai, la quale io in mia gioventù non disegnassi: e non solo di pitture, ma anche di sculture et architetture antiche e moderne, et oltre al frutto ch'io feci in disegnando la volta e cappella di Michelagnolo, non restò cosa di Raffaello, Pulidoro e Baldassarre da Siena, che similmente io non disegnassi in compagnia di Francesco Salviati, come già s'è detto nella sua vita. Et acciò che avesse ciascuno di noi i disegni d'ogni cosa, non disegnava il giorno l'uno quello che l'altro, ma cose diverse; di notte poi ritraevamo le carte l'uno dell'altro, per avanzar tempo e fare più studio, per non dir nulla che le più volte non mangiavamo la mattina se non così ritti, e poche cose. Dopo la quale incredibile fatica, la prima opera che m'uscisse di mano, come di mia propria fucina, fu un quadro grande di figure quanto il vivo d'una Venere con le Grazie, che la adornavano e facevan bella, la quale mi fece fare il cardinale de' Medici; del qual quadro non accade parlare, perché fu cosa da giovanetto, né io lo toccherei, se non che mi è grato ricordarmi ancor di que' primi principii e molti giovamenti nel principio dell'arti. Basta che quel signore et altri mi diedero a credere che fusse un non so che di buon principio e di vivace e pronta fierezza. E perché fra l'altre cose vi avea fatto per mio capriccio un satiro libidinoso, il quale, standosi nascosto fra certe frasche, si rallegrava e godeva in guardare le Grazie e Venere ignude, ciò piacque di maniera al cardinale, che, fattomi tutto di nuovo rivestire, diede ordine che facessi in un quadro maggiore pur a olio la battaglia de' satiri intorno a' fauni, silvani e putti, che quasi facessero una baccanalia; per che, messovi mano, feci il cartone e dopo abbozzai di colori la tela, che era lunga dieci braccia.
Avendo poi a partire il cardinale per la volta d'Ungheria, fattomi conoscere a papa Clemente, mi lasciò in protezione di Sua Santità che mi dette in custodia del signor Ieronimo Montaguto suo maestro di camera, con lettere che volendo io fuggire l'aria di Roma quella state, io fussi ricevuto a Fiorenza dal duca Alessandro, il che sarebbe stato bene che io avessi fatto; perciò che volendo io pure stare in Roma, fra i caldi, l'aria e la fatica, amalai di sorte, che per guarire fui forzato a farmi portare in ceste ad Arezzo. Pure, finalmente guarito intorno alli dieci del dicembre vegnente, venni a Fiorenza dove fui dal detto Duca ricevuto con buona cera, e poco appresso dato in custodia al magnifico Messer Ottaviano de' Medici, il quale mi prese di maniera in protezzione, che sempre, mentre visse, mi tenne in luogo di figliuolo; la buona memoria del quale io riverirò sempre e ricorderò come d'un mio amorevolissimo padre.
Tornato dunque ai miei soliti studii, ebbi comodo, per mezzo di detto signore, d'entrare a mia posta nella sagrestia nuova di San Lorenzo, dove sono l'opere di Michelagnolo, essendo egli di quei giorni andato a Roma, e così le studiai per alcun tempo con molta diligenza così come erano in terra. Poi, messomi a lavorare, feci in un quadro di tre braccia un Cristo morto, portato da Niccodemo, Gioseffo et altri alla sepoltura, e dietro le Marie piangendo. Il quale quadro, finito che fu, l'ebbe il duca Alessandro, con buono e felice principio de' miei lavori; perciò che non solo ne tenne egli conto mentre visse, ma è poi stato sempre in camera del duca Cosimo, et ora è in quella dell'illustrissimo Principe suo figliuolo, et ancora che alcuna volta io abbia voluto rimettervi mano per migliorarlo in qualche parte, non sono stato lasciato.
Veduta dunque questa mia prima opera, il duca Alessandro ordinò che io finissi la camera terrena del palazzo de' Medici, stata lasciata imperfetta, come s'è detto, da Giovanni da Udine. Onde io vi dipinsi quattro storie de' fatti di Cesare: quando, notando, ha in una mano i suoi comentarii et in bocca la spada; quando fra abruciare i scritti di Pompeo, per non vedere l'opere de' suoi nemici; quando, dalla fortuna in mare travagliato, si dà a conoscere a un nocchieri; e finalmente il suo trionfo, ma questo non fu finito del tutto. Nel qual tempo, ancor che io non avessi se non poco più di diciotto anni, mi dava il Duca sei scudi il mese di provisione, il piatto a me, et un servitore, e le stanze da abitare, con altre molte commodità. Et ancor che io conoscessi non meritar tanto a gran pezzo, io facea nondimeno tutto che sapeva con amore e con diligenza; né mi pareva fatica dimandare a' miei maggiori quello che io non sapeva, onde più volte fui d'opera e di consiglio aiutato dal Tribolo, dal Bandinello e da altri.
Feci adunque in un quadro alto tre braccia esso duca Alessandro, armato e ritratto di naturale, con nuova invenzione et un sedere fatto di prigioni legati insieme e con altre fantasie. E mi ricorda che oltre al ritratto, il quale somigliava, per far il brunito di quell'arme bianco, lucido e proprio, che io vi ebbi poco meno che a perdere il cervello, cotanto mi affaticai in ritrarre dal vero ogni minuzia. Ma disperato di potere in questa opera accostarmi al vero, menai Iacopo da Puntormo, il quale io per la sua molta virtù osservava, a vedere l'opera e consigliarmi; il quale, veduto il quadro e conosciuta la mia passione, mi disse amorevolmente: “Figliuol mio, insino a che queste arme vere e lustranti stanno a canto a questo quadro, le tue ti parranno sempre dipinte, perciò che se bene la biacca è il più fiero colore che adoperi l'arte, e nondimeno più fiero e lustrante è il ferro. Togli via le vere e vedrai poi che non sono le tue finte armi così cattiva cosa, come le tieni”. Questo quadro, fornito che fu, diedi al Duca, et il Duca lo donò a Messer Ottaviano de' Medici, nelle cui case è stato insino a oggi, in compagnia del ritratto di Caterina allora giovane sorella del detto Duca e poi Reina di Francia, e di quello del magnifico Lorenzo Vecchio. Nelle medesime case sono tre quadri pur di mia mano e fatti nella mia giovanezza. In uno Abramo sacrifica Isac, nel secondo è Cristo nell'orto, e nell'altro la cena che fa con gl'Apostoli.
Intanto, essendo morto Ipolito cardinale, nel quale era la somma collocata di tutte le mie speranze, cominciai a conoscere quanto sono vane, le più volte, le speranze di questo mondo, e che bisogna in se stesso, e nell'essere da qualche cosa, principalmente confidarsi. Dopo quest'opere, veggendo io che il Duca era tutto dato alle fortificazioni et al fabricare, cominciai, per meglio poterlo servire, a dare opera alle cose d'architettura, e vi spesi molto tempo. Intanto, avendosi a far l'apparato per ricevere l'anno 1536 in Firenze l'imperatore Carlo Quinto, nel dare a ciò ordine il Duca comise ai deputati sopra quella onoranza, come s'è detto nella vita del Tribolo, che m'avessero seco a disegnare tutti gl'archi et altri ornamenti da farsi per quell'entrata. Il che fatto, mi fu anco, per beneficarmi, allogato, oltre le bandiere grandi del castello e fortezza, come si disse, la facciata a uso d'arco trionfale, che si fece a San Felice in piazza, alta braccia quaranta e larga venti; et appresso l'ornamento della porta a San Piero Gattolini, opere tutte grandi e sopra le forze mie. E, che fu peggio, avendomi questi favori tirato addosso mille invidie, circa venti uomini, che m'aiutavano far le bandiere e gl'altri lavori, mi piantarono in sul buono, a persuasione di questo e di quello, acciò io non potessi condurre tante opere e di tanta importanza. Ma io, che aveva preveduto la malignità di que' tali, ai quali avea sempre cercato di giovare, parte lavorando di mia mano giorno e notte, e parte aiutato da pittori avuti di fuora, che m'aiutavano di nascoso, attendeva al fatto mio et a cercare di superare cotali difficultà e malivoglienze con l'opere stesse.
Il qual mentre Bertoldo Corsini, allora generale proveditore per sua eccellenzia, aveva rapportato al Duca che io aveva preso a far tante cose, che non era mai possibile che io l'avessi condotte a tempo, e massimamente non avendo io uomini et essendo l'opere molto a dietro; per che, mandato il Duca per me e dettomi quello che avea inteso, gli risposi che le mie opere erano a buon termine, come poteva vedere sua eccellenzia a suo piacere, e che il fine loderebbe il tutto; e partitomi da lui, non passò molto che occultamente venne dove io lavorava, e vide il tutto, e conobbe in parte l'in-vidia e malignità di coloro che sanza averne cagione mi pontavano addosso. Venuto il tempo che doveva ogni cosa essere a ordine, ebbi finito di tutto punto e posti a' luoghi loro i miei lavori, con molta sodisfazione del Duca e dell'uni-versale. Là dove quelli di alcuni che più avevano pensato a me, che a loro stessi, furono messi su imperfetti. Finita la festa, oltre a' quattrocento scudi che mi furono pagati per l'opere, me ne donò il Duca trecento, che si levarono a coloro che non avevano condotto a fine le loro opere al tempo determinato, secondo che si era convenuto d'accordo. Con i quali avanzi e donativo maritai una delle mie sorelle, e poco dopo ne feci un'altra monaca nelle Murate d'Arezzo, dando al monasterio oltre alla dote, o vero limosina, una tavola d'una Nunziata di mia mano, con un tabernacolo del Sacramento in essa tavola accomodato, la quale fu posta dentro nel loro coro, dove stanno a ufiziare.
Avendomi poi dato a fare la Compagnia del Corpus Domini d'Arezzo la tavola dell'altar maggiore di San Domenico, vi feci dentro un Cristo deposto di croce, e poco appresso per la Compagnia di San Rocco cominciai la tavola della loro chiesa in Firenze. Ora, mentre andava procacciandomi sotto la protezione del duca Alessandro onore, nome e facultà, fu il povero signore crudelmente ucciso, et a me levato ogni speranza di quello che io mi andava, mediante il suo favore, promettendo dalla fortuna. Per che mancati, in pochi anni, Clemente, Ipolito et Alessandro, mi risolvei, consigliato da Messer Ottaviano, a non volere più seguitare la fortuna delle corti, ma l'arte sola, se bene facile sarebbe stato accomodarmi col signor Cosimo de' Medici nuovo duca. E così tirando innanzi in Arezzo la detta tavola, e facciata di San Rocco con l'ornamento, mi andava mettendo a ordine per andare a Roma, quando per mezzo di Messer Giovanni Pollastra, come Dio volle (al quale sempre mi sono raccomandato e del quale riconosco et ho riconosciuto sempre ogni mio bene), fu' chiamato a Camaldoli, capo della congregazione camaldolense, dai padri di quell'eremo a vedere quello che disegnavano di voler fare nella loro chiesa. Dove giunto, mi piacque sommamente l'alpestre et eterna solitudine e quiete di quel luogo santo, e se bene mi accorsi di prima giunta che que' padri d'aspetto venerando, veggendomi così giovane, stavano sopra di loro, mi feci animo e parlai loro di maniera, che si risolverono a volere servirsi dell'opera mia nelle molte pitture che andavano nella loro chiesa di Camaldoli a olio et in fresco. Ma dove volevano che io innanzi a ogni altra cosa facessi la tavola dell'altar maggiore, mostrai loro con buone ragioni che era meglio far prima una delle minori, che andavano nel tramezzo, e che finita quella, se fusse loro piaciuta, arei potuto seguitare; oltre ciò non volli fare con essi alcun patto fermo di danari, ma dissi che dove piacesse loro, finita che fusse l'opera mia, me la pagassero a lor modo, e non piacendo me la rendessero, che la terrei per me ben volentieri. La qual condizione parendo loro troppo onesta et amorevole, furono contenti che io mettessi mano a lavorare.
Dicendomi essi adunque che vi volevano la Nostra Donna col Figlio in collo, San Giovanni Batista e San Ieronimo, i quali ambidue furono eremiti et abitarono i boschi e le selve, mi parti' dall'ermo e scorsi giù alla Badia loro di Camaldoli, dove fattone con prestezza un disegno, che piacque loro, cominciai la tavola, et in due mesi l'ebbi finita del tutto e messa al suo luogo, con molto piacere di que' padri (per quanto mostrarono) e mio; il quale in detto spazio di due mesi, provai quanto molto più giovi agli studii una dolce quiete et onesta solitudine, che i rumori delle piazze e delle corti, conobbi dico l'error mio, d'avere posto per l'addietro le speranze mie negl'uomini e nelle baie e girandole di questo mondo. Finita dunque la detta tavola, mi allogorono subitamente il resto del tramezzo della chiesa, cioè le storie et altro, che da basso et alto vi andavano di lavoro a fresco, perciò che le facessi la state vegnente, atteso che la vernata non sarebbe quasi possibile lavorare a fresco in quell'alpe e fra que' monti.
Per tanto, tornato in Arezzo fini' la tavola di San Rocco, facendovi la Nostra Donna, sei Santi et un Dio Padre, con certe saette in mano figurate per la peste. Le quali mentre egli è in atto di fulminare, è pregato da San Rocco et altri Santi per lo popolo. Nella facciata sono molte figure a fresco, le quali insieme con la tavola sono come sono. Mandandomi poi a chiamare in val di Caprese fra' Bartolomeo Graziani, frate di Sant'Agostino dal Monte San Savino, mi diede a fare una tavola grande a olio nella chiesa di Santo Agostino del monte detto, per l'altar maggiore. E così rimaso d'ac-cordo, me ne venni a Firenze a vedere Messer Ottaviano, dove stando alcuni giorni, durai delle fatiche a far sì che non mi rimettesse al servizio delle corti, come aveva in animo; pure io vinsi la pugna con buone ragioni, e risolveimi d'an-dar per ogni modo, avanti che altro facessi, a Roma. Ma ciò non mi venne fatto se non poi che ebbi fatto al detto Mes-ser Ottaviano una copia del quadro, nel quale ritrasse già Raffaello da Urbino papa Leone, Giulio cardinale de' Medici et il cardinale de' Rossi, perciò che il Duca rivoleva il proprio, che allora era in potere di esso Messer Ottaviano. La qual copia che io feci è oggi nelle case degl'eredi di quel signore, il quale nel partirmi per Roma mi fece una lettera di cambio di 500 scudi a Giovanbatista Puccini, che me gli pagasse ad ogni mia richiesta, dicendomi: “Serviti di questi per potere attendere a' tuoi studii; quando poi n'arai il commodo, potrai rendermegli o in opere, o in contanti a tuo piacimento”.
Arrivato dunque in Roma di febraio l'anno 1538, vi stei tutto giugno, attendendo, in compagnia di Giovanbatista Cungi dal Borgo mio garzone, a disegnare tutto quello che mi era rimaso indietro l'altre volte che era stato in Roma, et in particolare ciò che era sotto terra nelle grotte. Né lasciai cosa alcuna d'architettura o scultura che io non disegnassi e non misurassi; in tanto che posso dire con verità che i disegni ch'io feci in quello spazio di tempo furono più di trecento. De' quali ebbi poi piacere et utile molti anni in rivedergli, e rinfrescare la memoria delle cose di Roma. Le quali fatiche e studio, quanto mi giovassero, si vide tornato che fui in Toscana nella tavola, che io feci al Monte San Savino, nella quale dipinsi con alquanto miglior maniera un'Assunzione di Nostra Donna, e da basso, oltre agl'Apostoli che sono intorno al sepolcro, Santo Agostino e San Romualdo.
Andato poi a Camaldoli, secondo che avea promesso a que' padri romiti, feci nell'altra tavola del tramezzo la Natività di Gesù Cristo, fingendo una notte alluminata dallo splendore di Cristo nato, circondato da alcuni pastori che l'adora-no. Nel che fare andai imitando con i colori i raggi solari, e ritrassi le figure e tutte l'altre cose di quell'opera dal naturale e col lume, acciò fussero più che si potesse simili al vero. Poi, perché quel lume non potea passare sopra la capanna, da quivi in su et all'intorno, feci che suplisse un lume che viene dallo splendore degl'Angeli che in aria cantano Gloria in excelsis Deo, senzaché in certi luoghi fanno lume i pastori, che vanno attorno con covoni di paglia accesi, et in parte la luna, la stella e l'Angelo che apparisce a certi pastori. Quanto poi al casamento, feci alcune anticaglie a mio capriccio con statue rotte, et altre cose somiglianti. Et insomma condussi quell'opera con tutte le forze e saper mio, e se bene non arrivai con la mano e col pennello al gran disiderio e volontà di ottimamente operare, quella pittura nondimeno a molti è piaciuta. Onde Messer Fausto Sabeo, uomo letteratissimo et allora custode della libreria del Papa, fece, e dopo lui alcuni altri, molti versi latini in lode di quella pittura, mossi per aventura più da molta affezzione, che dall'eccellenza del-l'opera; comunche sia, se cosa vi è di buono, fu dono di Dio.
Finita quella tavola, si risolverono i padroni che io facessi a fresco nella facciata le storie che vi andavano; onde feci sopra la porta il ritratto dell'eremo, da un lato San Romualdo con un doge di Vinezia, che fu sant'uomo, e dall'altro una visione, che ebbe il detto Santo là dove fece poi il suo eremo, con alcune fantasie, grottesche et altre cose che vi si veggiono. E ciò fatto, mi ordinarono che la state dell'anno a venire io tornassi a fare la tavola dell'altar grande. Intanto il già detto don Miniato Pitti, che allora era visitator della congregazione di Monte Uliveto, avendo veduta la tavola del Monte S. Savino e l'opere di Camaldoli, trovò in Bologna don Filippo Serragli fiorentino, abbate di S. Michele in Bosco, e gli disse che avendosi a dipignere il refettorio di quell'onorato monasterio, gli pareva che a me e non ad altri si dovesse quell'opera allogare; per che fattomi andare a Bologna, ancor che l'opera fusse grande e d'importanza, la tolsi a fare, ma prima volli vedere tutte le più famose opere di pittura che fussero in quella città, di bolognesi e d'altri. L'opera dunque della testata di quel refettorio fu divisa in tre quadri: in uno aveva ad essere quando Abramo nella valle Mambre apparecchiò da mangiare agl'Angeli; nel secondo Cristo che essendo in casa di Maria Madalena e Marta, parla con essa Marta, dicendogli che Maria ha eletto l'ottima parte; e nella terza aveva da essere dipinto S. Gregorio a mensa co' dodici poveri, fra i quali conobbe essere Cristo. Per tanto messo mano all'opera in quest'ultima finsi San Gregorio a tavola in un convento, e servito da monaci bianchi di quell'Ordine, per potervi accomodare que' padri, secondo che essi volevano. Feci, oltre ciò, nella figura di quel santo Pontefice l'effigie di papa Clemente VII, et intorno, fra molti signori, ambasciadori, principi et altri personaggi che lo stanno a vedere mangiare, ritrassi il duca Alessandro de' Medici per memoria de' beneficii e favori che io aveva da lui ricevuti, e per essere stato chi egli fu, e con esso molti amici miei; e fra coloro che servono a tavola, poveri, ritrassi alcuni frati miei domestici di quel convento, come di forestieri che mi servivano, dispensatore, canovaio, et altri così fatti, e così l'abate Serraglio, il generale don Cipriano da Verona et il Bentivoglio. Parimente ritrassi il naturale ne' vestimenti di quel Pontefice, contrafacendo velluti, damaschi et altri drappi d'oro e di seta d'ogni sorte. L'apparecchio poi, vasi, animali et altre cose feci fare a Cristofano dal Borgo, come si disse nella sua vita. Nella seconda storia cercai fare di maniera le teste, i panni et i casamenti, oltre all'essere diversi dai primi, che facessino più che si può apparire l'affetto di Cristo nell'instituire Madalena, e l'affezione e prontezza di Marta nell'ordinare il convito e dolersi d'essere lasciata sola dalla sorella in tante fatiche e ministerio; per non dir nulla dell'at-tenzione degl'Apostoli et altre molte cose da essere considerate in questa pittura. Quanto alla terza storia, dipinsi i tre Angeli (venendomi ciò fatto non so come) in una luce celeste, che mostra partirsi da loro, mentre i raggi d'un sole gli circonda in una nuvola. De' quali tre Angeli il vecchio Abramo adora uno, se bene sono tre quelli che vede, mentre Sarra si sta ridendo e pensando come possa essere quello che gl'è stato promesso, et Agar con Ismael in braccio si parte dall'ospizio. Fa anco la medesima luce chiarezza ai servi che apparecchiano, fra i quali alcuni, che non possono sofferire lo splendore, si mettono le mani sopra gl'occhi e cercano di coprirsi; la quale varietà di cose, perché l'ombre crude et i lumi chiari danno più forza alle pitture, fecero a questa aver più rilievo che l'altre due non hanno, e variando di colore, fecero effetto molto diverso. Ma così avess'io saputo mettere in opera il mio concetto, come sempre con nuove invenzioni e fantasie sono andato, allora e poi, cercando le fatiche et il difficile dell'arte!
Quest'opera dunque, comunche sia, fu da me condotta in otto mesi, insieme con un fregio a fresco et architettura, intagli, spalliere, tavole et altri ornamenti di tutta l'opera e di tutto quel refettorio; et il prezzo di tutto mi contentai che fusse dugento scudi, come quelli che più aspirava alla gloria che al guadagno. Onde Messer Andrea Alciati mio amicissimo, che allora leggeva in Bologna, vi fece far sotto queste parole: “Octonis mensibus opus ab Aretino Georgio pictum, non tam praecio, quam amicorum obsequio, et honoris voto anno 1539. Philippus Serralius pon. curavit”.
Feci in questo medesimo tempo due tavolette d'un Cristo morto e d'una Ressurrezzione, le quali furono da don Miniato Pitti abate poste nella chiesa di Santa Maria di Barbiano fuor di San Gimignano di Valdelsa; le quali opere finite, tornai subito a Fiorenza, perciò che il Trevisi, maestro Biagio et altri pittori bolognesi, pensando che io mi volessi acasare in Bologna e torre loro di mano l'opere et i lavori, non cessavano d'inquietarmi, ma più noiavano loro stessi che me, il quale di certe lor passioni e modi mi rideva. In Firenze adunque copiai da un ritratto grande infino alle ginocchia un cardinale Ipolito a Messer Ottaviano, et altri quadri con i quali mi andai trattenendo in que' caldi insoportabili della state. I quali venuti, mi tornai alla quiete e fresco di Camaldoli, per fare la detta tavola dell'altar maggiore. Nella quale feci un Cristo che è deposto di croce, con tutto quello studio e fatica che maggiore mi fu possibile; e perché col fare e col tempo mi pareva pur migliorare qualche cosa, né mi sodisfacendo della prima bozza, gli ridetti di mestica e la rifeci quale la si vede di nuovo tutta. Et invitato dalla solitudine, feci in quel medesimo luogo dimorando un quadro al detto Messer Ottaviano, nel quale dipinsi un San Giovanni ignudo e giovinetto, fra certi scogli e massi e che io ritrassi dal naturale di que' monti.
Né a pena ebbi finite quest'opere, che capitò a Camaldoli Messer Bindo Altoviti, per fare dalla cella di Santo Alberigo, luogo di que' padri, una condotta a Roma per via del Tevere, di grossi abeti, per la fabrica di San Piero; il quale veggendo tutte l'opere da me state fatte in quel luogo, e per mia buona sorte piacendogli, prima che di lì partisse, si risolvé che io gli facessi per la sua chiesa di Santo Apostolo di Firenze una tavola. Per che finita quella di Camaldoli con la facciata della cappella in fresco, dove feci esperimento di unire il colorito a olio con quello, e riuscimmi assai acconciamente, me ne venni a Fiorenza e feci la detta tavola. E perché aveva a dare saggio di me a Fiorenza, non avendovi più fatto somigliante opera, aveva molti concorrenti e desiderio di acquistare nome, mi disposi a volere in quell'opera far il mio sforzo e mettervi quanta diligenza mi fusse mai possibile. E per potere ciò fare scarico di ogni molesto pensiero, prima maritai la mia terza sorella e comperai una casa principiata in Arezzo, con un sito da fare orti bellissimi nel borgo di San Vito, nella miglior aria di quella città. D'ottobre adunque l'anno 1540 cominciai la tavola di Messer Bindo, per farvi una storia che dimostrassi la Concezione di Nostra Donna, secondo che era il titolo della cappella. La qual cosa perché a me era assai malagevole, avutone Messer Bindo et io il parere di molti comuni amici, uomini litterati, la feci finalmente in questa maniera: figurato l'albero del peccato originale nel mezzo della tavola, alle radici di esso come primi trasgressori del comandamento di Dio feci ignudi Adamo et Eva, e dopo agl'altri rami feci legati di mano in mano Abram, Isac, Iacob, Moisè, Aron, Iosuè, Davit, e gl'altri Re successivamente secondo i tempi, tutti dico legati per ambedue le braccia, eccetto Samuel e S. Giovanni Batista i quali sono legati per un solo braccio, per essere stati santificati nel ventre. Al tronco dell'albero feci avvolto con la coda l'antico serpente, il quale, avendo dal mezzo in su forma umana, ha le mani legate di dietro; sopra il capo gli ha un piede, calcandogli le corna, la gloriosa Vergine, che l'altro tiene sopra una luna, essendo vestita di sole e coronata di dodici stelle. La qual Vergine, dico, è sostenuta in aria dentro a uno splendore da molti Angeletti nudi, illuminati dai raggi che vengono da lei, i quali raggi parimente, passando fra le foglie dell'albero, rendono lume ai legati e pare che vadano loro sciogliendo i legami con la virtù e grazia che hanno da colei donde procedono. In cielo poi, cioè nel più alto della tavola sono due putti che tengono in mano alcune carte, nelle quali sono scritte queste parole: “Quos Evae culpa damnavit, Mariae gratia solvit”. Insomma io non avea fino allora fatto opera, per quello che mi ricorda, né con più studio, né con più amore e fatica di questa, ma tuttavia, se bene satisfeci a altri per aventura, non satisfeci già a me stesso, come che io sappia il tempo, lo studio e l'opera ch'io misi particolarmente negl'ignudi, nelle teste, e finalmente in ogni cosa. Mi diede Messer Bindo, per le fatiche di questa tavola, trecento scudi d'oro, et inoltre l'anno seguente mi fece tante cortesie et amorevolezze in casa sua in Roma, dove gli feci in un piccol quadro, quasi di minio, la pittura di detta tavola, che io sarò sempre alla sua memoria ubbligato.
Nel medesimo tempo ch'io feci questa tavola che fu posta, come ho detto, in S. Apostolo, feci a Messer Ottaviano de' Medici una Venere et una Leda con i cartoni di Michelagnolo, et in un gran quadro un San Girolamo, quanto il vivo, in penitenza, il quale contemplando la morte di Cristo, che ha dinanzi in sulla croce, si percuote il petto, per scacciare della mente le cose di Venere e le tentazioni della carne, che alcuna volta il molestavano, ancor che fusse nei boschi e luoghi solinghi e salvatichi, secondo che egli stesso di sé largamente racconta. Per lo che dimostrare, feci una Venere, che con Amore in braccio fugge da quella contemplazione, avendo per mano il Giuoco et essendogli cascate per terra le frecce et il turcasso; senzaché le saette da Cupido tirate verso quel Santo, tornano rotte verso di lui, et alcune, che cascano, gli sono riportate col becco dalle colombe di essa Venere. Le quali tutte pitture, ancora che forse allora mi piacessero e da me fussero fatte come seppi il meglio, non so quanto mi piacciano in questa età. Ma perché l'arte in sé è dificile, bisogna torre da chi fa quel che può. Dirò ben questo, però che lo posso dire con verità, d'avere sempre fatto le mie pitture, invenzioni e disegni comunche sieno, non dico con grandissima prestezza, ma sì bene con incredibile facilità e senza stento: di che mi sia testimonio, come ho detto in altro luogo, la grandissima tela ch'io dipinsi in San Giovanni di Firenze in sei giorni soli l'anno 1542, per lo battesimo del signor don Francesco Medici, oggi principe di Firenze e di Siena.
Ora se bene io voleva, dopo quest'opere, andare a Roma per satisfare a Messer Bindo Altoviti, non mi venne fatto; perciò che chiamato a Vinezia da Messer Pietro Aretino, poeta allora di chiarissimo nome e mio amicissimo, fui forzato, perché molto disiderava vedermi, andar là; il che feci anco volentieri per vedere l'opere di Tiziano e d'altri pittori in quel viaggio. La qual cosa mi venne fatta, però che in pochi giorni vidi in Modena et in Parma l'opere del Coreggio, quelle di Giulio Romano in Mantoa, e l'antichità di Verona finalmente. Giunto in Vinezia con due quadri dipinti di mia mano con i cartoni di Michelagnolo, gli donai a don Diego di Mendozza, che mi mandò dugento scudi d'oro. Né molto dimorai a Vinezia, che pregato dall'Aretino feci ai signori della Calza l'apparato d'una loro festa, dove ebbi in mia compagnia Batista Cungi, e Cristofano Gherardi dal Borgo S. Sepolcro, e Bastiano Flori aretino molto valenti e pratichi, di che si è in altro luogo ragionato a bastanza, e gli nove quadri di pittura nel palazzo di Messer Giovanni Cornaro, cioè nel soffittato d'una camera del suo palazzo, che è da San Benedetto.
Dopo queste et altre opere di non piccola importanza che feci allora in Vinezia, me ne partii, ancor che io fussi soprafatto dai lavori che mi venivano per le mani, alli sedici d'agosto l'anno 1542, e tornaimene in Toscana dove, avanti che ad altro volessi por mano, dipinsi nella volta d'una camera, che di mio ordine era stata murata nella già detta mia casa, tutte l'arti che sono sotto il disegno o che da lui dependono; nel mezzo è una Fama, che siede sopra la palla del mondo e suona una tromba d'oro, gettandone via una di fuoco finta per la Maledicenza, et intorno a lei sono con ordine tutte le dette arti con i loro strumenti in mano. E perché non ebbi tempo a far il tutto, lasciai otto ovati per fare in essi otto ritratti di naturale de' primi delle nostre arti.
Ne' medesimi giorni feci alle monache di Santa Margherita di quella città, in una cappella del loro orto, a fresco una Natività di Cristo di figure grandi quanto il vivo. E così consumata che ebbi nella patria il resto di quella state e parte dell'autunno, andai a Roma. Dove essendo dal detto Messer Bindo ricevuto e molto carezzato, gli feci in un quadro a olio un Cristo quanto il vivo levato di croce e posto in terra a' piedi della madre, e nell'aria Febo che oscura la faccia del sole e Diana quella della luna. Nel paese poi, oscurato da queste tenebre, si veggiono spezzarsi alcuni monti di pietra, mossi dal terremoto che fu nel patir del Salvatore; e certi morti corpi di Santi si veggiono, risorgendo, uscire de' sepolcri in varii modi. Il quale quadro finito che fu, per sua grazia non dispiacque al maggior pittore, scultore et architetto che sia stato a' tempi nostri e forse de' nostri passati; per mezzo anco di questo quadro, fui, mostrandogliele il Giovio e Messer Bindo, conosciuto dall'illustrissimo cardinale Farnese, al quale feci sì come volle, in una tavola alta otto braccia e larga quattro, una Iustizia che abbraccia uno struzzo, carico delle dodici tavole, e con lo scettro che ha la cicogna in cima; et armata il capo d'una celata di ferro e d'oro, con tre penne, impresa del giusto giudice, di tre variati colori, era nuda tutta dal mezzo in su; alla cintura ha costei legati, come prigioni, con catene d'oro i sette Vizii che a lei sono contrarii: la Corruzione, l'Ignoranza, la Crudeltà, il Timore, il Tradimento, la Bugia e la Maledicenza; sopra le quali è posta in sulle spalle la Verità tutta nuda, offerta dal Tempo alla Iustizia, con un presente di due colombe fatte per l'Innocenza; alla quale Verità mette in capo essa Iustizia una corona di quercia per la Fortezza dell'animo. La quale tutta opera condussi con ogni accurata diligenza, come seppi il meglio.
Nel medesimo tempo, facendo io gran servitù a Michelagnolo Buonarruoti e pigliando da lui parere in tutte le cose mie, egli mi pose per sua bontà molta più affezione, e fu cagione il suo consigliarmi a ciò, per avere veduto alcuni disegni miei, che io mi diedi di nuovo e con miglior modo allo studio delle cose d'architettura; il che per aventura non arei fatto già mai, se quell'uomo eccellentissimo non mi avesse detto quel che mi disse, che per modestia lo taccio.
Il San Pietro seguente, essendo grandissimi caldi in Roma, et avendo lì consumata tutta quella vernata del 1543, me ne tornai a Fiorenza, dove in casa Messer Ottaviano de' Medici, la quale io poteva dir casa mia, feci a Messer Biagio Mei lucchese suo compare in una tavola il medesimo concetto di quella di Messer Bindo in Santo Apostolo, ma variai dalla invenzione in fuore ogni cosa, e quella finita si mise in Lucca in San Piero Cigoli alla sua cappella. Feci in un'altra della medesima grandezza, cioè alta sette braccia e larga quattro, la Nostra Donna, San Ieronimo, San Luca, Santa Cecilia, Santa Marta, Santo Agostino e San Guido romito, la quale tavola fu messa nel Duomo di Pisa, dove n'erano molte altre di mano d'uomini eccellenti. Ma non ebbi sì tosto condotto questa al suo fine, che l'Operaio di detto Duomo mi diede a fare un'altra. Nella quale perché aveva andare similmente la Nostra Donna, per variare dall'altra, feci essa Madonna con Cristo morto a' piè della croce posato in grembo a lei, i ladroni in alto sopra le croci, e con le Marie e Niccodemo che sono intorno, accomodati i Santi titolari di quelle cappelle che tutti fanno componimento e vaga la storia di quella tavola.
Di nuovo tornato a Roma l'anno 1544, oltre a molti quadri che feci a diversi amici, de' quali non accade far memoria, feci un quadro d'una Venere col disegno di Michelagnolo a Messer Bindo Altoviti che mi tornavo seco in casa, e dipinsi per Galeotto da Girone mercante fiorentino in una tavola a olio Cristo deposto di croce, la quale fu posta nella chiesa di Santo Agostino di Roma alla sua cappella. Per la quale tavola poter fare con mio commodo, insieme alcun'o-pere che mi aveva allogato Tiberio Crispo castellano di Castel Sant'Agnolo, mi era ritirato da me in Trastevere, nel palazzo, che già murò il vescovo Adimari, sotto Santo Onofrio, che poi è stato fornito da Salviati il secondo. Ma sentendomi indisposto e stracco da infinite fatiche, fui forzato tornarmene a Fiorenza, dove feci alcuni quadri, e fra gl'altri uno in cui era Dante, Petrarca, Guido Cavalcanti, il Boccaccio, Cino da Pistoia e Guittone d'Arezzo, il quale fu poi di Luca Martini, cavato dalle teste antiche loro accuratamente, del quale ne sono state fatte poi molte copie.
Il medesimo anno 1544 condotto a Napoli da don Giammateo d'Anversa generale de' monaci di Monte Oliveto, per-ch'io dipignessi il refettorio d'un loro monasterio fabricato dal re Alfonso Primo, quando giunsi fui per non accettare l'opera, essendo quel refettorio e quel monastero fatto d'architettura antica e con le volte a quarti acuti, e basse, e cieche di lumi, dubitando di non avere ad acquistarvi poco onore. Pure astretto da don Miniato Pitti e da don Ipolito da Milano miei amicissimi et allora visitatori di quell'Ordine, accettai finalmente l'impresa. Là dove, conoscendo di non poter fare cosa buona, se non con gran copia d'ornamenti, gl'occhi abagliando di chi avea a vedere quell'opera, con la varietà di molte figure, mi risolvei a fare tutte le volte di esso refettorio lavorate di stucchi per levar via con ricchi partimenti di maniera moderna tutta quella vecchiaia e goffezza di sesti. Nel che mi furon di grande aiuto le volte e mura, fatte, come si usa in quella città, di pietre di tufo, che si tagliono come fa il legname, o meglio cioè come i mattoni non cotti interamente. Perciò che io vi ebbi commodità, tagliando, di fare sfondati di quadri, ovali et ottangoli ringrossando con chiodi e rimettendo de' medesimi tufi. Ridotte adunque quelle volte a buona proporzione con quei stucchi, i quali furo-no i primi che a Napoli fussero lavorati modernamente, e particolarmente le facciate e teste di quel refettorio, vi feci sei tavole a olio, alte sette braccia, cioè tre per testata. In tre che sono sopra l'entrata del refettorio è il piovere della manna al popolo ebreo, presenti Moisè et Aron che la ricogliono, nel che mi sforzai di mostrare nelle donne, negl'uomini e ne' putti diversità d'attitudini e vestiti, e l'affetto con che ricogliono e ripongono la manna ringraziandone Dio. Nella testata che è a sommo è Cristo che desina in casa di Simone, e Maria Madalena, che con le lacrime gli bagna i piedi e gl'asciu-ga con i capelli, tutta mostrandosi pentita de' suoi peccati. La quale storia è partita in tre quadri: nel mezzo è la cena, a man ritta una bottiglieria con una credenza piena di vasi in varie forme e stravaganti, et a man sinistra uno scalco che conduce le vivande. Le volte furono compartite in tre parti: in una si tratta della Fede, nella seconda della Religione e nella terza dell'Eternità. Ciascuna delle quali, perché erano in mezzo, ha otto Virtù intorno, dimostranti ai monaci che in quel refettorio mangiano quello che alla loro vita e perfezzione è richiesto. E per arricchire i vani delle volte, gli feci pieni di grottesche, le quali in quarantotto vani fanno ornamento alle quarantotto immagini celesti; et in sei facce per lo lungo di quel refettorio sotto le finestre fatte maggiori e con ricco ornamento, dipinsi sei delle parabole di Gesù Cristo, le quali fanno a proposito di quel luogo. Alle quali tutte pitture et ornamenti corrisponde l'intaglio delle spalliere fatte riccamente. Dopo, feci all'altar maggiore di quella chiesa una tavola alta otto braccia dentrovi la Nostra Donna che presenta a Simeone nel tempio Gesù Cristo piccolino, con nova invenzione. Ma è gran cosa, che dopo Giotto, non era stato insino allora in sì nobile e gran città maestri che in pittura avessino fatto alcuna cosa d'importanza, se ben vi era stato condotto alcuna cosa di fuori di mano del Perugino e di Raffaello, per lo che m'ingegnai fare di maniera, per quanto si estendeva il mio poco sapere, che si avessero a svegliare gl'ingegni di quel paese a cose grandi et onorevoli operare. E questo o altro che ne sia stato cagione, da quel tempo in qua vi sono state fatte di stucchi e pitture molte bellissime opere.
Oltre alle pitture sopradette, nella volta della foresteria del medesimo monasterio condussi a fresco, di figure grandi quanto il vivo, Gesù Cristo che ha la croce in ispalla, et a imitazione di lui molti de' suoi Santi che l'hanno similmente addosso, per dimostrare che a chi vuole veramente seguitar lui, bisogna portare e con buona pacienza l'avversità che dà il mondo. Al generale di detto Ordine condussi in un gran quadro Cristo, che aparendo agl'Apostoli travagliati in mare dalla fortuna, prende per un braccio S. Piero, che a lui era corso per l'acqua, dubitando non affogare. Et in un altro quadro per l'abate Capeccio feci la Ressurezione; e queste cose condotte a fine, al signor don Pietro di Tolledo viceré di Napoli dipinsi a fresco nel suo giardino di Pozzuolo una cappella et alcuni ornamenti di stucchi sottilissimi. Per lo medesimo si era dato ordine di far due gran logge, ma la cosa non ebbe effetto per questa cagione. Essendo stata alcuna differenza fra il viceré e detti monaci, venne il bargello con sua famiglia al monasterio per pigliar l'abate et alcuni monaci, che in processione avevano avuto parole, per conto di precedenza, con i monaci neri. Ma i monaci facendo difesa, aiutati da circa quindici giovani che meco di stucchi e pitture lavoravano, ferirono alcuni birri, per lo che bisognando di notte cansargli, s'andarono chi qua e là, e così io rimaso quasi solo, non solo non potei fare le logge di Pozzuolo, ma né anco fare ventiquattro quadri di storie del Testamento Vecchio e della vita di S. Giovanni Batista; i quali, non mi sadisfacendo di restare in Napoli più, portai a fornire a Roma, donde gli mandai, e furono messi intorno alle spalliere e sopra gl'armarii di noce fatti con mia disegni et architettura, nella sagrestia di San Giovanni Carbonaro, convento de' frati eremitani osservanti di Santo Agostino, ai quali poco innanzi avea dipinto in una cappella fuor della chiesa in tavola un Cristo crucifisso, con ricco e vario ornamento di stucco, a richiesta del Seripando lor generale, che fu poi cardinale. Parimente a mezzo le scale di detto convento feci a fresco San Giovanni Evangelista, che sta mirando la Nostra Donna vestita di sole, con i piedi sopra la luna e coronata di dodici stelle. Nella medesima città dipinsi a Messer Tommaso Cambi, mercante fiorentino e mio amicissimo, nella sala d'una sua casa, in quattro facciate i tempi e le stagioni dell'an-no: il Sogno, il Sonno sopra un terrazzo, dove fece una fontana.
Al duca di Gravina dipinsi in una tavola, che egli condusse al suo Stato, i Magi che adorano Cristo, et ad Orsanca segretario del viceré feci un'altra tavola, con cinque figure intorno a un Crucifisso, e molti quadri. Ma con tutto ch'io fussi assai ben visto da que' signori, guadagnassi assai e l'opere ogni giorno moltiplicassero, giudicai, poi che i miei uomini s'erano partiti, che fusse ben fatto, avendo in un anno lavorato in quella città opere a bastanza, ch'io me ne tornassi a Roma. E così fatto, la prima opera che io facessi fu al signor Ranuccio Farnese, allora arcivescovo di Napoli, in tela quattro portegli grandissimi a olio per l'organo del piscopio di Napoli, dentrovi dalla parte dinanzi cinque Santi patroni di quella città, e dentro la Natività di Gesù Cristo, con i pastori, e Davit re, che canta in sul suo salterio: “Dominus dixit ad me”, etc. E così i sopra detti ventiquattro quadri et alcuni di Messer Tommaso Cambi, che tutti furono mandati a Napoli. E ciò fatto, dipinsi cinque quadri a Raffaello Acciaiuoli che gli portò in Ispagna, della Passione di Cristo. L'anno medesimo, avendo animo il cardinale Farnese di far dipignere la sala della Cancelleria nel palazzo di San Giorgio, monsignor Giovio, disiderando che ciò si facesse per le mie mani, mi fece fare molti disegni di varie invenzioni, che poi non furono messi in opera. Nondimeno si risolvé finalmente il cardinale ch'ella si facesse in fresco, e con maggior prestezza che fusse possibile, per servirsene a certo suo tempo determinato. È la detta sala lunga poco più di palmi cento, larga cinquanta et alta altretanto. In ciascuna testa adunque larga palmi cinquanta, si fece una storia grande, et in una delle facciate lunghe due, nell'altra per essere impedita dalle finestre, non si poté far istorie, e però vi si fece un ribattimento, simile alla facciata in testa, che è dirimpetto; e per non far basamento, come insino a quel tempo s'era usato dagl'artefici in tutte le storie, alto da terra nove palmi almeno, feci, per variare e far cosa nuova, nascere scale da terra, fatte in varii modi et a ciascuna storia la sua. E sopra quelle feci poi cominciare a salire le figure a proposito di quel suggetto, a poco a poco, tanto che trovano il piano, dove comincia la storia. Lunga e forse noiosa cosa sarebbe dire tutti i particolari e le minuzie di queste storie, però toccherò solo e brevemente le cose principali. Adunque, in tutte sono storie de' fatti di papa Paulo Terzo, et in ciascuna è il suo ritratto di naturale. Nella prima, dove sono, per dirle così, le spedizioni della corte di Roma, si veggiono sopra il Tevere diverse nazioni e diverse ambascerie, con molti ritratti di naturale, che vengono a chieder grazie et ad offerire diversi tributi al Papa. Et oltre ciò, in certe nicchione, due figure grandi, poste sopra le porte, che mettono in mezzo la storia, delle quali una è fatta per l'Eloquenza, che ha sopra due Vittorie che tengono la testa di Giulio Cesare, e l'altra per la Iustizia, con due altre Vittorie che tengono la testa di Alessandro Magno, e nell'alto del mezzo è l'arme di detto Papa sostenuta dalla Liberalità e dalla Rimunerazione. Nella facciata maggiore è il medesimo Papa che rimunera la virtù donando porzioni, cavalierati, benefizii, pensioni, vescovadi e cappelli di cardinali, e fra quei che ricevono sono il Sadoleto, Polo, il Bembo, il Contarino, il Giovio, il Buonarruoto et altri virtuosi tutti ritratti di naturale, et in questa è dentro a un gran nicchione una Grazia con un corno di dovizia pieno di dignità, il quale ella riversa in terra. E le Vittorie, che ha sopra a somiglianza dell'altre, tengono la testa di Traiano imperatore. Èvvi anco l'Invidia, che mangia vipere e pare che crepi di veleno. E di sopra nel fine della storia è l'arme del cardinal Farnese, tenuta dalla Fama e dalla Virtù. Nell'altra storia, il medesimo papa Paulo si vede tutto intento alle fabriche, e particolarmente a quella di S. Piero sopra il Vaticano. E però sono innanzi al Papa ginocchioni la Pittura, la Scultura e l'Architettura, le quali, avendo spiegato un disegno della pianta di esso San Piero, pigliano ordine di essequire e condurre al suo fine quell'opera. Èvvi, oltre le dette figure, l'Animo, che aprendosi il petto mostra il cuore, la Sollecitudine appresso e la Ricchezza. E nella nicchia, la Copia con due Vittorie, che tengono l'effigie di Vespasiano. E nel mezzo è la Religione cristiana in un'altra nicchia che divide l'una storia dall'altra, e sopra le sono due Vittorie, che tengono la testa di Numa Pompilio. E l'arme che è sopra questa istoria è del cardinal San Giorgio, che già fabricò quel palazzo. Nell'altra storia, che è dirimpetto alle spedizioni della corte, è la pace universale fatta fra i cristiani per mezzo di esso papa Paulo Terzo, e massimamente fra Carlo Quinto imperatore e Francesco re di Francia che vi son ritratti. E però vi si vede la Pace abruciar l'arme, chiudersi il tempio di Iano, et il Furor incatenato. Delle due nicchie grandi, che mettono in mezzo la storia, in una è la Concordia, con due Vittorie sopra, che tengono la testa di Tito imperadore e nel-l'altra è la Carità con molti putti. Sopra la nicchia tengono due Vittorie la testa d'Augusto, e nel fine è l'arme di Carlo Quinto tenuta dalla Vittoria e dalla Ilarità, e tutta quest'opera è piena d'inscrizioni e motti bellissimi fatti dal Giovio; et in particolare ve n'ha uno che dice quelle pitture essere state tutte condotte in cento giorni.
Il che io come giovane feci, come quegli che non pensai se non a servire quel signore, che come ho detto desiderava averla finita per un suo servizio, in quel tempo. E nel vero, se bene io m'affaticai grandemente in far cartoni e studiare quell'opera, io confesso aver fatto errore in metterla poi in mano di garzoni per condurla più presto come mi bisognò fare, perché meglio sarebbe stato aver penato cento mesi et averla fatta di mia mano. Perciò che se bene io non l'avessi fatta in quel modo che arei voluto per servizio del cardinale et onor mio, arei pure avuto quella satisfazione d'averla condotta di mia mano. Ma questo errore fu cagione che io mi risolvei a non far più opere, che non fussero da me stesso del tutto finite sopra la bozza di mano degl'aiuti, fatta con i disegni di mia mano. Si fecero assai pratichi in quest'opera Bizzera e Roviale spagnuoli, che assai vi lavorarono con esso meco, e Batista Bagnacavallo bolognese, Bastian Flori aretino, Giovanpaolo dal Borgo e fra' Salvadore Foschi d'Arezzo, e molti altri miei giovani.
In questo tempo andando io spesso la sera, finita la giornata, a veder cenare il detto illustrissimo cardinal Farnese, dove erano sempre a trattenerlo, con bellissimi et onorati ragionamenti, il Molza, Anibal Caro, Messer Gandolfo, Mes-ser Claudio Tolomei, Messer Romolo Amasseo, monsignor Giovio, et altri molti letterati e galantuomini, de' quali è sempre piena la corte di quel signore, si venne a ragionare una sera fra l'altre del museo del Giovio, e de' ritratti de-gl'uomini illustri che in quello ha posti con ordine et inscrizioni bellissime. E passando d'una cosa in altra, come si fa ragionando, disse monsignor Giovio avere avuto sempre gran voglia, et averla ancora, d'aggiugnere al museo et al suo libro degli Elogi un trattato nel quale si ragionasse degl'uomini illustri nell'arte del disegno, stati da Cimabue insino a' tempi nostri. Dintorno a che allargandosi, mostrò certo aver gran cognizione e giudizio nelle cose delle nostre arti, ma è ben vero che bastandogli fare gran fascio, non la guardava così in sottile e spesso, favellando di detti artefici, o scambiava i nomi, i cognomi, le patrie, l'opere, e non dicea le cose come stavano a punto, ma così alla grossa. Finito che ebbe il Giovio quel suo discorso, voltatosi a me disse il cardinale: “Che ne dite voi Giorgio, non sarà questa una bell'opera e fatica?”. “Bella”, rispos'io “monsignor illustrissimo, se il Giovio sarà aiutato da chichesia dell'arte a mettere le cose a' luoghi loro, et a dirle come stanno veramente. Parlo così, perciò che, se bene è stato questo suo discorso maraviglioso, ha scambiato e detto molte cose una per un'altra.” “Potrete dunque”, soggiunse il cardinale pregato dal Giovio, dal Caro, dal Tolomei e dagl'altri “dargli un sunto voi, et una ordinata notizia di tutti i detti artefici, dell'opere loro secondo l'ordine de' tempi. E così aranno anco da voi questo benefizio le vostre arti.” La qual cosa ancor che io conoscessi essere sopra le mie forze, promisi secondo il poter mio di far ben volentieri; e così messomi giù a ricercare miei ricordi, e scritti fatti intorno a ciò, infin da giovanetto, per un certo mio passatempo e per una affezione che io aveva a la memoria de' nostri artefici, ogni notizia de' quali mi era carissima, misi insieme tutto che intorno a ciò mi parve a proposito. E lo portai al Giovio, il quale, poi che molto ebbe lodata quella fatica, mi disse: “Giorgio mio, voglio che prendiate voi questa fatica di distendere il tutto in quel modo che ottimamente veggio saprete fare, perciò che a me non dà il cuore, non conoscendo le maniere, né sapendo molti particolari che potrete sapere voi, sanza che quando pure io facessi, farei il più più un trattatetto simile a quello di Plinio; fate quel ch'io vi dico, Vasari, perché veggio che è per riuscirvi bellissimo, ché saggio dato me ne avete in questa narrazione”. Ma parendogli che io a ciò fare non fussi molto risoluto me lo fé dire al Caro, al Molza, al Tolomei et altri miei amicissimi; per che risolutomi finalmente, vi misi mano con intenzione, finita che fusse, di darla a uno di loro, che rivedutola et acconcia, la mandasse fuori sotto altro nome che il mio.
Intanto partito di Roma l'anno 1546 del mese d'ottobre, e venuto a Fiorenza, feci alle monache del famoso monasterio delle Murate, in tavola a olio, un Cenacolo per lo loro refettorio, la quale opera mi fu fatta fare e pagata da papa Paulo Terzo, che aveva monaca in detto monasterio una sua cognata, stata contessa di Pitigliano. E dopo feci in un'altra tavola la Nostra Donna che ha Cristo fanciullo in collo, il quale sposa Santa Caterina vergine e martire, e due altri San-ti; la qual tavola mi fece fare Messer Tomaso Cambi per una sua sorella allora badessa nel monasterio del Bigallo fuor di Fiorenza. E quella finita feci a monsignor de' Rossi de' conti di San Secondo e vescovo di Pavia due quadri grandi a olio: in uno è San Ieronimo e nell'altro una Pietà, i quali amendue furono mandati in Francia. L'anno poi 1547, fini' del tutto per lo Duomo di Pisa, ad instanza di Messer Bastiano della Seta Operaio, un'altra tavola che aveva cominciata; e dopo a Simon Corsi mio amicissimo un quadro grande a olio d'una Madonna.
Ora, mentre che io faceva quest'opere, avendo condotto a buon termine il libro delle vite degl'artefici del disegno, non mi restava quasi altro a fare che farlo trascrivere in buona forma, quando a tempo mi venne alle mani don Gian Matteo Faetani da Rimini, monaco di Monte Oliveto, persona di lettere e d'ingegno, perché io gli facessi alcun'opere nella chiesa e monasterio di Santa Maria di Scolca d'Arimini, là dove egli era abate. Costui dunque, avendomi promesso di farlami trascrivere a un suo monaco eccellente scrittore e di correggerla egli stesso, mi tirò ad Arimini a fare, per questa comodità, la tavola et altar maggiore di detta chiesa, che è lontana dalla città circa tre miglia. Nella qual tavola feci i Magi che adorano Cristo, con una infinità di figure da me condotte in quel luogo soletario con molto studio, imitando quanto io potei gl'uomini delle corti di tre re, mescolati insieme, ma in modo però che si conosce all'arie de' volti di che regione e soggetto a qual re sia ciascuno. Conciò sia, che alcuni hanno le carnagioni bianche, i secondi bigie, et altri nere, oltre che la diversità delli abiti e varie portature fa vaghezza e distinzione. È messa la detta tavola in mezzo da due gran quadri, nei quali è il resto della corte, cavalli, liofanti e giraffe, e per la cappella in varii luoghi sparsi Profeti, Sibille, Evangelisti in atto di scrivere. Nella cupola o vero tribuna feci quattro gran figure, che trattano delle lodi di Cristo, e della sua stirpe, e della Vergine, e questi sono Orfeo et Omero con alcuni motti greci, Vergilio col motto: “Iam redit et Virgo”, etc. e Dante con questi versi:
Tu sei colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che il suo fattore
non si sdegnò di farsi tua fattura.
Con molte altre figure et invenzioni delle quali non accade altro dire. Dopo, seguitandosi intanto di scrivere il detto libro e ridurlo a buon termine, feci in S. Francesco d'Arimini all'altar maggiore una tavola grande a olio, con un S. Francesco che riceve da Cristo le stimate nel monte della Vernia, ritratto dal vivo; ma perché quel monte è tutto di mas-si e pietre bigie, e similmente S. Francesco et il suo compagno si fanno bigi, finsi un sole, dentro al quale è Cristo con buon numero di Serafini, e così fa l'opera variata, et il Santo con altre figure tutto lumeggiato dallo splendore di quel sole, et il paese aombrato dalla varietà d'alcuni colori cangianti, che a molti non dispiacciono, et allora furono molto lodati dal cardinale Capodiferro, legato della Romagna. Condotto poi da Rimini a Ravenna, feci come in altro luogo s'è detto una tavola nella nuova chiesa della Badia di Classi dell'Ordine di Camaldoli, dipignendovi un Cristo deposto di croce in grembo alla Nostra Donna; e nel medesimo tempo feci per diversi amici molti disegni, quadri, et altre opere minori che sono tante e sì diverse, che a me sarebbe difficile il ricordarmi pur di qualche parte, et a' lettori forse non grato udir tante minuzie.
Intanto essendosi fornita di murare la mia casa d'Arezzo, et io tornatomi a casa, feci i disegni per dipignere la sala, tre camere e la facciata, quasi per mio spasso di quella state. Nei quali disegni feci fra l'altre cose tutte le provincie e luoghi dove io aveva lavorato, quasi come portassino tributi, per i guadagni che avea fatto con esso loro, a detta mia casa; ma nondimeno per allora non feci altro che il palco della sala, il quale è assai ricco di legnami, con tredici quadri grandi, dove sono gli dei celesti, et in quattro angoli i quattro tempi dell'anno ignudi, i quali stanno a vedere un gran quadro, che è in mezzo, dentro al quale sono in figure grandi quanto il vivo la Virtù, che ha sotto i piedi l'Invidia e, presa la Fortuna per i capegli, bastona l'una e l'altra; e quello che molto allora piacque si fu che in girando la sala attorno, et essendo in mezzo la Fortuna, viene talvolta l'Invidia a esser sopra essa Fortuna e Virtù, e d'altra parte la Virtù sopra l'Invidia e Fortuna, sì come si vede che aviene spesse volte veramente. Dintorno nelle facciate sono la Copia, la Liberalità, la Sapienza, la Prudenza, la Fatica, l'Onore et altre cose simili, e sotto attorno girano storie di pittori antichi, di A-pelle, di Zeusi, Parrasio, Protogene et altri con varii partimenti e minuzie, che lascio per brevità. Feci ancora nel palco d'una camera di legname intagliato, Abram in un gran tondo, di cui Dio benedice il seme e promette multiplicherà in infinito, et in quattro quadri, che a questo tondo sono intorno, feci la Pace, la Concordia, la Virtù e la Modestia, e perché adorava sempre la memoria e le opere degli antichi, vedendo tralasciare il modo di colorire a tempera, mi venne voglia di risuscitare questo modo di dipignere, e la feci tutta a tempera; il qual modo per certo non merita d'esser affatto dispregiato o tralasciato; et all'entrar della camera feci, quasi burlando, una sposa, che ha in una mano un rastrello, col quale mostra avere rastrellato e portato seco quanto ha mai potuto dalla casa del padre, e nella mano che va innanzi, entrando in casa il marito ha un torchio acceso, mostrando di portare dove va il fuoco, che consuma e distrugge ogni cosa.
Mentre che io mi stava così passando tempo, venuto l'anno 1548, don Giovan Benedetto da Mantoa, abate di Santa Fiore e Lucilla monasterio de' monaci neri cassinensi, dilettandosi infinitamente delle cose di pittura et essendo molto mio amico, mi pregò che io volessi fargli nella testa di uno loro refettorio un Cenacolo, o altra cosa simile. Onde risolutomi a compiacerli, andai pensando di farvi alcuna cosa fuor dell'uso comune, e così mi risolvei insieme con quel buon padre a farvi le nozze della reina Ester con il re Assuero, et il tutto in una tavola a olio, lunga quindici braccia, ma prima metterla in sul luogo, e quivi poi lavorarla; il qual modo (e lo posso io affermare, che l'ho provato) è quello che si vorrebbe veramente tenere a volere che avessono le pitture i suoi proprii e veri lumi, perciò che infatti il lavorare a basso, o in altro luogo che in sul proprio dove hanno da stare, fa mutare alle pitture i lumi, l'ombre e molte altre proprietà. In quest'opera adunque mi sforzai di mostrare maestà e grandezza, comeché io non possa far giudizio se mi venne fatto
o no; so bene che il tutto disposi in modo, che con assai bell'ordine si conoscono tutte le maniere de' serventi, paggi, scudieri, soldati della guardia, bottiglieria, credenza, musici, et un nano, et ogni altra cosa che a reale e magnifico convito è richiesta. Vi si vede fra gl'altri lo scalco condurre le vivande in tavola, accompagnato da buon numero di paggi vestiti a livrea, et altri scudieri e serventi. Nelle teste della tavola, che è aovata, sono signori et altri gran personaggi e cortigiani che in piedi stanno, come s'usa, a vedere il convito. Il re Assuero stando a mensa come re altero et innamorato sta tutto appoggiato sopra il braccio sinistro, che porge una tazza di vino alla reina, et in atto veramente regio et ono-rato. Insomma se io avessi a credere quello che allora sentii dirne al popolo, e sento ancora da chiunche vede quest'ope-ra, potrei credere d'aver fatto qualcosa, ma io so da vantaggio come sta la bisogna, e quello che arei fatto se la mano avesse ubidito a quello che io m'era concetto nell'idea. Tuttavia vi misi (questo posso confessare liberamente) studio e diligenza. Sopra l'opera viene nel peduccio d'una volta un Cristo che porge a quella regina una corona di fiori, e questo è fatto in fresco, e vi fu posto per accennare il concetto spirituale della istoria, per la quale si denotava che repudiata l'antica sinagoga Cristo sposava la nuova chiesa de' suoi fedeli cristiani.
Feci in questo medesimo tempo il ritratto di Luigi Guicciardini, fratello di Messer Francesco che scrisse la Storia, per essermi detto Messer Luigi amicissimo et avermi fatto quell'anno, come mio amorevole compare, essendo commensario d'Arezzo, una grandissima tenuta di terre, dette Frassineto in Valdichiana; il che è stata la salute et il maggior bene di casa mia, e sarà de' miei successori, sì come spero, se non mancheranno a loro stessi. Il quale ritratto, che è appresso gl'eredi di detto Messer Luigi, si dice essere il migliore e più somigliante, d'infiniti che n'ho fatti. Né de' ritratti fatti da me che pur sono assai farò menzione alcuna, che sarebbe cosa tediosa; e per dire il vero, me ne sono difeso quanto ho potuto di farne. Questo finito, dipinsi a fra' Mariotto da Castiglioni aretino, per la chiesa di San Francesco di detta terra, in una tavola la Nostra Donna, Santa Anna, San Francesco e San Salvestro. E nel medesimo tempo disegnai al cardinal di Monte, che poi fu papa Giulio Terzo, molto mio patrone, il quale era allora legato di Bologna, l'ordine e pianta d'una gran coltivazione, che poi fu messa in opera a' piè del Monte San Savino, sua patria, dove fui più volte d'ordine di quel signore, che molto si dilettava di fabricare. Andato poi, finite che ebbi quest'opere, a Fiorenza, feci quella state, in un segno da portare a processione della Compagnia di San Giovanni de' Peducci d'Arezzo, esso Santo che predica alle turbe da una banda, e dall'altra il medesimo che battezza Cristo, la qual pittura avendo sùbito che fu finita mandata nelle mie case d'Arezzo, perché fusse consegnata agl'uomini di detta Compagnia, avvenne che passando per Arezzo monsignor Giorgio cardinale d'Armignach franzese, vide, nell'andare per altro a vedere la mia casa, il detto segno, o vero stendardo; per che, piacciutogli, fece ogni opera d'averlo, offerendo gran prezzo, per mandarlo al re di Francia, ma io non volli mancar di fede a chi me l'aveva fatto fare, perciò che se bene molti dicevano che n'arei potuto fare un altro, non so se mi fusse venuto fatto così bene e con pari diligenza.
E non molto dopo feci per Messer Anibale Caro, secondo che mi aveva richiesto molto innanzi per una sua lettera che è stampata, in un quadro Adone che muore in grembo a Venere, secondo l'invenzione di Teocrito, la quale opera fu poi, e quasi contra mia voglia, condotta in Francia e data a Messer Albizo del Bene, insieme con una Psiche che sta mirando con una lucerna Amore che dorme, e si sveglia avendolo cotto una favilla di essa lucerna. Le quali tutte figure ignude e grandi quanto il vivo furono cagione che Alfonso di Tommaso Cambi giovanetto allora bellissimo, letterato, virtuoso e molto cortese e gentile, si fece ritrarre ignudo, e tutto intero, in persona d'uno Endimione cacciatore amato dalla Luna, la cui candidezza, et un paese all'intorno capriccioso, hanno il lume dalla chiarezza della luna, che fa nell'o-scuro della notte una veduta assai propria e naturale, perciò che io m'ingegnai con ogni diligenza di contrafare i colori proprii che suol dare il lume di quella bianca giallezza della luna alle cose che percuote.
Dopo questo, dipinsi due quadri per mandare a Raugia: in uno la Nostra Donna e nell'altro una Pietà; et appresso a Francesco Botti in un gran quadro la Nostra Donna col Figliuolo in braccio e Giuseppo, il quale quadro, che io certo feci con quella diligenza che seppi maggiore, si portò seco in Ispagna. Forniti questi lavori andai l'anno medesimo a vedere il cardinale de' Monti a Bologna, dove era legato, e con esso dimorando alcuni giorni, oltre a molti altri ragionamenti, seppe così ben dire, e ciò con tante buone ragioni persuadermi, che io mi risolvei, stretto da lui, a far quello che insino allora non avea voluto fare, cioè a pigliare moglie, e così tolsi, come egli volle, una figliuola di Francesco Bacci nobile cittadino aretino. Tornato a Fiorenza feci un gran quadro di Nostra Donna, secondo un mio nuovo capriccio e con più figure, il quale ebbe Messer Bindo Altoviti, che perciò mi donò cento scudi d'oro, e lo condusse a Roma, dove è oggi nelle sue case. Feci oltre ciò nel medesimo tempo molti altri quadri, come a Messer Bernardetto de' Medici, a Messer Bartolomeo Strada fisico eccellente, et a altri miei amici, che non accade ragionarne.
Di que' giorni, essendo morto Gismondo Martelli in Fiorenza, et avendo lasciato per testamento che in S. Lorenzo alla cappella di quella nobile famiglia si facesse una tavola con la Nostra Donna et alcuni Santi, Luigi e Pandolfo Martelli, insieme con Messer Cosimo Bartoli, miei amicissimi, mi ricercarono che io facessi la detta tavola. Et avutone licenza dal signor duca Cosimo patrone e primo Operaio di quella chiesa, fui contento di farla, ma con facultà di potervi fare a mio capriccio alcuna cosa di S. Gismondo, alludendo al nome di detto testatore. La quale convenzione fatta, mi ricordai avere inteso che Filippo di ser Brunellesco architetto di quella chiesa avea data quella forma a tutte le cappelle, acciò in ciascuna fusse fatta, non una piccola tavola, ma alcuna storia o pittura grande, che empiesse tutto quel vano. Per che, disposto a volere in questa parte seguire la volontà et ordine del Brunellesco, più guardando all'onore che al picciol guadagno che di quell'opera destinata a far una tavola piccola e con poche figure potea trarre, feci in una tavola larga braccia dieci et alta tredici la storia, o vero martirio di San Gismondo re, cioè quando egli, la moglie e due figliuoli furono gettati in un pozzo da un altro re, o vero tiranno, e feci che l'ornamento di quella cappella, il quale è mezzo tondo, mi servisse per vano della porta d'un gran palazzo, rustica, per la quale si avesse la veduta del cortile quadro, sostenuto da pilastri e colonne doriche, e finsi che per lo straforo di quella si vedesse nel mezzo un pozzo a otto facce, con salita intorno di gradi, per i quali salendo i ministri, portassono a gettare detti due figliuoli nudi nel pozzo; et intorno nelle logge dipinsi popoli che stanno da una parte a vedere quell'orrendo spettacolo, e nell'altra, che è la sinistra, feci alcuni masnadieri, i quali avendo presa con fierezza la moglie del re, la portano verso il pozzo per farla morire. Et in sulla porta principale feci un gruppo di soldati che legano San Gismondo, il quale con attitudine relassata e paziente mostra patir ben volentieri quella morte e martirio, e sta mirando in aria quattro Angeli che gli mostrano le palme e corone del martirio, sue, della moglie e de' figliuoli, la qual cosa pare che tutto il riconforti e consoli. Mi sforzai similmente di mostrare la crudeltà e fierezza dell'empio tiranno, che sta in sul pian del cortile di sopra a vedere quella sua vendetta e la morte di San Gismondo. Insomma, quanto in me fu, feci ogni opera che in tutte le figure fussero più che si può i proprii affetti e convenienti attitudini e fierezze, e tutto quello si richiedeva; il che quanto mi riuscisse, lascerò ad altri farne giudizio. Dirò bene che io vi misi quanto potei e seppi di studio, fatica e diligenza. Intanto disiderando il signor duca Cosimo che il libro delle vite, già condotto quasi al fine, con quella maggior diligenza che a me era stato possibile e con l'aiuto d'alcuni miei amici, si desse fuori et alle stampe, lo diedi a Lorenzo Torrentino impressor ducale, e così fu cominciato a stamparsi. Ma non erano anche finite le teoriche, quando, essendo morto papa Paulo Terzo, cominciai a dubitare d'avermi a partire di Fiorenza, prima che detto libro fusse finito di stampare. Perciò che andando io fuor di Fiorenza ad incontrare il cardinal di Monte, che passava per andare al Conclavi, non gli ebbi sì tosto fatto riverenza et alquanto ragionato, che mi disse: “Io vo a Roma, et al sicuro sarò papa. Spedisciti, se hai che fare, e subito, avuto la nuova, vientene a Roma sanza aspettare altri avvisi o d'essere chiamato”. Né fu vano cotal pronostico, però che essendo quel carnovale in Arezzo, e dandosi ordine a certe feste e mascherate, venne nuova che il detto cardinale era diventato Giulio Terzo, per che montato subito a cavallo venni a Fiorenza, donde, sollecitato dal Duca, andai a Roma per esservi alla coronazione di detto nuovo Pontefice et al fare dell'apparato.
E così giunto in Roma e scavalcato a casa Messer Bindo, andai a far reverenza e baciare il piè a Sua Santità il che fatto, le prime parole che mi disse furono il ricordarmi che quello che mi aveva di sé pronosticato non era stato vano. Poi dunque che fu coronato e quietato alquanto, la prima cosa che volle si facesse si fu sodisfare a un obligo, che aveva alla memoria di Messer Antonio vecchio e primo cardinal di Monte, d'una sepoltura da farsi a S. Piero a Montorio. Del-la quale fatti i modelli e disegni, fu condotta di marmo, come in altro luogo s'è detto pienamente, et in tanto io feci la tavola di quella cappella, dove dipinsi la conversione di S. Paulo: ma per variare da quello che avea fatto il Buonarruoto nella Paulina, feci S. Paulo, come egli scrive, giovane che già cascato da cavallo è condotto dai soldati ad Anania cieco, dal quale per imposizione delle mani riceve il lume degl'occhi perduto et è battezzato. Nella quale opera, o per la strettezza del luogo, o altro che ne fusse cagione, non sodisfeci interamente a me stesso, se bene forse ad altri non dispiacque, et in particolare a Michelagnolo.
Feci similmente a quel Pontefice un'altra tavola per una cappella del palazzo, ma questa, per le cagioni dette altra volta, fu poi da me condotta in Arezzo e posta in Pieve all'altar maggiore. Ma quando né in questa, né in quella già detta di S. Piero a Montorio, io non avessi pienamente sodisfatto né a me, né ad altri, non sarebbe gran fatto, imperò che, bisognandomi essere continuamente alla voglia di quel Pontefice, era sempre in moto, o vero occupato in far disegni d'architettura, e massimamente essendo io stato il primo che disegnasse e facesse tutta l'invenzione della vigna Iulia, che egli fece fare con spesa incredibile, la quale se bene fu poi da altri essequita, io fui nondimeno quegli che misi sempre in disegno i capricci del Papa, che poi si diedero a rivedere e correggere a Michelagnolo; et Iacopo Barozzi da Vignuola finì con molti suoi disegni le stanze, sale et altri molti ornamenti di quel luogo. Ma la fonte bassa fu d'ordine mio e dell'Amannato, che poi vi restò e fece la loggia che è sopra la fonte. Ma in quell'opera non si poteva mostrare quello che altri sapesse, né far alcuna cosa pel verso, perciò che venivano di mano in mano a quel Papa nuovi capricci, i quali bisognava metter in essecuzione, secondo che ordinava giornalmente Messer Piergiovanni Aliotti, vescovo di Forlì.
In quel mentre, bisognandomi l'anno 1550 venire per altro a Fiorenza ben due volte, la prima finii la tavola di San Gismondo, la quale venne il Duca a vedere in casa Messer Ottaviano de' Medici dove la lavorai, e gli piacque di sorte, che mi disse, finite le cose di Roma, me ne venissi a Fiorenza al suo servizio, dove mi sarebbe ordinato quello avessi da fare. Tornato dunque a Roma e dato fine alle dette opere cominciate, e fatta una tavola all'altar maggiore della Compagnia della Misericordia di un San Giovanni decollato, assai diverso dagl'altri che si fanno comunemente, la quale posi su l'anno 1553, me ne volea tornare, ma fui forzato, non potendogli mancare, a fare a Messer Bindo Altoviti due logge grandissime di stucchi et a fresco. Una delle quali dipinsi alla sua vigna con nuova architettura, perché essendo la loggia tanto grande che non si poteva senza pericolo girarvi le volte, le feci fare con armadure di legname, di stuoie, di canne, sopra le quali si lavorò di stucco, e dipinse a fresco come se fussero di muraglia, e per tale appariscono e son credute da chiunque le vede, e son rette da molti ornamenti di colonne di mischio, antiche e rare; e l'altra nel terreno della sua casa in ponte, piena di storie a fresco. E dopo per lo palco d'una anticamera quattro quadri grandi a olio delle quattro stagioni dell'anno, e questi finiti fui forzato ritrarre per Andrea della Fonte mio amicissimo una sua donna di naturale, e con esso gli diedi un quadro grande d'un Cristo che porta la croce, con figure naturali, il quale aveva fatto per un parente del Papa, al quale non mi tornò poi bene di donarlo. Al vescovo di Vasona feci un Cristo morto tenuto da Niccodemo e da due Angeli, et a Pierantonio Bandini una Natività di Cristo col lume della notte e con varia invenzione.
Mentre io faceva quest'opere e stava pure a vedere quello che il Papa disegnasse di fare, vidi finalmente che poco si poteva da lui sperare, e che in vano si faticava in servirlo. Per che, non ostante che io avessi già fatto i cartoni per dipignere a fresco la loggia che è sopra la fonte di detta vigna, mi risolvei a volere per ogni modo venire a servire il duca di Fiorenza; massimamente, essendo a ciò fare sollecitato da Messer Averardo Serristori e dal vescovo de' Ricasoli, ambasciatori in Roma di sua eccellenza, e con lettere da Messer Sforza Almeni suo coppiere e primo cameriere.
Essendo dunque trasferitomi in Arezzo, per di lì venirmene a Fiorenza, fui forzato fare a monsignor Minerbetti vescovo di quella città, come a mio signore et amicissimo, in un quadro, grande quanto il vivo, la Pacienza, in quel modo che poi se n'è servito per impresa e riverso della sua medaglia il signor Ercole duca di Ferrara. La quale opera finita, venni a baciar la mano al signor duca Cosimo, dal quale fui per sua benignità veduto ben volentieri; et in tanto che s'andò pensando a che primamente io dovessi por mano, feci fare a Cristofano Gherardi dal Borgo con miei disegni la facciata di Messer Sforza Almeni di chiaro scuro, in quel modo e con quelle invenzioni che si son dette in altro luogo distesamente. E perché in quel tempo mi trovavo essere de' signori priori della città di Arezzo, ofizio che governa la città, fui con lettere del signor Duca chiamato al suo servizio et assoluto da quello obligo; e venuto a Fiorenza trovai che sua eccellenza aveva cominciato quell'anno a murare quell'appartamento del suo palazzo che è verso la piazza del Grano con ordine del Tasso intagliatore et allora architetto del palazzo; ma era stato posto il tetto tanto basso, che tutte quelle stanze avevano poco sfogo et erano nane affatto, ma perché l'alzare i cavagli et il tetto era cosa lunga, consigliai che si facesse uno spartimento e ricinto di travi con sfondati grandi di braccia due e mezzo fra i cavagli del tetto, e con ordine di mensole per lo ritto che facessono fregiatura circa a due braccia sopra le travi; la qual cosa piacendo molto a sua eccellenza, diede ordine subito che così si facesse, e che il Tasso lavorasse i legnami et i quadri, dentro ai quali si aveva a dipignere la geneologia degli dei, per poi seguitare l'altre stanze.
Mentre dunque che si lavoravano i legnami di detti palchi, avuto licenza dal Duca, andai a starmi due mesi fra Arezzo e Cortona, parte per dar fine ad alcuni miei bisogni e parte per fornire un lavoro in fresco cominciato in Cortona nelle facciate e volta della Compagnia del Gesù. Nel qual luogo feci tre istorie della vita di Gesù Cristo, e tutti i sacrificii stati fatti a Dio nel Vecchio Testamento da Caino et Abel infino a Nemia profeta, dove anche in quel mentre accomodai di modelli e disegni la fabrica della Madonna Nuova fuor della città. La quale opera del Gesù finita, tornai a Fiorenza con tutta la famiglia l'anno 1555, al servizio del duca Cosimo; dove cominciai e finii i quadri e le facciate et il palco di detta sala di sopra chiamata degli Elementi, facendo nei quadri, che sono undici, la castrazione di Cielo per l'Aria, et in un terrazzo a canto a detta sala feci nel palco i fatti di Saturno e di Opi, e poi nel palco d'un'altra camera grande tutte le cose di Cerere e Proserpina; in una camera maggiore, che è allato a questa, similmente nel palco, che è ricchissimo, istorie della dea Berecinzia e di Cibele col suo trionfo e le 4 stagioni, e nelle facce tutti e dodici mesi. Nel palco d'un'altra, non così ricca, il nascimento di Giove, il suo essere nutrito dalla capra Alfea, col rimanente dell'altre cose di lui più segnalate. In un altro terrazzo a canto alla medesima stanza, molto ornato di pietre e di stucchi, altre cose di Giove e Giunone. E finalmente nella camera che segue il nascere d'Ercole con tutte le sue fatiche, e quello che non si poté mettere nel palco si mise nelle fregiature di ciascuna stanza, o si è messo ne' panni d'arazzo che il signor Duca ha fatto tessere con mia cartoni a ciascuna stanza, corrispondenti alle pitture delle facciate in alto. Non dirò delle grottesche, ornamenti e pitture di scale, né altre molte minuzie fatte di mia mano in quello apparato di stanze, perché oltre che spero se n'abbia a fare altra volta più lungo ragionamento, le può vedere ciascuno a sua voglia e darne giudizio. Mentre di sopra si dipignevano queste stanze, si murarono l'altre che sono in sul piano della sala maggiore e rispondono a queste per dirittura a piombo, con gran comodi di scale publiche e secrete che vanno dalle più alte alle più basse abitazioni del palazzo.
Morto intanto il Tasso, il Duca, che aveva grandissima voglia che quel palazzo, stato murato a caso et in più volte in diversi tempi e più a comodo degl'ufiziali che con alcuno buon ordine, si correggesse, si risolvé a volere che per ogni modo, secondo che possibile era, si rassettasse, e la sala grande col tempo si dipignesse, et il Bandinello seguitasse la cominciata udienza. Per dunque accordare tutto il palazzo insieme, cioè il fatto con quello che s'aveva da fare, mi ordinò che io facessi più piante e disegni, e finalmente, secondo che alcune gl'erano piaciute, un modello di legname, per meglio potere a suo senno andare accomodando tutti gl'appartamenti, e dirizzare e mutar le scale vecchie che gli pare-vano erte, mal considerate e cattive. Alla qual cosa, ancor che impresa difficile e sopra le forze mi paresse, misi mano, e condussi, come seppi il meglio, un grandissimo modello, che è oggi appresso sua eccellenza, più per ubbidirla che con speranza mi avesse da riuscire. Il quale modello, finito che fu, o fusse sua o mia ventura, o il disiderio grandissimo che io aveva di sodisfare, gli piacque molto; per che, dato mano a murare, a poco a poco si è condotto, facendo ora una cosa e quando un'altra, al termine che si vede. Et in tanto che si fece il rimanente, condussi con ricchissimo lavoro di stucchi in varii spartimenti le prime otto stanze nuove, che sono in sul piano della gran sala, fra salotti, camere et una cappella, con varie pitture et infiniti ritratti di naturale che vengono nelle istorie, cominciando da Cosimo Vecchio, e chiamando ciascuna stanza dal nome d'alcuno disceso da lui grande e famoso. In una adunque sono l'azzioni del detto Cosimo più notabili, e quelle virtù che più furono sue proprie, et i suoi maggiori amici e servitori, col ritratto de' figliuoli, tutti di naturale; e così sono insomma quella di Lorenzo Vecchio, quella di papa Leone suo figliuolo, quella di papa Clemente, quella del signor Giovanni padre di sì gran Duca, quella di esso signor duca Cosimo. Nella cappella è un bellissimo e gran quadro di mano di Raffaello da Urbino, in mezzo a S. Cosimo e Damiano mie pitture, nei quali è detta cappella intitolata; così delle stanze poi di sopra dipinte alla signora duchessa Leonora, che sono quattro, sono azzioni di donne illustri, greche, ebree, latine e toscane, a ciascuna camera una di queste; perché oltre che altrove n'ho ragionato, se ne dirà pienamente nel Dialogo che tosto daremo in luce, come s'è detto, che il tutto qui raccontare sarebbe stato troppo lungo. Delle quali mie fatiche ancora che continue, difficili e grandi, ne fui dalla magnanima liberalità di sì gran Duca, oltre alle provisioni, grandemente e largamente rimunerato con donativi, e di case onorate e comode in Fiorenza et in villa, perché io potessi più agiatamente servirlo; oltre che nella patria mia d'Arezzo mi ha onorato del supremo magistrato del Gonfalonieri et altri ufizii con facultà che io possa sostituire in quegli un de' cittadini di quel luogo, senza che a ser Piero mio fratello ha dato in Fiorenza ufizi d'utile, e parimente a' mia parenti d'Arezzo favori eccessivi, là dove io non sarò mai per le tante amorevolezze sazio di confessar l'obligo che io tengo con questo signore.
E tornando all'opere mie dico che pensò questo eccellentissimo signore di mettere ad esecuzione un pensiero avuto già gran tempo, di dipignere la sala grande, concetto degno della altezza e profondità dell'ingegno suo, né so se, come dicea, credo burlando meco, perché pensava certo che io ne caverei le mani, et a' dì suoi la vederebbe finita, o pur fusse qualche altro suo segreto, e, come sono stati tutti e' suoi, prudentissimo giudizio. L'effetto insomma fu che mi commesse che si alzassi i cavalli et il tetto più di quel che gl'era braccia tredici, e si facessi il palco di legname, e si mettessi d'o-ro, e dipignessi pien di storie a olio: impresa grandissima, importantissima e se non sopra l'animo forse sopra le forze mie; ma o che la fede di quel gran signore, e la buona fortuna che gl'ha in tutte le cose, mi facessi da più di quel che io sono, o che la speranza e l'occasione di sì bel suggetto mi agevolassi molto di facultà, o che (e questo dovevo preporre a ogn'altra cosa) la grazia di Dio mi somministrassi le forze, io la presi. E come si è veduto la condussi contra l'openione di molti in molto manco tempo, non solo che io avevo promesso e che meritava l'opera, ma neanche io, o pensassi mai sua eccellenza illustrissima. Ben mi penso che ne venissi maravigliata e sodisfattissima, perché venne fatta al maggior bisogno et alla più bella occasione che gli potessi occorrere, e questa fu, acciò si sappia la cagione di tanta sollecitudine, che avendo prescritto il maritaggio che si trattava dello illustrissimo Principe nostro con la figliuola del passato Imperatore, e sorella del presente, mi parve debito mio far ogni sforzo che in tempo et occasione di tanta festa, questa che era la principale stanza del palazzo, e dove si avevano a far gli atti più importanti, si potessi godere. E qui lascerò pensare non solo a chi è dell'arte, ma a chi è fuora ancora pur che abbi veduto la grandezza e varietà di quell'opera, la quale occasione terribilissima e grande, doverrà scusarmi se io non avessi per cotal fretta satisfatto pienamente in una varietà così grande di guerre in terra et in mare, espugnazioni di città, batterie, assalti, scaramuccie, edificazioni di città, consigli publici, cerimonie antiche e moderne, trionfi, e tante altre cose che non che altro gli schizzi, disegni e cartoni di tanta opera richiedevano lunghissimo tempo, per non dir nulla de' corpi ignudi, nei quali consiste la perfezzione delle nostre arti, né de' paesi dove furono fatte le dette cose dipinte, i quali ho tutti avuto a ritrarre di naturale in sul luogo e sito proprio, sì come ancora ho fatto molti capitani generali, soldati et altri capi che furono in quelle imprese che ho dipinto. Et insomma ardirò dire che ho avuto occasione di fare in detto palco quasi tutto quello che può credere pensiero e concetto d'uomo, varietà di corpi, visi, vestimenti, abigliamenti, celate, elmi, corazze, acconciature di capi diverse, cavalli, fornimenti, barde, artiglierie d'ogni sorte, navigazioni, tempeste, pioggie, nevate, e tante altre cose che io non basto a ricordarmene, ma chi vede quest'opera può agevolmente immaginarsi quante fatiche e quante vigilie abbia sopportato in fare con quanto studio ho potuto maggiore, circa quaranta storie grandi, et alcune di loro in quadri di braccia dieci per ogni verso, con figure grandissime, et in tutte le maniere. E se bene mi hanno alcuni de' giovani miei creati aiutato, mi hanno alcuna volta fatto commodo et alcuna no. Perciò che ho avuto tallora, come sanno essi, a rifare ogni cosa di mia mano, e tutta ricoprire la tavola, perché sia d'una medesima maniera. Le quali storie dico trattano delle cose di Fiorenza, dalla sua edificazione insino a oggi, la divisione in quartieri, le città sottoposte, nemici superati, città soggiogate, et in ultimo il principio e fine della guerra di Pisa, da uno de' lati, e dall'altro il principio similmente e fine di quella di Siena; una dal governo popolare condotta et ottenuta nello spazio di quattordici anni, e l'altra dal Duca in quattordici mesi, come si vedrà; oltre quello che è nel palco, e sarà nelle facciate, che sono ottanta braccia lunghe ciascuna et alte venti, che tuttavia vo dipignendo a fresco, per poi anco di ciò poter ragionare in detto Dialogo.
Il che tutto ho voluto dire in fin qui non per altro che per mostrare con quanta fatica mi sono adoperato et adopero tuttavia nelle cose dell'arte, e con quante giuste cagioni potrei scusarmi, dove in alcuna avessi (che credo avere in molte) mancato. Aggiugnerò anco, che quasi nel medesimo tempo, ebbi carico di disegnare tutti gl'archi da mostrarsi a sua eccellenza per determinare l'ordine tutto, e poi mettere gran parte in opera, e far finire il già detto grandissimo apparato, fatto in Fiorenza per le nozze del signor principe illustrissimo: di far fare con miei disegni in dieci quadri, alti braccia quattordici l'uno et undici larghi, tutte le piazze delle città principali del dominio, tirate in prospettiva, con i loro primi edificatori et insegne, oltre di far finire la testa di detta sala, cominciata dal Bandinello; di far fare nell'altra una scena, la maggiore e più ricca che fusse da altri fatta mai, e finalmente di condurre le scale principali di quel palazzo, i loro ricetti, et il cortile, e colonne in quel modo che sa ognuno e che si è detto di sopra, con quindici città dell'imperio e del Tiruolo, ritratte di naturale in tanti quadri.
Non è anche stato poco il tempo che ne' medesimi tempi ho messo in tirare innanzi, da che prima la cominciai, la loggia e grandissima fabrica de' magistrati, che volta sul fiume d'Arno, della quale non ho mai fatto murare altra cosa più difficile, né più pericolosa, per essere fondata in sul fiume e quasi in aria. Ma era necessaria, oltre all'altre cagioni, per appiccarvi, come si è fatto, il gran corridore, che attraversando il fiume, va dal palazzo ducale al palazzo e giardino de' Pitti. Il quale corridore fu condotto in cinque mesi con mio ordine e disegno ancor che sia opera da pensare che non potesse condursi in meno di cinque anni. Oltre che anco fu mia cura il far rifare, per le medesime nozze, et accrescere nella tribuna maggiore di Santo Spirito i nuovi ingegni della festa che già si faceva in San Felice in Piazza, il che tutto fu ridotto a quella perfezzione che si poteva maggiore, onde non si corrono più di que' pericoli che già si facevano in detta festa.
È stata similmente mia cura l'opera del palazzo e chiesa de' cavalieri di Santo Stefano in Pisa, e la tribuna, o vero cupola della Madonna dell'Umiltà in Pistoia, che è opera importantissima. Di che tutto, senza scusare la mia imperfezzione, la quale conosco da vantaggio se cosa ho fatto di buono, rendo infinite grazie a Dio, dal quale spero avere anco tanto d'aiuto che io vedrò quando che sia finita la terribile impresa delle dette facciate della sala, con piena sodisfazione de' miei signori, che già, per ispazio di tredici anni, mi hanno dato occasione di grandissime cose, con mio onore et utile operare, per poi, come stracco, logoro et invecchiato riposarmi. E se le cose dette, per la più parte, ho fatto con qualche fretta e prestezza, per diverse cagioni, questa spero io di fare con mio commodo, poi che il signor Duca si contenta che io non la corra, ma la faccia con agio, dandomi tutti quei riposi e quelle ricreazioni che io medesimo so disiderare.
Onde l'anno passato, essendo stracco per le molte opere sopra dette, mi diede licenza che io potessi alcuni mesi andare a spasso, per che messomi in viaggio cercai poco meno che tutta Italia, rivedendo infiniti amici, e miei signori, e l'opere di diversi eccellenti artefici, come ho detto di sopra ad altro proposito. In ultimo essendo in Roma per tornarme-ne a Fiorenza, nel baciare i piedi al santissimo e beatissimo papa Pio Quinto, mi comise che io gli facessi in Fiorenza una tavola per mandarla al suo convento e chiesa del Bosco, ch'egli faceva tuttavia edificare nella sua patria, vicino ad Alessandria della Paglia. Tornato dunque a Fiorenza, e per averlomi Sua Santità comandato, e per le molte amorevolezze fattemi, gli feci, sì come avea commessomi, in una tavola l'Adorazione de' Magi, la quale come seppe essere stata da me condotta a fine, mi fece intendere che per sua contentezza e per conferirmi alcuni suoi pensieri, io andassi con la detta tavola a Roma, ma sopra tutto per discorrere sopra la fabrica di San Piero, la quale mostra di avere a cuore sommamente. Messomi dunque a ordine con cento scudi, che per ciò mi mandò, e mandata innanzi la tavola, andai a Roma. Dove, poi che fui dimorato un mese, et avuti molti ragionamenti con Sua Santità, e consigliatolo a non permettere che s'alterasse l'ordine del Buonarruoto nella fabrica di San Piero, e fatti alcuni disegni, mi ordinò che io facessi per l'altar maggiore della detta sua chiesa del Bosco, e non una tavola, come s'usa comunemente, ma una machina grandissima quasi a guisa d'arco trionfale, con due tavole grandi, una dinanzi et una di dietro, et in pezzi minori circa trenta storie piene di molte figure che tutte sono a bonissimo termine condotte. Nel qual tempo ottenni graziosamente da Sua Santità (mandandomi con infinita amorevolezza e favore le bolle espedite gratis) la erezione d'una cappella e decanato nella Pieve d'Arezzo, che è la cappella maggiore di detta Pieve, con mio padronato e della casa mia, dotata da me e di mia mano dipinta, et offerta alla bontà divina per una ricognizione (ancor che minima sia) del grande obligo c'ho con sua maiestà per infinite grazie e benefizii che s'è degnato farmi. La tavola della quale, nella forma, è molto simile alla detta di sopra; il che è stato anche cagione in parte di ridurlami a memoria, perché è isolata et ha similmente due tavole, una già tocca di sopra nella parte dinanzi, et una della istoria di S. Giorgio di dietro, messe in mezzo da quadri con certi Santi, e sotto in quadretti minori l'istorie loro che di quanto è sotto l'altare in una bellissima tomba i corpi loro con altre reliquie principali della città. Nel mezzo viene un tabernacolo assai bene accomodato per il Sacramento, perché corrisponde a l'uno e l'altro altare, abellito di istorie del Vecchio e Nuovo Testamento, tutte approposito di quel misterio, come in parte s'è ragionato altrove. Mi era anche scordato di dire che l'anno innanzi, quando andai la prima volta a baciargli i piedi, feci la via di Perugia, per mettere a suo luogo tre gran tavole fatte ai monaci neri di San Piero in quella città, per un loro refettorio. In una cioè quella del mezzo sono le nozze di Cana Galilea, nelle quali Cristo fece il mira-colo di convertire l'acqua in vino. Nella seconda da man destra è Eliseo profeta, che fa diventar dolce con la farina l'a-marissima olla, i cibi della quale guasti dalle coloquinte i suoi Profeti non potevano mangiare; e nella terza è S. Benedetto, al quale annunziando un converso, in tempo di grandissima carestia e quando a punto mancava da vivere ai suoi monaci, che sono arrivati alcuni camelli carichi di farina alla porta, e' vede che gl'Angeli di Dio gli conducevano miracolosamente grandissima quantità di farina. Alla signora Gentilina, madre del signor Chiappino e signor Paulo Vitelli, dipinsi in Fiorenza, e di lì le mandai a Città di Castello, una gran tavola, in cui è la coronazione di Nostra Donna, in alto un ballo d'Angeli, et a basso molte figure maggiori del vivo, la qual tavola fu posta in San Francesco di detta città.
Per la chiesa del Poggio a Caiano, villa del signor Duca, feci in una tavola Cristo morto in grembo alla madre, San Cosimo e San Damiano che lo contemplano, et un Angelo in aria, che piangendo mostra i misterii della Passione di es-so Nostro Salvatore. E nella chiesa del Carmine di Fiorenza fu posta, quasi ne' medesimi giorni, una tavola di mia mano nella cappella di Matteo e Simon Botti, miei amicissimi, nella quale è Cristo crucifisso, la Nostra Donna, San Giovanni e la Madalena, che piangono. Dopo a Iacopo Capponi feci, per mandare in Francia, due gran quadri: in uno è la Primavera e nell'altro l'Autunno, con figure grandi e nuove invenzioni; et in un altro quadro maggiore un Cristo morto sostenuto da due Angeli e Dio Padre in alto. Alle monache di Santa Maria Novella d'Arezzo mandai, pur di que' giorni, o poco avanti, una tavola, dentro la quale è la Vergine annunziata dall'Angelo, e dagli lati due Santi; et alle monache di Luco di Mugello, dell'Ordine di Camaldoli, un'altra tavola, che è nel loro coro di dentro, dove è Cristo crucifisso, la Nostra Donna, San Giovanni e Maria Madalena.
A Luca Torrigiani molto mio amorevolissimo e domestico, il quale desiderando, fra molte cose che ha dell'arte nostra, avere una pittura di mia mano propria, per tenerla appresso di sé, gli feci in un gran quadro Venere ignuda, con le tre Grazie attorno, che una gli acconcia il capo, l'altra gli tiene lo specchio e l'altra versa acqua in un vaso per lavarla; la qual pittura m'ingegnai condurla col maggiore studio e diligenza che io potei, sì per contentare non meno l'animo mio, che quello di sì caro e dolce amico. Feci ancora a Antonio de' Nobili generale depositario di sua eccellenza e molto mio affezionato, oltre a un suo ritratto, sforzato contro alla natura mia di farne, una testa di Gesù Cristo, cavata dalle parole che Lentulo scrive della effigie sua, che l'una e l'altra fu fatta con diligenzia; e parimente un'altra alquanto maggiore, ma simile alla detta al signor Mondragone, primo oggi appresso a don Francesco de' Medici principe di Fiorenza e Siena, quale donai a sua signoria per esser egli molto affezionato alle virtù e nostre arti, a cagione che e' possa ricordarsi quando la vede che io lo amo e gli sono amico.
Ho ancora fra mano che spero finirlo presto un gran quadro cosa capricciosissima che deve servire per il signore Antonio Montalvo signore della Sassetta, degnamente primo cameriere e più intrinseco al Duca nostro e tanto a me amicissimo e dolce domestico amico per non dir superiore, che se la mano mi servirà alla voglia ch'io tengo di lasciargli di mia mano un pegno della affezione che io le porto, si conoscerà quanto io lo onori et abbia caro che la memoria di sì onorato e fedel signore amato da me, viva ne' posteri, poiché egli volentieri si affatica e favorisce tutti e' begli ingegni di questo mestiero o che si dilettino del disegno.
Al signor principe don Francesco ho fatto ultimamente due quadri, che ha mandati a Tolledo in Ispagna a una sorella della signora duchessa Leonora sua madre, e per sé un quadretto piccolo a uso di minio, con quaranta figure fra grandi e piccole, secondo una sua bellissima invenzione. A Filippo Salviati ho finita, non ha molto, una tavola che va a Prato nelle suore di San Vincenzio, dove in alto è la Nostra Donna coronata, come allora giunta in cielo, et a basso gl'Apostoli intorno al sepolcro. Ai monaci neri della Badia di Fiorenza dipingo similmente una tavola, che è vicina al fine, d'una Assunzione di Nostra Donna, e gl'Apostoli in figure maggiori del vivo, con altre figure dalle bande, e storie et ornamenti intorno, in nuovo modo accomodati. E perché il signor Duca, veramente in tutte le cose eccellentissimo, si compiace non solo nell'edificazioni de' palazzi, città, fortezze, porti, logge, piazze, giardini, fontane, villaggi, et altre cose somiglianti, belle, magnifiche et utilissime, e comodo de' suoi popoli, ma anco sommamente in far di nuovo e ridurre a miglior forma e più bellezza, come catolico prencipe, i tempii e le sante chiese di Dio, a imitazione del gran re Salamone, ultimamente ha fattomi levare il tramezzo della chiesa di Santa Maria Novella, che gli toglieva tutta la sua bellezza, e fatto un nuovo coro e ricchissimo dietro l'altare maggiore, per levar quello che occupava nel mezzo gran parte di quella chiesa; il che fa parere quella una nuova chiesa bellissima, come è veramente. E perché le cose, che non hanno fra loro ordine e proporzione, non possono eziandio essere belle interamente, ha ordinato che nelle navate minori si facciano, in guisa che corrispondano al mezzo degl'archi, e fra colonna e colonna, ricchi ornamenti di pietre con nuova foggia, che servino con i loro altari in mezzo per cappelle e sieno tutte d'una o due maniere. E che poi nelle tavole che vanno dentro a' detti ornamenti, alte braccia sette e larghe cinque, si facciano le pitture a volontà e piacimento de' padroni di esse cappelle.
In uno dunque di detti ornamenti di pietra, fatti con mio disegno, ho fatto per monsignor reverendissimo Alessandro Strozzi vescovo di Volterra, mio vecchio et amorevolissimo padrone, un Cristo crucifisso, secondo la visione di Santo Anselmo, cioè con sette virtù, senza le quali non possiamo salire per sette gradi a Gesù Cristo, et altre considerazioni fatte dal medesimo maestro Andrea Pasquali, medico del signor Duca, ho fatto in uno di detti ornamenti la Ressurrezione di Gesù Cristo in quel modo che Dio mi ha inspirato, per compiacere esso maestro Andrea mio amicissimo. Il medesimo ha voluto che si faccia questo gran Duca nella chiesa grandissima di Santa Croce di Firenze: cioè che si lievi il tramezzo, si faccia il coro dietro l'altar maggiore, tirando esso altare alquanto innanzi e ponendovi sopra un nuovo ricco tabernacolo per lo Santissimo Sacramento, tutto ornato d'oro, di storie e di figure; et oltre ciò, che nel medesimo modo che si è detto di Santa Maria Novella, vi si faccino quattordici cappelle a canto al muro, con maggior spesa et ornamento che le su dette, per essere questa chiesa molto maggiore che quella. Nelle quali tavole, accompagnando le due del Salviati e Bronzino, ha da essere tutti i principali misterii del Salvatore dal principio della sua Passione insino a che manda lo Spirito Santo sopra gl'Apostoli. La quale tavola della missione dello Spirito Santo, avendo fatto il disegno delle cappelle et ornamenti di pietre, ho io fra mano per Messer Agnolo Biffoli generale tesauriere di questi signori e mio singolare amico. Ho finito non è molto due quadri grandi, che sono nel magistrato de' nove conservadori a canto a San Piero Scheraggio, in uno è la testa di Cristo e nell'altro una Madonna.
Ma perché troppo sarei lungo a volere minutamente raccontare molte altre pitture, disegni che non hanno numero, modelli e mascherate che ho fatto, e perché questo è a bastanza e da vantaggio, non dirò di me altro, se non che per grandi e d'importanza che sieno state le cose che ho messo sempre innanzi al duca Cosimo, non ho mai potuto aggiugnere, non che superare la grandezza dell'animo suo, come chiaramente vedrassi in una terza sagrestia, che vuol fare a canto a San Lorenzo, grande e simile a quella che già vi fece Michelagnolo, ma tutta di varii marmi mischi e musaico, per dentro chiudervi, in sepolcri onoratissimi e degni della sua potenza e grandezza, l'ossa de' suoi morti figliuoli, del padre, madre, della magnanima duchessa Leonora sua consorte e di sé. Di che ho io già fatto un modello a suo gusto, e secondo che da lui mi è stato ordinato, il quale mettendosi in opera farà questa essere un nuovo mausoleo magnificentissimo e veramente reale.
E fin qui basti aver parlato di me, condotto con tante fatiche nella età d'anni cinquantacinque, e per vivere quanto piacerà a Dio con suo onore et in servizio sempre delli amici e quanto le mie forze potranno in uno commodo et augumento di queste nobilissime arti.
FINE DELLA VITA DI G. V., PITTORE ET ARCHITETTO ARETINO
L'AUTORE
AGL'ARTEFICI DEL DISEGNO
Onorati e nobili artefici, a pro e comodo de' quali principalmente io a così lunga fatica, la seconda volta messo mi sono, io mi veggio, col favore et aiuto della divina grazia, avere quello compiutamente fornito che io nel principio della presente mia fatica promisi di fare. Per la qual cosa Iddio primieramente et appresso i miei signori ringraziando, che mi hanno onde io abbia ciò potuto fare comodamente conceduto, è da dare alla penna et alla mente faticata riposo, il che farò tosto che arò detto alcune cose brievemente.
Se adunque paresse ad alcuno che, talvolta, in scrivendo fussi stato anzi lunghetto et alquanto prolisso, l'avere io voluto più che mi sia stato possibile essere chiaro, e davanti altrui mettere le cose in guisa, che quello che non s'è inteso, o io non ho saputo dire così alla prima, sia per ogni modo manifesto. E se quello che una volta si è detto è talora stato in altro luogo replicato, di ciò due sono state le cagioni: l'avere così richiesto la materia di cui si tratta, e l'avere io nel tempo che ho rifatta e si è l'opera ristampata, interrotto più d'una fiata per ispazio non dico di giorni, ma di mesi, lo scrivere, o per viaggi, o per soprabondanti fatiche, opere di pitture, disegni e fabriche; sanzaché a un par mio (il confesso liberamente) è quasi impossibile guardarsi da tutti gl'errori.
A coloro ai quali paresse che io avessi alcuni o vecchi o moderni troppo lodato, e che facendo comparazione da essi vecchi a quelli di questa età, se ne ridessero, non so che altro mi rispondere se non che intendo avere sempre lodato non semplicemente, ma, come s'usa dire, secondo che et avuto rispetto ai luoghi, tempi et altre somiglianti circonstanze; e nel vero, come che Giotto fusse, poniam caso, ne' suoi tempi lodatissimo, non so quello che di lui e d'altri antichi si fusse detto, se fussi stato al tempo del Buonarruoto; oltre che gl'uomini di questo secolo, il quale è nel colmo della perfezzione, non sarebbono nel grado che sono, se quelli non fussero prima stati tali e quel che furono innanzi a noi, et insomma credasi che quello che ho fatto in lodare, o biasimare, non l'ho fatto malagevolmente, ma solo per dire il vero, o quello che ho creduto che vero sia. Ma non si può sempre aver in mano la bilancia dell'orefice, e chi ha provato che cosa è lo scrivere, e massimamente dove si hanno a fare comparazioni, che sono di loro natura odiose, o dar giudizio, mi averà per iscusato.
E ben so io quante sieno le fatiche, i disagi et i danari che ho speso in molti anni dietro a quest'opera. E sono state tali e tante le difficultà che ci ho trovate, che più volte me ne sarei giù tolto per disperazione, se il soccorso di molti buoni e veri amici, ai quali sarò sempre obbligatissimo, non mi avessero fatto buon animo e confortatomi a seguitare, con tutti quegl'amorevoli aiuti che per loro si sono potuti, di notizie, e d'avisi, e riscontri di varie cose, delle quali, come che vedute l'avessi, io stava assai perplesso e dubbioso. I quali aiuti sono veramente stati sì fatti, che io ho potuto puramente scoprire il vero e dare in luce quest'opera, per ravvivare la memoria di tanti rari e pellegrini ingegni, quasi del tutto sepolta et a benefizio di que' che dopo noi verranno. Nel che fare mi sono stati, come altrove si è detto, di non piccolo aiuto gli scritti di Lorenzo Ghiberti, di Domenico Grillandai e di Raffaello da Urbino; ai quali se bene ho prestato fede, ho nondimeno sempre voluto riscontrare il lor dire con la veduta dell'opere, essendo che insegna la lunga pratica i solleciti dipintori a conoscere, come sapete, non altramente le varie maniere degl'artefici, che si faccia un dotto e pratico cancelliere i diversi e variati scritti de' suoi eguali, e ciascuno i caratteri de' suoi più stretti famigliari amici e congiunti. Ora, se io averò conseguito il fine che io ho desiderato, che è stato di giovare et insiememente dilettare, mi sarà sommamente grato, e quando sia altrimenti mi sarà di contento, o almeno alleggiamento di noia, aver durato fatica in cosa onorevole, che dee farmi degno appo i virtuosi di pietà, non che perdono.
Ma per venire al fine oggimai di sì lungo ragionamento, io ho scritto come pittore, e con quell'ordine e modo che ho saputo migliore; e quanto alla lingua in quella ch'io parlo, o fiorentina, o toscana ch'ella sia, et in quel modo che ho sa-puto più facile et agevole, lasciando gl'ornati e lunghi periodi, la scelta delle voci e gli altri ornamenti del parlare e scrivere dottamente a chi non ha come ho io più le mani ai pennelli che alla penna, e più il capo ai disegni che allo scrivere. E se ho seminati per l'opera molti vocaboli proprii delle nostre arti, dei quali non occorse per aventura servirsi ai più chiari e maggiori lumi della lingua nostra, ciò ho fatto per non poter far di manco, e per essere inteso da voi artefici, per i quali come ho detto mi sono messo principalmente a questa fatica.
Nel rimanente, avendo fatto quello che ho saputo, accettatelo volentieri, e da me non vogliate quel ch'io non so e non posso, appagandovi del buono animo mio, che è e sarà sempre di giovare e piacere altrui.